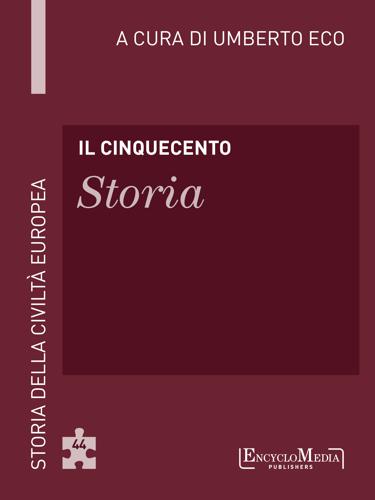Avvisi e gazzette
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Nelle principali città europee, nel Cinquecento, circolano fogli d’informazione, che in Italia sono chiamati “avvisi”, “gazzette” o “reporti”. Essi hanno diffusione non solo a livello locale ma anche internazionale, e danno notizia di eventi di natura eterogenea accaduti in diverse parti del mondo. Per il tipo di notizie e la periodicità con cui escono sono considerati le forme embrionali del giornalismo periodico.
Le origini
Queste prime espressioni dell’attività giornalistica si formano nell’ambiente ricco di fermenti dei librai, degli editori, degli stampatori, ma forse ancor più sono legate al mondo dei mercanti e dei banchieri, nonché agli ambienti popolari e al mondo delle corti, dove il gusto per il pettegolezzo e per la notizia piccante trova fertile terreno. Gli avvisi vengono spesso allegati ai dispacci diplomatici, alla corrispondenza tra sedi diverse delle grandi compagnie commerciali e delle banche o ai carteggi privati. Si inseriscono così in un circuito internazionale attraverso i servizi postali. La periodicità con cui escono questi fogli di notizie è legata alla partenza di corrieri per le principali direttrici; i tempi di diffusione sono anch’essi legati ai ritmi postali.
“Menanti” e “gazzettieri”
Tra i numerosi avvisi a stampa e manoscritti che si sono conservati, molto noti sono quelli che nella seconda metà del secolo vengono settimanalmente spediti al duca d’Urbino Francesco Maria della Rovere dal suo agente in Roma. Un’altra serie importante, legata al mondo mercantile e finanziario, è costituita dagli avvisi inviati da Venezia al banchiere Ulrich Fugger ad Augusta negli anni che vanno dal 1554 al 1564 (le due serie sono entrambe conservate nel Fondo Urbinate della Biblioteca Vaticana). In questi casi, gli agenti del duca e del banchiere, assieme alla corrispondenza da loro redatta, inviano con regolarità gli avvisi, ossia bollettini informativi, non stilati personalmente, bensì acquistati presso persone che di mestiere raccolgono notizie su quanto accade in città e all’estero, e sintetizzano tutto in brevi note informative. Chiamati “menanti”, “novellanti” o “gazzettieri”, essi stilano una sorta di giornale da vendere, traendo le loro notizie dagli uffici dei maestri di posta (dove vengono registrati gli arrivi dei corrieri ordinari e straordinari), dalle banche, dagli ambienti di corte, dai menanti di altre città con i quali sono in contatto. Questi professionisti della penna sono particolarmente numerosi nelle capitali, nelle città commerciali e in quelle situate su importanti direttrici di traffico: Parigi, Lione, Anversa, Bruxelles, Valladolid, Madrid e, per l’Italia, Roma, Venezia, Bologna e Milano.
Il genere di notizie
La propaganda religiosa nel corso del Cinquecento incentiva la stampa di libri e ancor più di opuscoli, di fogli volanti con immagini satiriche e provocatorie, di brevi testi facili da leggere. Lo scopo è quello di suscitare la discussione pubblica e di indirizzare i lettori verso un’opinione. Il ritmo con cui un opuscolo viene messo in circolazione lo rende simile a un periodico. L’affinità non sta solo nella periodicità, ma anche nel tipo di notizie che vengono divulgate. Infatti, lo scopo degli avvisi e delle gazzette è di fornire informazioni su argomenti e fatti che sono avvenuti, che sono degni d’attenzione oppure oggetto di curiosità: eventi militari, notizie sugli spostamenti della flotta turca nel Mediterraneo, avvenimenti politici, informazioni economiche finanziarie e commerciali, aggiornamenti sulla situazione della legislazione annonaria, notizie di eventuali problemi sanitari. Riferiscono di nascite, matrimoni, morti di personaggi importanti, danno conto di quello che accade nelle altre corti europee. Abbondano poi i fatti miracolosi e naturali, i resoconti di crimini e di condanne esemplari, ma anche i pettegolezzi, i componimenti satirici mordaci, gli attacchi a personaggi politici o a ecclesiastici di rilievo. Tutte notizie che attirano un pubblico ampio e curioso.
Menanti e gazzettieri mettono talvolta la loro penna a disposizione di persone danarose, che fanno degli avvisi lo strumento per diffamare gli avversari politici. Quando un evento è di particolare interesse, l’avviso viene diffuso a stampa anziché manoscritto, così da consentire una più ampia circolazione. Gli avvisi manoscritti e quelli a stampa si rivolgono comunque a un pubblico diverso. I primi sono indirizzati a lettori particolari, contengono spesso notizie salaci e diffamatorie. Le autorità hanno difficoltà a esercitare forme di controllo e di censura su quanto viene in essi divulgato. Dallo stesso giro di menanti e novellanti provengono anche le satire piccanti, gli epigrammi provocatori, le accuse alla degenerazione dei costumi ecclesiastici, le critiche sferzanti a governanti incapaci. Vengono diffuse in maniera anonima, affisse alle cosiddette “statue parlanti” – quella di Pasquino a Roma, o quella del Gobbo di Rialto a Venezia – che tanto godono della simpatia popolare quanto vengono detestate dalle autorità. Gli avvisi a stampa, chiamati più comunemente gazzette, offrono una tipologia d’informazione ampia e generale, hanno una diffusione più estesa e capillare, di solito vengono letti per strada e hanno l’intento di formare una pubblica opinione. Legati al mondo dei tipografi, degli editori e dei librai, sono più facilmente sottoposti al controllo dell’autorità pubblica.
Roma e Venezia
In Italia, Roma e Venezia sono i due principali centri in cui fiorisce l’attività dei novellanti e da cui si irradiano moltissimi bollettini informativi. Venezia, città ricca di stranieri (mercanti, banchieri, agenti), dove prospera l’attività editoriale, costituisce il punto di collegamento sia tra Occidente e Oriente, sia tra gli Stati italiani e i Paesi di lingua tedesca e slava.
Nella seconda metà del secolo a Venezia gli avvisi escono con regolarità il sabato e vengono venduti al prezzo di una “gazeta” (una monetina d’argento del valore di due soldi, da cui prendono forse il nome). Sull’ampia produzione di fogli veneziani, diffusi via posta in molte altre città italiane ed europee, veglia sempre con attenzione il governo della Repubblica, che lascia comunque una libertà d’espressione piuttosto ampia, specie se si fa il confronto con Roma, l’altra grande città italiana dove questa attività è fiorente. Roma infatti è città cosmopolita, punto di confluenza e di smistamento di corrieri che garantiscono il collegamento con i principali Stati italiani ed europei. È sede del papato con la sua popolatissima curia, uno snodo politico e religioso importante, dove ogni potenza cristiana invia un suo rappresentante. Gli avvisi romani, oltre a notizie generali, rispecchiano le lotte tra fazioni cardinalizie, si inseriscono nelle rivalità interne alla corte di Roma e, più in generale, nelle ostilità tra famiglie aristocratiche romane. Nel corso dei conclavi, approfittando della sede vacante e dell’allentamento della censura, si accentuano i toni, solitamente già aspri, degli avvisi.
I controlli e la censura
La grande diffusione delle gazzette e degli avvisi fa circolare le informazioni e consente di mettere a confronto idee diverse e opinioni contrastanti sui medesimi avvenimenti politici. Permette insomma lo sviluppo di un modo più autonomo di pensare, favorisce il formarsi di un’“opinione pubblica”, sia pure di dimensioni ancora molto limitate. Ma questa maggiore libertà preoccupa seriamente le autorità religiose e politiche, che intervengono con controlli e censure. Nella Roma del secondo Cinquecento sono numerosi i provvedimenti di Paolo IV e Pio V per ostacolare la diffusione di notizie considerate pericolose, e per impedire che i menanti lavorino apertamente come fonti d’informazione per ambasciatori residenti in Roma.
Nel 1572 Gregorio XIII emana la bolla Contra famigeratores et menantes con la quale non solo ribadisce le pene già in vigore, ma estende la responsabilità anche ai lettori, considerati colpevoli se non denunciano tali forme d’informazione faziosa. Nel 1587 un menante, accusato di divulgare notizie false, viene catturato, sottoposto al taglio della lingua e della mano e infine impiccato. Sequestri, persecuzioni, condanne a morte, provocano la contrazione di queste forme di circolazione d’idee. Tuttavia si creano zone franche in cui queste scritture, assieme alle relazioni, agli annuari, alle memorie, continuano a esistere e costituiscono le premesse per la formazione delle prime gazzette a stampa a carattere periodico.