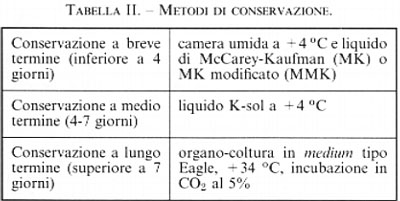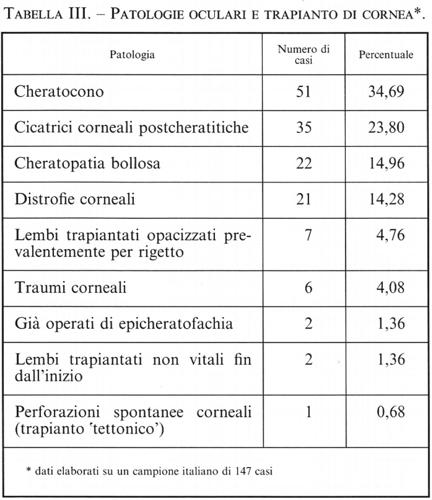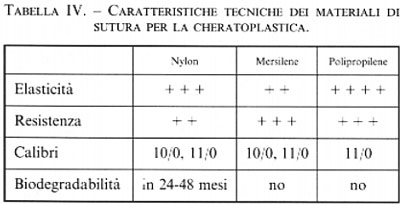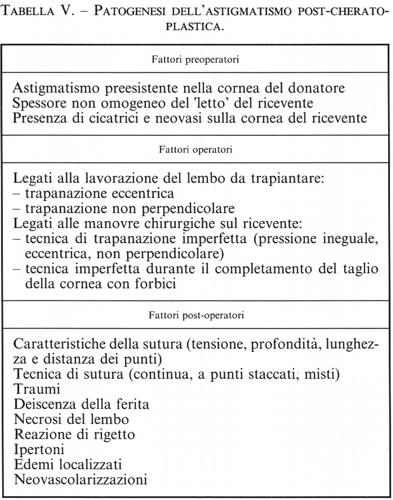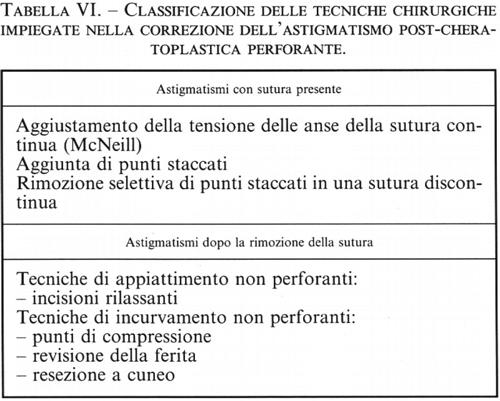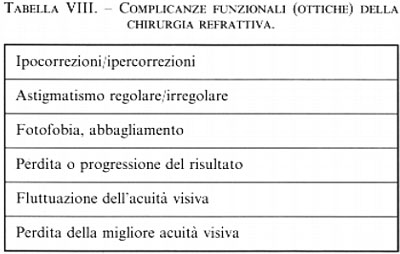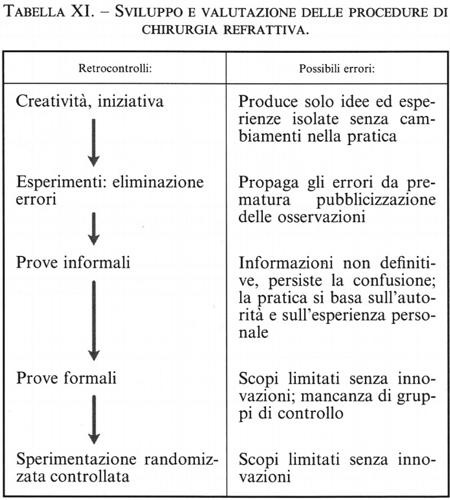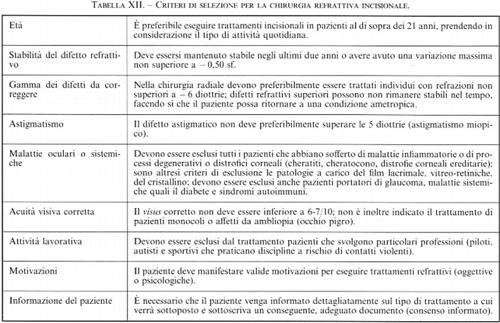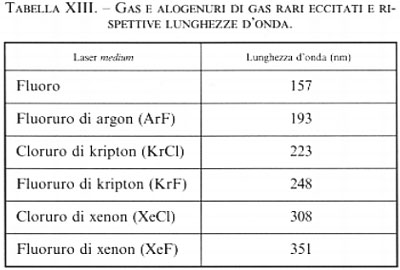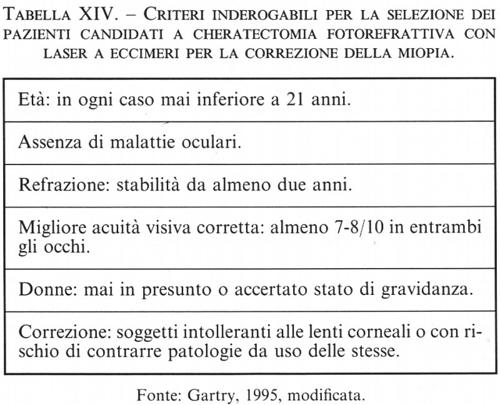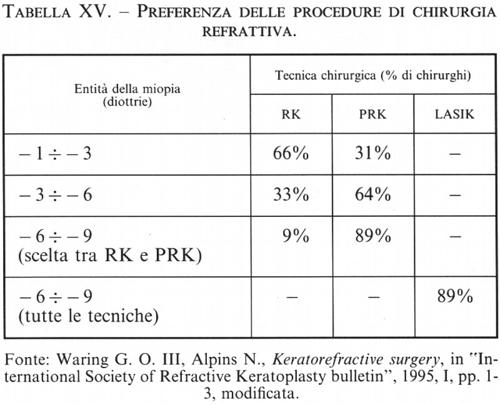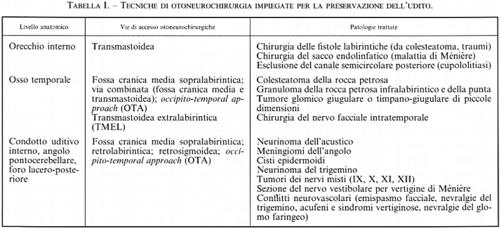Chirurgia
Chirurgia
Artroprotesi totale dell'anca di James V. Bono e Eduardo A. Salvati
SOMMARIO: 1. Introduzione: a) deiginizione e generalità; b) aspetti socio-sanitari. 2. Cenni storici. 3. Problemi tecnici generali: a) scelta dell'impianto; b) reazione dell'ospite; c) cemento o non cemento; d) tecnica con il cemento; e) tecnica senza cemento. 4. Struttura della protesi: a) componente femorale; b) componente acetabolare. 5. Tecniche chirurgiche: a) vie di accesso; b) osteotomia trocanterica; c) adattamento dei componenti protesici. 6. Indicazioni: a) indicazioni e controindicazioni generali; b) necrosi ischemica della testa femorale; c) spondilite anchilosante; d) malattia di Paget; e) anchilosi ossea; f) lussazione congenita dell'anca. 7. Complicazioni: a) tromboembolia; b) allentamento asettico; c) infezione; d) ossificazione eterotopica; e) mancata giunzione trocanterica e lussazione; f) lesioni neurologiche e vascolari; g) frattura del femore; h) fratture del gambo. 8. Revisione. 9. Trattamento post-operatorio. 10. Cenni conclusivi. □ Bibliografia.
1. Introduzione.
a) Definizione e generalità
L'articolazione dell'anca, o coxofemorale, è essenzialmente costituita da un componente femorale sferico e convesso - la testa del femore - e da un componente iliaco sferico e concavo - la cavità acetabolare. Entrambe le superfici articolari sono normalmente rivestite da cartilagine liscia e bagnate da liquido sinoviale che mantiene uniforme la pressione all'interno dell'articolazione: ciò consente un movimento agevole del femore all'interno della cavità acetabolare e la normale funzionalità dell'anca. Alterazioni più o meno gravi a carico dei componenti dell'anca possono comprometterne la funzionalità anche in modo totale. Attualmente, tuttavia, le moderne tecniche di chirurgia ortopedica consentono di eliminare gli elementi anatomici lesi e di sostituirli con protesi costituite da un componente acetabolare, o coppa, e un componente femorale, o gambo, di materiale vario, ben tollerato dall'organismo, che vengono fissate prossimalmente all'osso iliaco e distalmente al femore, con o senza sostanze cementanti. Per effettuare la sostituzione di questa articolazione, così come per individuare e risolvere i complessi problemi che potrebbero porsi in futuro, è naturalmente essenziale conoscere la storia di questo intervento - noto come artroprotesi totale dell'anca - e la letteratura relativa ai recenti progressi verificatisi in questo campo.
L'attuale possibilità di effettuare una sostituzione dell'anca deriva - oltre che dal simultaneo sviluppo di modelli, materiali e tecniche - dagli studi relativi alla emiartroplastica, un intervento che era stato messo a punto per il trattamento delle fratture del collo del femore: tali studi e le sperimentazioni a esso connesse permisero a sir John Charnley (v., 1979) di individuare i principî che sono alla base della sostituzione totale dell'articolazione. La complessità di questo intervento richiede che il chirurgo ortopedico che lo pratica sia un esperto di biomeccanica dell'anca, che conosca tutti gli aspetti tecnici della chirurgia e che sia in grado di scegliere gli opportuni componenti; è necessaria inoltre una buona programmazione preoperatoria e un efficace trattamento post-operatorio. L'obiettivo della sostituzione dell'anca è quello di creare un'anca artificiale durevole, capace di movimenti funzionali e in grado di assicurare una deambulazione senza impacci e sofferenze.
b) Aspetti socio-sanitari
L'uso dell'artroprotesi totale dell'anca si è diffuso rapidamente divenendo in breve la più comune procedura ricostruttiva dell'anca nell'età adulta, anche perché i mezzi non chirurgici disponibili non erano in grado di mitigare un dolore talvolta debilitante; le indicazioni all'intervento, effettuato in un primo periodo su pazienti con fratture del collo del femore, si sono estese a includere malattie degenerative (artrosi) e infiammatorie (artrite reumatoide) dell'articolazione, necrosi ischemiche della testa femorale e molte altre.
Tuttavia, non si può non riconoscere che il costo della tecnologia ortopedica è elevato e ricade sui pazienti. Alcuni tipi di protesi, largamente pubblicizzati sul mercato, sono stati dichiarati obsoleti dopo poco tempo e sostituiti con modelli più nuovi: questa pratica, dettata spesso da valutazioni di natura esclusivamente economica, non fa che aumentare i costi dell'impianto, che sono i pazienti a dover sostenere, e spesso le differenze tra le varie protesi sono minime, se non addirittura inesistenti, quanto a risultati clinici e benefici che ne derivano.
Occorre fare un uso cauto e basato su prospettive realistiche di questo intervento, che ha certamente mutato in modo radicale le prospettive per i pazienti affetti da artropatie dell'anca; ad esempio, la grande pubblicità che è stata data all'intervento effettuato su un noto atleta, Bo Jackson, ha fatto nascere speranze illusorie specie nei pazienti più giovani (v. Chandler e altri, 1981). È importante far conoscere esattamente le indicazioni e le controindicazioni dell'artroprotesi totale di anca e anche le possibili alternative.
2. Cenni storici
La storia della sostituzione totale dell'anca, per gli aspetti relativi a materiali, modelli e tecniche, può essere suddivisa in tre distinti periodi: durante il primo, caratterizzato dalla sperimentazione dei materiali, si riuscì spesso a ottenere un momentaneo alleviamento del dolore, seguito però da un precoce insuccesso meccanico; durante il secondo, grazie principalmente all'opera di Charnley, fu possibile individuare i materiali, i modelli e i principî di biomeccanica su cui si basa l'attuale artroprotesi totale; nel terzo periodo, infine, vennero perfezionati questi primi principî e si svilupparono i sistemi di sostituzione dell'anca senza cemento e i sistemi ibridi.
La genesi della moderna artroprotesi totale dell'anca può esser fatta risalire al chirurgo tedesco T. Gluck, che nel 1890 operò la prima sostituzione protesica della testa del femore utilizzando una sfera d'avorio, mantenuta nella sua sede tramite viti, e un particolare tipo di colla, costituita da colofonia, polvere di pomice e gesso (v. Gluck, 1890). L'intervento, tuttavia, non ebbe successo a causa della ‛estrusione' delle parti; neppure l'uso di protesi di gomma e di avorio ebbe esito migliore. Nel 1923, M. N. Smith-Petersen (v., 1939) effettuò per la prima volta il rivestimento della testa del femore introducendo una protesi di vetro a forma di coppa concava; nonostante l'alta incidenza di insuccessi dovuti alle aumentate sollecitazioni meccaniche sull'osso, questo intervento, noto come artroprotesi a coppa, fu largamente praticato per oltre un quarto di secolo, in quanto permetteva di eliminare solo le superfici patologiche dei capi articolari, lasciando intatte la normale anatomia e la funzione biomeccanica dell'anca. Tuttavia, a causa della facilità con cui si frammentava il vetro, in molti casi (fino al 60%) era necessaria una revisione; questo materiale fu quindi sostituito prima dal pirex (1933), poi dalla bachelite (1937) e infine dal vitallio (1938; v. Smith-Petersen, 1948).
Contemporaneamente si svilupparono tecniche di impianto di metallo su metallo, che utilizzavano acciaio inossidabile e cromo-cobalto: tali componenti venivano fissati mediante una placca e viti (nell'acetabolo) o un bullone (nel femore). L'esito clinico più consueto di quei primi interventi consisteva in un sostanziale alleviamento del dolore, seguito però a breve tempo da insuccesso meccanico, le cui cause più frequenti erano l'allentamento dovuto alla maggiore spinta di torsione per aumento dell'attrito tra i componenti, insoddisfacenti tecniche cementanti e inadeguati modelli di gambo femorale.
In questo periodo si sperimentò anche un tipo di artroplastica a interposizione, realizzata rivestendo i capi articolari con tessuti biologici diversi, come la fascia lata, la pelle e l'amnios umani. G. R. Girdlestone descrisse un'artroplastica escissionale dell'anca come ‟usuale trattamento dell'artrosi monolaterale dell'articolazione". Fu allora che A. T. Moore avanzò la pionieristica idea di un gambo femorale intramidollare, usando un'endoprotesi in acciaio inossidabile, e tale tecnica venne largamente impiegata negli interventi di emiartroplastica (v. Moore, 1952). Nel 1950 i fratelli J. e R. Judet idearono una protesi acrilica della testa del femore, inserita con un gambo entro il collo femorale; col tempo, tuttavia, il materiale acrilico si frammentava determinando una catastrofica reazione del tessuto molle e osteolisi. Nel corso del decennio successivo, R. P. Giliberty introdusse l'emiartroplastica bipolare, derivata dall'artroplastica unipolare di Moore: dato però che quelle primitive endoprotesi causavano l'erosione dell'osso acetabolare, si arrivò all'idea di un rivestimento della superficie acetabolare.
Nel 1953, E. J. Haboush impiegò il metilmetacrilato, una resina dentale autoindurente, per fissare all'osso una testa di femore e una cavità acetabolare, ambedue in vitallio. La fissazione con cemento divenne parte integrante di questa prima generazione di artroprotesi totali di anca, di cui J. Charnley (v., 1960) fu il principale precursore: è a lui che va ascritto il merito della grande diffusione odierna di tale intervento; la divulgazione della fissazione con cemento acrilico si deve infatti ai risultati clinici di lunga durata che Charnley ottenne utilizzando questa semplice tecnica.
Il principio scientifico su cui si basa l'artroprotesi di Charnley (v., 1979) è quello della bassa frizione esercitata, grazie anche a una testa femorale di piccole dimensioni (22 mm). L'importanza dell'opera di Charnley è dovuta anche al suo contributo alla comprensione della biomeccanica dell'articolazione dell'anca. Le prime esperienze misero in evidenza alcuni aspetti essenziali per il successo delle artroprotesi: 1) la necessità di sostituire ambedue le componenti articolari, femorale e acetabolare; 2) la necessità di ottenere una iniziale stabilità protesica onde scongiurare i micromovimenti e il conseguente riassorbimento osseo; 3) per prevenire il riassorbimento osseo si deve evitare anche che vi siano zone sottoposte a forti pressioni; 4) le parti protesiche devono essere fatte di materiali appropriati e risultare perfettamente congrue, per evitare l'usura; 5) il gambo della componente femorale deve essere sufficientemente lungo da distribuire omogeneamente il carico (v. Brand e altri, 1992).
L'idea di Charnley di una artroprotesi che rispondesse al principio della bassa frizione si basava sulle dimensioni della testa del componente femorale: egli comprese che il momento di attrito è direttamente proporzionale al raggio interno della testa e ipotizzò che una testa di diametro maggiore avrebbe predisposto l'impianto all'allentamento; peraltro, egli capiva anche che la sollecitazione superficiale sarebbe risultata tanto minore quanto più grande era la superficie della testa femorale. Utilizzando una testa di diametro minore, con un ridotto momento di attrito, si esercitava una pressione più elevata per unità di superficie a carico della coppa acetabolare, determinando, in teoria, un'accentuazione del logorio; una testa di maggiori dimensioni, come quella adottata più tardi da M. E. Müller, offriva invece il vantaggio di una minore pressione per unità di superficie, a spese, però, dell'aumento del momento di attrito. Charnley optò per la prima soluzione.
I primi componenti acetabolari utilizzati da Charnley, in politetrafluoroetilene (PTFE), si logoravano a un ritmo inaccettabile e furono quindi sostituiti da quelli in polietilene ad altissimo peso molecolare (HMWP, High Molecular Weight Polyethylene), con conseguente riduzione dell'usura della coppa. L'aumento dell'usura dovuto al maggior carico per unità di superficie non fu mai così elevato come Charnley aveva temuto, e risultò essere circa 0,1 mm per anno (v. Charnley e Halley, 1975). Per compensare la maggiore usura venne accresciuto lo spessore della coppa in polietilene ad altissimo peso molecolare, ottenendo così anche una maggiore rigidità all'impianto e pertanto una distribuzione più uniforme dello sforzo all'osso circostante.
Il principio sostenuto da Charnley di un'artroprotesi caratterizzata da basso attrito della superficie portante tra testa femorale e componente acetabolare risultò fondamentale al fine di evitare il momento di attrito su entrambi i componenti, che avrebbe potuto causare un allentamento. Il coefficiente di attrito, decisamente basso (0,005) in un'articolazione naturale, può essere modificato in base ai materiali protesici scelti per realizzare la superficie portante: il coefficiente delle prime protesi metallo su metallo, che era 0,8, fu uno dei molti fattori responsabili dell'allentamento degli impianti e, quindi, del loro insuccesso; invece, il coefficiente delle protesi metallo su HMWP, che era solo 0,02 (v. Walker e Bullough, 1973), rappresentò un netto vantaggio.
La stabilità del componente protesico fu un altro elemento preso in considerazione da Charnley quando scelse una testa di 22 mm: intuendo che una testa più piccola sarebbe stata più facilmente soggetta alle lussazioni, egli prevenne tale evenienza progettando una cavità acetabolare di 2 mm più profonda degli 11 mm del raggio della testa e aumentando la tensione dei muscoli abduttori tramite una osteotomia trocanterica. Queste scelte erano state dettate da alcune fondamentali considerazioni di biomeccanica, e in particolare dall'aver identificato due fondamentali bracci di leva (momenti) che agiscono sull'articolazione dell'anca. Il primo momento, che viene creato dal peso del corpo, agisce dal centro di gravità del corpo stesso sul centro della testa femorale e deve essere controbilanciato da un secondo momento, rappresentato dal meccanismo abduttore che si estende dalla faccia laterale del gran trocantere alla testa del femore. La comprensione di questi principî permise a Charnley di concepire l'idea di ridurre il momento creato dal peso del corpo massimizzando al contempo quello costituito dal meccanismo di abduzione. Il primo momento può essere ridotto o attraverso una diminuzione del peso corporeo, oppure con l'accorciamento della distanza tra il centro di gravità del corpo e il centro della testa femorale, attuabile - come intuì Charnley - con una centralizzazione (medializzazione) dell'articolazione dell'anca, cioè approfondendo la cavità acetabolare. L'aumento del braccio di leva del meccanismo abduttore dell'anca avrebbe potuto essere vantaggioso dal punto di vista meccanico: la tecnica dell'osteotomia trocanterica con ricongiunzione laterale faceva aumentare la distanza tra il meccanismo abduttore e il centro della testa femorale, aumentando di conseguenza il braccio di leva del meccanismo abduttore dell'anca.
L'artroprotesi a bassa frizione di Charnley, in metallo e polietilene, così come i primi concetti biomeccanici che egli aveva individuato e reso noti, hanno resistito alla prova del tempo e tuttora rappresentano la base di riferimento sulla quale vengono valutati tutti gli altri impianti. I dati riassuntivi a più di 15 anni dall'intervento riportano il 91% di soppravvivenza, di cui l'87,5% con buoni o eccellenti risultati (v. McCoy e altri, 1988); dopo 15-21 anni, assenza di dolore nell'85% dei casi e recupero completo, o quasi, del movimento nel 78% dei pazienti trattati. Inoltre, dopo un minimo di venti anni di osservazione, l'85% dei pazienti conserva le protesi originali (v. Schulte e altri, 1993). Attualmente cominciano a comparire studi comparativi a lungo termine dei modelli che utilizzano nuovi componenti, con o senza impiego di cemento, che dovranno essere sottoposti allo stesso esame critico e minuzioso che ha subito il lavoro di Charnley.
I principî definiti da Charnley relativamente all'artroprotesi totale dell'anca sono stati in seguito perfezionati e messi alla prova. Grazie anche ai progressi nel campo della biomeccanica è stato possibile ideare e mettere a punto nuovi materiali e nuovi modelli. Anche le tecniche di fissazione con cemento sono state migliorate ed è stato introdotto un nuovo tipo di fissazione senza cemento.
Tutti questi nuovi sviluppi, che hanno dato origine a una varietà di possibilità diverse relativamente alla sostituzione totale dell'articolazione, hanno dovuto peraltro essere confrontati coi risultati ottenuti con le protesi cementate di Charnley.
3. Problemi tecnici generali
a) Scelta dell'impianto.
Il chirurgo deve risolvere una molteplicità di problemi per operare una corretta scelta sia dei componenti femorale e acetabolare dell'impianto, sia del sistema di fissazione. Innanzi tutto, deve decidere se sostituire l'articolazione dell'anca di un solo lato o di ambedue, poi deve scegliere i costituenti metallici (per esempio, cromo-cobalto o titanio) e il polietilene (HMWP standard o ‛rinforzato'). Se è il caso di usare il cemento, i componenti possono essere prerivestiti con polimetilmetacrilato oppure no; se si opta per un componente che non necessita di cemento, questo può avere un rivestimento poroso o essere metallizzato con arcoplasma oppure rivestito con materiale bioattivo come idrossiapatite. Il rivestimento poroso, applicabile mediante sinterizzazione o per saldatura a diffusione, favorisce un maggior contatto tra osso e protesi e il processo di osteointegrazione; se si sceglie l'idrossiapatite, che ha proprietà osteogenica, bisogna decidere anche tra i vari spessori possibili. Il gambo può essere dotato o meno di colletto, con possibilità di adattamento autonomo prossimale e distale; se si usano componenti modulari, esistono diverse alternative circa la lunghezza del collo e le dimensioni della testa; quest'ultima può essere in metallo (cromo-cobalto) o in ceramica (allumina o ossido di zirconio), mentre il gambo può essere curvo - e in questo caso sono disponibili componenti a curvatura singola o doppia - oppure dritto, e per fissarlo possono essere impiegati alesatori dritti o flessibili.
Il componente acetabolare può essere rinforzato con metallo o essere interamente in polietilene. I componenti privi di cemento si possono inserire progressivamente, con ulteriori elementi di fissazione, come viti, oppure mediante fissazione istantanea a pressione, tramite incasso di un involucro metallico più largo (1-4 mm) della cavità alesata. È possibile che si renda necessario un impianto disegnato appositamente, che può essere realizzato sulla base delle immagini fornite dalla tomografia computerizzata (TC) o la ricostruzione computerizzata dell'immagine intraoperatoria. Insomma, è possibile realizzare una serie di varianti utilizzabili nei diversi e sempre più frequenti casi in cui è indicata l'artroprotesi totale dell'anca.
b) Reazione dell'ospite.
Il fine che qualunque impianto si prefigge di ottenere è quello di una armoniosa coesistenza coi tessuti ospiti. L'impianto deve resistere ad anni di carico ciclico, approssimativamente un milione di cicli per anno, e deve tollerare carichi di 3-12 volte il peso corporeo. La proprietà meccanica ideale di un impianto dovrebbe essere simile a quella propria dell'osso umano; tuttavia, i materiali con i quali è costruito sono di gran lunga più resistenti dell'osso corticale, per cui l'inserzione dell'impianto altera irrevocabilmente lo schema di sollecitazione meccanica esercitata sulla parte prossimale del femore.
L'interazione dell'impianto con l'ospite è di tipo sia biomeccanico, sia fisiologico: infatti, l'impianto deve essere tollerato dall'ospite non solo dal punto di vista biochimico, ma anche da quello fisiologico. Da un punto di vista istologico, le reazioni dell'ospite all'impianto possono essere di tre tipi: reattive, inerti e bioattive. Il cemento osseo, l'acciaio inossidabile e le leghe di cromo-cobalto stimolano la formazione di un rivestimento fibroso attorno all'impianto, in risposta alla diffusione degli ioni. D'altro canto, taluni preferiscono le leghe in titanio sostenendo che sono meglio tollerate dall'osso ospite e non stimolano alcuna reazione fibrosa. Il modulo di elasticità del titanio, per esempio, è circa la metà di quello di altri metalli, anche se è circa cinque volte quello dell'osso: la sua elevata resistenza alla fatica e il basso modulo di elasticità consentono la trasmissione dell'aumentato carico dell'impianto alla regione dello sperone osseo femorale (lo sperone femorale è una piccola lamina di tessuto osseo compatto disposta verticalmente dall'estremità superiore della diafisi al collo del femore, con funzioni di sostegno; v. Sarmiento e Gruen, 1985). Tutti i gambi progettati per l'artroprotesi totale dell'anca, compresi quelli in titanio, hanno un modulo di elasticità più alto di quello dell'osso, e ciò inevitabilmente altera la distribuzione della tensione e dello sforzo in tutta la parte prossimale del femore. La differente rigidità dovuta ai diversi moduli di elasticità di Young nel metallo e nell'osso è un fattore importante che contribuisce all'allentamento asettico dell'impianto. Con l'introduzione, negli anni settanta, dei gambi in lega di titanio si è cercato di attenuare questa differenza di rigidità e quindi l'aumento di carico sulla corteccia mediale della parte prossimale del femore.
Nel tentativo di creare un impianto con un modulo di elasticità simile a quello dell'osso, si è cercato di costruire un'intera articolazione utilizzando componenti di natura diversa, come polimeri di metallo, ceramica o carbonio, che possono essere resi estremamente resistenti pur essendo relativamente flessibili in confronto agli usuali componenti metallici.
I materiali bioattivi (idrossiapatite e vetroceramica) hanno dimostrato di stimolare attivamente la crescita dell'osso, una risposta fisiologica caratterizzata da invasione di osteoblasti e proliferazione di tessuto osseo. In anni recenti, grande interesse hanno suscitato i biomateriali di fosfato di calcio, come le idrossiapatiti, a causa della loro affinità con l'osso una volta che vi vengano a contatto. Occorre però accertare se i materiali bioattivi siano in grado di resistere agli anni di carico ciclico ordinariamente richiesto agli impianti. L'aderenza e la resistenza alla fatica del rivestimento di idrossiapatite sono influenzate non solo dalla tecnica di applicazione del rivestimento, ma anche dal suo spessore.
c) Cemento o non cemento.
L'insuccesso delle prime artroprotesi cementate, risalenti agli anni sessanta, ha determinato la rapida evoluzione e l'entusiastica accoglienza dei modelli senza cemento; è opportuno, tuttavia, raccomandare una maggiore cautela al riguardo fintantoché non vi sarà un'adeguata documentazione dei risultati a lungo termine.
Il cemento rappresenta l'anello più debole dell'intero impianto: non è una colla né ha proprietà adesive, ma agisce come una malta; le sue proprietà di legante sono dovute alla capacità di penetrazione del polimetilmetacrilato negli interstizi dell'osso spugnoso formando microconnessioni. Quando è usato in modo corretto, il cemento ha la capacità di fissare saldamente all'osso i componenti e di trasferire le sollecitazioni alla più larga superficie ossea di contatto. Il cemento è stato erroneamente ritenuto l'unico responsabile dell'osteolisi della parte prossimale del femore, ma attualmente anche nei sistemi di impianto non cementati si registra una allarmante, anche se variabile, frequenza di osteolisi secondaria al logorio del polietilene e alla tossicità dello ione metallico (27-71% dei casi; v. Kim e Kim, 1993; v. Bono e altri, 1994); è probabilmente a questa causa che si deve l'insuccesso tardivo (5% dei casi) dell'artroprotesi totale dell'anca senza cemento nei pazienti di età inferiore ai 50 anni (v. Cooper e altri, 1992).
In realtà alcuni studi suggeriscono che le tecniche cementanti perfezionate possano prevenire l'osteolisi piuttosto che provocarla, come sembrerebbero indicare i dati relativi all'incidenza di osteolisi endostale del femore (7%) a 11 anni dall'intervento (v. Mulroy e Harris, The effect..., 1990). Inoltre, la comprovata durabilità dei sistemi di artroprotesi cementata a 15 anni dall'intervento depone decisamente a favore di questo sistema per quei pazienti nei quali tale termine si accordi con la speranza di vita.
d) Tecnica con il cemento.
Le principali operazioni previste dalle tecniche cementanti comprendono attualmente la perfetta pulizia del canale midollare della parte prossimale del femore mediante sistemi di lavaggio a pressione e di spazzole endomidollari. Si ottiene una migliore pressurizzazione del cemento negli interstizi dell'osso spugnoso se lo si inietta con apposito strumento allo stato semiliquido. La pressurizzazione in sede acetabolare può essere ottenuta usando particolari accorgimenti, o semplicemente premendo fortemente con una siringa a bulbo. Se il cemento viene centrifugato oppure mescolato sotto vuoto se ne diminuisce la porosità e pertanto se ne migliora la penetrazione senza lacune o deficienze residue nel manto. Un manto cementizio resistente e con poche imperfezioni, che si estenda per 1 o 2 cm oltre l'estremità del gambo, si traduce in una maggior resistenza dell'impianto composito cemento-osso.
La tecnica di cementazione degli impianti femorali, perfezionata da Harris e McGann (v., 1986), ha ridotto il tasso di allentamento femorale portandolo all'1,3% a sei anni dall'intervento, e al 3% a dieci anni (v. Mulroy e Harris, The effect..., 1990). Anche l'interfaccia metallo-cemento è stata migliorata, grazie all'uso di un prerivestimento con una struttura in polimetilmetacrilato.
e) Tecnica senza cemento.
Con l'avvento dei sistemi non cementati sono entrati nel vocabolario ortopedico numerosi termini nuovi: fissazione con interferenza (interference fit), fissazione a pressione (press fit), fissazione a riempimento (fit and fill) e macroconnessione (macro interlock), che si riferiscono alla stabilità meccanica primaria ottenuta al momento dell'impianto di un componente non cementato. Se l'impianto è stato rivestito con materiale poroso o bioattivo (v. Engh e Bobyn, 1985), è possibile, col tempo, che si instauri un processo di osteointegrazione. Gli elementi a favore della fissazione senza cemento sono la biocompatibilità dell'impianto, la preservazione in buono stato dell'osso circostante, il processo di osteointegrazione e l'assenza di micromovimenti all'interfaccia, che è il risultato della stabilità meccanica primaria conseguita al momento dell'impianto.
Il processo di osteointegrazione avviene con modalità simili a quelle che si osservano nella guarigione di una frattura: dopo 2-3 settimane, l'iniziale stadio infiammatorio è seguito da una fase di riparazione, durante la quale si forma osso trabecolare, e quindi, dopo circa 6 settimane, da una fase rimodellante che segue la legge di Wolff, cioè stratificazione dell'osso nei punti di maggiore sforzo e riassorbimento osseo ove lo sforzo è minore. La crescita ossea è influenzata da numerosi fattori: oltre a fattori individuali dei pazienti, possono avere importanza il buon allineamento e la correttezza delle dimensioni dell'impianto, la terapia radiante, alcuni farmaci (come aspirina, indometacina e ibuprofen) e l'instaurarsi di infezioni. La crescita ossea è stata confermata dall'esame dei preparati istologici degli impianti recuperati.
La stabilizzazione dipende da ambedue i processi, quello meccanico e quello biologico. La stabilità meccanica primaria si ottiene in sede operatoria e dipende dal modello dell'impianto e dall'anatomia del paziente; la fissazione biologica, che può sopravvenire solo dopo che è stata conseguita la stabilità meccanica, dipende dal tempo e dalle capacità osteoinduttive dell'ospite. La fissazione stabile in zona femorale, se non si usa la tecnica di microconnessione cementata, si ottiene utilizzando un principio simile, la macroconnessione o fissazione con interferenza, cioè l'impianto viene convenientemente adattato contro l'osso corticale a livello sia prossimale che distale. La fissazione con interferenza, inoltre, può essere potenziata impiegando impianti provvisti di fenestrazioni o pori che favoriscano la penetrazione ossea e quindi la successiva osteointegrazione. Gli impianti con rivestimenti porosi, in assenza di una stabile fissazione con interferenza, cedono ai movimenti del gambo, causando assorbimento dell'osso e allentamento. Quanto all'affidabilità e agli esiti della fissazione biologica sarà necessario un lungo periodo di osservazione clinica prima di potersi esprimere con sicurezza. La fissazione a interferenza, o istantanea a pressione, è stata resa possibile dall'introduzione dei componenti femorali ideati da Moore e Thompson, con gambi leggermente più larghi del canale intramidollare fresato, in modo da poter essere pressati o spinti nella loro posizione finale. Lo sviluppo dei gambi femorali modulari, con adattamento indipendente prossimale e distale, ha consentito la fabbricazione intraoperatoria di un impianto su misura.
Di fondamentale importanza, nei sistemi senza cemento, è il concetto di fissazione a riempimento: se la fissazione distale è serrata e quella prossimale è lenta, il segmento prossimale subirà un'atrofia da non uso e conseguentemente osteolisi e riassorbimento osseo (legge di Wolff); se la fissazione prossimale è serrata e quella distale è lenta, si verificherà quel movimento a bascula della parte distale del gambo che è stato ritenuto una possibile causa del dolore alla faccia anteriore della coscia presente nel 4-30% dei casi. Anche la fissazione istantanea a pressione è stata migliorata sulla base dei dati ottenuti dall'esperienza, ed è stato così possibile ridurre l'incidenza di fratture intraoperatorie del femore, inizialmente pari a cira il 3% (v. Schwartz e altri, 1989).
I fautori dell'impianto non cementato sostengono, come abbiamo già detto, che la stabilità meccanica primaria seguita dalla osteointegrazione consente il trasferimento dei carichi sull'osso, per cui lo sforzo a cui è sottoposto l'osso ospite è più simile a quello fisiologico ed è minore quello a carico dell'impianto. In teoria, il risultato a lungo termine dovrebbe consistere in una riduzione dei casi di allentamento, in quanto il trasferimento di una tensione più uniforme e fisiologica sposta il logorio a lungo termine sull'osso risparmiando l'impianto e pertanto preservandolo. La capacità di osteointegrazione è accresciuta dall'assenza di micromovimenti all'interfaccia. L'impiego di questi componenti, che rende necessaria la rigida osservazione di prolungati periodi di deambulazione assistita, è comunque destinato ai pazienti capaci di rispettare rigorosamente le restrizioni post-operatorie loro prescritte. Altre controindicazioni all'impianto senza cemento sono la presenza di affezioni metaboliche croniche dell'osso, marcata osteoporosi, ossa corticali sottili, scarsa capacità osteogenetica e, nei pazienti più anziani, la ridotta speranza di vita.
I risultati a lungo termine dei sistemi non cementati, di particolare interesse per i pazienti più giovani, sono a tutt'oggi ignoti. I sistemi non cementati sono tecnicamente difficili e il loro successo dipende da diverse variabili. L'aumentata incidenza di dolore alla faccia anteriore della coscia riscontrabile dopo l'inserzione del gambo femorale è stata attribuita sia alla dimensione del componente femorale - che, essendo inferiore al normale, causa micromovimenti - sia alla diversa rigidità del gambo protesico e dell'osso ospite. Questa complicanza, che sembra peraltro diminuire col tempo, costituisce comunque un problema.
Le protesi interamente rivestite di materiale poroso sono in grado di favorire la crescita ossea, ma provocano vaste aree di osteolisi nella parte prossimale del femore. La valutazione dei risultati - dopo un periodo di 3-9 anni - ottenuti impiegando gambi interamente rivestiti ha evidenziato la perdita dello sperone osseo femorale e la frattura dei due trocanteri, attribuite all'osteoporosi secondaria da non uso. Tali osservazioni hanno permesso di progettare modifiche di cui discuteremo più avanti.
L'entusiasmo con cui è stata accolta l'introduzione dei componenti non cementati è stato mitigato dai diversi problemi che essa ha posto e dai risultati ottenuti, che sono ancora lontani da quelli raggiunti dalle nuove tecniche di cementazione. Riguardo alla componente acetabolare, si ottiene una eccellente crescita ossea facendo passare delle viti attraverso la cavità emisferica. Queste osservazioni hanno fatto nascere l'idea di una artroprotesi totale ibrida dell'anca, i cui risultati nelle valutazioni a cinque anni e mezzo sono apparsi eccellenti e - come sembra indicare uno studio comparativo, anche se limitato - superiori a quelli ottenuti con artroprotesi totale non cementata (v. Maloney e Harris, 1990).
4. Struttura della protesi
a) Componente femorale.
Le modifiche del modello dell'impianto succedutesi nel tempo sono state la conseguenza dei precedenti insuccessi, oppure sono state studiate teoricamente in laboratorio e poi applicate a determinate condizioni cliniche. Il successo di molte idee è basato su considerazioni teoriche, mentre altre idee innovative, come la modularità dei componenti, si fondano sul buon senso. È comunque essenziale integrare le innovazioni create in laboratorio con l'esperienza clinica, dato che le prove di laboratorio in vitro degli impianti metallici simulano solo le forze statiche che agiscono sull'impianto, mentre quelle che agiscono in vivo sono invariabilmente dinamiche e multiplanari.
I primi insuccessi dell'impianto del gambo femorale portarono a modificarne il modello e le tecniche di fissazione. Il minuzioso esame dei materiali utilizzati fece ritenere che la frattura del gambo potesse essere correlata all'impiego dell'acciaio inossidabile. Fu allora modificata la configurazione della sezione trasversale del femore, per compensare le tensioni connesse al momento flettente attraverso il gambo. Fu anche dimostrato che un gambo più lungo, con un alto modulo di elasticità, è in grado di diminuire le tensioni sul cemento (v. Crowninshield e altri, An analysis..., 1980).
Le forze che agiscono sul gambo femorale dipendono dall'ampiezza dell'angolo del collo stesso. Aumentando l'angolo tra fusto e collo diminuisce sia il momento nel punto di giunzione fusto-collo sia il momento degli abduttori, mentre una diminuzione di tale angolo sposta efficacemente il trocantere in senso laterale; ciò fa aumentare il momento degli abduttori e crea una maggior potenza di abduzione, ma determina al contempo un incremento delle forze di reazione dell'articolazione che può predisporre all'allentamento dell'impianto. Dato che modificare la biomeccanica dell'articolazione dell'anca è rischioso, si preferisce, se possibile, il posizionamento anatomico: la ricostituzione del centro dell'articolazione evita le possibili complicanze conseguenti ad alterazioni della sua meccanica.
Le modifiche apportate al modello della testa e del collo femorali si devono in gran parte ai suggerimenti dati da vari autori. La scelta delle dimensioni della testa è basata su valutazioni teoriche della stabilità dell'articolazione e di un aumento del momento di attrito. Le dimensioni maggiori di una testa, in teoria, determinano una maggiore stabilità dell'articolazione e un aumento del momento di attrito, ma anche un momento di attrito maggiore all'interfaccia osso-cemento dell'acetabolo. Le migliori caratteristiche di usura lineare e volumetrica, determinate sulla base di misurazioni radiografiche a lungo termine, si ottengono con l'uso di una testa femorale protesica di misura intermedia, ad esempio 28 mm (v. Livermore e altri, 1990). Le modifiche della dimensione e della forma del collo hanno determinato un notevole aumento dell'ampiezza del movimento ottenuta con la sostituzione totale dell'anca. L'impiego di colli ovali o trapezoidali ha drasticamente ridotto l'urto del collo sul margine della coppa acetabolare, ed è stato dimostrato che il movimento dell'anca è tanto più agevole quanto più elevato è il rapporto tra i diametri della testa e del collo.
La resistenza all'usura del sistema dipende dal materiale scelto per la costruzione della testa: secondo alcuni dati, l'inserimento in una cavità acetabolare in polietilene di una testa in ceramica di ossido di alluminio invece che metallica ridurrebbe il tasso di usura del 75%; ciò nonostante, l'uso di questo tipo di testa è stato messo in discussione - oltre che dal fatto che si sono verificati casi di frattura - anche dalla recente introduzione del processo di innesto ionico, che pare in grado di accrescere la durata delle protesi in lega di titanio (v. Zimmer, 1990).
Un fattore importante nella scelta del componente femorale è quello relativo all'inclusione o esclusione del colletto. Un componente senza colletto penetra in basso finché raggiunge una posizione stabile, mentre una protesi con colletto si arresta sullo sperone femorale; tuttavia, se l'area di contatto è troppo piccola può sopravvenire una necrosi locale con riassorbimento dell'osso e allentamento. Il colletto, in teoria, impedisce che il componente femorale, qualora non sia completamente assestato nel canale midollare, si abbassi fino a raggiungere una posizione stabile nella parte prossimale del femore. Nel caso di una protesi con colletto, è possibile prevedere un riassorbimento dello sperone osseo femorale di circa 2-5 mm dopo un intervento di artroprotesi cementata: non è chiaro se si tratti di un fenomeno di necrosi focale dovuto a ischemia o di atrofia da non uso; nondimeno, ciò non sembra essere causa di allentamento del gambo femorale. Il componente munito di colletto deve essere alloggiato con precisione, il gambo va fissato fermamente nel canale intramidollare, così da stabilire esattamente il livello del colletto e l'opportuna lunghezza del collo; in tal modo si otterrà una combinazione di tensioni tangenti dovute alla solida fissazione del componente prossimale e di tensioni compressive dovute al colletto. La presenza del colletto dovrebbe evitare che eventuali frammenti possano arrivare al collo; inoltre, se il colletto è collocato in posizione mediale non ostacola l'accesso anteroposteriore al gambo qualora questo dovesse essere rimosso.
L'introduzione di un gambo femorale dritto in un femore ricurvo può rendere necessari tre punti di fissazione; la concentrazione di tensioni prodotta può generare un osso ipertrofico con atrofia da non uso prossimale o addirittura necrosi dell'osso adiacente con osteolisi. Questi riscontri determinarono lo sviluppo delle protesi a curva singola o doppia che sono più simili all'anatomia della parte prossimale del femore. Inizialmente, gli impianti femorali non cementati si reggono solo sulla stretta giustapposizione tra protesi e corpo femorale; è pertanto fondamentale evitare di sottoporre qualsiasi punto a eccessiva tensione, così da aumentare la probabilità di una stabilità a lungo termine. Un gambo femorale ricurvo si adatta alla curvatura del canale midollare nel piano laterale e consente che la tensione venga trasferita nel modo più uniforme verso l'osso (v. Callaghan e altri, 1992). In un sistema senza cemento si ottiene una buona fissazione istantanea a pressione se il gambo femorale, dritto o curvo, si trova a stretto contatto con tutta la superficie corticale endostale a livello dell'istmo. Gli studi iniziali sui gambi femorali non cementati hanno portato a concludere che la corretta scelta delle dimensioni dell'impianto rappresenta l'elemento più importante per assicurare il buon risultato a lungo termine (v. Engh e altri, 1987).
I modelli in grado di trasferire maggior carico sulla parte prossimale del femore sono preferibili perché evitano l'atrofia ossea da non uso, fornendo uno stimolo fisiologico per mantenere la densità e la solidità dell'osso (legge di Wolff).
Sono state condotte numerose esperienze e osservazioni sull'atrofia da non uso negli impianti parzialmente (zona prossimale o distale) o totalmente rivestiti da materiale poroso. Gli impianti totalmente rivestiti favoriscono la crescita ossea ma determinano atrofia da non uso della parte prossimale del femore e possono causare perdita dello sperone femorale e frattura dei due trocanteri dovute a osteoporosi (v. Brown e Ring, 1985), mentre gli impianti con rivestimento nella zona distale causano atrofia prossimale dovuta alla fissazione distale. Gli impianti con rivestimento applicato alla sola parte prossimale del gambo femorale sono risultati fisiologicamente preferibili e hanno ottenuto ampi consensi. È chiaro che il tipo di materiale poroso e il metodo di fissazione hanno importanza cruciale per la sopravvivenza dell'impianto.
L'uso del ‛rivestimento poroso' - un'espressione generica con cui si indicano materiali diversi, come polimeri, ceramica e metalli - è volto a migliorare i risultati ottenuti negli impianti con cemento. Per quanto riguarda i metalli porosi, l'interesse è concentrato principalmente sul confronto tra il processo di sinterizzazione di polvere o sfere di cromo-cobalto e la saldatura a diffusione della maglia di filo di titanio. I gambi in cromo-cobalto presentano, rispetto a quelli in titanio, una maggiore rigidità strutturale, ma la sinterizzazione può indebolire il gambo e compromettere la durata a lungo termine dell'impianto. La saldatura a diffusione, impiegata per applicare la maglia di titanio, non è un processo altrettanto termodipendente quanto la sinterizzazione, e ciò riduce il pericolo di indebolimento del gambo. La dimensione dei pori, che ha fondamentale importanza per la crescita ossea, può essere controllata al momento della fabbricazione del materiale. Tuttavia, l'applicazione del rivestimento poroso può indebolire il gambo femorale e ridurre la durata e la resistenza alla fatica dell'impianto.
Le reazioni osteolitiche nella parte prossimale del femore, già osservate negli impianti cementati, cominciano a essere riscontrate anche in quelli non cementati e sono attribuite alla presenza di frammenti di metallo e polietilene: pertanto, non è più possibile considerare l'osteolisi come una ‛malattia da cemento'. Bisogna inoltre controllare attentamente i possibili effetti carcinogenetici a lungo termine di metalli, plastica o cemento.
b) Componente acetabolare.
Le modifiche apportate al modello del componente acetabolare sono basate sulle originarie esperienze di Charnley, il quale aveva osservato non solo che i componenti di teflon (PTFE) e cemento acrilico erano soggetti a un'usura inaccettabile, ma che l'uso di tali materiali si associava spesso a un ‟quadro clinico decisamente simile a quello di un'infezione", sebbene ‟il materiale patologico fosse ripetutamente risultato sterile" (v. Charnley, 1979). Possiamo ritenere che queste osservazioni corrispondano al quadro anatomopatologico oggi noto come osteolisi.
È probabile che a determinare l'aumentata longevità degli impianti abbia contribuito in più larga misura lo spessore del polietilene ad alta densità che le piccole dimensioni delle teste femorali. Nell'evoluzione dell'intervento di sostituzione totale dell'anca, una tra le principali preoccupazioni è stata l'eccessivo logorio del polietilene del componente acetabolare, intuitivamente ritenuto un fattore fondamentale per la longevità dell'impianto; si dimostrò che il minor tasso di usura di tale componente si ottiene combinando vari fattori: maggior spessore della coppa acetabolare, adeguata copertura ossea, angolazione della coppa minore di 40°, più basso livello di attività e testa femorale in ceramica (v. Livermore e altri, 1990).
Le considerazioni relative al modello dell'acetabolo riguardano le proprietà dei materiali e la geometria della cavità. Il fatto che una cavità rigida abbia dimostrato di trasmettere le tensioni in modo più uniforme e il problema dell'usura del polietilene hanno portato a ideare componenti in polietilene rinforzati con metallo. È stato verificato che con tali componenti si ottiene una migliore distribuzione del carico, riducendo la possibilità che il peso si concentri su piccole aree e producendo minori tensioni a carico del cemento, dell'osso e del polietilene (v. Crowninshield e altri, 1983). Il modello iniziale di coppa rinforzata con metallo, concepito per permettere l'eventuale sostituzione del rivestimento in polietilene senza intaccare il cemento, è stato da allora universalmente accettato quale mezzo per diminuire le tensioni massime all'interfaccia osso-cemento. Tuttavia si è poi riscontrato non solo che l'usura delle coppe interamente in polietilene è tutto sommato inferiore al previsto (meno di 1 mm l'anno), ma anche che vi è un significativo aumento della media di insuccessi con l'uso delle coppe rinforzate con metallo, tanto che è stata espressa la convinzione, peraltro non generalmente condivisa, che il rinforzo metallico non sia raccomandabile per un componente acetabolare cementato (v. Ritter e altri, 1990).
La possibilità che il cemento rappresentasse una delle cause di osteolisi acetabolare ha portato a sviluppare componenti acetabolari non cementati. Sono stati elaborati altri metodi di fissazione per sostituire le microconnessioni del cemento tra impianto e interstizi dell'osso circostante. L'impianto non cementato di un componente acetabolare in due pezzi rinforzato con metallo e rivestito da materiale poroso o bioattivo può essere migliorato aumentando la stabilità meccanica con l'impiego di viti, perni o cotili avvitati, il cui rivestimento poroso, però, può creare aree di concentrazione di tensione, danneggiando l'impianto. Il metodo di fissazione con interferenza è stato sviluppato al fine di perfezionare la stabilità iniziale; ove questo non sia possibile può risultare necessario un piccolo alesaggio acetabolare (1-4 mm), seguito da fissazione istantanea a pressione del componente, che all'occorrenza può essere integrata da una vite.
Le modifiche apportate al modello della coppa in polietilene, come l'introduzione di margini smussati e minore profondità della cavità, hanno ridotto lo sfregamento del collo sul bordo della coppa, consentendo movimenti più ampi. Alcuni modelli a margini smussati hanno tuttavia mostrato una più elevata incidenza di lussazione (v. Brien e altri, 1993).
5. Tecniche chirurgiche
a) Vie di accesso.
La scelta della via di accesso nella chirurgia dell'anca è in larga misura una questione di preferenze personali. Statisticamente, tra le diverse vie di accesso esistono poche differenze significative, tranne forse un lieve aumento di incidenza delle lussazioni post-operatorie nel caso di accesso posteriore (v. Woo e Morrey, 1982). È generalmente noto che il rischio di complicazioni post-operatorie aumenta quando un chirurgo comincia a usare una tecnica che non gli è familiare. Le vie di accesso comunemente seguite per l'artroprotesi totale dell'anca sono tre: la transtrocanterica, la anterolaterale, la posterolaterale.
La via transtrocanterica, seguita abitualmente da Charnley, oggi è meno frequentemente utilizzata a causa dei problemi inerenti la migrazione prossimale, la mancata giunzione trocanterica, la borsite trocanterica e la più lunga durata dell'intervento. Attualmente, viene usata nel caso di lussazioni congenite dell'anca, per la demolizione di anchilosi ossee, per gravi deformità anatomiche e in circa metà dei casi in cui è necessaria una revisione dell'anca.
La via anterolaterale viene seguita preferenzialmente nel caso di pazienti non in grado di cooperare, per i quali esiste un elevato rischio di lussazione.
La via posterolaterale, o per divisione del gluteo, consente una comoda esposizione, una minima distensione delle fibre muscolari e una migliore visualizzazione. L'intervento, che può essere eseguito in anestesia epidurale o generale, consiste essenzialmente nei seguenti tempi: accesso all'articolazione; esposizione, liberazione e apertura della capsula articolare; lussazione dell'anca in flessione, adduzione e rotazione interna; resezione della testa femorale; esposizione e alesaggio della cavità acetabolare; fresatura e pulizia del canale midollare femorale; adattamento dei componenti protesici. Nel caso di una protrusione intrapelvica dell'acetabolo, può rendersi necessario resecare il collo femorale prima di operare la dislocazione, oppure applicare al femore una trazione laterale al fine di ottenere una buona esposizione dell'anca.
b) Osteotomia trocanterica.
Al momento dell'intervento è di fondamentale importanza decidere se eseguire o meno l'osteotomia trocanterica, considerandone vantaggi e svantaggi: tra i primi ricordiamo la migliore esposizione di femore e acetabolo, la possibilità di intervenire sul momento del meccanismo abduttore, di adattare la tensione dei tessuti molli in tutta l'anca e di operare una capsulectomia più completa. Gli svantaggi sono rappresentati da: aumentata disposizione alla lussazione; accentuato traumatismo dei tessuti molli, che si ritiene responsabile dell'aumento di incidenza delle calcificazioni eterotopiche; maggiore durata dell'intervento, che può causare più abbondante perdita di sangue e facilitare la formazione di ematomi post-operatori; maggiori rischi di distacco o di mancata giunzione (v. Johnston e Crowninshield, 1983); possibilità di lussazioni dopo l'avulsione trocanterica (circa 18% dei casi; v. Woo e Morrey, 1982); possibile comparsa di sintomatologia dolorosa e borsite, che può ritardare la riabilitazione. L'osteotomia trocanterica dovrebbe essere limitata ai casi di anatomia gravemente alterata o di difficile esposizione chirurgica dell'articolazione, come la demolizione di una anchilosi ossea o una complessa revisione di protesi. Essa si rende inoltre frequentemente necessaria nelle situazioni caratterizzate da allungamento o accorciamento del meccanismo abduttore.
c) Adattamento dei componenti protesici.
Per adattare in posizione corretta i componenti protesici onde evitare sollecitazioni abnormi e lussazioni è necessario valutare attentamente la tensione dei tessuti molli - che è controllata dalla posizione dell'acetabolo -, la lunghezza del collo protesico, il livello dell'osteotomia del collo femorale, il livello della ricongiunzione trocanterica e la tensione capsulare.
Al fine di assicurare una corretta distribuzione delle sollecitazioni e di evitare lesioni dei componenti protesici o alterazioni dei segmenti ossei che debbono accoglierli, è indispensabile orientare il gambo femorale in posizione neutra o valga e la coppa acetabolare in senso inferiore, mediale e anteriore.
Prima dell'operazione è di fondamentale importanza preparare una riproduzione su trasparente della radiografia del paziente al fine di identificare quali componenti siano più adatti alle necessità dei pazienti, soprattutto negli impianti senza cemento nei quali si deve ottenere un bloccaggio serrato senza ledere la corteccia ossea.
6. Indicazioni
a) Indicazioni e controindicazioni generali.
La principale indicazione per la sostituzione totale dell'anca è sempre stata quella di alleviare il dolore debilitante e consentire una soddisfacente funzionalità dell'articolazione. Come regola generale, prima di decidere l'esecuzione dell'intervento debbono quindi essere attentamente valutati l'intensità del dolore e il grado di invalidità, ed è doveroso tentare tutti i rimedi non chirurgici (perdita di peso corporeo, somministrazione di antinfiammatori non steroidei, limitazione dell'attività, uso del bastone, ecc.). Ormai l'età, il sesso, la bilateralità dell'artropatia non rappresentano limitazioni all'esecuzione dell'intervento. L'artroprotesi totale dell'anca è indicata in quelle malattie degenerative e infiammatorie dell'articolazione che ne compromettono seriamente la normale funzione, nelle necrosi ischemiche della testa femorale, nelle fratture non consolidate della testa del femore. Le condizioni cliniche più comuni sono quindi rappresentate da artrosi primaria e secondaria, vecchie fratture, lussazioni, alterazioni prodottesi in età pediatrica come l'epifisiolisi prossimale del femore, l'artrite reumatoide e altre artropatie infiammatorie. Nei pazienti affetti da quest'ultimo gruppo di malattie (artrite reumatoide, artropatia psoriasica, lupus eritematoso sistemico), relativamente inattivi e meno esigenti, si ottengono generalmente migliori risultati, malgrado l'incidenza di una serie di elementi sfavorevoli, quali lo stato di debilitazione, la dipendenza dai cortisonici e l'osteoporosi che questi ultimi determinano - unitamente all'inattività -, la stentata crescita ossea e l'aumentato rischio di infezione. In tali casi, inoltre, vi è un maggior rischio di fratture femorali e acetabolari, e pelle e tessuti molli sono difficilmente trattabili.
In caso di bilateralità dell'affezione, l'artroprotesi totale dell'anca può essere eseguita in un solo tempo o in due tempi (v. Salvati e altri, 1978). La sostituzione bilaterale in un unico tempo è indicata per i pazienti con deformità in flessione bilaterale delle anche: la frequenza di complicanze post-operatorie non è maggiore in questo caso (v. Ritter e Stringer, 1980) che nell'intervento in due tempi, in seguito al quale vi è un notevole ritardo nella riabilitazione per la residua deformità in flessione dell'anca controlaterale.
Per quanto riguarda le controindicazioni, queste sono essenzialmente rappresentate da alcune condizioni ben definite: anzitutto una storia di infezione attiva, con dolore, arrossamento, tumefazione e possibile presenza di un tramite fistoloso; quindi, immaturità dello scheletro, debilitazione generale, artropatie neurogene, osteopenia progressiva e malattie neurologiche progressive caratterizzate da disturbi della percezione e da deficit muscolari.
b) Necrosi ischemica della testa femorale.
La necrosi ischemica della testa femorale, sia conseguente a trauma sia idiopatica, si riscontra abitualmente in soggetti giovani e in piena attività, che sono quindi più esigenti nei riguardi della durata dei componenti protesici.
La necrosi ischemica rappresenta, insieme alla frattura non consolidata del collo del femore, sempre in assenza di fenomeni degenerativi a carico dell'acetabolo, l'indicazione primaria per la sostituzione endoprotesica della sola parte prossimale del femore (v. Cabanela e VanDemark, 1984; v. Bateman e altri, 1990). Nelle necrosi idiopatiche, frequentemente bilaterali e tendenti all'anchilosi, devono essere attentamente ricercati e trattati i possibili fattori eziopatogenetici di base, quali alcolismo, uso di cortisonici, anomalie ematologiche (anemia drepanocitica). Nelle necrosi da trauma, l'intervento è generalmente differito fino a quando la conseguente artrosi secondaria non divenga causa di dolore debilitante.
c) Spondilite anchilosante.
Nella spondilite anchilosante, una artropatia infiammatoria deformante che colpisce tipicamente giovani uomini al di sotto dei 30 anni, si osserva un progressivo coinvolgimento bilaterale dell'anca, radiologicamente caratterizzato da condrolisi, anchilosi e tendenza alla protrusione acetabolare con deficiente massa ossea. Sono spesso presenti alterazioni extra-articolari, come difetti di conduzione cardiaca e insufficienza della valvola aortica, e compromissione dell'apparato respiratorio, clinicamente rilevabile dalla diminuita escursione toracica durante l'inspirazione. In presenza di anchilosi della colonna cervicale è consigliabile una tracheotomia preoperatoria. Le deficienze acetabolari debbono essere corrette durante l'intervento mediante innesti ossei o con manovre antiprotrusione.
Malgrado la scarsa resistenza dell'osso, che fa aumentare il rischio di penetrazione nella corteccia, i risultati funzionali dell'artroprotesi nel trattamento di questa affezione sono buoni: si ottiene un sollievo pressoché completo dal dolore e una buona motilità anche nei soggetti con anchilosi. Particolarmente importante per i pazienti più giovani è il carattere di lunga durata dei risultati ottenuti (v. Kilgus e altri, 1990).
L'incidenza di ossificazione eterotopica post-operatoria nella spondilite anchilosante, che è stata posta in relazione a precedenti interventi sull'anca e ad anchilosi totale, consiglia l'adozione di misure profilattiche in caso di precedenti ossificazioni eterotopiche, di artroprotesi dell'anca controlaterale o di reintervento sulla stessa anca (v. Bisla e altri, 1976; v. Kilgus e altri, 1990).
d) Malattia di Paget.
La malattia di Paget delle ossa è un'osteite deformante poliostotica la cui diagnosi è basata sul caratteristico quadro radiologico e sugli elevati livelli della fosfatasi alcalina ematica e dell'idrossiprolina urinaria. In questa malattia l'interessamento dell'anca può essere tale da richiedere l'esecuzione di osteotomie multiple prima di effettuare l'artroprotesi totale; aumentano in questo caso i rischi di una più abbondante perdita di sangue e di ossificazione eterotopica. Prima dell'intervento è comunque opportuno effettuare cicli di terapia con calcitonina o bifosfonati.
e) Anchilosi ossea.
Il procedimento per risolvere un'anchilosi ossea tramite artroprotesi totale è complesso (v. Amstutz e Sakai, 1975). L'intervento viene preso in considerazione quando il paziente, data l'età avanzata, ha ormai diminuito il livello della sua attività e pertanto il rischio di insuccesso è minore. I risultati dell'intervento sono simili a quelli che si ottengono nei pazienti con artrosi. I rischi di insuccesso sono significativamente più elevati nel caso di pazienti portatori di anchilosi ossea chirurgica (artrodesi) e di età inferiore ai 50 anni, o che abbiano subito in precedenza più di due operazioni all'anca compromessa (v. Strathy e Fitzgerald, 1988). In ogni caso prima dell'intervento occorre valutare attentamente la possibilità che vi siano alterazioni anatomiche femorali, specialmente nel caso in cui l'osteotomia femorale sia stata eseguita prima dello stabilirsi dell'anchilosi ossea.
f) Lussazione congenita dell'anca.
I progressi registrati nei modelli e nei componenti protesici, oltre che nelle tecniche cementanti, hanno consentito di estendere le indicazioni dell'artroprotesi totale all'artrosi secondaria alla lussazione congenita dell'anca. L'intervento è indicato solo quando il dolore causato dalla lesione è debilitante, e deve essere preceduto da un'accurata valutazione delle alterazioni anatomiche: spesso, infatti, la testa del femore è ipoplasica e deformata, con collo accorciato e anteverso. L'opportunità di effettuare una osteotomia trocanterica, una sistemazione anatomica dell'acetabolo e, in alcuni casi, un innesto osseo per la copertura acetabolare e la parete acetabolare mediale è stata confermata da anni di esperienze (v. Garvin e altri, 1991). Ciò che è attualmente oggetto di discussione è il collocamento del componente acetabolare: secondo alcuni va posto in posizione più prossimale, ma non più laterale (dislocamento isolato prossimale), in modo che l'osso ospite possa sostenerne la parte più cospicua (v. Russotti e Harris, 1991); altri autori, dato che l'osso con il massimo spessore disponibile si trova nel vero acetabolo, a meno che la parete superiore non sia stata consumata dal logorio, suggeriscono di scavarlo opportunamente per sistemarvi la coppa, aumentandone il supporto osseo con innesto di osso; in questo modo l'arto risulta relativamente allungato, tanto da rendere talvolta necessaria la risoluzione della contrattura di tutti i tessuti molli, effettuando la tenotomia, la fasciotomia e la capsulectomia. Per conservare le inserzioni del meccanismo abduttore può essere necessario eseguire un taglio a gradino del collo femorale.
Se la copertura ossea del componente acetabolare è inferiore al 75%, può essere necessario un innesto osseo supplementare, oppure un innesto autogeno della testa femorale (v. Harris, 1982): quest'ultimo metodo sembra seguito da successo entro i 7 anni dall'intervento, ma a 12 anni si osserva un'incidenza del 47% di allentamento del componente acetabolare, così che è attualmente raccomandato solo nelle situazioni di estrema deficienza di massa ossea acetabolare (v. Mulroy e Harris, Failure of..., 1990; v. Kwong e altri, 1993). Tuttavia, le tecniche oggi comunemente impiegate, basate sull'uso di microcomponenti, consentono una buona copertura ossea anche in situazioni di massa ossea deficitaria (v. Garvin e altri, 1991).
7. Complicazioni
L'intervento di artroprotesi totale dell'anca può essere seguito da serie complicazioni, ma solo nell'1% dei casi mortali; la prevenzione di queste ultime, dovute principalmente a tromboembolia e, in misura nettamente inferiore, a infarto del miocardio e insufficienza congestizia di cuore, è stata oggetto di numerosi studi, come risulta dalla letteratura ortopedica corrente.
Tra le complicanze non mortali, le più frequenti sono l'allentamento asettico e l'osteolisi, mentre più raramente si osservano processi infettivi, ossificazione eterotopica, mancata giunzione trocanterica e lussazione, lesioni neurologiche e vascolari, fratture del femore e dell'acetabolo, rottura del gambo.
a) Tromboembolia.
La tromboembolia è la complicazione dell'artroprotesi totale dell'anca più frequente ed è la principale causa della mortalità post-operatoria; l'embolo che occlude l'arteria polmonare, costituito da un trombo rosso che si mobilizza dalle vene profonde delle gambe, può risultare fatale nell'1-2% dei casi se non si è provveduto a un'adeguata profilassi.
Le trombosi venose profonde - che si verificano con maggior frequenza nel quarto giorno dopo l'operazione e la cui incidenza può raggiungere il 70% dei casi (v. Sharrock e altri, 1990; v. Sikorski e altri, 1981) - si originano probabilmente nel corso dell'intervento a causa dell'intensa attivazione del sistema di coagulazione del sangue determinata dalla lesione vasale e dalla stasi nella vena femorale. I sintomi classici dell'embolia dell'arteria polmonare (insufficienza respiratoria, violento dolore toracico puntorio, stato ansioso) non sono sempre presenti e possono essere assenti non solo febbricola, stanchezza, tachicardia e sudorazione, ma anche il dolore al polpaccio provocato dalla flessione dorsale del piede sulla gamba (segno di Homan), indicativo dell'esistenza di trombosi venosa profonda. Con una radiografia del torace, seguita, se negativa, da uno studio scintigrafico della funzione respiratoria, è possibile mettere in evidenza la maggior parte degli emboli polmonari, mentre l'esame elettrocardiografico può riuscire utile per escludere eventuali cause cardiologiche responsabili della sintomatologia presentata dal paziente. Il principale mezzo per la diagnosi di embolia polmonare rimane ancora l'angiocardiografia dell'arteria polmonare.
I provvedimenti terapeutici debbono essere adottati immediatamente e comprendono l'ossigenoterapia e la somministrazione di farmaci betabloccanti antipertensivi, nonché il trattamento anticoagulante terapeutico (non profilattico). Se si sviluppano emboli polmonari supplementari malgrado il trattamento anticoagulante, o se questo non è tollerato dal paziente, può esser necessario l'uso di un filtro Greenfield, che si è dimostrato un metodo sicuro, facile ed efficace per la prevenzione dell'embolia polmonare mortale sia nei pazienti a rischio eccezionalmente elevato di tromboembolia, sia in quelli con una tromboembolia documentata per i quali è controindicato il trattamento anticoagulante, sia, infine, in quelli con complicazioni secondarie a trattamento anticoagulante (v. Vaughn e altri, 1989).
È stato dimostrato che il rischio di complicazioni emorragiche post-operatorie, secondarie a somministrazione di eparina per via endovenosa nei primi sei giorni dopo l'intervento, è molto alto, raggiungendo il 45% dei casi (v. Patterson e altri, 1989). È quindi opportuno cercare di prevenire l'insorgenza di tromboembolia; come misure profilattiche sono stati impiegati vari mezzi oltre a quelli farmacologici, come l'uso di calze e calzature speciali e la mobilizzazione precoce del paziente. Per diagnosticare la presenza di trombosi ed embolie sono disponibili sofisticate procedure pre- e post-operatorie, quali eco-Doppler, venografia, pletismografia a impedenza, scintigrafia polmonare, studio scintigrafico del fibrinogeno marcato con iodio radioattivo.
b) Allentamento asettico.
Con la disponibilità di componenti più resistenti è diminuita l'incidenza delle fratture del gambo ed è aumentata quella dell'allentamento asettico, che è divenuta la più frequente complicanza a lungo termine dell'artroprotesi totale dell'anca. È stato dimostrato che l'allentamento da osteolisi dipende sostanzialmente dalla tecnica di cementazione, dalla preparazione delle superfici ossee e dalla collocazione dei componenti.
Il primo segno clinico dell'allentamento asettico è costituito dal dolore nella fase iniziale del carico, alleviato dal riposo. L'allentamento di un componente può essere messo in evidenza dalla minuziosa osservazione di radiografie seriate. La ricerca batteriologica sul materiale aspirato dall'articolazione, associata a un'artrografia eseguita con la tecnica della sottrazione delle immagini (v. Salvati e altri, 1974), può aiutare a definire le aree di allentamento e a scoprire un'infezione non manifesta. La somministrazione di un anestetico locale dopo artrografia può costituire un sussidio diagnostico e terapeutico per l'allentamento di un componente. L'importanza delle radiografie seriate per la ricerca di un allentamento asettico non può comunque essere sopravvalutata, anche se l'evidenziazione di distruzione ossea, di migrazione dei componenti, di rottura del cemento, di una radiotrasparenza a livello osso-cemento di 2 o più mm o di qualsiasi radiotrasparenza a livello protesi-cemento indica con molta probabilità l'esistenza di un allentamento. Sono stati descritti tre livelli di allentamento (v. Harris e altri, 1982): 1) definito, consistente nella migrazione del componente o del cemento; 2) probabile, costituito dal 100% di radiotrasparenza attorno al manto cementizio; 3) possibile, consistente in una zona di radiotrasparenza circostante il manto cementizio inferiore al 100% ma maggiore del 50%.
L'allentamento della coppa è meno frequente di quello del gambo femorale, dato che l'acetabolo non è soggetto a forze di rotazione e di torsione (come il gambo femorale), ma principalmente a forze compressive. Le principali cause di allentamento in un impianto cementato sono una massa ossea inadeguata, tecniche cementanti inefficienti, instabilità, posizionamento verticale ed errori tecnici. L'allentamento della coppa è stato anche messo in relazione al logorio a livello acetabolare, che predispone al collasso da carico, e agli effetti osteolitici di frammenti di un corpo mobile che con l'andar del tempo possono formarsi nei componenti acetabolari cementati (v. Schmalzried e Harris, 1992).
L'allentamento asettico del gambo costituisce attualmente la più comune indicazione alla revisione dell'impianto. Grazie all'efficacia biomeccanica delle moderne protesi, la durata del gambo femorale generalmente sopravanza la speranza di vita dei pazienti, ma il suo allentamento asettico può verificarsi qualora non sia fissato in maniera corretta, a prescindere dalla tecnica adottata, con o senza cemento. Nei sistemi senza cemento può verificarsi allentamento asettico qualora i componenti femorali con rivestimento poroso e adattati con fissazione istantanea a pressione risultino sottodimensionati (v. Malchou e altri, 1988). La vera osteolisi è un fenomeno tardivo che si verifica come reazione alla presenza di frammenti (metallici, cementizi, plastici) in tutte le zone accessibili al liquido sinoviale, e quindi ai detriti particolati (v. Schmalzried e Harris, 1992).
c) Infezione.
Tra le complicanze non mortali della sostituzione totale dell'anca nessuna può essere più devastante di un processo infettivo. L'incidenza di fenomeni settici, che nelle prime artroprotesi cementate raggiungeva l'11%, è diminuita grazie all'identificazione dei fattori di rischio e allo sviluppo di adeguate misure profilattiche. È stato dimostrato che il rischio di infezioni profonde aumenta per preesistenti condizioni patologiche del paziente (v. Harkess, 19928), quali artrite reumatoide (1,2%), artropatia psoriasica (5,5%), diabete mellito (5,6%), e nei pazienti maschi nei quali si renda necessario un cateterismo uretrale post-operatorio (6,2%).
La profilassi antisettica inizia con l'identificazione dei microrganismi: Staphylococcus aureus coagulasi-positivo è la più comune causa di infezione acuta post-operatoria, mentre S. epidermidus e S. albus sono ordinariamente causa di infezioni tardive. Poiché questi agenti si annidano abitualmente sulla pelle, è necessario instaurare una efficace profilassi antibiotica in grado di garantire un'elevata concentrazione tessutale di antibiotico - in genere cefalosporine di prima generazione - al momento dell'incisione cutanea, che rappresenta il momento più critico per il rischio di contaminazione. È ovviamente indispensabile la rigorosa osservanza della più assoluta asepsi nel corso dell'intervento, sia per quanto riguarda i chirurghi e i locali nei quali operano, sia per ciò che si riferisce alla corretta esecuzione delle tecniche operatorie. L'introduzione di una piccola dose di antibiotico (tobramicina) nel cemento si è rivelata in grado di assicurare elevati livelli di concentrazione locale di antibiotico senza alterare in modo significativo il substrato meccanico del cemento stesso, consentendo altresì di diminuirne la concentrazione sistemica; tuttavia, va sempre tenuto presente che anche basse concentrazioni di antibiotico per via sistemica possono determinare reazioni tossiche. La profilassi antibiotica è comunque indispensabile, specie per prevenire possibili infezioni post-operatorie a carico dell'apparato urinario - che si manifestano nel 7-14% dei casi senza che vi sia alcuna relazione con i microrganismi responsabili delle infezioni osteoarticolari - e infezioni ematogene tardive conseguenti a interventi odontoiatrici, ginecologici, urologici o gastroenterici.
La comparsa di un inspiegabile dolore post-operatorio o l'allentamento di un componente deve far sospettare un processo infettivo: la conferma diagnostica è fornita dall'esame clinico e radiologico e dalle indagini di laboratorio. I reperti radiologici che possono far presupporre un processo infettivo sono bordi endostali irregolari o dentellati, neoformazione ossea, tumefazione dei tessuti molli. Una ricerca batteriologica sul materiale aspirato dall'articolazione dovrebbe essere compiuta in ogni paziente per il quale sia stata presa in considerazione la diagnosi di sepsi (v. Barrack e Harris, 1993), anche se un suo esito negativo non esclude definitivamente l'esistenza di un processo infettivo.
Vi sono tre tipi di infezione: acuta post-operatoria, profonda ritardata, ematogena tardiva. I segni dell'infezione acuta post-operatoria comprendono essenzialmente calore, dolorabilità e arrossamento della ferita chirurgica, spesso accompagnati da fuoriuscita di siero. La classica manifestazione di un'infezione profonda ritardata è la presenza di un tragitto fistoloso, con febbre e leucocitosi. Il dolore spontaneo, indipendente dal carico, dovrebbe far pensare alla possibilità di un processo settico profondo, anche se non sempre questo sintomo è presente; sono invece dimostrabili elevati valori di velocità di eritrosedimentazione e di proteina C reattiva. Le indagini scintigrafiche eseguite col tecnezio99 non consentono di distinguere tra allentamento settico e asettico, mentre la scintigrafia con indio dà risultati più precisi anche nel caso di sepsi muscoloscheletriche di lieve entità (v. Merkel e altri, 1985; v. radiologia medica, vol. V).
Il trattamento dell'infezione è basato sull'identificazione del microrganismo che ne è responsabile e della sua sensibilità ai vari antibiotici, sulle difese dell'ospite e sulla fissazione dell'impianto. Ogni infezione superficiale deve essere, il più presto possibile, completamente drenata e accuratamente detersa; se si cerca di mantenere i componenti, può essere usato un sistema di drenaggio chiuso aspirativo. Le infezioni che si manifestano dopo oltre sei mesi dall'intervento richiedono, di frequente, la rimozione dei componenti e di tutto il cemento, cui può seguire, immediatamente o in un secondo tempo, un reimpianto. In queste condizioni è difficile che si verifichi un'anchilosi ossea, perché vi è una riduzione della massa ossea. La possibilità di un reimpianto si basa sulle condizioni fisiologiche e l'età del paziente, sulla sensibilità agli antibiotici e sull'assenza di un processo settico attivo.
d) Ossificazione eterotopica.
L'incidenza di ossificazioni eterotopiche dopo artroprotesi totale dell'anca varia tra 0,6 e 61,7% (v. Ritter e Vaughan, 1977; v. Kilgus e altri, 1990). L'eziologia e la patogenesi di questa complicanza, che può essere di scarsa entità ma arrivare anche alla totale anchilosi ossea tra femore e pelvi, sono ancora oscure. Vi è una probabile correlazione con la durata dell'intervento e la quantità di tessuto molle dissecato, e sembra associata a patologie come spondilite anchilosante, malattia di Forestier e artrosi post-traumatica. Particolarmente a rischio risultano i pazienti maschi con marcata artrosi osteofitica bilaterale (v. Ritter e Vaughan, 1977).
Di solito l'ossificazione eterotopica non causa dolore e raramente richiede la rimozione dell'impianto, poiché la formazione dell'osso ectopico non sembra influire sul risultato funzionale se non si determina un'anchilosi ossea.
Sono state sviluppate varie modalità di trattamento per ridurre l'incidenza dell'ossificazione eterotopica. Negli impianti porosi ogni tentativo di ridurre l'ossificazione eterotopica ostacola l'ossificazione ‛porosa' dei componenti. Il trattamento radiante ha dimostrato di essere di una certa utilità nella prevenzione della complicanza, ma la sua validità è dubbia se l'osso ectopico è già radiograficamente visibile (v. Coventry e Scanlon, 1981). Occorre tuttavia tenere presente che le radiazioni sono potenzialmente cancerogene e possono determinare una riduzione della resistenza degli impianti: è quindi conveniente somministrare le dosi più basse e comunque se gli impianti non sono cementati ma porosi essi devono essere adeguatamente schermati. Tra gli altri mezzi terapeutici impiegati, elevate dosi di indometacina, ibuprofen e aspirina sono risultati in grado di diminuire la crescita ossea in animali da laboratorio con impianti a rivestimento poroso; sperimentalmente, i bifosfonati sono apparsi attivi nell'ostacolare la mineralizzazione dell'osteoide piuttosto che nel prevenire la formazione di osso eterotopico.
e) Mancata giunzione trocanterica e lussazione.
Come abbiamo già accennato (v. sopra, § b), sono spesso maggiori le complicazioni cui l'osteotomia trocanterica dà origine dei vantaggi che essa offre, per cui tale tecnica viene usata solo per la revisione o la ricostruzione di anche displasiche.
La ricongiunzione del trocantere è tecnicamente molto complessa e il suo esito favorevole dipende dalle dimensioni dell'osso e dalla superficie di contatto, dalla adeguata tensione del meccanismo abduttore (10-15° di abduzione) e dalla stabilità dell'impianto. Il successo della ricongiunzione, in definitiva, dipende dalla reazione dell'ospite e dal mantenimento della fissazione. Se lo spostamento di un trocantere non ricongiunto è superiore a 2 cm, il rilassamento dei tessuti molli può contribuire ad aumentare il rischio di lussazione dell'anca (v. Woo e Morrey, 1982).
L'incidenza globale di lussazioni dopo artroprotesi totale dell'anca è stimata intorno al 3% ed è forse un po' maggiore quando viene usata la via di accesso posteriore rispetto alle vie anterolaterale e transtrocanterica. Molti fattori sono stati indicati come responsabili del maggior rischio di lussazione: tra questi, l'accorciamento e la rotazione post-operatoria dell'arto; preesistenti disordini neuromuscolari che causano debolezza e deficit propriocettivi; precedenti interventi chirurgici sull'anca, che sono risultati addirittura in grado di raddoppiare il rischio di lussazioni post-operatorie. Tuttavia, parecchie lussazioni sono dovute a errori tecnici durante l'intervento, in particolare al cattivo posizionamento dei componenti.
Tra le altre cause di lussazione ricordiamo le masse osteofitiche o di cemento, che possono agire da leva e far fuoriuscire la testa dalla coppa, lo sfregamento del trocantere sulla pelvi e quello del collo del femore sulla coppa. Tutti questi fattori vanno individuati al momento dell'intervento e corretti con opportune tecniche chirurgiche o con l'impianto di particolari tipi di componenti, come coppe smussate, colli ovali o trapezoidali.
È assolutamente necessario, a scopo preventivo, un regime post-operatorio di limitazione del moto fintantoché non si sia costituita una pseudocapsula articolare periprotesica. Una lussazione acuta traumatica risponde bene alla riduzione seguita dalla limitazione del moto per alcune settimane, mentre per le lussazioni dolorose ricorrenti è spesso necessaria la revisione dell'artroprotesi.
f) Lesioni neurologiche e vascolari.
La paralisi da lesione di un nervo è certamente una delle complicazioni più preoccupanti della sostituzione totale dell'anca: la sua incidenza varia dallo 0,6 al 3,7%, ma aumenta al 5,2% nei casi di artroprotesi primaria per lussazione congenita o displasia, ed è pari al 3,2% in seguito a revisione (v. Schmalzried e altri, 1991). Le cause sono molteplici e includono il trauma diretto del nervo, la tensione eccessiva conseguente all'allungamento delle estremità, fenomeni ischemici o emorragici, fenomeni compressivi da parte di frammenti di metilmetacrilato estruso, costrizione da parte di un filo metallico trocanterico o di un filo di sutura, lussazione del componente femorale.
Solo nello 0,2-0,3% dei casi si verificano lesioni vascolari. Lesioni delle arterie femorale e otturatoria, associate a lesione dei nervi omonimi, possono prodursi in seguito a rimozione del legamento rotondo della testa femorale e del legamento acetabolare trasverso dalla cavità acetabolare. In caso di protrusione acetabolare, in considerazione del rischio di lesioni ai vasi iliaci comuni è bene procedere, prima dell'operazione, a un'angiografia; le conseguenze di una penetrazione accidentale delle viti acetabolari nel lume di questi importanti vasi intraddominali possono essere catastrofiche. Eleganti studi anatomici hanno permesso di dividere la cavità acetabolare in quattro quadranti, ottenuti tracciando una linea dalla spina iliaca anteriore-superiore alla fovea posteriore e la sua normale passante per il centro dell'acetabolo; questi quattro quadranti corrispondono a zone più o meno pericolose, la più sicura delle quali per la collocazione delle viti è quella postero-superiore (v. Wasielewski e altri, 1991).
g) Frattura del femore.
Le fratture femorali intraoperatorie, che erano di osservazione frequente nel corso delle revisioni, sono divenute più comuni anche nel corso di sostituzioni primarie che utilizzano tecniche senza cemento; le nuove tecniche di ‛adattamento a riempimento' si basano infatti sull'inserzione forzata entro la parte prossimale del femore di un componente femorale delle maggiori dimensioni possibili (v. Fitzgerald e altri, 1988; v. Schwartz e altri, 1989). Anche l'inserzione di un componente dritto in un femore curvo può causarne la frattura. Nei sistemi non cementati, la frattura femorale è seguita, nei successivi due anni, da una più elevata incidenza di allentamento.
Se nel corso dell'intervento si verifica una perforazione femorale accidentale è sufficiente inserire un componente a gambo lungo in grado di superare il difetto osseo per un tratto pari a 1,5 volte il diametro della diafisi femorale (v. Panjabi e altri, 1985). Le fratture e le perforazioni intraoperatorie debbono essere immediatamente riparate; esse richiedono prolungati periodi post-operatori di limitata tolleranza al carico, ma di solito guariscono senza incidenti. Per prevenire le fratture e limitarne l'estensione possono essere utilizzati con profitto i comuni fili di cerchiaggio.
h) Fratture del gambo.
La rottura del gambo, la cui massima incidenza si è registrata negli anni settanta, dipende in larga misura dalle dimensioni del gambo stesso e dalla resistenza dei materiali che lo costituiscono. La frattura per deformazione e sforzo è dovuta al carico ciclico cui è sottoposto il gambo, e si verifica in genere parecchi anni dopo l'intervento. Attualmente, i moderni gambi in superleghe hanno una durata che sopravanza la speranza di vita dei pazienti.
Originariamente, le fratture del gambo dipendevano da certe caratteristiche dei componenti in acciaio inossidabile, quali insufficiente area della sezione trasversale, angoli troppo netti ed eccessiva contrapposizione testa-gambo. Nell'area di maggior tensione (quella anterolaterale) poteva verificarsi una frattura incompleta da sforzo, cui seguiva, col tempo, una frattura completa. La più lunga sopravvivenza degli attuali componenti non cementati li sottopone a una più prolungata esposizione al carico ciclico che può essere pericolosa anche per le moderne superleghe. È comunque possibile che si renda necessaria una correzione dei modelli, dal momento che le nuove tecniche di rivestimento poroso dei gambi, come la sinterizzazione e la saldatura a diffusione, determinano un certo grado di indebolimento del componente.
8. Revisione
È oggi definitivamente dimostrato che i risultati di un'artroprotesi di revisione sono significativamente peggiori di quelli di un'artroprotesi primaria (v. Pellicci e altri, 1985). Le principali indicazioni alla revisione sono la presenza di allentamento asettico e di osteolisi - che, come si è detto, sono le più comuni complicazioni a lungo termine dell'artroprotesi totale dell'anca -, la documentata perdita della massa ossea, il rischio di frattura del gambo, la lussazione recidivante o irriducibile, l'infezione.
Malgrado che la maggior parte della letteratura relativa alla revisione si riferisca ai componenti cementati, è attualmente sempre più spesso necessario eseguire la revisione dei componenti non cementati, sulla quale si vanno già accumulando i dati delle osservazioni a lungo termine. I vantaggi della revisione chirurgica, molto complessa dal punto di vista tecnico e contrassegnata da un più elevato livello di morbilità e mortalità, devono essere accuratamente valutati tenendo presenti la condizione del paziente, la massa ossea disponibile, il grado di invalidità.
Il principale problema che l'intervento ricostruttivo deve affrontare è quello della perdita di massa ossea, a livello del femore o dell'acetabolo o di entrambi, causata da precedenti interventi, allentamento, infezione, o dalla rimozione dell'impianto. La diminuita massa ossea non permette, in sede di revisione chirurgica, una buona fissazione con cemento nonostante i progressi delle tecniche, e rende così necessario l'uso di componenti non cementati. Inoltre, quando si effettua la revisione di un componente femorale cementato, è necessario estrarlo, il che comporta un'ulteriore perdita di massa ossea. La revisione degli impianti non cementati presenta difficoltà ancora maggiori, data l'affinità dell'impianto per l'osso.
Il principale rischio di una revisione chirurgica rimane la frattura femorale, che può prodursi per penetrazione corticale, per cedimento di un osso già indebolito e per manovre incongrue durante la lussazione e la riduzione dell'anca. L'accurata rimozione di tutto il cemento, facilitata dall'uso di strumenti a ultrasuoni o dalla tecnica di estrazione a segmenti, è l'essenziale premessa per l'inserzione di un nuovo impianto senza cemento. Per la sostituzione di un gambo femorale allentato è necessario inserire un impianto più grande, onde assicurare una fissazione soddisfacente.
Un'osteotomia o una trasposizione trocanterica consentono, durante le complesse procedure di ricostruzione, la sistemazione del meccanismo degli abduttori, spesso accorciati e fibrotici e inseriti su un trocantere osteoporotico; tuttavia, l'intervento di revisione fa aumentare il rischio di una mancata giunzione del trocantere o di una sua separazione forzata e di recisione del filo metallico.
La revisione dei componenti acetabolari, specie se cementati, avviene generalmente in una situazione di marcata deficienza ossea, che spesso richiede la ricostruzione della parete acetabolare mediale. Inoltre, negli impianti cementati l'allentamento acetabolare è frequentemente seguito dalla migrazione prossimale della coppa; al momento della revisione si tenta di ricostruire l'alveo acetabolare a livello della linea dell'articolazione originaria. Consistenti difetti ossei possono essere colmati con omoinnesti segmentari massivi, che danno immediata stabilità ma che impiegano mesi o anni per incorporarsi ripristinando la normale anatomia. Gli innesti autoplastici non sembrano assicurare risultati migliori a lungo termine (v. Mulroy e Harris, Failure of..., 1990; v. Kwong e altri, 1993), mentre un omoinnesto segmentario massivo correttamente fissato durante l'intervento, specie per quanto riguarda l'orientamento delle trabecole, sembra offrire maggiori probabilità di successo. Se non viene impiegato materiale di innesto, si deve tentare, ogni volta che sia possibile, una fissazione istantanea a pressione o una fissazione marginale della coppa. Con la ricostruzione del bordo acetabolare si cerca di ripristinare la normale anatomia e il centro di rotazione per ottenere le migliori caratteristiche biomeccaniche dell'anca.
Durante gli interventi di revisione, come pure in casi di artropatie infiammatorie, è possibile che si riscontri una protrusione dell'acetabolo; la dislocazione mediale della testa del femore si associa alla sua dislocazione superiore, alterando la normale anatomia e le funzioni biomeccaniche dell'articolazione. È stato dimostrato che nella maggior parte delle revisioni di artroprotesi totale con innesto osseo non solo si arresta efficacemente la progressione della protrusione acetabolare, ma si ottengono tassi di allentamento e di successive revisioni uguali a quelli segnalati per interventi su anche senza protrusione (v. Gates e altri, 1990). In caso di protrusione acetabolare è comunque consigliabile, prima dell'intervento ricostruttivo, eseguire una angiografia.
9. Trattamento post-operatorio
Dopo l'intervento è essenziale - specie se nel corso dell'operazione sono stati registrati episodi di ipotensione arteriosa - effettuare il monitoraggio emodinamico non invasivo del paziente. È altresì consigliabile mettere in atto un opportuno trattamento profilattico antibiotico per scongiurare possibili processi infettivi. Il controllo della stabilità della protesi può agevolmente effettuarsi confrontando le radiografie seriate eseguite prima e dopo l'intervento.
La terapia riabilitativa deve essere iniziata precocemente e continuata per lungo tempo: nel giro di poche settimane può essere consentita la deambulazione assistita e, nel giro di pochi mesi, senza l'ausilio dei bastoni. La ripresa dell'attività e il ritorno alla vita normale devono essere graduali, evitando sforzi eccessivi e prolungati.
10. Cenni conclusivi
La moderna chirurgia della sostituzione totale dell'anca non solo ha rappresentato per molti pazienti la risoluzione di una sintomatologia dolorosa intensa e invalidante, ma ha permesso loro un recupero funzionale completo e il reinserimento sociale. È chiaro che non vanno sottovalutate le potenziali complicazioni dell'intervento: se, infatti, attuando una serie di misure preventive è possibile ridurre l'incidenza di complicanze letali (ad es. la tromboembolia), l'osteolisi e l'allentamento asettico sono ancora problemi riscontrati con frequenza.
Le attuali procedure chirurgiche ortopediche sono il risultato di 40 anni di ricerche in campo anatomo-fisiologico e biomeccanico oltre che di progressi biotecnologici. Le sperimentazioni, i tentativi, talvolta travagliati, hanno consentito di mettere a punto un tipo di chirurgia ricostruttiva che permette di ottenere validi risultati anche a lungo termine.
BIBLIOGRAFIA
Amstutz, H. C., Sakai, D. N., Total joint replacement for ankylosed hips, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1975, LVII, pp. 619-625.
Barrack, R. L., Harris, W. H., The value of aspiration of the hip joint before revision of total hip arthroplasty, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1993, LXXV, pp. 66-76.
Bateman, J. E., Berenji, A. R., Bayne, O., Greyson, N. D., Long-term results of bipolar arthroplasty in osteoarthritis of the hip, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1990, CCLI, pp. 54-56.
Beckenbaugh, R. D., Ilstrup, D. M., Total hip arthroplasty. A review of three hundred and thirty-three cases with long follow-up, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1978, LX, 3, pp. 306-313.
Bisla, R. S., Ranawat, C. S., Inglis, A. E., Total hip replacement in patients with ankylosing spondylitis with involvement of the hip, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1976, LVIII, pp. 233-238.
Bobyn, J. D., Pilliar, R. M., Cameron, H. U., Weatherly, G. C., The optimum pore size for the fixation of porous-surfaced metal implants by the ingrowth of bone, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1980, CL, pp. 263-270.
Bono, J. V., Sanford, L., Toussaint, J. T., Severe polyethylene wear in total hip arthroplasty, in ‟Journal of arthroplasty", 1994, IX, pp. 119-125.
Brand, R. A., Johnston, R. C., Callaghan, J. J., Total hip replacement, in ‟The Iowa orthopaedic journal", 1992, II, pp. 19-42.
Brien, W. W., Salvati, E. A., Wright, T. M., Burstein, A. H., Dislocation following THA: comparison of two acetabular component designs, in ‟Orthopaedics", 1993, XVI, 8, pp. 869-874.
Brown, I. W., Ring, T. A., Osteolytic changes in the upper femoral shaft following porous-coated hip replacement, in ‟Journal of bone and joint surgery: British volume", 1985, LXVII, pp. 218-221.
Cabanela, M., VanDemark, R. E. Jr., Bipolar endoprosthesis, in ‟Proceedings of the Hip Society", 1984, XII, pp. 68-82.
Callaghan, J. J., Dysart, S., Savory, C. G., The uncemented porous-coated anatomic total hip prosthesis, two-year results of prospective consecutive series, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1988, LXX, pp. 337-346.
Callaghan, J. J., Fulghum, C. S., Glisson, R. R., Stranne, S. K., The effect of femoral stem geometry in interface motion in uncemented porous-coated total hip prostheses, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1992, LXXIV, pp. 839-848.
Chandler, H. P., Reineck, F. T., Wixson, R. L., McCarthy, J. C., Total hip replacement in patients younger than thirty years old, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1981, LXIII, pp. 1426-1434.
Charnley, J., Anchorage of the femoral head prosthesis to the shaft of the femur, in ‟Journal of bone and joint surgery: British volume", 1960, XLII, pp. 28 ss.
Charnley, J., Low friction arthroplasty of the hip, Berlin-Heidelberg-New York 1979.
Charnley, J., Halley, D. K., Rate of wear in total hip replacements, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1975, CXII, pp. 170-179.
Cooper, R. A., McAllister, C. M., Borden, L. S., Bauer, T. W., Polyethylene debris-induced osteolysis and loosening in uncemented total hip arthroplasty, in ‟Journal of arthroplasty", 1992, VII, 3, pp. 285-290.
Coventry, M. B., Scanlon, P. W., The use of radiation to discourage ectopic bone. A nine-year study in surgery about the hip, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1981, LXVIII, pp. 201-208.
Crowninshield, R. D., Brand, R. A., Johnston, R. C., Milroy, J. C., An analysis of femoral component stem design in total hip arthroplasty, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1980, LXII, pp. 68-78.
Crowninshield, R. D., Brand, R. A., Johnston, R. C., Milroy, J. C., The effect of femoral stem cross-sectional geometry on cement stresses in total hip reconstruction, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1980, CXLVI, pp. 71-77.
Crowninshield, R. D., Pedersen, D. R., Brand, R. A., Johnston, R. C., Analytical support for acetabular component metal backing, in ‟Proceedings of the Hip Society", 1983, XI, pp. 207-215.
Engh, C. A., Bobyn, J. D., Biological fixation in a total hip arthroplasty, Thorofare, N. J., 1985.
Engh, C. A., Bobyn, J. D., Glassman, A. H., Porous-coated hip replacement. The factor governing bone ingrowth. Stress shielding and clinical results, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1987, LXIX, pp. 45-55.
Fitzgerald, R. H. Jr., Brindley, G. W., Kavanagh, B. F., The uncemented total hip arthroplasty: intraoperative femoral fractures, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1988, CCXXXV, pp. 61-66.
Garvin, K. L., Bowen, M. K., Salvati, E. A., Ranawat, C. S., Long-term results of total hip arthroplasty in congenital dislocation and dysplasia of the hip: a followup note, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1991, LXXIII, pp. 1348-1354.
Gates, H. S., McCollum, D. E., Poletti, S. C., Nunley, J. A., Bone-grafting in total hip arthroplasty for protrusio acetabuli: a followup note, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1990, LXXII, pp. 248-251.
Gluck, T., Autoplastik-Transplantation Implantation von Fremdkörpern, in ‟Klinische Wochenschrift", 1890, XXVII, pp. 421-427.
Gruen, T. A., NcNeice, G. M., Amstutz, H. C., ‟Modes of failure" of cemented stem-type femoral components: a radiographic analysis of loosening, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1979, CXLI, pp. 17-27.
Harkess, J. W., Arthroplasty of the hip, in Campbell's operative orthopaedics (a cura di A. H. Crenshaw), St. Louis, Mo., 19928, pp. 571-572.
Harris, W. H., Allografting in total hip arthroplasty: in adults with severe acetabular deficiency including a surgical technique for bolting the graft to the ilium, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1982, CLXII, pp. 150-164.
Harris, W. H., McCarthy, J. C. e altri, Femoral component loosening using contemporary techniques of femoral cement fixation, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1982, LXIV, pp. 1063-1067.
Harris, W. H., McGann, W. A., Loosening of the femoral component after use of the medullary-plug cementing technique: followup note with a minimum five-year followup, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1986, LXVIII, pp. 1064-1066.
Johnston, R. C., Crowninshield, R. D., Roentgenologic results of total hip arthroplasty: a ten-year followup study, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1983, CLXXXI, pp. 92-98.
Kilgus, D. J., Namba, R. S., Gorek, J. E., Cracchiolo, A. III, Amstutz, H. C., Total hip replacement for patients who have ankylosing spondylitis. The importance of the formation of heterotopic bone and of the durability of fixation of cemented components, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1990, LXXII, pp. 834-839.
Kim, Y. H., Kim, V. E., Uncemented porous-coated anatomic total hip replacement. Results at six years in a consecutive series, in ‟Journal of bone and joint surgery: British volume", 1993, LXXV, pp. 6-14.
Kwong, L. M., Jasti, M., Harris, W. H., High failure rate of bulk femoral head allografts in total hip acetabular reconstructions at 10 years, in ‟Journal of arthroplasty", 1993, VIII, pp. 341-346.
Livermore, J., Ilstrup, D., Morrey, B., Effect of femoral head size on wear of the polyethylene acetabular component, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1990, LXXII, pp. 518-528.
McCoy, T. H., Salvati, E. A., Ranawat, C. S., Wilson, P. D., A fifteen-year followup study of one hundred Charnley low-friction arthroplasties, in ‟Orthopaedic clinics of North America", 1988, XIX, 3, pp. 467-476.
Malchou, Hen., Malchou, Heb., Malchou, P., A Scandinavian multi-centric uncemented THR study: clinical and radiological evaluations with two-year results, Scientific exhibit at the annual meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, Atlanta, Ga., Feb. 4-9, 1988.
Maloney, W. J., Harris, W. H., Comparison of a hybrid with an uncemented total hip replacement. A retrospective matched-pair study, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1990, LXXII, pp. 1349-1352.
Merkel, K. D., Brown, M. L., Dewanjee, M. K., Fitzgerald, R. H. Jr., Comparison of indium-labeled-leukocyte imaging with sequential technetium-gallium scanning in the diagnosis of low-grade musculoskeletal sepsis. A prospective study, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1985, LXVII, pp. 465-476.
Moore, A. T., Metal hip joint: a new self-locking vitallium prosthesis, in ‟Southern medical journal", 1952, XLV, pp. 1015-1019.
Mulroy, R. D., Harris, W. H., Failure of acetabular autogenous grafts in total hip arhroplasty. Increasing incidence: a followup note, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1990, LXXII, pp. 1536-1540.
Mulroy, R. D., Harris, W. H., The effect of improved cementing techniques on component loosening in total hip replacement, in ‟Journal of bone and joint surgery: British volume", 1990, LXXII, pp. 757-760.
Panjabi, M. M., Trumble, T., Hult, J. E., Southwick, W. O., Effect of femoral stem length on stress raisers associated with revision hip arthroplasty, in ‟Journal of orthopaedic research", 1985, III, 4, pp. 447-455.
Patterson, B. M., Marchand, R., Ranawat, C., Complications of heparin therapy after total joint arthroplasty, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1989, LXXI, pp. 1130-1134.
Pellicci, P. M., Wilson, P. D. Jr., Sledge, C. B., Salvati, E. A., Ranawat, C. S., Poss, R., Callaghan, J. J., Long term results of revision total hip replacement. A followup report, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1985, LXVII, 4, pp. 513-516.
Ritter, M. A., Keating, M., Faris, P. M., Brugo, G., Metal-backed acetabular cups in total hip arthroplasty, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1990, LXXII, pp. 672-677.
Ritter, M. A., Stringer, E. A., Bilateral total hip arthroplasty, a single procedure, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1980, CXLIX, pp. 185-190.
Ritter, M. A., Vaughan, R. G., Ectopic ossification after total hip arthroplasty. Predisposing factors, frequency and effect on results, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1977, LIX, pp. 345-351.
Russotti, G. M., Harris, W. H., Proximal placement of the acetabular component in total hip arthroplasty. A long-term followup study, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1991, LXXIII, pp. 587-592.
Salvati, E. A., Ghelman, B., McLaren, T., Wilson, P. D. Jr., Subtraction technique in arthrography for loosening of total hip replacement fixed with radiopaque cement, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1974, CI, pp. 105-109.
Salvati, E. A., Hughes, P., Lachiewicz, P., Bilateral total hip replacement arthroplasty in one stage, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1978, LX, 5, pp. 640-644.
Sarmiento, A., Gruen, T. A., Radiographic analysis of a low-modulus titanium-alloy femoral total hip component: two to six-year followup, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1985, LXVII, 1, pp. 48-56.
Schmalzried, T. P., Amstutz, H. C., Dorey, F. J., Nerve palsy associated with total hip replacement. Risk factors and prognosis, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1991, LXXIII, pp. 1074-1080.
Schmalzried, T. P., Harris, W. H., Periprosthetic bone loss in total hip arthroplasty, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1992, LXXIV, pp. 849-861.
Schulte, K. R., Callaghan, J. J., Kelley, S. S., Johnston, R. C., The outcome of Charnley total hip arthroplasty with cement after a minimum twenty-year followup. The results of one surgeon, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1993, LXXV, pp. 961-975.
Schwartz, J. T. Jr., Mayer, J. G., Engh, C. A., Femoral fracture during non-cemented total hip arthroplasty, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1989, LXXI, pp. 1135-1142.
Sharrock, N. E., Brien, W. W., Salvati, E. A., Mineo, R., Garvin, K., Sculco, T. P., The effect of intravenous fixed-dose heparin during total hip arthroplasty in the incidence of deep-vein thrombosis. A randomized, double-blind trial in patients operated on with epidural anesthesia and controlled hypotension, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1990, LXXII, pp. 1456-1461.
Sikorski, J. M., Hampson, W. G. e altri, The natural history and etiology of deep vein thrombosis after total hip replacement, in ‟Journal of bone and joint surgery: British volume", 1981, LXIII, pp. 171-177.
Smith-Petersen, M. N., Arthroplasty of the hip, a new method, in ‟Journal of bone and joint surgery: British volume", 1939, XXI, pp. 269-288.
Smith-Petersen, M. N., Evolution of mould arthroplasty of the hip joint, in ‟Journal of bone and joint surgery: British volume", 1948, XXX, pp. 59-75.
Strathy, G., Fitzgerald, R. H., Total hip arthroplasty in the ankylosed hip. A ten-year followup, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1988, LXX, pp. 963-966.
Trancik, T., Mills, W., Vinson, N., The effect of indomethacin, aspirin, and ibuprofen on bone ingrowth into a porous-coated implant, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1989, CCXLIX, pp. 113-121.
Vaughn, B. K., Knezevich, S., Lombardi, A. V. Jr., Mallory, T. H., Use of the Greenfield filter to prevent fatal pulmonary embolism associated with total hip and knee arthroplasty, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1989, LXXI, pp. 1542-1548.
Walker, P. S., Bullough, P. G., The effects of friction and wear in artificial joints, in ‟Orthopaedic clinics of North America", 1973, IV, pp. 275-293.
Wasielewski, R. C., Cooperston, L. A., Kruger, M. P., Rubash, H. E., Acetabular anatomy and the transacetabular fixation of screws in total hip arthroplasty, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1991, LXXII, pp. 501-508.
Wise, M. W. III, Robertson, I. D., Lachiewica, P. F., Thrall, D. E., Metcalf, M., The effect of radiation therapy on the fixation strength of an experimental porous-coated implant in dogs, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1990, CCLXI, pp. 276-280.
Wixon, R. L., Stulberg, S. D., Mehlhott, M., Total hip replacement with cemented, uncemented and hybrid prostheses, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1991, LXXIII, pp. 257-270.
Woo, R. Y. G., Morrey, B. F., Dislocations after total hip arthroplasty, in ‟Journal of bone and joint surgery: American volume", 1982, LXIV, pp. 1295-1306.
Wroblewski, B. M., 15-21 year results of the Charnley low friction arthroplasty, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1986, CCXI, pp. 30-35.
Zimmer, Inc., Improved abrasion resistance of nitrogen hardened titanium alloy surfaces, in ‟Current topics in orthopaedic technology", 1990, III, p. 6.
Chirurgia della cornea di Renato Frezzotti e Aldo Caporossi
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Cenni di anatomia e fisiologia corneale. 3. Cheratoplastica e cheratoprotesi: a) premessa; b) concetti di immunologia nel trapianto della cornea; c) indicazioni al trapianto della cornea; d) tecnica chirurgica; e) astigmatismo post-operatorio; f) prostocheratoplastica, cheratoprotesi. 4. Chirurgia refrattiva corneale: a) richiami semeiologici; b) classificazione, razionale, possibilità e limiti della chirurgia refrattiva; c) chirurgia refrattiva incisionale nella miopia: cheratotomia radiale; d) chirurgia refrattiva incisionale nell'astigmatismo; e) chirurgia refrattiva lamellare corneale; f) chirurgia refrattiva mediante laser. □ Bibliografia.
1. Introduzione
La chirurgia della cornea rappresenta un capitolo nuovo e importante dell'oftalmologia, verso il quale si rivolge con grandi aspettative un numero di pazienti attualmente già considerevole e che è prevedibile aumenterà consistentemente in futuro. È questo il motivo che stimola molti chirurghi esperti a orientarsi in questa direzione; l'interesse della disciplina a progredire su tale strada è indubbio, bisogna solo evitare di incorrere nell'errore di confondere atteggiamenti critici costruttivi con atteggiamenti critici di ostile, anacronistico pregiudizio.
Tra le branche della moderna chirurgia oculistica che vanno sempre più affermandosi, prenderemo in esame la cheratoplastica e la cheratoprotesi, le quali consentono il trattamento delle alterazioni della struttura della cornea che ne determinano la perdita di trasparenza fino alla cecità, e il settore della chirurgia refrattiva corneale, che comprende invece le varie tecniche chirurgiche idonee a modificare il potere refrattivo della cornea.
2. Cenni di anatomia e fisiologia corneale
La cornea è la porzione anteriore della tonaca fibrosa sferoidale sclerale (strato esterno del bulbo oculare, che prende origine dal mesoderma), di cui costituisce un sesto dell'estensione totale, e rappresenta la componente più importante del diottro oculare. È formata da cinque strati - e cioè, dall'esterno verso l'interno, epitelio, membrana di Bowman, parenchima o stroma, membrana di Descemet ed endotelio - ognuno dei quali ha molteplici e complesse funzioni che concorrono a farle acquisire robustezza complessiva e a mantenerne la trasparenza.
L'epitelio corneale è un epitelio pavimentoso composto, dello spessore di circa 50 µm, costituito da 5-6 ordini di cellule, distinte in uno strato superficiale di cellule squamose, uno intermedio di cellule alari e uno profondo di cellule basali, dotate di attività mitotica riproduttiva; la sua funzione principale è quella di barriera nei confronti di acqua ed elettroliti, o agenti fisico-chimici, che dal film lacrimale e dall'esterno tenderebbero a entrare nella cornea.
La membrana di Bowman è costituita da fibre collagene caratterizzate, all'osservazione al microscopio elettronico, dalla stessa periodicità di quelle dello stroma corneale (640 Å) ma disposte irregolarmente: si tratta in realtà di uno strato, non essendone mai stata dimostrata l'ultrastruttura membranosa.
Nello stroma, il cui spessore di circa 500 µm rappresenta approssimativamente il 90% dello spessore corneale, si distinguono le lamelle collagene, le cellule e la sostanza fondamentale: le lamelle collagene hanno uno spessore uniforme (compreso tra 1,5 e 2,5 µm) e un periodo di 640 Å, e presentano una disposizione in fasci paralleli alla quale si deve la trasparenza corneale; nella sostanza fondamentale mucopolisaccaridica che cementa le fibre collagene si trovano elementi cellulari appiattiti e fusiformi, denominati cheratociti: si tratta di cellule di natura fibroblastica (corrispondono ai fibroblasti presenti in altri tessuti connettivi) che provvedono alla sintesi e al mantenimento delle fibre stromali e della sostanza fondamentale.
La ‛membrana' di Descemet è uno spesso strato profondo prodotto dalle cellule endoteliali e costituito da fibre collagene con periodo diverso rispetto a quello delle fibre stromali (1.170 Å); con la microscopia elettronica vi si possono distinguere una porzione anteriore più regolare e una posteriore granulosa che tende ad aumentare di volume con l'età.
L'endotelio corneale è costituito da un unico strato di cellule cuboidali di origine mesodermica, dotate di attività mitotica prossima a zero (popolazione cellulare semiperenne): la perdita cellulare fisiologica (valutata intorno allo 0,5-0,8% annuo) e quella eventualmente prodotta da insulti di varia natura vengono compensate attaverso un aumento delle dimensioni di ogni singolo elemento cellulare (v. Tuft e Coster, 1990). Le funzioni principali dell'endotelio corneale consistono nel mantenere una barriera effettiva con l'umore acqueo, fornire una pompa metabolica e garantire la trasparenza corneale (v. Davson, 1990). La funzione di barriera dell'endotelio è calcio-dipendente: in assenza di ioni Ca le zonulae occludentes lasciano ampi spazi intercellulari che consentono il passaggio di liquidi dalla camera anteriore verso lo stroma, con conseguente rigonfiamento di quest'ultimo. La trasparenza corneale è garantita dal mantenimento di un equilibrio tra i liquidi che entrano nello stroma e quelli che ne fuoriescono. Ciò si realizza per effetto di un gradiente osmotico generato da una pompa metabolica sodio-potassio ATP-asi dipendente, il cui funzionamento è subordinato alla disponibilità di energia. La più importante fonte di energia per l'endotelio è il glucosio, che dall'umore acqueo entra nelle cellule per trasporto facilitato (più rapido di quello ottenibile con la sola diffusione; v. anche: trasporto attraverso membrane biologiche, vol. VII). La quasi totalità del glucosio disponibile è metabolizzata attraverso la glicolisi aerobia, con produzione di acido piruvico che, convogliato nel ciclo di Krebs, libera ATP, H2O e CO2 (v. Berman, 1990).
Per ciò che riguarda il potere refrattivo, la cornea rappresenta la componente più importante del diottro oculare, fornendo da sola circa il 70-80% del potere totale del bulbo (circa 60 diottrie, D). Al potere diottrico totale della cornea contribuisce la sua forma: il raggio di curvatura anteriore è di 7,7 mm, quello posteriore 6,9 mm; il suo spessore è di 0,54 mm centralmente e 0,70 mm in periferia, il che la rende simile a un menisco; gli indici di refrazione sono rispettivamente 1,336 per le lacrime, 1,376 per le strutture corneali e 1,336 per l'umore acqueo. Le tre interfacce risultanti danno rispettivamente i poteri diottrici di + 43,6 D (aria/lacrime), + 5,3 D (lacrime/cornea) e - 5,8 D (cornea/umore acqueo).
A fini pratici e funzionali, la cornea si divide anatomicamente in due regioni: la zona centrale ottica, che corrisponde al forame pupillare e porta alla formazione dell'immagine sulla retina foveale, e la zona restante, che ha la funzione di struttura di supporto, divenendo zona ottica solo quando le condizioni della pupilla sono alterate. Recentemente, proprio la chirurgia refrattiva ha reso conveniente distinguere nella cornea 4 zone concentriche: la centrale (3-4 mm di diametro), la paracentrale (7-8 mm), la periferica (11 mm) e la limbare (12 mm). La zona centrale è la zona ottica: essa rappresenta la porzione di cornea più sferica e, insieme a parte della paracentrale, è quella dove vengono refratti tutti i raggi provenienti dall'esterno verso la retrostante area pupillare.
3. Cheratoplastica e cheratoprotesi
a) Premessa.
Cheratoplastica perforante (o trapianto della cornea) e cheratoprotesi sono approcci chirurgici diversi atti a ricostituire nell'area corneale centrale, più o meno ampia, un disco di trasparenza e un corretto transito ottico in cornee opacizzate e/o geometricamente deformate per alterazioni congenite o, assai più spesso, acquisite, a seguito di traumi o per processi infiammatori o degenerativi.
La cheratoplastica consiste nel trapianto di un disco di cornea e si distingue in: ‛autotrapianto' (nello stesso individuo); ‛isotrapianto' (tra soggetti geneticamente identici, gemelli monovulari); ‛omotrapianto' (di gran lunga il più frequente, tra individui della stessa specie, geneticamente non identici); ‛xenotrapianto' (tra individui di specie differenti, attualmente destinato a sicuro insuccesso per i problemi relativi alla istocompatibilità). La cheratoprotesi si realizza, invece, con l'innesto di materiali non organici, plastici, trasparenti (alloplastica).
Preliminare necessario a un intervento chirurgico di questo tipo è la valutazione della capacità funzionale dell'endotelio corneale. La monitorizzazione delle cellule endoteliali viene effettuata con la microscopia speculare, che consente di visualizzare il mosaico endoteliale nell'immagine speculare della superficie corneale posteriore. Attualmente esistono strumenti di due tipi: microscopi contact, nei quali l'immagine viene raccolta previa applanazione sulla cornea, e microscopi non contact, che consentono l'osservazione dell'endotelio senza traumatismo per l'occhio (o per la cornea espiantata). Così l'analisi morfologica consente di evidenziare i confini cellulari, la presenza di eventuali strutture eterogenee intra- o extracellulari o di aree scure (gutte o lacune) intercalate a cellule normoconfigurate.
Il rilevamento di una distrofia guttata, il cui stadio può essere stabilito sulla base delle dimensioni delle lacune rapportate a quelle cellulari, è indice di una ridotta capacità funzionale dell'endotelio che, se di grado marcato, può sfociare in scompenso corneale con conseguente perdita della trasparenza; è noto, infatti, come la funzionalità dell'endotelio sia legata al mantenimento dei rapporti intercellulari (importante il contatto cellula-cellula per il funzionamento della pompa elettrolitica), così che ogni evento patologico capace d'indurre una perdita endoteliale porterà a un indebolimento della ‛funzione barriera' dell'endotelio (v. Waring e altri, 1982). Per una corretta valutazione della capacità funzionale dell'endotelio l'analisi più importante è però quella densitometrica e morfometrica ottenibile attraverso programmi computerizzati annessi al microscopio speculare. Le moderne attrezzature consentono, infatti, di ricavare quei parametri che rappresentano gli indici più sensibili della riserva funzionale dell'endotelio fornendo dati quali la densità cellulare media su un'area nota (CD: valori normali nel giovane adulto intorno a 2.800 cellule/mm2), l'area cellulare media (AVE: valori normali nel giovane adulto intorno a 320 µ2), la percentuale di cellule esagonali (6 A: la cellula esagonale è la più stabile per monostrato cellulare, poiché ha il minor perimetro totale ed esprime la minore energia nella tensione superficiale; valori normali > 60%) e il coefficiente di variazione dell'area cellulare (CV: valore normale 〈 35%), dato dal rapporto tra la deviazione standard (SD) delle conte cellulari e l'area cellulare media.
L'interpretazione di questi dati, che forniscono in maniera indiretta un quadro alquanto preciso della funzionalità dell'endotelio corneale, è di fondamentale interesse clinico, e ha una doppia finalità: da un lato predittiva di quelle situazioni corneali che porteranno a uno scompenso della cornea stessa e quindi necessiteranno di una cheratoplastica perforante quale unica soluzione terapeutica proponibile; dall'altro valutativa, nel caso in cui il trapianto si renda necessario, delle caratteristiche della cornea del donatore e della sua idoneità, allo scopo di garantire al paziente un sicuro risultato funzionale (v. Mishima, 1982).
b) Concetti di immunologia nel trapianto della cornea.
Caratteristiche antigeniche della cornea. - La cornea, che in passato veniva considerata un sito di privilegio immunologico per la mancanza di una circolazione linfatica e sanguigna, in realtà ha una sua ben definita identità antigenica, dipendente dalla presenza nei vari strati degli antigeni dei sistemi di istocompatibilità, cioè: 1) sistema AB0: gli antigeni di questo sistema sono localizzati a livello dell'epitelio, ma la loro importanza nei meccanismi immunitari che coinvolgono la cornea è controversa; 2) sistema HLA: appartengono a questo sistema gli antigeni del sistema maggiore di istocompatibilità MHC (Major Histocompatibility Complex), chiamato nell'uomo HLA (Human Leukocyte Antigens).
Gli antigeni di classe I (HLA: A, B, C) sono presenti a livello di epitelio, stroma ed endotelio; la loro densità non si modifica nel corso degli anni, mentre la loro distribuzione non è uniforme, in quanto sono più numerosi a livello del limbus rispetto al centro della cornea. Gli antigeni di classe II (HLA: DR) sono invece localizzati nelle cellule di Langerhans o cellule APC (Antigen Presenting Cells), presenti nell'epitelio o nello stroma in condizioni normali, ma talvolta - nel caso che la cornea sia stata oggetto di processi infiammatori - anche a livello dell'endotelio; la densità delle cellule di Langerhans è pari a 200-400 per mm2 a livello della congiuntiva, a 150-350 a livello del limbus, a 75-150 nella cornea periferica, a 25-50 nella cornea paracentrale, mentre sono assenti nella cornea centrale.
Reazione di rigetto. - La risposta verso gli antigeni del donatore che il sistema immunitario del ricevente riconosce come estranei, not self, è detta reazione di rigetto. Sperimentalmente è stato dimostrato che i singoli strati corneali possono andare incontro a una reazione di rigetto, indicata nella prima descrizione clinica come maladie du greffon (v. Paufique e altri, 1948). Si distinguono 4 diversi tipi di reazione di rigetto: 1) epiteliale; 2) subepiteliale; 3) stromale; 4) endoteliale. Per quanto riguarda la reazione epiteliale, il suo riscontro nel 10% dei casi corrisponde in realtà a una percentuale sottostimata, perché la diagnosi viene fatta durante controlli di routine in pazienti asintomatici. La reazione subepiteliale, anch'essa asintomatica, si manifesta nel 15% dei casi con la comparsa, dopo 10 mesi dall'intervento, di piccoli depositi biancastri sotto la membrana di Bowmann, che regrediscono con l'instillazione di corticosteroidi. La reazione stromale, rara, si caratterizza per un opacamento periferico a tutto spessore. Nella reazione endoteliale, l'elemento caratteristico è la linea di Khodadoust - una linea di fini precipitati costituiti da cellule linfoidi che progressivamente distruggono l'endotelio (v. Khodadoust e Silverstein, 1969) - descritta dagli autori anglosassoni come ‛il fronte di un incendio che distrugge una foresta': la distruzione dell'endotelio, avvertita dal paziente per una diminuzione del visus e l'arrossamento del bulbo, porta inevitabilmente all'opacamento della cornea trapiantata.
La reazione di rigetto può verificarsi anche dopo 30 anni dal trapianto, anche se con il passare del tempo diviene progressivamente meno frequente; le condizioni che ne aumentano il rischio di comparsa possono essere locali e generali. I fattori locali comprendono: il diametro del lembo trapiantato, la cui maggiore estensione comporta da un lato una più grande quantità di antigeni introdotti, dall'altro una minore distanza dalla circolazione limbare e la conseguente maggiore possibilità di contatto con le cellule del sistema immunocompetente del ricevente; la vascolarizzazione della cornea ricevente, poiché molti processi patologici che interessano la cornea, oltre a determinarne un opacamento, provocano una neoformazione di vasi, così che il lembo trapiantato viene direttamente a contatto con le cellule immunocompetenti favorendo lo sviluppo di una reazione di rigetto; una precedente manifestazione di rigetto, poiché in questa situazione permane nel ricevente una capacità di risposta immunitaria più elevata che facilita una nuova reazione di rigetto. I fattori generali sono essenzialmente identificabili nella incompatibilità: certamente la presenza di determinanti antigeniche comuni tra donatore e ricevente fa diminuire i rischi di rigetto e numerose casistiche hanno confermato l'importanza della valutazione della compatibilità HLA (v. Volker-Dieben e altri, 1982) soprattutto nei casi ad alto rischio (v. Frezzotti, 1981), cioè in pazienti con cornee molto vascolarizzate o che abbiano già presentato reazioni di rigetto. Tuttavia, non mancano al riguardo alcune valutazioni discordanti (v. CCTS 1992). Il rischio del rigetto sembra inoltre aumentato nei soggetti politrasfusi e nelle donne che hanno avuto numerose gravidanze.
Nella terapia delle reazioni da incompatibilità, i corticosteroidi, somministrati localmente o per via generale, sono i farmaci più utilizzati, ma i loro effetti collaterali sia generali che locali (cataratta e glaucoma) non ne consentono un uso prolungato. Tra i farmaci immunodepressori il più utilizzato è la ciclosporina somministrata per via generale e locale, sotto attento controllo ematochimico per prevenirne gli effetti collaterali, soprattutto a livello renale. Più recentemente sono stati proposti altri immunodepressori, quali l'FK506, agente sugli acidi nucleici più selettivamente della storica azatioprina usata negli anni sessanta. Di solito i corticosteroidi e gli immunodepressori vengono associati e, soprattutto nei casi ad alto rischio, la loro somministrazione viene prudenzialmente protratta per qualche mese dopo l'intervento a scopo preventivo. In caso di reazione di rigetto, è importante la pronta somministrazione dei farmaci per evitare che il danno al tessuto trapiantato ne comprometta in modo irreversibile la trasparenza.
c) Indicazioni al trapianto della cornea.
Caratteristiche del materiale prelevato. - Premessa indispensabile a ogni intervento di trapianto è stabilire con certezza che il donatore non sia ammalato né portatore sano di patologie trasmissibili al ricevente e che l'organo o il tessuto da trapiantare siano caratterizzati da una condizione di integrità anatomica e funzionale. Nel caso del trapianto di cornea, una corretta anamnesi del donatore (età, patologie pregresse, causa di morte, tempo trascorso dal decesso, ecc.) può già fornire buone indicazioni sulla possibile esistenza di condizioni che escludano in modo assoluto o relativo il prelievo del tessuto da trapiantare (v. tab. I). Tuttavia, un esame biomicroscopico eseguito al letto del deceduto prima del prelievo, e soprattutto una valutazione dell'endotelio corneale effettuata col microscopio speculare sul bulbo oculare prelevato dal donatore, consentiranno di acquisire migliori informazioni circa le caratteristiche del lembo da trapiantare ed eventualmente di correlarle con quelle della cornea del ricevente. Tra queste, della massima importanza è la valutazione delle condizioni dell'endotelio: è noto, infatti, che, a seguito del trauma chirurgico, nel primo anno dopo l'intervento si verifica la perdita di circa il 50% delle cellule endoteliali del lembo trapiantato, così che devono essere giudicate assolutamente non idonee al trapianto cornee con densità cellulare media inferiore a 2.000-2.200/mm2.
Esaminata la cornea nel modo sopra descritto, a seconda del tempo previsto tra prelievo e trapianto si deciderà il sistema più idoneo di conservazione: l'individuazione e la preparazione del ricevente, l'attesa per gli accertamenti della compatibilità immunitaria tra donatore e ricevente sono gli elementi che determinano l'ampiezza dell'intervallo tra prelievo e intervento. La conservazione in camera umida a + 4 °C, a bulbo intero, risulta idonea per eseguire il trapianto entro 24 ore dal prelievo o per trasportare il bulbo, prelevato altrove, all'ospedale o alla banca degli occhi in cui la cornea può poi essere preparata e opportunamente conservata a breve, medio o lungo termine con mezzi e tecniche adeguati (v. tab. II).
Il ricevente: indicazioni al trapianto di cornea. - La necessità di sostituire una cornea è determinata essenzialmente da due condizioni: alcune modificazioni morfologiche, e quindi diottriche - tra le quali le più frequenti sono i difetti irregolari di curvatura, cheratocono ed ectasie corneali - e la perdita di trasparenza.
Il cheratocono è un'alterazione talora ereditaria per lo più bilaterale, asimmetrica, che predilige il sesso femminile: consiste in un aumento di curvatura corneale, centrale, conoide, che provoca astigmatismo miopico irregolare. Nelle prime fasi della malattia (fase refrattiva) si può ancora ottenere un buon recupero funzionale con occhiali, o meglio, progredendo l'irregolarità dell'astigmatismo, con lenti a contatto; proseguendo lo sfiancamento della cornea, con pieghe e opacizzazioni che rendono impossibile il compenso funzionale con qualsiasi mezzo correttivo (fase involutiva), l'unico valido provvedimento è rappresentato dalla sostituzione del tessuto. In tutte le casistiche internazionali la cheratoplastica perforante per cheratocono rappresenta almeno il 20-30% dei trapianti eseguiti negli ultimi vent'anni (v. Sharif e Casey, 1991); nella nostra casistica, riferita come un campione, la percentuale di pazienti operati per cheratocono è di circa il 34,7 sul totale degli interventi di cheratoplastica (v. tab. III).
La perdita della trasparenza può avvenire per eventualità infiammatorie diverse (per es. cheratiti erpetiche) o degenerative (cheratopatia a bandelletta), oppure distrofiche (distrofia epiteliale giovanile di Meesman, distrofia granulosa, distrofia a graticciata e la grave e non rara distrofia di Fuchs), o infine traumatiche (v. Lindquist e altri, 1991; v. Manalis e altri, 1991) e non ultime per cause iatrogene, come la cheratopatia bollosa in afachico e pseudoafachico, che negli ultimi 15 anni è progressivamente divenuta uno dei motivi più frequenti di cheratoplastica perforante (v. Waring, 1989). Quest'ultima malattia produce rapidamente perdita irreversibile e progressiva della trasparenza della cornea per un danneggiamento dell'endotelio verificatosi direttamente nel corso dell'intervento per cataratta e/o in condizioni conseguenti a esso e proseguite poi con evoluzione lesiva. Il fatto che questa patologia rappresenti il 20-30% di tutte le indicazioni agli interventi di cheratoplastica perforante e sia caratteristicamente in forte aumento costituisce un segnale di allarme per la tendenza a effettuare la chirurgia della cataratta con poco rispetto di scelte tecniche e di accortezze intraoperatorie.
d) Tecnica chirurgica.
L'intervento di cheratoplastica si suddivide in due tempi chirurgici: 1) preparazione e trapanazione del lembo del donatore; 2) preparazione e sutura del lembo nel ricevente.
Preparazione del lembo del donatore. - La cornea da trapiantare può provenire o da una banca degli occhi (in tal caso la cornea, unita a una piccola flangia sclerale di 3 mm, viene recapitata in un piccolo flaconcino, nel liquido di conservazione a + 4 °C) o da un donatore deceduto per cause compatibili con la donazione stessa. Nel secondo caso, se si prevede che l'impiego della cornea avvenga oltre 24 ore dopo il decesso, la trapanazione per il prelievo del lembo verrà effettuata direttamente sul bulbo precedentemente enucleato e opportunamente conservato; altrimenti, per un trapianto da eseguire entro le 24 ore, la cornea viene preparata con la flangia sclerale e immersa in idoneo liquido di conservazione. Per prelevare la cornea da trapiantare da un bulbo intero, occorre iniettare nel vitreo dello stesso della soluzione salina per conferirgli un tono sufficiente, quindi tenere il bulbo tra le dita con una garza per consentirne la presa e permettere di esercitare una pressione adeguata e uniforme; la trapanazione avviene con movimenti rotatori del trapano tenuto rigorosamente in posizione verticale fino al completamento del taglio del lembo corneale; eseguito il taglio, il bottone corneale ottenuto viene posizionato con la superficie epiteliale in basso su un blocchetto di silicone e quindi conservato in una capsula di Petri, immerso nel liquido di conservazione. Nel caso in cui il lembo da trapiantare venga preparato da materiale corneosclerale, asportato precedentemente dal bulbo intero, è possibile procedere secondo due tecniche: la prima prevede che il taglio venga eseguito dall'epitelio verso l'endotelio (in questo caso si deve utilizzare una camera anteriore artificiale che blocchi il lembo sclerocorneale tra due anelli avvitati); secondo l'altra il taglio va invece eseguito dall'endotelio all'epitelio, ponendo il lembo corneosclerale con la superficie epiteliale rivolta in basso con sistemi di punch block. Quest'ultimo sistema è sicuramente il più usato per le caratteristiche di rapidità, sicurezza e qualità del taglio; il primo invece permette di ottenere nel lembo donato lo stesso profilo della cornea del ricevente, ma comporta una maggiore perdita di cellule endoteliali durante la lavorazione (v. Rama, 1993).
Preparazione e sutura del lembo nel ricevente. - L'intervento viene eseguito in anestesia generale. La trapanazione della cornea del ricevente, eseguita sino a pochi anni fa con trapani manuali, oggi si avvale di trapani meccanici forniti di un meccanismo di suzione che ne assicura stabilità e verticalità costanti durante l'intervento. L'impiego di trapani manuali sprovvisti di suzione può apparire più agevole, soprattutto per la maggiore facilità di eseguire la centratura, ma più frequentemente induce distorsioni del bulbo e perdita della verticalità, essendo il bulbo stesso tenuto immobile con pinze o con un anello di fissazione. I trapani meccanici a suzione, quali il trapano di Hessburg-Barron e il trapano di Hanna, presentano i vantaggi del sistema di suzione e aspirazione che assicura la stabilità del bulbo, la possibilità di operare una buona centratura e infine eseguire un taglio regolare e completo che non rende necessario il completamento con forbici corneali (v. Waring, 1989). Il bottone corneale asportato dal ricevente deve avere un diametro di 0,2-0,5 mm minore rispetto a quello proveniente dal donatore (a causa della disparità dei diametri corneali posteriori che si viene a creare quando vengono utilizzate tecniche di trapanazione in senso differente); il diametro di trapanazione generalmente è compreso fra 7 e 9 mm.
Dopo averlo posizionato sull'occhio ricevente, si inizia a suturare il lembo del donatore. La sutura è una delle fasi più delicate dell'intervento, poiché un'apposizione non corretta è potenzialmente in grado di dar luogo allo sviluppo di distorsioni morfologiche del lembo (fonte di importanti astigmatismi post-operatori e di risultati refrattivi, e quindi visivi, non soddisfacenti), di ectasie della ferita o di necrosi del lembo. Le grandezze determinanti che devono essere rispettate in una sutura sono rappresentate dalla profondità dei punti (che devono interessare costantemente i 2/3 dello spessore corneale, per evitare cicatrizzazioni anomale e irregolari), dalla tensione della regione corneale (che, se sottoposta a una sutura eccessivamente stretta, subisce un incurvamento con conseguente origine di un astigmatismo rispetto alla zona del lembo fissata con sutura più lenta, che subisce un appiattimento) e dalla regolarità dei punti, che devono essere equidistanti fra loro. Solitamente viene utilizzato per la sutura un nylon 10/0 (v. tab. IV). Dopo avere posizionato i 4 punti cardinali viene completata la sutura, la quale può essere eseguita secondo tre modalità. La sutura a punti staccati consiste nell'apposizione da 16 a 20 punti singoli, radiali, i cui nodi vengono, a fine intervento, infossati nello stroma corneale: è la tecnica più semplice, che permette anche, attraverso la rimozione selettiva dei singoli punti, un migliore controllo dell'astigmatismo post-operatorio, ma presenta lo svantaggio di indurre un maggiore traumatismo tissutale e di essere più astigmogena perché comporta una maggiore difficoltà di dare la stessa tensione a tutti i punti; i nodi, inoltre, hanno un effetto vasogenico, favorente dunque reazioni di rigetto. La sutura continua consiste nel suturare il lembo con un unico filo di sutura attraverso 8 punti (passaggi intrastromali) radiali alla pupilla, e viene definita doppia quando è realizzata con due giri, in modo tale che le anse assumano un aspetto speculare: la sua esecuzione è tecnicamente più complessa, come più arduo è controllare l'astigmatismo post-operatorio, per la difficoltà di dare la giusta tensione alle anse; ma a tali fattori negativi si contrappongono quelli positivi di un minore traumatismo tissutale e di una migliore azione di contenimento. Da pochi anni alcuni chirurghi prediligono la sutura mista, caratterizzata da 8 punti staccati associati a una sutura continua, semplice o doppia, che consente di associare a una maggiore stabilità della ferita la possibilità di un'asportazione selettiva dei punti staccati, e quindi un migliore controllo dell'astigmatismo post-operatorio nel periodo cosiddetto plastico del decorso (v. Binder, 1985).
e) Astigmatismo post-operatorio.
L'astigmatismo postintervento di cheratoplastica perforante è la conseguenza di irregolarità morfologiche geometriche cui soggiace il lembo trapiantato. Tale difetto geometrico, quindi refrattivo, è suscettibile di continue variazioni durante la fase post-operatoria, quando sono ancora presenti le suture che assicurano l'innesto, sia per la riduzione della tensione delle suture stesse che per il processo di cicatrizzazione non ancora completato (fase plastica); in una fase successiva, dopo la completa rimozione delle suture (6°-18° mese), si assiste alla definitiva stabilizzazione dell'astigmatismo che, se accentuato, può offuscare il risultato chirurgico ottenuto. L'astigmatismo, quindi, rappresenta una vera complicanza dell'intervento stesso, oltre quella più tradizionale dell'opacamento del lembo. Oggigiorno il perfezionamento della strumentazione (trapani, aghi e materiale di sutura) e della tecnica chirurgica, come pure una più raffinata metodologia nel seguire e modulare da parte del chirurgo la cicatrizzazione del lembo (selettiva rimozione o riapplicazione di punti di sutura) permettono, insieme a sistemi correttivi ottici (occhiali o lenti a contatto), di correggere, nella maggior parte dei casi, del tutto o in parte l'astigmatismo chirurgico residuo (v. Riss, 1991).
Per definizione l'astigmatismo è un vizio di refrazione dell'occhio provocato da una asfericità, a sede corneale in questo caso. Una cornea sferica presenta su ogni meridiano uguale potere di refrazione, per cui quando un fascio luminoso la attraversa, i raggi convergono su un unico punto (punto focale); una cornea non sferica presenta poteri diversi nei vari meridiani. L'astigmatismo è ‛regolare' quando esiste un meridiano più refrattivo e uno, a questo ortogonale, meno refrattivo: la superficie corneale è quella di un ellissoide di rivoluzione e il fascio luminoso refratto verrà focalizzato su due piani, con due linee (1a e 2a linea focale) ortogonali fra loro, separate da un tratto detto ‛intervallo di Sturm.' L'astigmatismo è ‛irregolare' quando più punti di uno stesso meridiano presentano una refrazione differente, provocando una molteplicità di linee focali (v. cap. 4): quest'ultima è la situazione refrattiva che più frequentemente si riscontra dopo un intervento di trapianto (v. Kaufman, 1989).
La valutazione di un astigmatismo nel periodo post-operatorio è molto importante, perché consente di seguire la cicatrizzazione del lembo trapiantato. Esistono diverse metodiche di misurazione, ciascuna specifica per scopi diversi. L'analisi oftalmometrica consente lo studio della curvatura corneale nei 3 mm centrali e suggerisce la correzione ottica ottimale ai fini della migliore acuità visiva corretta raggiungibile. Tale misurazione non ha utilità ai fini della correzione chirurgica dell'astigmatismo, la cui area operativa è nella periferia corneale. È perciò divenuto un approccio fondamentale la cheratoscopia computerizzata che, attraverso scansioni, permette lo studio dell'intera superficie corneale, evidenziando le irregolarità corneali e i meridiani che presentano la refrazione maggiore. Nasce così una classificazione morfologica originale, che riconosce astigmatismi ‛regolari', a clessidra simmetrica, e ‛irregolari', con clessidra asimmetrica, oppure con asse della clessidra inclinato, o con morfologia multiassiale o non classificabile.
Nella patogenesi di un astigmatismo postintervento di cheratoplastica intervengono fattori molteplici, non sempre clinicamente ben inquadrabili: una classificazione didattica permette di suddividerli in preoperatori, intraoperatori e post-operatori (v. tab. V). Nell'ambito delle cause astigmogene intraoperatorie assume primaria importanza la tecnica di sutura del lembo. Da qualche anno viene privilegiata la tecnica ‛mista', una doppia sutura continua antitorsione (dove gli angoli contrapposti delle anse consentono una minore deformazione) associata a otto punti staccati, adottata anche da noi in quanto convinti che l'asportazione selettiva di questi ultimi consenta una modulazione dell'astigmatismo impossibile con qualsiasi altra tecnica. In seguito alla completa rimozione della sutura certi astigmatismi potranno persistere oppure scomparire o, in certi casi, comparirne di nuovi. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le tecniche chirurgiche per ridurre l'entità delle irregolarità morfologiche del lembo. Localizzando nello studio della mappa corneale del paziente i meridiani più refrattivi e quelli meno refrattivi, occorre stabilire la principale causa di irregolarità e, mediante ‛tecniche di incurvamento non perforanti' ovvero ‛tecniche di appiattimento non perforanti', cercare di regolarizzare la morfologia del lembo (v. tab. VI) e ricondurre il difetto alle dimensioni di un lieve astigmatismo regolare correggibile con elementari presidi ottici. Un lembo trasparente, infatti, ma con un astigmatismo grave, è oggi un risultato che paziente e chirurgo considerano un insuccesso.
f) Prostocheratoplastica, cheratoprotesi.
Nonostante che le possibilità di eseguire con successo la cheratoplastica perforante siano in continuo aumento, esiste pur sempre una tipologia di pazienti per la quale questo approccio chirurgico è privo, completamente o quasi, di possibilità di successo: sono i pazienti nei quali il deterioramento corneale è talmente avanzato che il razionale cui fare affidamento è la sostituzione del tessuto corneale alterato con una cornea artificiale di materiale alloplastico trasparente, che prende il nome di ‛cheratoprotesi'. La cheratoprotesi è schematicamente un elemento cilindrico, ottico, il cui compito è di trasmettere la luce, con una parte di sostegno, parte aptica, che ha il compito di fissare la protesi alla cornea del paziente. Sono stati compiuti molti sforzi per promuovere questa tecnica, nota come ‛prostocheratoplastica' (PKP), che tuttavia, per la complessità dell'atto chirurgico e soprattutto per l'elevata percentuale di insuccessi, non ha avuto una diffusione tale da entrare nel normale training di ogni chirurgo oftalmologo.
Tipi di cheratoprotesi. - Da un punto di vista anatomo-funzionale, possiamo dividere le tecniche di cheratoprotesi sviluppatesi negli ultimi quarant'anni in tre tipi: 1) non penetranti (superficiali o intrastromali); 2) penetranti (anteriori o posteriori); 3) perforanti (v. Barron, 1988), distinte da Strampelli (v., 1984) in esoprotesi, endoprotesi, mesoprotesi; queste ultime, poiché il materiale alloplastico non si salda mai ai tessuti, tendono a divenire esoprotesi, estruse, per necrosi del connettivo (determinata dall'enzima collagenasi) e proliferazione sequestrante epiteliale.
La tecnica chirurgica più recente utilizza pressoché solo le cheratoprotesi perforanti a fissazione anteriore, nelle quali alla superficie anteriore della cornea si sutura un piatto di supporto con inserito al centro un cilindro ottico trapassante l'intera cornea. Questa tecnica, anche se non mette consistentemente al riparo dall'estrusione della cheratoprotesi, certamente permette agli elementi nutritivi dell'umore acqueo di raggiungere tutti gli strati corneali, riducendo così il rischio di necrosi. Si è pensato di ridurre il rischio di estrusione rinforzando la superficie corneale con materiali quali la sclera, o la cornea, la fascia lata, il periostio, il dacron e/o addirittura la palpebra superiore (through and through). Sempre nello stesso intento alcuni autori hanno pensato di strutturare la parte aptica della protesi, solitamente formata da materiale inerte, con un tessuto autologo: l'impiego di denti e osso (osteo-odontocheratoprotesi) ha consentito di ottenere risultati positivi, non così quello di cartilagine e unghie (condrocheratoprotesi, onicocheratoprotesi).
Tra le tecniche di cheratoprotesi oggi maggiormente impiegate è doveroso ricordare la cheratoprotesi through and through di Cardona; la osteo-odontocheratoprotesi (OOKP) di Strampelli; la cheratoprotesi a ‛invasione biologica' di Pintucci.
La cheratoprotesi through and through di Cardona (v. Cardona, 1983) è formata da due elementi: un cilindro in polimetilmetacrilato (PMMA) e un piatto di supporto in teflon. La flangia di supporto è caratterizzata da una serie di fenestrature tali da ottimizzare l'ancoraggio al tessuto corneale, rendendo più agevole la sutura e l'intermissione del tessuto cicatriziale; la parte centrale del disco è disegnata in modo che il cilindro ottico sia filettato e possa essere fissato avvitandolo.
La osteo-odontocheratoprotesi di Strampelli (v., 1963), assai originale, è caratterizzata da un supporto formato da tessuto autologo devitalizzato (avorio senza polpa) e da tessuto vitale (osso alveolare), saldati tra loro dal legamento alveolodentario; alla parte non vitale, avorio, viene saldato un cilindro ottico con una resina acrilica, costituendo un vero e proprio autotrapianto eterotopico di ottima biocompatibilità con i tessuti oculari. È stato infatti dimostrato che l'epitelio corneale si salda al legamento alveolodentario stabilmente: la saldatura è il fattore saliente, in quanto ostacola la complicanza più tipica e temuta della prostocheratoplastica, l'espulsione della cheratoprotesi.
Il razionale della cheratoprotesi di Pintucci (v. Pintucci e Pintucci, 1991) si basa sulla convinzione della necessità che una porzione della parte aptica della protesi diventi parte integrante dell'organismo ospitante, in modo da formare un tessuto vivo: questo importante presupposto è stato soddisfatto, secondo l'autore, realizzando la parte aptica della cheratoprotesi in feltro di dacron a integrazione biologica, adottato da tempo in cardiochirurgia.
Indicazioni e controindicazioni. - Una PKP è indicata in pazienti con cecità bilaterale per gravi ustioni e causticazioni, pemfigoide, sindrome di Steven-Johnson, malattia di Lyell, forme mucosinechianti in generale, tracoma, cheratocongiuntiviti di elevata gravità, dry eye terminale, infezioni batteriche. Condizione necessaria, però, è che il paziente sia in grado di avvertire una minima percezione luminosa; esami quali l'elettroretinografia e la tecnica dei potenziali visivi evocati sono utili, anche se si è visto che in alcuni pazienti con risposte molto alterate si è avuto un recupero visivo. È opportuno eseguire anche un'ecografia, in modo da sincerarsi della situazione del segmento posteriore (retina, corpo vitreo). Grave controindicazione è la presenza di un glaucoma, facilmente coesistente, difficile da trattare, il cui monitoraggio diventa post-operatoriamente difficile o impossibile a seguito delle modificazioni strutturali causate dall'intervento medesimo. In sintesi, le controindicazioni a un intervento di prostocheratoplastica sono rappresentate dall'assenza di qualsiasi percezione luminosa nell'occhio da operare, da una pregressa patologia vitreoretinica oppure dalla presenza di un glaucoma non suscettibile di compenso con qualsiasi tipo di terapia.
Complicanze e risultati. - Le complicanze dell'intervento sono il glaucoma, le vitreiti, le endoftalmiti settiche, gli ascessi endobulbari, le celluliti, ecc.; per le protesi tipo Cardona, fuoriuscita di umore acqueo, ipotono, membrane retroprotesiche, estrusione; per la OOKP, meno frequenti, necrosi dell'osso alveolare, inconvenienti del mastice acrilico.
Il risultato funzionale delle cheratoprotesi permette ad alcuni pazienti di leggere e soprattutto di diventare più indipendenti funzionalmente, anche se il loro campo visivo risulta ristretto rispetto a quello di un soggetto normale. In generale si può dire che i risultati e le complicanze dipendono fondamentalmente dalle condizioni preoperatorie dell'occhio e dal tipo di cheratoprotesi adottata: le percentuali di successo, anche se da taluni autori sono definite buone (v. Falcinelli, 1992), sembrano generalmente limitate nel tempo e inferiori a quelle delle complicanze più o meno gravi, tanto che fino a oggi hanno impedito uno sviluppo dell'intervento tale da poterlo definire di routine.
4. Chirurgia refrattiva corneale
a) Richiami semeiologici.
La chirurgia refrattiva corneale comprende le tecniche idonee a modificare il potere refrattivo corneale; essa è rivolta prevalentemente alla correzione della miopia, l'ametropia più frequente (si riscontra nel 25% circa della popolazione), caratterizzata da un eccesso di potere refrattivo totale, alla cui eliminazione tanti chirurghi si sono dedicati nel corso degli anni sviluppando numerose tecniche, talune ormai obsolete o del tutto abbandonate, altre migliorate e affermate al punto da sopravvivere accanto a quelle di più recente elaborazione. L'effetto refrattivo indotto chirurgicamente è conseguente a modifiche apportate sia direttamente sulla zona centrale della cornea (Photo Refractive Keratectomy, PRK), sia su quelle paracentrale e periferica (incisional Refractive Keratotomy, RK).
Questo settore della chirurgia oftalmologica, insieme alle varie metodiche finalizzate a modificare il potere refrattivo, ha promosso lo sviluppo di tecniche e strumenti semeiologici che consentono di esaminare la superficie corneale e di valutare se le modifiche apportate dalla chirurgia risultino opportune o indesiderate. La tecnica della misurazione della curvatura anteriore corneale, che già da moltissimi anni consente di valutare il potere diottrico corneale, è stata affiancata da altri strumenti, ora usati correntemente, come il cheratometro e il cheratoscopio, e da metodiche ancora in via di sviluppo, come la rasterstereografia e l'interferometria.
Il cheratometro, o oftalmometro di Javal-Schiøtz, ancora di uso corrente nella pratica clinica attuale ma rudimentale per la chirurgia refrattiva, effettua la misurazione del raggio di curvatura anteriore su un ambito centrale di circa 3 mm; con opportune modifiche può essere impiegato anche in regioni corneali diverse dalla centrale.
Il cheratoscopio (come pure il cheratografo) è un disco contenente una serie di mire, di solito cerchi concentrici (come nello storico disco di Placido), le cui immagini speculari sulla cornea possono essere osservate visivamente o in fotografia; questo strumento fornisce un'informazione qualitativa e molto approssimativamente quantitativa della condizione di curvatura della superficie corneale. Più recentemente si è passati dal fotocheratoscopio al videocheratoscopio, che ha consentito un'analisi più raffinata della superficie corneale e valutazioni quantitative precedentemente impensabili: questo tipo di strumento proietta sulla superficie corneale da 15 a 32 anelli illuminati che vengono registrati con un sistema video e la cui immagine digitalizzata può essere quantificata mediante algoritmi matematici generati da un appropriato software. Per facilitare e rendere immediata la comprensione di tali rilevazioni da parte del medico, a ogni raggio di curvatura è stato convenzionalmente assegnato un colore, caldo sul rosso per valori di potere diottrico più alti, freddo sul blu e nero per poteri più bassi: si costruiscono così mappe corneali disegnate con falsi colori. Questo tipo di esame è divenuto uno strumento formidabile per la comprensione dell'anatomia topografica della cornea in genere e, nel nostro problema specifico, per la comprensione dei programmi di chirurgia refrattiva e, soprattutto, dei suoi risultati.
La rasterstereografia e l'interferometria, ancora a uno stadio di sperimentazione e di messa a punto, sono tecniche attraverso le quali si cerca di ottenere immagini tridimensionali che consentano non solo di definire con precisione i parametri della curvatura corneale, ma soprattutto di accertare se i difetti sono in elevazione o in depressione rispetto alla circostante superficie. Queste tecniche consentiranno di analizzare anche patologie della cornea dovute a processi infiammatori, a cicatrici, o all'effetto di suture o incisioni, ecc.
Infine, la misura dello spessore delle singole zone corneali è spesso di importanza basilare ai fini della programmazione chirurgica di tecniche invasive incisionali eseguite con bisturi e cheratotomi. Tali tecniche di misurazione, note col nome di ‛pachimetria', verranno descritte in relazione alla cheratotomia radiale (v. cap. 4, § c), la quale, più delle altre tecniche chirurgiche, basa le sue strategie sulla misura dello spessore corneale.
b) Classificazione, razionale, possibilità e limiti della chirurgia refrattiva.
L'uso di occhiali e di lenti a contatto ha certamente permesso ai pazienti portatori di ametropie di migliorare la qualità della loro vita, ma al contempo ha generato il desiderio di poter vedere senza di essi, per necessità funzionali (professionali, sportive, ecc.) o per esigenze estetiche.
La prima tecnica di chirurgia refrattiva codificata, cheratotomica, fu quella ideata da Tutomu Sato nei tardi anni trenta, consistente in tagli radiali sulla superficie interna posteriore della cornea, per la correzione della miopia e dell'astigmatismo, del resto già ipotizzata in Europa molti decenni prima. Purtroppo, dato che allora non si conosceva la delicata funzione dell'endotelio corneale, vitale per il mantenimento della trasparenza corneale, i risultati di tali interventi furono disastrosi: cecità per decompensazione e opacizzazione della cornea.
A partire dal 1949, negli anni cinquanta-sessanta, José I. Barraquer (v., 1958) sviluppò a Bogotá i principî della chirurgia lamellare refrattiva corneale, introducendo uno strumento innovatore, il microcheratotomo, grazie al quale fu in grado di realizzare gli interventi di cheratomileusi e di cheratofachia.
Negli anni sessanta-settanta, Svatyslav N. Fjodorov a Mosca riprese taluni dei principî di Sato e mise a punto la sua cheratotomia con tagli radiali centrifughi sulla sola superficie anteriore della cornea (v. Fjodorov e Durssen, 1977): l'operazione riscosse notevoli consensi in tutto il mondo, e nel 1978 Leo Bores (v., 1993) la introdusse, denominandola RK, negli Stati Uniti, ove fu ampiamente utilizzata.
Nell'ambito dell'approccio lamellare, negli anni settanta iniziarono i primi tentativi di usare per la tecnica di cheratofachia materiali inorganici plastici intrastromali (inlays) in luogo di un lenticolo di stroma corneale di donatore (v. Barraquer, 1980), tentativi che sono stati continuati negli anni ottanta da D. P. Choyce, che utilizzò lenticoli di polysulfone, e sono tutt'oggi in corso quelli riguardanti l'impiego di lenticoli di hydrogel (v. Werblin, Epikeratophakia..., e A prospective..., 1981, e 1989; v. Werblin e altri, 1980; v. Binder e altri, 1986).
Nel 1980, Herbert E. Kaufman (v., 1980), a New Orleans, ha introdotto una tecnica lamellare molto semplificata: il lenticolo, lavorato nel suo potere refrattivo in una struttura centrale, viene inviato liofilizzato al chirurgo che provvede a impiantarlo sulla cornea del ricevente con una tecnica chirurgica sicura e soprattutto reversibile.
Nel 1983, Stephen L. Trokel (v. Trokel e altri, 1983) ha introdotto un nuovo laser per produrre incisioni e rimozioni sul tessuto corneale (laser a eccimeri); vennero in seguito messe a punto numerose tecniche originali o evoluzioni di tecniche già esistenti, quali la possibilità di lavorazione a fresco del tessuto corneale per le tecniche di cheratomileusi ed epicheratoplastica iperopica e miopica (v. Krumeich, 1983 e 1984; v. Krumeich e Swinger, 1987); la cheratomileusi in situ e la cheratofachia fresh di A. S. Ruitz; la epicheratoplastica con lenticolo in collagene IV di Romanet. La tab. VII riporta una classificazione modificata delle tecniche di chirurgia refrattiva corneale proposta da Waring (v., 1987); il terreno è sicuramente molto fertile e nuove possibilità si intravedono all'orizzonte.
Le cinque caratteristiche che dovrebbero connotare una procedura chirurgica refrattiva ‛ideale' sono: sicurezza, predittività, reversibilità, semplicità, stabilità nel tempo. Purtroppo, l'analisi delle tecniche proposte finora mette in evidenza come spesso manchino una o più di tali caratteristiche.
Le complicazioni più frequenti e importanti legate alle procedure refrattive possono essere suddivise in funzionali (ottiche) e organiche (v. tabb. VIII e IX): le prime sono in genere collegate al mancato soddisfacimento di due delle caratteristiche essenziali sopra ricordate (predittività e stabilità), mentre le seconde sono per lo più correlate alle altre tre caratteristiche (sicurezza, reversibilità e semplicità). Il grado di lesività dovuto a questi due tipi di complicanze può essere assai diverso, a seconda che la procedura refrattiva sia effettuata su un paziente portatore di una ametropia facilmente correggibile con semplici presidi ottici, oppure su un paziente considerato funzionalmente cieco per la totale impotenza dei sistemi correttivi tradizionali (occhiali e lenti a contatto) nei confronti della sua ametropia. La realtà clinica offre un'estesa gamma di situazioni intermedie e una grande varietà di norme circa le indicazioni, la liceità, l'utilità terapeutica, il rapporto fra rischio e beneficio, con implicazioni molto diverse dal punto di vista clinico, deontologico, medico-legale. Ad esempio, la procedura refrattiva può non essere indicata in taluni casi - appartenenti alle forze armate, praticanti di sport come il pugilato o le arti marziali - e può invece esserlo in altri - chi lavora in luoghi polverosi o a temperatura elevata o pratica sport di alta montagna o acquatici.
In tema di predittività, che è uno degli aspetti maggiormente considerati, è facilmente intuibile come possa significare una cosa diversa considerare soddisfatto questo parametro nel caso che si tratti di correggere una miopia bilaterale di 4-5 diottrie e in quello, ad esempio, della correzione di un'ametropia fortemente dissimmetrica nei due lati (anisometropia) non correggibile con sistemi tradizionali. La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha condotto un monitoraggio su scala nazionale nell'ambito dello studio Prospective Evaluation of Radial Keratotomy (PERK study); come risulta dal recente rendiconto decennale, tale studio ha evidenziato come per la cheratotomia radiale sia stato ottenuto un risultato refrattivo tra una diottria e zero nel 67% dei casi nelle miopie tra -2 e -3,12, nel 62% dei casi nelle miopie tra -3,25 e -4,37, e nel 54% dei casi nelle miopie tra -4,5 e -8. La fig. 13 evidenzia la regressione lineare e gli intervalli fiduciali della refrazione ottenuta rispetto a quella programmata nella nostra personale casistica di pazienti operati di epicheratofachia con tessuto fresco e liofilizzato.
La presenza di un astigmatismo regolare, che non rappresenta una grossa difficoltà nella chirurgia lamellare, pone invece notevoli problemi nella cheratotomia radiale, in cui si effettua la riduzione di un difetto sferico in uno cilindrico. Astigmatismo irregolare può essere provocato nella chirurgia radiale da un difetto di cicatrizzazione, oppure da una zona ottica troppo piccola o decentrata; nella chirurgia lamellare da fattori riguardanti la cicatrizzazione, la sutura, l'interfaccia, la stessa lavorazione del lenticolo e la riepitelizzazione, spesso accompagnata da una riduzione dell'acuità visiva.
Fotofobia e abbagliamento sono due sintomi spesso presenti nelle procedure refrattive e legati a vari fattori epitelio-corneali, quali aumento dello spessore corneale, zone ottiche piccole o decentrate, problemi di interfaccia.
Le fluttuazioni dell'acuità visiva, frequenti nella chirurgia radiale, sono legate a diversi fattori, come pressione intraoculare, curvatura corneale, ritardo nella cicatrizzazione ed edema, che tendono però a risolversi nell'arco dei primi sei mesi successivi all'intervento chirurgico.
La perdita (regressione) della correzione ottenuta - osservata con frequenza nel primo periodo successivo a chirurgia radiale - o la sua progressione sono fenomeni attentamente studiati; recentemente in letteratura sono stati riportati dati che indicano la presenza di una progressiva attività in senso iperopico dei tagli radiali. Questo fenomeno è meno studiato nelle procedure lamellari e la sua presenza è sempre correlata all'asportazione delle suture; nella epicheratofachia miopica, invece, questa complicanza si è rivelata così importante da aver indotto l'interruzione della sperimentazione. La perdita della migliore acuità visiva ottenuta, che è uno degli aspetti deontologicamente più rilevanti, può sempre presentarsi in seguito a procedure refrattive, anche se nella chirurgia radiale è oggi più rara; le cause più frequenti sono un errore nelle centrature dell'asse ottico, tagli in zona ottica, cicatrici in zona ottica legate a flogosi post-operatoria, presenza di astigmatismo irregolare. La sua manifestazione nella cheratofachia è con tutta probabilità legata a problemi di interfaccia, alle caratteristiche del lenticolo nel quale si possono reperire frammenti di membrana di Bowman o della Descemet con conseguente astigmatismo irregolare; complicanze simili possono osservarsi anche nella cheratomileusi o nella epicheratoplastica o epicheratofachia.
La tab. X, tramite un sistema a punteggio, evidenzia l'osservanza delle cinque caratteristiche essenziali di una procedura chirurgica refrattiva relativamente a sei tecniche: risulta evidente come la epicheratoplastica sia la tecnica refrattiva che più rispetta queste cinque regole e la cheratomileusi quella che ne osserva meno (anche se nella nostra esperienza questa tecnica ci ha dato risultati migliori e soddisfazioni maggiori di qualsiasi altra). Questa chirurgia, la più nuova della disciplina oftalmologica, è spesso guardata con diffidenza e talvolta osteggiata per molteplici ragioni, alcune delle quali sono state esposte sopra. Essa ha comunque motivazioni, validità e potenzialità sufficienti per espandersi, per ricercare nuovi spazi, nuove applicazioni, nuovi spunti di creatività.
Dato che molte delle tecniche sono ancora in fase sperimentale più o meno avanzata, è fondamentale rispettare le regole basilari, scientifiche ed etiche, della ricerca. Le sperimentazioni clinico-chirurgiche devono infatti sottostare a precisi protocolli di attuazione che consentano di ridurre gli errori, che diano indicazioni precise e adeguati criteri circa il reclutamento o l'esclusione dei pazienti, e inoltre che definiscano procedure di esame, di trattamento e di valutazione post-operatoria precise e omogenee, con imparziali analisi e interpretazioni statistiche dei risultati, dato che - come ha efficacemente sostenuto Waring (v., 1987) - ‟the randomized controlled clinical trial [...] has affected medical practice as powerfully as the invention of microscope". In qualsiasi nuova tecnica chirurgica devono essere individuate le varie fasi di sviluppo e di valutazione (v. tab. XI) che fanno sì che la creatività iniziale, spesso individuale, divenga una tecnica investigata, sperimentata, sino a renderla una pratica stabilita, efficace, sicura, tale da potere essere adottata da tutti i chirurghi.
Le cinque fasi di sviluppo e valutazione di una tecnica non sono fine a se stesse, ma rappresentano il modo appropriato in cui un'idea deve evolversi ed è deontologicamente corretta solo la pubblicazione delle tecniche giunte al IV stadio di sperimentazione (formal trial), allorché è stato raggiunto un buon grado di attendibilità; il passaggio al V stadio (randomized controlled clinical trial) consente una sua valutazione più sofisticata non in assoluto, ma perché in comparazione e in competizione con altre tecniche esistenti. Cercando di esaminare la posizione delle tecniche refrattive più collaudate nei riguardi dei cinque citati stadi di sviluppo, emerge come solo per la cheratotomia radiale e per la epicheratofachia si sia giunti al IV stadio delle prove formali e solo per la seconda siano stati condotti a termine anche studi randomizzati nei confronti di procedure alternative come l'impianto secondario di cristallino artificiale.
Nei riguardi del singolo paziente, la proposta di un trattamento chirurgico sicuro ed efficace, anche se non definitivamente convalidato dal tempo e dal follow up delle casistiche trattate, si configura come un atto medico che si pone tra terapia e sperimentazione; la liceità della sua applicazione è legata alle potenzialità di efficacia terapeutica del trattamento e a un'attenta valutazione del rapporto rischi-benefici che deve essere decisamente a vantaggio dei secondi.
Trattandosi di sperimentazione terapeutica, valgono le norme della Dichiarazione di Helsinki (1964) adottate dall'Associazione Medica Mondiale nella Carta di Venezia (1969), oltre alle leggi regionali che regolano la sperimentazione clinica. Un aspetto fondamentale da tenere presente è quello del consenso informato, che deve essere consapevole e cosciente; è necessario, cioè, fornire al paziente una informazione adeguata, dettagliata ed esauriente ma soprattutto comprensibile, che delinei i vantaggi, gli svantaggi e le possibili alternative disponibili. Per ciò che riguarda la chirurgia refrattiva, il paziente deve avere compreso in cosa consistano questi trattamenti, su quale base di esperienza si fondino e vengano proposti, quali incertezze vi siano ancora sulla precisione del risultato desiderato, che vi può essere ancora necessità di lenti - se non altro per la visione da vicino per coloro che hanno superato i 45 anni - e che si richiedono tempi di stabilizzazione che vanno da pochi mesi a un anno a seconda dei casi e delle tecniche. In particolare quest'ultimo punto è di grandissima importanza, perché attese a volte non realistiche e dovute a mancanza di precise informazioni non determinino insoddisfazione nei pazienti.
c) Chirurgia refrattiva incisionale nella miopia: cheratotomia radiale.
La cheratotomia radiale (RK) è una procedura di chirurgia refrattiva per la correzione di miopie lievi (sino a 6 diottrie) basata sulla possibilità di modificare la curvatura della cornea eseguendo più incisioni disposte a raggiera sulla sua superficie anteriore, risparmiando la zona centrale. Tali cheratotomie sono sempre eseguite alla massima profondità dello spessore corneale, quasi al limite della sua perforazione, in quanto dal punto di vista del risultato correttivo è preferibile ridurre il numero dei tagli piuttosto che la loro profondità. Una importante prerogativa, tanto concettuale quanto esecutiva, di questa metodica è il risparmio della zona corneale centrale (zona ottica).
Eseguendo tagli radiali profondi, non perforanti, in sede paracentrale e periferica sulla superficie anteriore della cornea, se ne modifica il potere refrattivo per rilassamento biomeccanico del tessuto circostante l'area centrale: tale indebolimento strutturale provoca una riduzione della curvatura della zona centrale (appiattimento), cioè un aumento del raggio di curvatura della curva corneale, il che permette, per la riduzione del potere refrattivo, uno spostamento in senso posteriore del punto focale.
Indicazioni. - La cheratotomia radiale è indicata nei casi di miopie lievi nei quali non si riscontrino alterazioni patologiche della cornea, come cicatrici post-traumatiche o malattie corneali degenerative, che renderebbero inopportuno il trattamento e assai poco prevedibile il risultato finale, con conseguenti errori refrattivi non voluti. Così, ad esempio, pregressi episodi di cheratiti, quali la cheratite erpetica, ne controindicano l'esecuzione, anche per il rischio della riattivazione della malattia virale. Devono altresì essere esclusi da questa tecnica pazienti con malattie vitreo-retiniche, comprese le degenerazioni retiniche periferiche, o predisposizione al glaucoma o alterazioni del cristallino. Nelle miopie di grado medio-alto, la RK è meno efficace per la minor stabilità e predittività del risultato finale. L'intervento è indicato per pazienti al di sopra dei 21 anni, nei quali il difetto miopico sia risultato stabile almeno nel corso degli ultimi 12-24 mesi (in dettaglio, v. tab. XII). Inoltre, è importante spiegare al paziente di età superiore ai quarant'anni che se da un lato il raggiungimento dell'emmetropizzazione lo porterà all'annullamento del difetto per la visione a distanza, dall'altro lo costringerà alla inevitabile e per lui inedita necessità di una correzione ottica per vedere da vicino, con lenti positive.
Indagini preliminari. - La valutazione precisa e obiettiva dell'entità del difetto refrattivo è di fondamentale importanza e, soprattutto nei soggetti al di sotto dei 30 anni, deve essere effettuata attraverso esame schiascopico in cicloplegia atropinica - che blocca il tono accomodativo - in quanto una eccessiva accomodazione potrebbe mascherare la refrazione statica. È indispensabile anche l'esame preliminare al biomicroscopio corneale, per poter evidenziare qualsiasi alterazione morfologica patologica.
La misurazione della curvatura corneale (cheratometria) si esegue classicamente utilizzando i cosiddetti cheratometri, i quali sfruttano le proprietà riflettenti della cornea: mire opportunamente costruite, riflesse dalla sua superficie anteriore, permettono di quantificarne la curvatura espressa con il raggio di curvatura anteriore e con il suo potere diottrico. Oggi i cheratometri sono stati superati, soprattutto nella programmazione di una qualsiasi procedura di chirurgia refrattiva, dalla moderna cheratoscopia computerizzata a riflessione (topografia corneale), che - grazie alla digitalizzazione ed elaborazione informatica delle immagini riflesse dalla cornea - consente di acquisire dati, non solo quantitativi ma anche qualitativi, sulle condizioni dell'intera superficie corneale.
Per la programmazione della chirurgia refrattiva incisionale è fondamentale la valutazione dello spessore corneale (pachimetria), effettuata tramite ecografia A-scan modificata mediante biometri ultrasonici a contatto, detti pachimetri. Attualmente, tali strumenti sono dotati di sofisticati nomogrammi di calcolo, che in base ai valori pachimetrici ottenuti, al valore del difetto refrattivo da correggere e ad altri parametri secondari (età, tensione endobulbare, ecc.) sono in grado di indicare il diametro della zona ottica, il numero dei tagli da effettuare e la loro profondità (calcolata sia come valore percentuale rispetto allo spessore corneale, sia come misura assoluta). L'esame pachimetrico deve essere eseguito in più punti (almeno 4) lungo i meridiani principali e quelli intermedi; infatti, viste le differenze di spessore tra le varie zone corneali (lo spessore aumenta dal centro verso la periferia), possono essere effettuati approfondimenti differenziati lungo il taglio, così da ottimizzare l'efficacia delle incisioni.
Predittività. - Un aspetto importante di qualsiasi tecnica chirurgica volta a ottenere un risultato quantitativamente preciso è la predittività e la riproducibilità della metodica. Ciò è particolarmente vero per la chirurgia refrattiva. È pertanto essenziale individuare tutte le possibili variabili in grado di influenzare la riproducibilità dell'atto chirurgico e anche conoscere con esattezza le possibilità di regolare per mezzo di farmaci i fenomeni di cicatrizzazione corneale, propri di ogni individuo, che interferiscono sul risultato.
Il risultato dell'intervento chirurgico refrattivo incisionale può essere condizionato anche da numerosi fattori individuali, e precisamente: tensione endobulbare; raggio di curvatura corneale (interno ed esterno); spessore corneale centrale e periferico; diametro, superficie e volume totale della cornea; età e sesso del paziente (per le variazioni della elasticità dei tessuti). A tali fattori si aggiungono variabili intraoperatorie quali: ampiezza della zona ottica non interessata dai tagli; lunghezza delle incisioni; numero delle incisioni (al di sopra di 8 il loro rendimento è minimo sulla refrazione) e loro profondità.
Attraverso algoritmi matematici tutti i suddetti fattori possono essere sottoposti a elaborazione computerizzata, che consente di costruire un modello geometrico del risultato finale abbastanza corrispondente alla realtà clinica.
Strumentario e tecnica. - La tecnica di RK viene eseguita in anestesia locale per instillazione; in qualche caso viene somministrato in precedenza un blando ansiolitico per via orale. In genere non vengono usati farmaci che modifichino il diametro pupillare. L'apertura palpebrale viene mantenuta mediante un blefarostato con blocco.
Il tagliente, che è lo strumento più importante di questa tecnica, deve avere una punta estremamente affilata per penetrare alla massima profondità stabilita e produrre un taglio il più regolare possibile. Attualmente il bisturi di diamante, di cui è possibile regolare micrometricamente la sporgenza della punta attraverso calibri a scalino pretarati, è considerato lo strumento ideale per l'esecuzione della RK. Nello strumentario usato per questo tipo di chirurgia sono importanti anche il forceps da fissazione a doppia punta e l'anello di fissazione, usati per ottenere la stabilità del bulbo durante le manovre di marcatura e quelle di incisione. Per facilitare la tecnica vengono inoltre utilizzati marcatori della zona ottica (da 3 a 5 mm) e marcatori radiali (con 4-6-8-12-16 linee rilevate) che, centrati e premuti sulla cornea, disegnano le linee guida che l'operatore deve seguire nell'atto chirurgico.
Oggi vengono utilizzate due tecniche chirurgiche, entrambe eseguite con l'ausilio di un microscopio operatorio, che si differenziano sia per il tipo di lame utilizzate che per la direzione del taglio: la prima, cosiddetta ‛russa' (Fjodorov), prevede che il taglio abbia direzione centripeta, cioè le cheratotomie procedono dalla periferia verso il centro della cornea; secondo l'altra, detta centrifuga ‛americana', i tagli procedono invece dal centro verso la periferia. Il numero delle incisioni, ognuna delle quali modifica di -0,70 diottrie la refrazione iniziale, va programmato in rapporto al difetto refrattivo da correggere, tenendo presente che le incisioni successive alle prime 8 influenzano in maniera limitata la modulazione della refrazione. Per la centratura e la marcatura dell'asse visivo, che rappresentano un momento basilare nell'esecuzione di corrette cheratotomie, si utilizza la riflessione corneale: dopo aver invitato il paziente a fissare la luce del microscopio operatorio, l'operatore, osservando con il proprio occhio destro l'occhio destro del paziente (e procedendo allo stesso modo per l'occhio sinistro), marca l'angolo inferomediale della spirale del microscopio, considerata come un rettangolo, riflessa dalla cornea esaminata.
Il risultato finale è influenzato fondamentalmente da 4 fattori principali:
1) diametro e centratura della zona ottica: maggiore è la zona e minore sarà l'effetto di appiattimento della cornea; in genere vengono usati diametri di 4 mm per miopie piccole (tra 2 e 3,25 diottrie), diametri di 3,5 mm per miopie tra 3,25 e 4,25, di 3 mm per miopie tra 4,50 e 5 diottrie;
2) numero delle incisioni: maggiore è il numero delle incisioni, maggiore dovrebbe essere il risultato chirurgico (Salz e altri - v., 1985 - hanno dimostrato che con 8 incisioni si raggiunge il 90% del risultato conseguibile);
3) profondità dell'incisione: dato che la cornea centrale ha spessore inferiore a quello della parte periferica, si possono eseguire incisioni di profondità costante, oppure aumentare la profondità dell'incisione man mano che si procede verso il limbus corneale; l'effetto correttivo si ottiene incidendo più del 90% dello spessore corneale;
4) lunghezza delle incisioni, in genere isometriche: il risultato finale è in rapporto direttamente proporzionale alla lunghezza delle incisioni, che va calcolata in relazione al diametro corneale e alle diottrie miopiche che si desidera eliminare. Per evitare fenomeni di neovascolarizzazione delle cicatrici corneali è opportuno non raggiungere mai il limbus corneale
Complicanze. - Nella pratica della RK possono verificarsi complicanze di tipo funzionale (ottiche) e di tipo organico. Tra le prime includiamo le ipocorrezioni (correggibili con un nuovo trattamento) e le ipercorrezioni, che possono essere determinate da errori nella programmazione chirurgica o da variazioni refrattive, come l'ipermetropia progressiva. Le cause di quest'ultima complicanza, che compare a distanza di circa due anni o più dalla chirurgia con una frequenza non ancora ben quantificata ma non irrilevante, sono ancora sconosciute: si ipotizza una inopportuna protrazione delle modifiche biomeccaniche che sono il razionale della tecnica. La presenza di astigmatismo regolare e irregolare dopo RK (causato da un difetto di cicatrizzazione o da una zona ottica decentrata) costituisce anch'essa una complicanza funzionale, in quanto la trasformazione di un difetto sferico in uno cilindrico non può rappresentare un motivo di soddisfazione per i pazienti. Sono stati inoltre segnalati casi di fotofobia e abbagliamento, in genere fluttuanti, dovuti ad alterazioni dello spessore corneale o a zone ottiche troppo piccole o decentrate, e anche fluttuazioni dell'acuità visiva causate dalla pressione del tessuto palpebrale sul bulbo oculare o dalla tensione endobulbare. Infine, l'abbagliamento (glare), conseguente alla diffrazione dei raggi luminosi attraverso le cicatrici corneali, è in rapporto alla dilatazione della pupilla e all'ampiezza della zona centrale.
Tra le varie complicanze organiche ricordiamo quelle che si manifestano intraoperatoriamente: nel caso di microperforazioni, la procedura chirurgica può essere portata a termine, mentre le macroperforazioni rendono necessario suturare la zona perforata. Nelle incisioni, oltre a flogosi settiche, si possono manifestare alterazioni a carico dell'epitelio, con erosioni precoci e tardive (recidivanti), accompagnate da cisti epiteliali della membrana basale e iperproliferazioni fibroblastiche delle ferite.
Un elemento a sfavore di questa tecnica è rappresentato dalla possibilità che le incisioni corneali determinino un indebolimento strutturale del bulbo oculare, fino al punto di provocarne la rottura per traumi contusivi di non eccessiva rilevanza.
Va comunque rilevato come non tutte le variabili, specie quelle di natura biologica, che influenzano l'esito della RK, siano conosciute, prevedibili e preventivabili; pertanto, medici, biologi, fisiologi, ingegneri, informatici dovrebbero continuare a lavorare per rendere il risultato finale di questa tecnica il più preciso possibile.
d) Chirurgia refrattiva incisionale nell'astigmatismo.
La chirurgia incisionale, oltre alla correzione dei difetti sferici miopici, è stata ed è vantaggiosamente usata anche per il trattamento chirurgico degli astigmatismi di tipo sia congenito che acquisito; recentemente il laser a eccimeri è stato perfezionato in modo da poter correggere anche ametropie astigmatiche.
L'astigmatismo corneale regolare consiste, in essenza, nella differenza di potere refrattivo fra i due meridiani ortogonali principali o secondari della cornea.
Il meccanismo di azione della chirurgia astigmatica si basa sul fatto che qualsiasi incisione corneale non perforante e non suturata provoca una ectasia, o sfiancamento, nella zona di incisione, con un aumento del raggio di curvatura della zona ottica nel meridiano nella zona del taglio, accompagnato da un appiattimento nella zona circostante. È proprio questo l'effetto che viene generalmente utilizzato per la correzione dell'astigmatismo. La forma e l'estensione della zona di appiattimento dipendono da un lato dalla forma, profondità e lunghezza dell'incisione, e dall'altro da caratteristiche tissutali quali elasticità e spessore. Nella correzione della miopia, le incisioni vengono effettuate secondo una disposizione assosimmetrica, e di conseguenza la variazione di curvatura centrale sarà anch'essa assosimmetrica. Se invece le incisioni vengono eseguite in due settori opposti, si otterrà un appiattimento centrale nel meridiano delle incisioni, e se questo meridiano è quello più curvo si avrà come effetto la correzione di un certo grado di astigmatismo.
Per quanto attiene più strettamente alle tecniche chirurgiche vere e proprie, queste possono essere classificate in tecniche cosiddette ‛semplici', per la correzione del solo astigmatismo, e tecniche cosiddette ‛miste', per la correzione di miopie associate ad astigmatismi.
Partendo dalla constatazione che la zona maggiormente sottoposta a sfiancamento in conseguenza di una incisione corneale è quella in corrispondenza del punto centrale dell'incisione stessa, si è passati dalle incisioni radiali, precedentemente illustrate, alle cheratotomie trasversali, in cui la massima zona di sfiancamento è localizzata nel meridiano passante nel mezzo dell'incisione, e che dovrà essere quindi il meridiano più refrangente. In realtà, però, a causa della conformazione corneale, le incisioni trasversali provocano uno sfiancamento disarmonico nella struttura sferica della cornea e, per ovviare a questa limitazione, sono state introdotte le cosiddette cheratotomie curve, a concavità rivolta verso la pulilla, il cui centro dell'arco è il centro della zona ottica.
Le principali variabili che possono alterare i risultati previsti sono correlate alla profondità e ampiezza delle incisioni, al diametro della zona ottica e ad altri parametri, quali l'età del paziente (effetto più marcato dopo i trenta anni) e la pressione endoculare (effetto aumentato oltre i 21-22 mm di Hg). Per la terapia chirurgica di miopie associate ad astigmatismi sono state pertanto effettuate incisioni radiali da un lato e cheratotomie trasversali o curve dall'altro, e anche chirurgia incisionale associata a laser a eccimeri. La massima correzione astigmatica raggiunta con tali metodiche è stimata dai vari autori in circa 5 diottrie, prendendo in considerazione anche l'esecuzione di incisioni trasversali fra cheratotomie radiali convergenti (schema trapezoidale di Ruiz).
Quanto alla scelta del tipo di tecnica, l'indicazione di massima per astigmatismi superiori alle 3 diottrie è rappresentata dalle cheratotomie curve, più efficaci e prevedibili; per valori inferiori, la differenza tra incisioni trasversali e arcuate diventa minima, considerando anche la minore difficoltà esecutiva delle prime.
Le complicanze preoperatorie legate alla chirurgia incisionale astigmatica possono essere causate da una non corretta pachimetria, da imprecisa marcatura, dallo stato dell'epitelio, da inadeguata fissazione del bulbo, da una non perfetta impostazione della profondità di taglio del bisturi. Le complicanze intraoperatorie, invece, possono essere determinate da inconvenienti legati alla manualità del chirurgo, come incisioni praticate al di fuori delle marcature o di forma irregolare (ad es., curve anziché diritte o viceversa). In sede intraoperatoria si possono verificare complicanze ancora più importanti, quali microperforazioni corneali e intersezioni fra incisioni nel caso siano impiegate tecniche miste. Tali evenienze porteranno entrambe a uno sfiancamento localizzato e conseguente astigmatismo irregolare.
In definitiva, i risultati della chirurgia incisionale di tipo astigmatico, se effettuata da operatori esperti, sono lusinghieri per quanto riguarda il trattamento sia di astigmatismi congeniti, sia, soprattutto, di quelli post-traumatici o postchirurgici, in particolar modo dopo cheratoplastica perforante.
e) Chirurgia refrattiva lamellare corneale.
La chirurgia refrattiva lamellare corneale, che rappresenta il filone storicamente più importante della chirurgia refrattiva, si basa sulla possibilità di prelevare e lavorare una lamella complanare di cornea umana. A partire dagli anni cinquanta-sessanta J. I. Barraquer (v., 1958, 1980 e 1986) ha iniziato un lavoro pionieristico di sviluppo della chirurgia lamellare corneale, il cui ambito si è progressivamente esteso dalla iniziale indicazione della afachia (o deprivazione del cristallino) a quello delle ametropie, soprattutto la miopica, che rappresentano percentualmente il numero di gran lunga maggiore dei casi. Anche le strumentazioni e le metodiche di lavorazione del tessuto corneale sono state notevolmente migliorate.
In base al tipo di lavorazione del lembo corneale, che chiaramente dipende dal tipo di difetto da correggere, le tecniche di chirurgia refrattiva lamellare possono dividersi in tecniche per sottrazione o per addizione di tessuto (v. tab. VIII).
Cheratomileusi. - La cheratomileusi è una tecnica di chirurgia refrattiva lamellare corneale per sottrazione di tessuto destinata alla correzione di miopie e ipermetropie elevate. Secondo la metodica chirurgica originale ideata da Barraquer, dalla superficie corneale anteriore del paziente veniva prelevato un lembo di circa metà dello spessore della cornea, che veniva quindi congelato e tornito a freddo per modificarne la curvatura, e poi scongelato e risuturato nella stessa posizione e sulla stessa superficie da cui era stato prelevato.
Soltanto in seguito, con lo sviluppo di strumentazioni sempre più precise e sofisticate, è stata introdotta la variante fresh, nella quale il lembo dopo il prelievo viene lavorato a fresco al microtornio (BKS 1000) e quindi risuturato sulla cornea. Secondo la variante chiamata ‛cheratomileusi in situ', dopo il prelievo della lamella la lavorazione refrattiva viene effettuata direttamente sulla superficie anteriore del tessuto corneale non rimosso, risuturando poi la lamella al proprio posto. La cheratomileusi fresh, dopo un periodo di notevole diffusione nella seconda metà degli anni ottanta, è andata declinando per la notevole complessità e per i rischi connessi alla metodica, nonché per la sua ridotta predittività. Più recentemente, lo sviluppo di una cheratotomia ad avanzamento automatizzato e con funzioni più semplici e riproducibili, unitamente all'uso del laser a eccimeri per sostituire il taglio refrattivo, ha dato un notevole impulso a queste tecniche (note come Automated Lamellar Keratoplasty, ALK, e excimer LASer In situ Keratomileusis, LASIK, rispettivamente), le cui potenzialità sembrano amplissime.
Epicheratoplastica. - La epicheratoplastica, o epicheratofachia, è una metodica ideata da H. E. Kaufman (v., 1980 e 1987; v. Kaufman e Werblin, 1982; v. Kaufman e McDonald, 1984) per la correzione della miopia e della ipermetropia, particolarmente quella conseguente all'afachia; tale metodica è stata in seguito utilizzata anche per la correzione del cheratocono. In precedenza, nei casi di ametropie monolaterali con intolleranza alle lenti a contatto, i due occhi, pur con potenzialità visive elevate, non erano di fatto suscettibili di un miglioramento della funzione per la inaccettabile disparità della correzione ottica spettante ai due lati. Kaufman ebbe l'idea di utilizzare una sorta di lente a contatto organica preparata con tessuto corneale umano, che, una volta ricoperta con l'epitelio del ricevente, era assimilata alla cornea stessa e in grado di fornire al sistema ottico oculare il potere diottrico necessario alla correzione dell'ametropia. Il lenticolo utilizzato può essere lavorato estemporaneamente al microtornio dopo il prelievo (epicheratoplastica fresh) oppure dopo congelamento (epicheratoplastica freeze) e quindi liofilizzato e conservato, per essere poi reidratato prima dell'innesto sulla cornea ricevente. La prima fase della metodica chirurgica originale per la miopia e l'afachia con lenticolo freeze consiste nella disepitelizzazione della superficie corneale previo marcamento del centro ottico, seguita da trapanazione anulare della cornea per uno spessore di 0,2 mm e da scolpimento di una tasca circolare nel parenchima, destinata ad accogliere l'ala del lenticolo refrattivo. Il lenticolo, opportunamente reidratato e posizionato sulla cornea ricevente, viene suturato con la sua ala nella tasca predisposta, quindi rapidamente ricoperto dall'epitelio della cornea ospite e alcuni mesi dopo viene ripopolato dai cheratociti e dalle fibre nervose provenienti anch'essi dal ricevente. Nella variante fresh, il lenticolo viene preparato a fresco lavorando con un microtornio (BKS 1000) sul versante posteriore della lamella a facce parallele prelevata dalla cornea donatrice, alla quale viene così fornito il profilo idoneo alla correzione desiderata.
Nella variante della epicheratoplastica destinata alla correzione del cheratocono di stadio intermedio, senza cicatrici apicali, la correzione dell'astigmatismo irregolare viene ottenuta mediante la regolarizzazione meccanica del profilo anteriore corneale (v. fig. 27): a tale scopo si utilizza un lenticolo freeze privo di potere refrattivo che, dopo disepitelizzazione, trapanazione e cheratectomia circolare, viene suturato in tensione sulla superficie corneale del ricevente. I bordi palpebrali devono essere temporaneamente suturati (blefarorrafia) fino a epitelizzazione ultimata, dopodiché il lenticolo, analogamente a ciò che accade nella epicheratoplastica refrattiva, viene ripopolato dai cheratociti e dalle fibre nervose del ricevente.
Il recupero visivo in questi casi è solitamente inferiore a quello ottenibile con le lenti corneali, per fenomeni di interfaccia e di insufficiente regolarizzazione del profilo corneale, ma la chirurgia, a differenza dei sistemi ottici tradizionali, consente solitamente di bloccare la progressività del cheratocono, senza precludere la possibilità di eseguire successivamente un trapianto corneale.
Le complicanze di questa chirurgia sono sostanzialmente limitate all'immediato periodo post-operatorio; in particolare, risulta cruciale per la riuscita dell'intervento il ricoprimento epiteliale del lenticolo in tempi brevi. Deficit epiteliali persistenti, di non raro riscontro nelle metodiche freeze, possono infatti condurre a sofferenza trofica del lembo che può esitare in ipotrasparenza o addirittura in melting, o colliquazione del lembo stesso, probabilmente per attivazione di enzimi litici (collagenasi) stromali. Per tale ragione nel periodo post-operatorio vengono di norma utilizzati presidi per facilitare l'avanzata epiteliale, quali la blefarorrafia e la somministrazione di farmaci ad applicazione topica dotati di capacità di stimolo sulla mitosi (Epidermal Growth Factor, EGF) e di inibizione delle collagenasi (acetilcisteina). Tra le possibili cause del melting, che rappresenta comunque la più temibile complicanza di questa chirurgia, vi è probabilmente anche la qualità intrinseca del lenticolo, che proviene al chirurgo liofilizzato e accreditato solo dalla certificazione del laboratorio.
La epicheratoplastica per la correzione della miopia, a causa della notevole instabilità del risultato refrattivo, non ha mai ottenuto l'approvazione della Food and Drug Administration statunitense, ed è stata ben presto abbandonata. Ciò ha comportato la totale interruzione della lavorazione e commercializzazione dei lenticoli da parte delle industrie, che sono guidate unicamente dalla logica del profitto; di conseguenza, questa metodica per la correzione dell'afachia, dopo aver avuto un periodo di notevole diffusione sul finire degli anni ottanta, è stata forzatamente interrotta e resa obsoleta.
Cheratofachia. - La cheratofachia rappresenta una variante di chirurgia refrattiva lamellare per la correzione dell'afachia tramite apposizione di tessuto: nello spessore corneale del ricevente viene inserito un lembo di tessuto corneale omologo opportunamente sagomato, previa rimozione dalla cornea ricevente di una lamella corneale che viene infine risuturata al proprio posto. Tale metodica, per gli scarsi risultati refrattivi e visivi, è stata ben presto abbandonata e ha oggi unicamente un interesse storico.
f) Chirurgia refrattiva mediante laser.
Da molto tempo si è cercato di utilizzare fonti di energia laser di varia lunghezza d'onda allo scopo di modificare il potere diottrico corneale, ma pochissimi tentativi hanno superato la fase di sperimentazione preclinica; a tutt'oggi solamente il laser a eccimeri con emissione a 193 nm è arrivato ad avere un impiego clinico, anche se finora la Food and Drug Administration ha approvato il suo impiego solo nella cheratectomia fototerapeutica (PTK), che non ha peraltro scopi refrattivi. Il laser a eccimeri in chirurgia refrattiva corneale, pur se impiegato soltanto per la correzione di difetti sferici miopici inferiori alle 6 diottrie, viene considerato a tutt'oggi una tecnica in fase sperimentale, in quanto ancora non si sono raggiunti i 10 anni di esperienza sull'uomo. Le uniche approvazioni per la chirurgia refrattiva, limitatamente alla correzione di ametropie miopiche comprese fra -1,5 e -6 diottrie, sono state concesse ai laser a grande spot Summit (novembre 1995) e VisX (ottobre 1996). In realtà, la procedura invade proprio l'asse visivo e non sappiamo ancora quali possano essere le conseguenze a lungo termine della deprivazione della membrana di Bowman. Tutte le altre possibili applicazioni dei laser in chirurgia refrattiva corneale sono ancora ben lontane dall'essere approvate per l'uso clinico.
I laser a eccimeri (EXCIted diMER, dimero eccitato) rappresentano una famiglia di laser che utilizza come elemento attivo un gruppo di miscele gassose altamente instabili formate dall'insieme di gas nobili e alogeni; ciascuna miscela si caratterizza per una specifica lunghezza d'onda di emissione (v. tab. XIII) e per un livello energetico peculiare che risulta, comunque, estremamente elevato in tutte le emissioni.
Il tipo di dimero utilizzato in chirurgia refrattiva è il fluoruro di argon (ArF), la cui specifica lunghezza d'onda di emissione (193 nm) risulta posizionata nell'ultravioletto lontano (UV-C) ed è quindi al di fuori dello spettro visibile. Questa radiazione ha una elevatissima energia (9,6 × 10-19 J = 6 eV) che, per la sua lunghezza d'onda, viene assorbita elettivamente (assorbimento > 98%) dal tessuto corneale, dove produce una reazione fotochimica in grado di rompere i legami covalenti (anche C-C); tale reazione determina l'espulsione a elevatissima velocità di frammenti submicroscopici di tessuto senza produrre effetti termici apprezzabili a carico delle strutture adiacenti e senza determinare fenomeni cavitazionali (effetto fotoablativo). La luce laser a 193 nm viene assorbita da tutte le strutture a elevata densità di atomi di carbonio, ma poiché l'H2O libera assorbe il 100% dell'energia, è impossibile usare questo laser su superfici bagnate. Per la sua elevata energia, la luce che esso emette non può essere trasportata in fibra ottica ma deve essere trasmessa, previa defocalizzazione, con sistemi a riflessione (specchi e prismi) per essere focalizzata solamente al momento di fuoriuscita dall'apparato, il che consente di conferire alla lama di luce diverse morfologie, a seconda dell'impiego che se ne vuole fare e del principio di funzionamento che si vuole imporre all'apparecchio; gli apparecchi attualmente in uso sono o ‛a scansione' o ‛a spot'.
Principî fondamentali di funzionamento di un laser a eccimeri. - Nella pratica clinica, per poter ridurre il potere diottrico della cornea (correzione della miopia) occorre aumentare il raggio di curvatura della convessità corneale operando una riduzione concentrica di tessuto con asportazione maggiore nel centro (zona ottica) che non in periferia (ablazione ‛ad anfiteatro'). Per correggere un difetto di curvatura asimmetrico - che agisce, cioè, in maniera diversa sui due diametri ortogonali (astigmatismo) - l'azione del laser dovrà invece comportare la rimozione selettiva di tessuto solo sull'asse più curvo e non sull'asse ortogonale. Viceversa, per aumentare il potere diottrico della cornea occorre diminuirne il raggio di curvatura in zona ottica, operando una asportazione di tessuto, in modo decrescente dalla periferia verso il centro, nella zona paracentrale (ablazione ‛a tronco di cono'). Per ottenere questi diversi tipi di impatto della luce laser con la superficie corneale è possibile agire con particolari diaframmi interni o esterni alla macchina, oppure interponendo tra il fascio luminoso e la superficie corneale delle strutture di materiale asportabile dalla luce laser e che abbiano il profilo dell'asportazione di tessuto che si vuole ottenere (maschere ablabili).
La prima generazione di laser a eccimeri per uso oftalmologico è nata nella prima metà degli anni ottanta con lo scopo di produrre incisioni (v. Trokel e altri, 1983), mentre nell'uomo le prime applicazioni con ablazioni di superficie (PRK) risalgono alla fine degli anni ottanta (v. Trokel e altri, 1983; v. Marshall e altri, 1986; v. Seiler e altri, 1988; v. McDonald e altri, 1990). Si trattava di apparecchiature estremamente complesse e delicate, che richiedevano numerose operazioni di calibrazione e che potevano essere usate con una accettabile ripetibilità e solo a livello sperimentale su animali o su occhi non vedenti.
Risale al 1988 la prima macchina utilizzata per sperimentazioni su occhi umani (non vedenti) e all'anno successivo il prototipo delle macchine utilizzate nella pratica clinica. La notevole evoluzione delle due modalità fondamentali di emissione (spot e scansione), verificatasi all'incirca tra il 1987 e il 1991, ha condotto alla commercializzazione, pressoché contemporanea, di tre diverse apparecchiature per la correzione di difetti miopici semplici, due delle quali basate sulla tecnologia di emissione a spot, e una sull'emissione a scansione mediante diaframmi esterni alla macchina.
Applicazioni del laser a eccimeri in chirurgia refrattiva. - La proposta di Trokel si basava sulla dimostrazione che l'alta energia fotonica dell'UV-C possiede la peculiare capacità di effettuare tagli così precisi e senza danno per le aree adiacenti da rendere possibile sezionare una singola cellula senza distruggerla o collassarla, non solo nel caso di tagli lineari, ma anche nelle ablazioni di superficie. Questa assoluta precisione ha per la prima volta consentito di intervenire con il laser a eccimeri anche nella zona centrale della cornea (zona ottica, usata per la visione) per correggere piccoli difetti refrattivi; infatti, la lieve entità dei fenomeni riparativi conseguenti alla fotoablazione, guidata e controllata con adeguata terapia farmacologica, fornisce una eccellente garanzia per la conservazione della trasparenza del diottro corneale. Per tale motivo e per la facilità di interporre diaframmi a parzializzazione centrifuga (o centripeta) fra raggio laser e cornea, le prime procedure messe a punto sperimentalmente (v. Trokel e altri, 1983) e utilizzate clinicamente (v. Seiler e altri, 1990 e 1993; v. Seiler e Wollensak, 1991) sono state quelle di cheratectomia fotorefrattiva (PRK) miopica per il trattamento di difetti miopici semplici (cioè non associati ad astigmatismo). In una prima fase della sperimentazione clinica, il trattamento ha riguardato zone ottiche abbastanza ridotte (4-4,5 mm) che però presentavano una sensibile incidenza di complicazioni sia oggettive che soggettive. Con il perfezionamento delle apparecchiature e l'incremento delle conoscenze sul processo di guarigione si è cercato di ampliare la zona di trattamento (5, 6 e 6,5 mm) e si sono modificati i controlli di gestione sul diaframma, così da poter trattare più zone ottiche, con zone di transizione che potessero minimizzare le complicazioni ottiche e funzionali. I perfezionamenti strumentali e clinici hanno, di conseguenza, ampliato le possibilità applicative di questo laser nelle correzioni miopiche: nella sperimentazione preclinica, avvenuta sotto il controllo della FDA (1989-1991), venivano trattate esclusivamente miopie semplici inferiori a 5 diottrie; negli studi successivi la soglia di trattamento è variata, a seconda delle macchine utilizzate, tra 6 diottrie (Summit) e 10 diottrie (VisX e Meditec), fino ad arrivare a possibilità correttive prossime alle 15 diottrie con le macchine di ultima generazione. La percentuale di successo del risultato è di circa il 95%, con un'incidenza di complicanze molto ridotta.
Da circa 4 anni sono iniziate le sperimentazioni cliniche e le applicazioni nella pratica clinica quotidiana della correzione dell'astigmatismo miopico, sia semplice che associato a difetti sferici miopici; attualmente, gli apparecchi di ultima generazione consentono di eseguire trattamenti fotoablativi agenti sull'asse di maggior curvatura corneale mediante la regolazione del raggio laser ottenuta con appositi diaframmi (interni negli apparati a spot, interni ed esterni negli apparecchi a scansione). I trattamenti dei difetti astigmatici associati ai difetti miopici vengono eseguiti in maniera sequenziale in tutti gli apparecchi di ultima generazione dotati di gestione computerizzata dei diaframmi interni, mentre nei laser di generazioni precedenti o forniti di diaframmi esterni la correzione del difetto richiede più trattamenti (sempre nella stessa seduta), con maggior rischio di alterazione della centratura.
I limiti entro i quali le più recenti apparecchiature possono correggere difetti miopici con o senza astigmatismo sono, teoricamente, intorno alle 10 diottrie (8-10 diottrie, a seconda delle macchine), anche se per mantenere la percentuale di successo del risultato intorno al 90-95% occorre abbassare tale soglia alle 6 diottrie e soprattutto seguire accurati criteri di selezione del paziente (v. tab. XIV) e una scelta comparativa delle metodiche (v. tab. XV). Come si evidenzia da quest'ultima tabella, l'89% dei chirurghi appartenenti alla International Society of Refractive Keratoplasty ritiene la cheratomileusi intrastromale con laser a eccimeri la tecnica più idonea per correggere difetti miopici di entità superiori a -6 diottrie.
Per quanto riguarda i trattamenti di fotoablazione dei difetti ipermetropici, tendenti ad aumentare il potere diottrico corneale in senso sia sferico che cilindrico, va ricordato che, seppure in fase di studio e sperimentazione preclinica da vari anni, al momento attuale non si hanno risultati tali da consentire lo sviluppo di una sperimentazione clinica controllata.
L'intervento è di semplice esecuzione: al paziente supino viene instillato un anestetico di contatto e coperto l'occhio controlaterale. La cornea viene disepitelizzata in un'area di circa 6 mm e asciugata; assicurata l'immobilità del bulbo facendo fissare al paziente una mira di riferimento o tramite anello a suzione, si cura la centratura, controllata mediante microscopio. Si avvia allora l'azione del laser computer-assistito che scolpisce gradualmente la cornea secondo l'algoritmo prescelto, a un ritmo di circa 15 secondi per ciascuna diottria da correggere. Nelle apparecchiature di più recente progettazione sono stati approntati dei sistemi di autoricentramento del fascio laser sulla superficie della cornea (eye tracker) in grado di consentire un trattamento sempre perfettamente centrato sull'asse ottico. L'occhio viene tenuto bendato per 3-5 giorni.
Problemi post-operatori nella fotoablazione. - La necessità di regolare il processo cicatriziale in modo che non si producano zone o cicatrici abnormi o risultati refrattivi non precisi rispetto a quelli programmati è apparsa, fin dalle prime fasi della sperimentazione preclinica, come un problema fondamentale; si è pertanto cercato di comprendere e di guidare il processo riparativo utilizzando varie classi di farmaci. I farmaci antiproliferativi, che sembravano i più efficaci per questo scopo, hanno però mostrato numerosi effetti collaterali a causa della loro tossicità a carico dell'epitelio corneale, e pertanto il loro impiego non ha avuto alcuna applicazione clinica. Grande efficacia hanno invece mostrato i farmaci corticosteroidei somministrati localmente a dosi piuttosto massicce (nella fase iniziale) e prolungatamente nel tempo, seguendo un protocollo che prevede una lentissima diminuzione delle dosi, proporzionalmente all'andamento della refrazione; il loro impiego è risultato estremamente efficace nel modulare il processo di guarigione e nel controllare il raggiungimento dell'obiettivo refrattivo programmato dopo la tipica iniziale fase di ipercorrezione. Tuttavia, è noto da tempo che la loro prolungata somministrazione topica può deteminare un aumento della pressione intraoculare (con prevalenza del 25-35% in soggetti geneticamente determinati), peraltro quasi sempre ben controllabile con appositi farmaci e sempre reversibile con la sospensione della terapia.
Per evitare inopportuni problemi di ipertono sono state sperimentate anche molecole antinfiammatorie non steroidee (FANS), che pur avendo mostrato una ottima capacità nel controllare le componenti dolorifica (tipica delle 24 ore successive al trattamento) e infiammatoria del processo riparativo, presentano una efficacia sensibilmente minore nel controllo della componente plastica riparativa (deposizione di neocollagene e proliferazione fibroblastica); ciò può causare regressione (ricomparsa della miopia) e opacizzazioni corneali centrali (haze) che rappresentano le principali cause di risultati visivi insoddisfacenti.
Decorso post-operatorio e complicanze. - La guarigione clinica dopo un intervento di PRK (associato o meno a cheratectomia astigmatica) presenta tre fasi ben distinte che si realizzano, orientativamente, nella prima settimana, entro il secondo mese ed entro il quarto-sesto mese dal trattamento. La prima fase di guarigione consiste nel ripristino di una superficie epiteliale continua e compatta che ricoprirà la zona che il laser ha rimodellato: la pellicola epiteliale neoformata, inizialmente costituita da un monostrato cellulare, in seguito si stratifica per riassumere, entro 15-20 giorni, lo spessore e la stratificazione propria dell'epitelio corneale (80-120 micron di spessore, 6-8 strati). Durante le fasi di riformazione del monostrato cellulare è sconsigliabile la somministrazione di farmaci che interferiscano con la proliferazione cellulare (corticosteroidi), mentre appaiono molto indicati farmaci antinfiammatori e/o analgesici topici (FANS o cicloplegici).
La seconda fase di guarigione, definita stromale, si presenta estremamente variabile: essa dipende sia dalla tecnica operatoria, sia dalle macchine utilizzate, ma soprattutto dalle capacità cicatriziali e dalla reattività tissutale del paziente. In questa fase, comunque, si osservano le maggiori variazioni di refrazione, con una fase di ipercorrezione immediatamente post-operatoria, che nell'arco di 30-90 giorni tende a decrescere assestandosi, in oltre il 95% dei casi, entro le 0,5 diottrie dall'obiettivo dopo circa 60-90 giorni dal trattamento.
La terza fase, o fase di stabilizzazione refrattiva, raramente si prolunga oltre il sesto mese dal trattamento e, pur mostrando fenomeni di rimodellamento epiteliale e stromale, è normalmente priva di fenomeni plastici. In questa fase, la diminuzione graduale della terapia farmacologica fino alla sospensione deve essere condotta dallo specialista con estrema cautela onde evitare, per incauta fretta, la riaccensione di fenomeni plastici con conseguente regressione del risultato. I risultati refrattivi e funzionali sono estremamente incoraggianti e, a titolo di esempio, su una casistica di 390 occhi trattati dal gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Oftalmologiche dell'Università degli Studi di Siena fra il gennaio 1991 e il gennaio 1995, si sono riscontrati solamente 3 casi di ipocorrezione superiore a 1 diottria in pazienti che abbiano seguito correttamente la terapia, e in nessun caso si è avuta una opacità corneale interferente con il visus.
In termini di complicanze occorre ricordare la già citata incidenza di ipertoni iatrogeni, peraltro sempre ben controllabili da oftalmologi esperti. Altra complicanza frequente riportata in letteratura è il mancato raggiungimento dell'obiettivo, per la ricomparsa di difetti miopici o la incompleta correzione di difetti astigmatici; nella maggioranza dei casi, tuttavia, queste evenienze si producono in pazienti che non hanno eseguito la terapia medica come da prescrizione, ed è allora frequente la comparsa di aree di opacità sottoepiteliali (segno di collagene neodeposto e di iperattività fibroblastica) che possono interferire con l'acuità visiva del paziente (talvolta dovuta anche a una sua abnorme capacità cicatriziale). Ben più gravi, anche se fortunatamente molto rare, sono le opacità di tipo cicatriziale leucomatoso, che richiedono l'asportazione chirurgica (ritrattamento con laser a eccimeri-cheratectomia fototerapeutica, oppure, nei casi più profondi e importanti, cheratoplastica perforante). Sono talvolta riferiti disturbi funzionali, quali alonatura attorno alle sorgenti luminose o visione sdoppiata, da ricollegare prevalentemente a trattamenti con zone ottiche eccessivamente piccole o marcatamente decentrate.
(Gli autori ringraziano Stefano Baiocchi, Fabrizio Casprini, Carlo Cerboni, Paolo Frezzotti, Claudio Manetti, Felice Menicacci, Claudia Sforzi, Carlo Simi e Claudio Traversi per la collaborazione prestata nella stesura dell'articolo).
BIBLIOGRAFIA
Barraquer, J. I., Método para la talla de injertos laminares en cornea congelada. Nueva orientación para la cirugía refractiva, in ‟Archivos de la Sociedad Americana de Oftalmología y Optometría", 1958, I, 3, pp. 1-19.
Barraquer, J. I., Queratomileusis y queratofaquía, Bogotà 1980.
Barraquer, J. I., Basis of refractive keratoplasty, in ‟Archivos de la Sociedad Americana de Oftalmología y Optometría", 1986, VI, pp. 21-68.
Barron, B. A., Prosthokeratoplasty, in The cornea (a cura di H. E. Kaufman), New York 1988, pp. 787-803.
Berman, E. R., Biochemistry of the eye, London 1990.
Binder, P. S., Selective suture can reduce post keratoplasty astigmatism, in ‟Ophthalmology", 1985, XCII, pp. 12-14.
Bores, L. D., Refractive eye surgery, Cambridge, Mass., 1993.
Caporossi, A., Baiocchi, S., Manetti, C., Frezzotti, R., Diclofenac versus clobetasone nella terapia postoperatoria della PRK, in Atti dell'XI congresso della Società Italiana di Laserterapia, Roma 1996.
Caporossi, A., Frezzotti, R., Manetti, C., Our experience in the treatment of keratoconus using epikeratophakia, in Cataract and refractive microsurgery (a cura di A. E. Maumenee, W. J. Stark e I. Esente), Milan 1989, pp. 277-282.
Cardona, H., Prosthokeratoplasty, in ‟Cornea", 1983, II, pp. 179-183.
CCTS (Collaborative Corneal Transplantation Studies research group), Effectiveness of histocompatibility matching in high risk corneal transplantation, in ‟Archives of ophthalmology", 1992, CX, pp. 1391-1399.
Davson, H., Physiology of the eye, London 1990.
Falcinelli, G. C., Osteoodontokeratoprosthesis today and its future prospects, relazione al KPRO Study Group Bascon Palmer Eye Institute, Miami, Flo., 1992.
Fjodorov, S. N., Durssen, V. V., Anterior keratotomy method application with the purpose of surgical correction of myopia, in Problems of ophthalmosurgery, New York 1977, pp. 47-48.
Frangieh, G. T., Kwitko, S., McDonnel, P. J., Prospective cornealtopographic analysis in surgery for post-keratoplasty astigmatism, in ‟Archives of ophthalmology", 1991, CIX, pp. 506-510.
Frezzotti, R., Immunological problems in corneal transplants, in ‟Impact of science on society", 1981, XXXI, pp. 185-197.
Frezzotti, R., Caporossi, A., Pennarola, F., Baiocchi, S., Epicheratofachia con tessuto fresco e liofilizzato: comparazione dei risultati anatomici e funzionali nella epicheratofachia fresh e freeze in pazienti afachici, in ‟Contattologia medica e chirurgia refrattiva", 1989, X, 2, pp. 57-68.
Gartry, D. S., Treating myopia with the excimer laser: the present position, in ‟British medical journal", 1995, CCCX, pp. 979-985.
Kaufman, H. E., The correction of aphakia, in ‟American journal of ophthalmology", 1980, LXXXIX, 1, pp. 1-10.
Kaufman, H. E., Refractive surgery, in ‟American journal of ophthalmology", 1987, CIII, 3, pp. 355-357.
Kaufman, H. E., Corneal transplant optics and visual disability, in ‟Refractive and corneal surgery", 1989, V, pp. 213-215.
Kaufman, H. E., McDonald, M. B., Refractive surgery for aphakia and myopia, in ‟Transaction of the Ophthalmological Society of the United Kingdom", 1984, CIV, pp. 43-47.
Kaufman, H. E., Werblin, T. P., Epikeratophakia for the treatment of keratoconus, in ‟American journal of ophthalmology", 1982, XCIII, 3, pp. 342-347.
Khodadoust, A., Silverstein, A. M., Transplantation and rejection of individual cell layers of the cornea, in ‟Investigative of ophthalmological sciences", 1969, VIII, pp. 180-195.
Krumeich, J. H., Indications, techniques and complications of myopic keratomileusis. Refractive corneal surgery: the correction of aphakia, hyperopia and myopia, Boston 1983.
Krumeich, J. H., Keratomileusis, keratophakia and keratokyphosis, in ‟Transaction of the Ophthalmological Society of the United Kingdom", 1984, CIV, pp. 48-51.
Krumeich, J. H., Swinger, C. A., Non freeze epikeratophakia for the correction of myopia, in ‟American journal of ophthalmology", 1987, CIII, pp. 397-408.
Lindquist, T. D., McGlothan, J. S., Rothis, W. D., Chandler, J. W., Indications for penetrating keratoplasty 1980-1988, in ‟Cornea", 1991, X, pp. 210-216.
McDonald, M. B., Frantz, Y. M., Klyce, S. D., Central photorefractive keratectomy for myopia, in ‟Archives of ophthalmology", 1990, CVIII, pp. 220-228.
Manalis, N., Craig, M. T., Coulter, V. L., Lundergan, M. K., Olson, R. J., Penetrating keratoplasty: 1981-1988 clinical indications and pathologic findings, in ‟Journal of cataract and refractive surgery", 1991, XVII, pp. 163-167.
Marshall, J., Trokel, S., Rothery, S., Photoablative reprofiling of the cornea using an excimer laser: photorefractive keratectomy, in ‟Lasers and light in ophthalmology", 1986, I, pp. 21-48.
Merlin, U., Correzione dell'astigmatismo secondario, in ‟Atti della Società Oftalmologica Meridionale", 1989, XXIII, pp. 313-317.
Mishima, S., Clinical investigation on the cornea endothelium, in ‟Ophthalmology", 1982, LXXXIX, pp. 525-530.
Paufique, L., Sourdille, G. P., Offret, G., Les greffes de la cornée, Paris 1948.
Pintucci, F., Pintucci, S., New keratoprosthesis, in ‟New trends in ophthalmology", 1991, VI, pp. 215-221.
Rama, G., Chirurgia della cornea, Milano 1993.
Riss, I., Astigmatisme dans les greffes de la cornée, in ‟Journal français d'ophthalmologie", 1991, XIV, pp. 36-45.
Salz, J. J., Rowsey, J. J., Coroline, P., A study of optical zone size and incision. Redeepening in experimental radial keratotomy, in ‟Archives of ophthalmology", 1985, CIII, pp. 590-594.
Seiler, T., Bende, T., Wollensak, J., Trokel, S., Excimer laser keratectomy for correction of astigmatism, in ‟American journal of ophthalmology", 1988, CV, pp. 117-124.
Seiler, T., Genth, U., Holschbach, A., Derse, M., Aspheric photorefractive keratectomy with excimer laser, in ‟Refractive and corneal surgery", 1993, IX, pp. 650-658.
Seiler, T., Gunter, K., Kriegerowski, M., Excimer laser (193nm) myopic keratomileusis in sighted and blind human eyes, in ‟Refractive and corneal surgery", 1990, VI, pp. 165-173.
Seiler, T., Wollensak, J., Myopic photorefractive keratectomy with the excimer laser. One year follow-up, in ‟Ophthalmology", 1991, XCVIII, pp. 1156-1163.
Sharif, K. W., Casey, T. A., Penetrating keratoplasty for keratoconus: complications and long-term success, in ‟British journal of ophthalmology", 1991, LXXV, pp. 142-146.
Strampelli, B., Osteo-odontocheratoprotesi, in ‟Annali di oftalmologia e clinica oculistica", 1963, LXXXIX, pp. 1039-1044.
Strampelli, B., Intervento per osteo-odonto-cheratoprotesi, in Trattato di tecnica chirurgica (a cura di B. Boles Carenini), vol. X, Torino 1984, pp. 362-382.
Trokel, S. L., Srinivasan, R., Braren, B., Excimer laser surgery of the cornea, in ‟American journal of ophthalmology", 1983, XCVI, pp. 710-715.
Tuft, S. J., Coster, D. J., The corneal endothelium, in ‟Eye", 1990, IV, pp. 389-424.
Volker-Dieben, H. G., Kok-Van Alphen C. C., Lansbergen, Q., Perjn, G. G., The effect of corneal prospective HLA matching on corneal survival, in ‟Acta ophthalmologica", 1982, LX, pp. 203-212.
Waring, G. O. III, Development and evaluation of refractive surgical procedures. Part I, Five stages in the continuum of development. Part II, Pratical implementation of formal clinical trials, in ‟Journal of refractive surgery", 1987, III, pp. 142-157 e 173-184.
Waring, G. O. III, The 50 year-epidemic of pseudophakic corneal edema, in ‟Archives of ophthalmology", 1989, CVII, pp. 657-659.
Waring, G. O. III, Bourne, W. M., Edelhauser, H. F., Kenyon, K. R., The corneal endothelium: normal and pathologic structure and function, in ‟Ophthalmology", 1982, LXXXIX, pp. 531-589.
Waring, G. O. III, Hanna, K. D., The Hanna suction block and trephine system for penetration keratoplasty, in ‟Archives of ophthalmology", 1989, CVII, pp. 1536-1538.
Werblin, T. P., A prospective study of the use of hyperopic epikeratophakia grafts for the correction of aphakia in adults, in ‟Ophthalmology", 1981, LXXXVIII, 11, pp. 1137-1140.
Werblin, T. P., Epikeratophakia: the surgical correction of aphakia, in ‟Archives of ophthalmology", 1981, XCIX, pp. 1957-1960.
Werblin, T. P., Lamellar refractive surgery: where have we been and where are we going?, in ‟Refractive and corneal surgery", 1989, V, pp. 167-176.
Werblin, T. P., Kaufman, H. E., Friendlander, M. H., Epikeratophakia: the surgical correction of aphakia, in ‟American journal of ophthalmology", 1980, LXXXIX, pp. 916-920.
Chirurgia della sordità di Carlo Zini
SOMMARIO: 1. Introduzione: a) definizione; b) evoluzione storica; c) fattori di progresso della chirurgia della sordità negli ultimi decenni. 2. Richiami anatomo-funzionali dell'apparato uditivo: a) elementi di anatomia topografica dell'osso temporale; b) elementi di fisiologia. 3. Sordità: a) definizione e classificazione; b) cause e meccanismi delle ipoacusie di trasmissione. 4. Fondamenti tecnici per la ricostruzione dell'apparato di trasmissione: a) premessa; b) canalplastiche; c) miringoplastiche; d) ossiculoplastiche; e) stapedioplastiche; f) tuboplastiche; g) valutazione dei risultati. 5. Attuali indicazioni per la chirurgia della sordità: a) microchirurgia dell'otosclerosi; b) microchirurgia dei processi infiammatori dell'orecchio medio e dei loro esiti; c) chirurgia delle malformazioni congenite maggiori (atresia maior); d) altre indicazioni. 6. Impianti cocleari e nucleari. 7. Preservazione della funzione uditiva nell'otoneurochirurgia. □ Bibliografia.
1. Introduzione
a) Definizione.
La chirurgia della sordità (detta anche ‛cofochirurgia' o, con termine più moderno, ‛microchirurgia della sordità') è una branca superspecializzata della moderna chirurgia otologica e otoneurologica che include tutti gli interventi tesi a migliorare la funzione uditiva. Tuttavia, secondo un'interpretazione più estensiva, e anche più corretta, l'ambito di questa chirurgia può arrivare a comprendere le tecniche volte a evitare di danneggiare le strutture dell'apparato uditivo - preservandone la funzione - nel corso di interventi effettuati per guarire i processi patologici a carico di tale apparato o per accedere a regioni profonde dell'osso temporale, della base cranica o delle formazioni endocraniche: si tratta, in questa accezione più ampia, di una vera microchirurgia funzionale uditiva, che include ormai quasi tutti gli interventi di otologia e di otoneurochirurgia.
Per ragioni di spazio, nella nostra esposizione adotteremo un criterio intermedio, tratteremo cioè più dettagliatamente tutti quegli interventi che hanno lo scopo di migliorare la funzione uditiva del paziente, fornendo invece solo brevi cenni relativi a quelli il cui scopo è di conservare una funzione uditiva socialmente utile in pazienti altrimenti destinati alla sordità totale.
b) Evoluzione storica.
La chirurgia otologica, nata in Europa nella seconda metà del secolo scorso, ha avuto per quasi un secolo lo scopo principale di salvare, quando possibile, la vita dei pazienti affetti da gravi complicanze endocraniche e di prevenire tempestivamente il loro sviluppo o la comparsa di altre complicanze dei processi infettivi dell'orecchio medio. Si trattava, quindi, di una chirurgia, spesso d'urgenza e sempre demolitiva, delle strutture affette, esente da riguardi particolari per la funzione uditiva. L'avvento dei sulfammidici e degli antibiotici ha determinato il radicale cambiamento della chirurgia otologica, che da vitale è diventata sempre più funzionale.
I primi tentativi di chirurgia della sordità risalgono comunque alla seconda metà del secolo scorso, per merito di autentici ‛pionieri', costretti a lavorare in condizioni di estrema difficoltà: infatti, da un lato operavano su strutture di pochi millimetri situate nella profondità del condotto uditivo esterno, con il campo operatorio illuminato unicamente dai raggi solari riflessi da uno specchio forato e, attraverso questo, osservato a occhio nudo; dall'altro, non avevano la possibilità, data la scarsità delle ancora limitate conoscenze microbiologiche e la mancanza di mezzi adeguati, di fronteggiare le infezioni post-operatorie. Malgrado tutto, alcuni otochirurghi, nel tentativo di migliorare l'udito dei loro pazienti, ebbero l'intuizione di mobilizzare o estrarre la staffa bloccata da processi infiammatori od otosclerotici.
Il primo tentativo di mobilizzazione della staffa fu operato in Italia da E. De Rossi nel 1871: si trattava però di una mobilizzazione indiretta, ottenuta mediante disarticolazione dell'incudine bloccata da una staffa già mobile (v. De Rossi, 1878). La prima vera mobilizzazione di una staffa, bloccata da aderenze timpanosclerotiche fra le branche e i bordi della fossa ovale, fu operata nel 1875 da J. Kessel, che successivamente eseguì anche la stapedectomia e osò addirittura ‛violare' il labirinto, considerato fino ad allora un limite invalicabile per il chirurgo.
Numerosi clinici, soprattutto in Francia, si avventurarono sulla strada di questa nuova chirurgia che sembrava veramente dare grandi speranze di riacquistare l'udito ai pazienti affetti da sordità anche gravi. I risultati, talvolta entusiasmanti, erano però il più delle volte incostanti, parziali, di durata limitata; soprattutto, gli operati andavano incontro spesso a complicanze, come l'infezione cronica in orecchi sani prima dell'intervento, e talvolta alla perdita totale dell'udito accompagnata da gravi sindromi vertiginose, più o meno prolungate. Si verificarono anche complicanze endocraniche severe, seguite da morte di pazienti. Sorsero pertanto accanite discussioni per divergenza di opinioni non solo sulle complicanze e sui risultati, ma anche sulle indicazioni, ancora ben lontane dall'essere codificate. Al Congresso internazionale di medicina di Roma del 1894 alcuni autorevoli chirurghi - come E. Moure, A. Politzer, F. Siebemann, R. Botey, V. Cozzolino - condannarono aspramente la chirurgia della sordità, condanna che venne poi sancita ufficialmente nel 1900 al Congresso internazionale di medicina di Parigi dai due autorevoli relatori Siebemann e Botey. Si chiudeva così la prima fase della chirurgia della sordità, e in particolare dell'otosclerosi, con giudizi contrastanti circa il suo futuro.
Diversi anni più tardi, nel 1929, sulla scorta di alcuni sporadici esempi chirurgici che avevano dimostrato come l'apertura del labirinto posteriore potesse permettere un recupero, almeno temporaneo, dell'udito negli otosclerotici (v. Barany e Scott, 1910; v. Jenkins, Otosclerosis..., e The treatment..., 1914; v. Holmgren, 1923), M. Sourdille presentò alla Societé de Laryngologie des Hôpitaux de Paris una comunicazione su ‛una nuova tecnica operatoria per il trattamento della sordità di trasmissione' e nel 1935, in una relazione al Congresso nazionale francese, riportò i risultati su 109 casi operati. Tale tecnica prevedeva la creazione di una nuova finestra labirintica sul canale semicircolare laterale che metteva in comunicazione con il condotto uditivo esterno, interrompendo la catena ossiculare (v. Sourdille, 1930 e 1931). L'intervento di Sourdille, pur essendo eseguito in due o tre tempi, ebbe ampia diffusione in vari paesi e divenne noto col nome di ‛fenestrazione'. Poco dopo, J. Lempert (v., 1938) pubblicò come nuova e personale - e senza neppure citare Sourdille - una tecnica basata sullo stesso principio, ma eseguita in un sol tempo e per via endoauricolare anziché per via retroauricolare. La semplificazione e la codificazione effettuate da Lempert, e in seguito da G. E. Shambaugh (v., 1942), determinarono una larga diffusione della fenestrazione; per una ventina di anni tale tecnica, coronata da successi sempre più sicuri e duraturi grazie anche all'avvento degli antibiotici, diventò il trattamento chirurgico di elezione della sordità otosclerotica.
Agli inizi degli anni cinquanta comincia una terza fase della chirurgia della sordità otosclerotica, grazie anche al perfezionamento del microscopio operatorio, oltreché alla piena disponibilità degli antibiotici. Mentre la mobilizzazione della staffa riproposta da S. Rosen (v., 1953) è seguita ancora, come ottant'anni prima, da risultati incostanti e limitati nel tempo, M. Portmann in Francia (v. Portmann e Claverie, 1957) e J. Shea (v., 1958) negli Stati Uniti riscoprono la stapedectomia, cioè la riapertura della finestra labirintica primaria (la finestra ovale) nella sua sede naturale; tale tecnica, già tentata fra molte polemiche da G. Cornelli (v., 1949) in Italia, veniva però completata con la ricostruzione della catena degli ossicini mediante un nuovo collegamento dell'incudine con il lembo di vena posto a chiusura della finestra ovale (interposizione), per proteggere il labirinto e per favorire la formazione di una membrana al posto della platina (base della staffa).
Si giunge così all'era più recente e attuale della chirurgia della sordità, che si arricchisce nello stesso periodo dei nuovi trattamenti chirurgici funzionali dei processi infiammatori e distrofici dell'orecchio medio e dei loro esiti, cioè delle timpanoplastiche, per opera dei tedeschi F. Zollner (v., 1955) e H. Wullstein (v., 1960).
Si è fatto rapidamente cenno alle principali tappe storiche che hanno rappresentato le premesse alla nascita e allo sviluppo della moderna microchirurgia, che, pur essendosi evoluta dalla chirurgia otologica, è stata in seguito utilizzata con successo anche in altre branche specialistiche.
c) Fattori di progresso della chirurgia della sordità negli ultimi decenni.
L'evoluzione e il progresso registrati negli ultimi decenni nel campo della chirurgia della sordità sono stati favoriti da una serie di fattori, dei quali alcuni di ordine generale, influenti cioè su tutte le branche della chirurgia, altri peculiari della chirurgia otologica.
Tra i primi debbono essere considerati: 1) la disponibilità di una sempre più ampia copertura antibiotica, in grado di assicurare un ottimo decorso post-operatorio e di scongiurare le complicanze infettive; 2) il progresso delle tecniche anestesiologiche ed emostatiche, grazie alle quali la durata dell'intervento non ha praticamente alcuna rilevante incidenza sulle condizioni del paziente; 3) il perfezionamento delle tecniche chirurgiche di trapianti e impianti, con l'utilizzazione di materiale biologico autogenico, allogenico o xenogenico, o di materiale biocompatibile, di largo impiego anche in chirurgia otologica (v. chirurgia dei trapianti, vol. VIII; v. Maffei e Zini, 1972; v. Zini e altri, 1986); 4) l'introduzione nel materiale chirurgico della colla di fibrina - un collante biologico derivato dal sangue impiegato per la sua attività emostatica, collante e biostimolante - che consente di solidarizzare i vari elementi ricostruttivi tra loro e con le pareti delle cavità in cui sono contenuti.
I fattori di progresso peculiari della chirurgia otologica sono identificabili nella creazione dei laboratori di dissezione dell'osso temporale e nella nascita e nel perfezionamento di mezzi tecnici particolari. I laboratori di dissezione dell'osso temporale, attrezzati con microscopi, trapani, aspiratori, irrigatori e strumentari uguali a quelli impiegati nelle sale chirurgiche, hanno permesso ai primi chirurghi di passare decine, centinaia di ore a perfezionare le loro conoscenze anatomiche, ad addestrarsi ripetendo più volte sul pezzo anatomico isolato gli interventi da eseguire poi sul vivente, ad apportare continui miglioramenti alle tecniche in uso e a metterne a punto di nuove. Grazie allo sviluppo tecnologico, sono stati messi a punto e perfezionati strumenti e microstrumenti che hanno consentito un enorme progresso delle tecniche chirurgiche. Ricordiamo di seguito alcune delle più importanti attrezzature attualmente impiegate in microchirurgia otologica.
Il microscopio operatorio a visione stereoscopica e a illuminazione coassiale consente una perfetta visione, anche in profondità, del campo chirurgico e, grazie al variatore di ingrandimenti (da 6 a 40 ×), la manipolazione di strutture molto piccole e l'uso di microstrumenti appositamente studiati per ogni intervento: bisturi, uncini, scollatori di varia forma e angolatura, cucchiai, pinze, forbici, frese, cannule aspiranti di sicurezza che evitano l'effetto ventosa nei tessuti (v. Brackmann e altri, 1994). Questo fondamentale strumento, che ha reso accessibili agli otochirurghi molte aree dell'osso temporale e delle regioni peritemporali prima considerate inaccessibili e ha permesso di manipolare con facilità strutture molto piccole come gli ossicini dell'orecchio medio (in particolare la staffa, che misura solo pochi millimetri), è stato messo a punto nei primi anni cinquanta: pertanto, solo dalla metà di questo secolo la chirurgia otologica e otoneurologica è diventata una vera microchirurgia. L'impiego del microscopio operatorio, e quindi lo sviluppo delle tecniche microchirurgiche, si sono poi diffusi dall'otologia all'oculistica, alla neurochirurgia, alla chirurgia vascolare e del sistema nervoso periferico, ad altri campi dell'otorinolaringoiatria (microchirurgia endonasale, dei seni paranasali, della rinofaringe, della laringe, della parotide, ecc.). Per visualizzare al microscopio le strutture normali o patologiche non visibili direttamente, perché nascoste dalle pareti del condotto uditivo e della cassa timpanica o comunque da formazioni non divaricabili, è stata introdotta (v. Zini, 1967) una serie di tre microspecchietti (di 3, 4 e 6 mm) in acciaio inossidabile malleabile, mettendo così a punto la tecnica di osservazione nota come ‛microtimpanoscopia indiretta'.
I trapani con micromotori elettrici o pneumatici collocati nell'impugnatura sono dotati di manipoli retti e angolati che possono montare frese di vario calibro, lunghezza e superficie abrasiva; in particolare, per la chirurgia della staffa è stata messa a punto una microfresa particolarmente sottile, funzionante a pila (v. Causse e Causse, 1984).
I sistemi di irrigazione e aspirazione continua facilitano il lavaggio continuo del campo durante la fresatura: gli aspiratori sono dotati di un controllo a pedale e di vari sistemi di sicurezza prossimali e distali.
Il sistema di coagulazione bipolare permette una microcoagulazione in profondità senza diffusione della corrente alle strutture vicine, ed è molto utile soprattutto nella chirurgia della base cranica e in quella endocranica.
I vari sistemi laser applicati alla chirurgia otologica si sono rivelati particolarmente utili negli interventi sulla staffa.
Lo sviluppo della videoendoscopia a fibre ottiche ha reso disponibili endoscopi rigidi e flessibili sempre più sottili, in grado di penetrare perfino nella tuba fino all'orecchio medio, che sono entrati ormai nel bagaglio tecnico della microchirurgia otologica.
Le recenti tecniche di monitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici e di altre strutture nervose e muscolari sono derivate dall'applicazione alla microchirurgia otologica e otoneurologica di strumenti da tempo in uso in elettrofisiologia sperimentale e diagnostica, gli elettrostimolatori e i registratori dei potenziali elettrici che si liberano durante l'attività delle strutture nervose e muscolari. Di particolare importanza sono il monitoraggio del nervo facciale e quello della funzione uditiva; per quanto riguarda quest'ultimo, stimolando il recettore cocleare con suoni e registrando i potenziali elettrici cocleari, del nervo uditivo, dei nuclei e delle vie cocleari centrali è possibile tenere sotto controllo la funzionalità dell'apparato uditivo durante interventi a rischio per la funzione uditiva stessa (chirurgia dell'orecchio interno, del condotto uditivo interno e dell'angolo ponto-cerebellare). Ancora più utilizzato è il monitoraggio continuo del nervo facciale, ancora a rischio di subire lesioni nel corso di molti interventi sull'osso temporale e a livello dell'angolo ponto-cerebellare, sia pure con minori probabilità rispetto all'era pre-microchirurgica: il monitoraggio rivela in tempo reale, acusticamente e graficamente, le più piccole contrazioni dei muscoli innervati dal facciale, le quali sono il primo effetto di stimolazioni di tipo meccanico, termico, anossico, elettrico, sul tronco del nervo. Pertanto, il monitoraggio facciale permette di allertare il chirurgo sul pericolo di lesioni prima che queste si instaurino. L'impiego dello stimolatore elettrico consente, inoltre, la rapida e precisa localizzazione del decorso del nervo. I metodi più in uso per rivelare le contrazioni dei muscoli mimici innervati dal facciale sono quello elettromiografico e quello pneumatico (Myo alarm). Quest'ultimo è stato messo a punto presso la clinica otorinolaringoiatrica di Parma e, data la sua semplicità e rapidità di installazione, trova larga applicazione, oltre che negli interventi otoneurologici, anche nella chirurgia dell'orecchio medio.
2. Richiami anatomo-funzionali dell'apparato uditivo
a) Elementi di anatomia topografica dell'osso temporale.
L'osso temporale su cui opera l'otochirurgo è una delle zone anatomicamente più complesse e delicate del corpo umano, poiché racchiude in uno spazio molto ristretto non solo tutte le parti periferiche dell'apparato uditivo e dell'apparato vestibolare, costituite da strutture estremamente miniaturizzate, precise e delicate, ma anche formazioni, altrettanto delicate e importanti, in stretto rapporto con gli organi neurosensoriali.
L'orecchio, classicamente, si divide in tre parti: orecchio esterno e orecchio medio, interamente al servizio dell'apparato uditivo; orecchio interno, o labirinto, nel quale sono contenuti gli organi sensoriali sia dell'apparato uditivo che dell'apparato vestibolare. L'orecchio esterno è costituito dal padiglione auricolare e dal condotto uditivo esterno. L'orecchio medio è una cavità contenuta nello spessore dell'osso temporale, la cui porzione più importante è la cavità timpanica, normalmente ripiena di aria che vi penetra attraverso la tromba di Eustachio, un piccolo condotto - in parte osseo, in parte membranoso - che la mette in comunicazione con la rinofaringe. La parete laterale della cavità timpanica è costituita quasi interamente dalla membrana timpanica, inserita su un segmento osseo anulare del temporale denominato anulus timpanicus; nella parte superiore della cavità timpanica vi è un recesso, chiamato ‛attico' o ‛loggetta degli ossicini', nel quale sono contenuti il corpo del martello e dell'incudine. La loggetta degli ossicini è separata dal meato acustico esterno da una sottile lamina ossea, detta ‛muro della loggetta'. La parete mediale della restante porzione della cavità timpanica, detta cassa timpanica, presenta una depressione, la fossa ovale, ove si apre la finestra ovale, colmata dalla platina o base della staffa; al di sotto di questa, in un'altra depressione, si apre la finestra rotonda, chiusa da una membrana. Questa parete è in rapporto con la porzione media e anteriore dell'orecchio interno, formata dal vestibolo e dalla chiocciola. La parete mediale dell'attico è in rapporto con la porzione timpanica del nervo facciale e con la parte posteriore del labirinto, composta dai canali semicircolari. La parete superiore, o tegmen timpani, è costituita da una sottile lamina ossea che separa la cavità timpanica dalla fossa cranica media, contenente il lobo temporale del cervello. La parete posteriore, o mastoidea, presenta, a livello della loggetta degli ossicini, un'apertura, il cosiddetto aditus ad antrum, che mette in comunicazione la cavità timpanica con una cavità principale, detta ‛antro', e numerosissime cellule ossee rivestite di mucosa e contenenti aria, che formano le cosiddette ‛cavità paratimpaniche' (mastoide e paramastoide-petrosa). La parete anteriore, o tubarica, è occupata dall'apertura della tromba di Eustachio, che poi si continua con la porzione ossea della tuba, detta protimpano, al di sotto della quale è situata l'arteria carotide interna. La parete inferiore è in rapporto col golfo della vena giugulare interna da cui è separata da un sottile strato osseo.
Il nervo facciale, che innerva tutti i muscoli mimici della faccia, trasporta varie altre fibre afferenti (quelle specifiche del gusto, provenienti dalla parte anteriore della lingua) ed efferenti (dirette alle ghiandole lacrimali e salivari sottomandibolari e alla mucosa nasale); è l'unico, fra i nervi cranici, che per fuoriuscire dalla base cranica passa non attraverso un foro ma attraverso una ‛galleria', il canale di Falloppio, lungo circa 2,5 cm, a decorso tortuoso, interamente contenuto nell'osso temporale.
L'arteria carotide interna, fondamentale per l'apporto sanguigno al cervello, per entrare dal collo nella cavità endocranica passa per circa 2,5 cm in un canale proprio, interamente scavato nell'osso temporale, in stretto rapporto con la tuba di Eustachio e con la coclea.
Il seno sigmoideo e il successivo golfo della vena giugulare interna - massimo scarico venoso del cervello, del tronco dell'encefalo e del cervelletto - si trovano ai limiti posteriori e inferiori dell'osso temporale, e pertanto molte vie d'accesso otologiche e otoneurologiche profonde sono condizionate dalla loro presenza.
L'osso temporale costituisce poi una delle parti essenziali della base cranica, in quanto separa la fossa cranica posteriore, contenente il cervelletto e buona parte del tronco dell'encefalo, dalla fossa cranica media, contenente il lobo temporale del cervello. Data questa collocazione topografica dell'osso temporale, la sua patologia e la relativa chirurgia sconfinano spesso nell'endocranio in sede extradurale (fra la dura madre e l'osso) o intradurale, cioè negli spazi liquorali e nelle altre meningi (aracnoide e pia madre), nonché nelle strutture del sistema nervoso centrale.
b) Elementi di fisiologia.
Da un punto di vista anatomo-funzionale, l'apparato uditivo è schematicamente costituito da: a) un apparato di trasmissione del suono; b) un sistema di trasduzione dell'energia meccanica vibratoria in energia nervosa; c) un apparato neurale di trasferimento dell'energia nervosa ai centri dell'apparato uditivo; d) un apparato centrale di decodificazione in sensazione acustica. L'apparato di trasmissione è essenzialmente costituito dal condotto uditivo esterno, dalla membrana del timpano e dalla catena ossiculare. Le vibrazioni della membrana timpanica, provocate dai suoni convogliati dal condotto uditivo esterno, sono trasmesse ai tre ossicini (martello, incudine e staffa), articolati tra loro, e tramite questi alla finestra ovale del labirinto, nella quale vibra la base o ‛platina' della staffa. La funzione dell'apparato è quella di trasportare le vibrazioni sonore da un mezzo aereo a un mezzo solido (sistema timpano-ossiculare) e successivamente a uno liquido (liquidi labirintici), concentrando l'energia sonora sulla finestra ovale e proteggendo al tempo stesso l'altra finestra labirintica, la finestra rotonda. La concentrazione dell'energia sonora avviene principalmente sulla base del rapporto di superficie fra membrana timpanica e platina della staffa, che consente un incremento della pressione sonora per unità di superficie di circa 18 volte.
Di fondamentale importanza nella fisiologia dell'orecchio medio è non solo la presenza di strutture (membrana timpanica e catena ossiculare) che agiscono come sistema di trasmissione e concentrazione dell'energia sonora, ma anche la differenza di fase tra le onde sonore trasmesse alla finestra ovale e le variazioni di pressione comunicate dal liquido endococleare alla finestra rotonda: la presenza delle due finestre è infatti necessaria per consentire all'onda di trasmettersi in un mezzo liquido all'interno di una camera ossea incomprimibile come la coclea. L'onda di pressione che si viene a creare nella perilinfa della rampa vestibolare comporta movimenti ondulatori della membrana basilare della coclea, che ne determinano la massima deformazione in un punto caratteristico per ogni frequenza di stimolazione. Questo meccanismo è alla base della discriminazione della frequenza, o lunghezza d'onda, del suono che ha stimolato in quell'istante la coclea. Esiste infatti nella coclea una localizzazione tonotopica longitudinale delle frequenze, come sulla tastiera di un pianoforte, ma in senso inverso, poiché i toni acuti sono distribuiti nel giro basale (iniziale) e quelli gravi nel giro apicale (finale) della coclea. Sulla ‛tastiera' della coclea sono rappresentati tutti i suoni udibili, dagli acutissimi (16 mila vibrazioni al secondo, o 16 mila hertz) ai più gravi (16 hertz); i suoni al di sopra delle frequenze udibili sono detti ‛ultrasuoni', quelli al di sotto ‛infrasuoni'.
La trasduzione dei suoni in impulsi nervosi viene effettuata dall'organo del Corti, un organo estremamente delicato, costituito da particolari cellule sensoriali ciliate, che poggia uniformemente sulla membrana basilare (vibrante) per tutta la lunghezza della coclea. Esso ha la forma di un tubo (canale cocleare) e contiene l'endolinfa, un liquido di composizione diversa da quello presente nelle due rampe (timpanica e vestibolare) della coclea, chiamato perilinfa. L'onda acustica deforma, in modo proporzionale all'intensità del suono, la membrana basilare e quindi l'organo del Corti. Questa deformazione determina, sempre in modo proporzionale all'ampiezza, una modificazione del potenziale delle cellule sensoriali e questa, a sua volta, fa partire, con l'intermezzo di un mediatore chimico che funge da neurotrasmettitore, una scarica di impulsi nelle fibre del nervo acustico, le cui terminazioni sono in rapporto con la membrana delle cellule sensoriali stesse. La scarica è costituita di impulsi elettrici tutti uguali fra di loro, di brevissima durata (200-300 millisecondi), la cui frequenza (variabile da uno a mille al secondo) è proporzionale alla differenza di potenziale che si è creata nella cellula e quindi, in definitiva, all'intensità del suono.
In tal modo a livello dell'organo del Corti si verifica la trasformazione in senso analogico-digitale di un fenomeno ondulatorio meccanico in un fenomeno elettrico, così che il numero totale degli impulsi che partono dai vari punti della coclea per raggiungere i centri nervosi uditivi esprime l'intensità del suono. Il nervo acustico costituisce poi l'elemento neurale che trasferisce l'energia nervosa che si è generata ai nuclei cocleari e, da questi, alle vie acustiche centrali. Il trasferimento dei potenziali uditivi ai centri corticali avverrebbe: 1) per quanto riguarda la frequenza, attraverso fibre selezionate secondo un criterio topografico; 2) per quanto riguarda l'intensità, secondo un criterio numerico (frequenza degli impulsi e numero di fibre nervose messe in funzione). La decodificazione in sensazione acustica, l'integrazione e la memorizzazione del messaggio sonoro avvengono a livello corticale.
Questi basilari elementi di fisiologia dell'apparato uditivo possono aiutare a meglio comprendere alcuni problemi di fisiopatologia e soprattutto di chirurgia ricostruttiva dell'orecchio medio (v. anche udito, vol. VII).
3. Sordità
a) Definizione e classificazione.
Qualsiasi menomazione della funzione uditiva, di vario grado, è generalmente definita ipoacusia (o sordità parziale); nei casi di perdita completa della funzione si parla di sordità totale. Ai fini clinici l'apparato uditivo si divide in apparato di trasmissione e apparato di percezione; quest'ultimo, a sua volta, si differenzia in apparato recettoriale e in apparato nervoso uditivo (nervo acustico, nuclei e vie uditive centrali).
Le ipoacusie si suddividono, a seconda della sede della lesione, in tre categorie principali: 1) di trasmissione, dovute ad alterazioni dell'orecchio esterno e medio e delle finestre labirintiche (apparato di trasmissione); 2) di percezione, dovute a lesioni dell'orecchio interno, del nervo e delle vie uditive centrali (apparato di percezione); 3) miste, per lesioni che interessano contemporaneamente gli apparati di trasmissione e di percezione. Le ipoacusie (sordità) di percezione si suddividono a loro volta in recettoriali o cocleari, se sono causate da lesioni dell'orecchio interno, e retrococleari, dipendenti da lesioni a carico dell'apparato nervoso uditivo.
Con la chirurgia è possibile correggere solo i difetti dell'apparato di trasmissione, e quindi migliorare o ripristinare totalmente la funzione in caso di ipoacusie di trasmissione; in caso di ipoacusie di tipo misto è possibile recuperare chirurgicamente la componente trasmissiva. Le lesioni dell'apparato di percezione possono invece essere corrette solamente mediante le protesi elettroacustiche, sempreché vi sia un residuo uditivo utilizzabile.
Il caso estremo di sordità, la sordità totale bilaterale, costituisce un grave handicap per i pazienti, soprattutto per i bambini al di sotto dei due anni di età, nei quali, poiché privati delle afferenze acustiche, non si sviluppa il linguaggio (sordomutismo): in questi casi, né la chirurgia, né le protesi tradizionali risultano efficaci.
Negli ultimi anni si è però aperta una nuova concreta possibilità di riabilitazione anche per questi pazienti. Sono infatti state messe a punto e applicate nella pratica clinica protesi elettroniche molto sofisticate (impianti o protesi cocleari), che stimolano direttamente le terminazioni nervose del nervo acustico per mezzo di elettrodi, che vengono collocati chirurgicamente all'interno della coclea attraverso la finestra rotonda. Le informazioni che queste nuove protesi forniscono al paziente sono ancora rudimentali rispetto a quelle di una coclea normale; esse permettono, tuttavia, un'efficace riabilitazione non solo degli adulti, ma anche dei bambini, che possono così sviluppare o migliorare il proprio linguaggio. Questa tecnica costituisce la più grande innovazione degli ultimi anni nel campo della riabilitazione delle sordità e il primo esempio di impianto definitivo di un organo artificiale nell'uomo. In Italia, fin dal 1981 sono stati costituiti i primi centri per gli impianti cocleari, tra cui quello di Parma, che tuttora incontrano però grosse difficoltà per l'applicazione di questo apparato su larga scala, soprattutto per il suo costo elevato, che il Servizio Sanitario Nazionale si rifiuta talvolta di sostenere.
Da quanto detto, si comprende come sia importante la diagnosi precoce e differenziale delle varie ipoacusie o sordità. Questa può essere formulata nei casi più semplici dai singoli specialisti in otorinolaringoiatria; i casi più complessi vengono indirizzati presso i centri di audiologia, che dispongono di attrezzature diagnostiche più sofisticate e complete per eseguire gli esami di audiometria tonale liminare, sopraliminare e vocale, di impedenzometria, di audiometria obiettiva (elettrococleografia, potenziali evocati del tronco encefalico, otoemissioni acustiche, ecc.). Gli esami audiologici permettono non solo di diagnosticare a ogni età la sede e la gravità della perdita uditiva, ma anche di individuarne il momento eziopatogenetico e quindi di porre l'indicazione terapeutica più appropriata: medica, chirurgica, protesica o riabilitativa.
b) Cause e meccanismi delle ipoacusie di trasmissione.
Una riduzione della capacità uditiva può essere dipendente da lesioni del condotto uditivo esterno, quali l'occlusione del suo lume o le alterazioni più o meno gravi delle sue pareti: si tratta di lesioni conseguenti a malattie infiammatorie, traumi, tumori o malformazioni, la più importante delle quali è certamente la mancanza congenita del condotto uditivo esterno (atresia), associata quasi sempre all'agenesia o malformazione del padiglione.
L'alterazione più frequente della membrana timpanica è la sua perforazione parziale o totale, determinata talvolta da traumi diretti, traumi cranici, barotraumi, ma, nella maggioranza dei casi, da otiti medie, acute o croniche, e dai loro esiti. La perforazione della membrana timpanica, oltre a comportare una ipoacusia, costituisce la porta di ingresso di nuove infezioni, specie in occasione di penetrazione di acqua nell'orecchio. Talvolta il processo infiammatorio, invece di causare una perforazione della membrana, può determinare un deposito di sali di calcio nello spessore della stessa membrana (miringosclerosi), che risulta quindi irrigidita, con una diminuita capacità vibrante.
Le alterazioni della catena ossiculare possono essere causate da vari processi patologici che possono condurre alla sua fissità o alla sua interruzione e talvolta alla sua completa distruzione, come avviene frequentemente nel colesteatoma. Anche nel caso delle lesioni ossiculari, le cause più comuni sono rappresentate dai traumi, dalle malformazioni congenite e dai processi infiammatori dell'orecchio medio: otiti medie acute e croniche (purulente semplici o colesteatomatose), timpanosclerosi, atelettasia (mancanza d'aria nella cavità timpanica, generalmente conseguente ad alterazioni tubariche). In caso di interruzione o fissità completa della catena ossiculare (anche se la membrana timpanica è integra) o di assenza totale dell'apparato timpano-ossiculare, si ha un'ipoacusia di trasmissione che raggiunge i 60 decibel (il decibel, dB, è l'unità audiometrica per l'intensità del suono: un dB è la più piccola differenza di intensità percepibile dall'uomo): nelle suddette condizioni, infatti, il suono raggiunge contemporaneamente le due finestre, ovale e rotonda, in concordanza di fase e di intensità, e non è quindi in grado di penetrare nella coclea. Se supera i 60 dB, tuttavia, il suono può raggiungere ugualmente la coclea per via ossea (ossa del cranio, capsula labirintica, perilinfa): nell'indagine audiometrica si sfrutta questo fenomeno per stimolare direttamente la coclea per via ossea con un opportuno vibratore, saltando completamente l'apparato di trasmissione.
Una causa molto frequente di ipoacusia o sordità di trasmissione nei bambini è rappresentata dall'otite sieromucosa (od otite media secretiva), una patologia sostenuta da una disfunzione complessa, non ancora completamente chiarita. La sua insorgenza è favorita, nella maggioranza dei casi, dall'ostruzione dell'ostio rinofaringeo della tuba a opera di un'ipertrofia della tonsilla faringea (adenoidi), associata a una eccessiva secrezione di muco più o meno denso da parte delle ghiandole della mucosa dell'orecchio medio, che aumentano di numero per metaplasia. L'accumulo di questa secrezione (versamento endotimpanico) è la conseguenza di una sproporzione tra quantità e densità del muco e capacità della tuba di operarne il drenaggio. Questa condizione patologica deve essere diagnosticata e curata precocemente, in quanto può evolvere verso altre forme di otite cronica e portare a esiti permanenti nell'apparato uditivo. Negli stadi precoci l'alterazione più importante è il versamento sieromucoso più o meno denso nella tuba, nella cassa timpanica o in tutto l'orecchio medio, con conseguente ipoacusia di trasmissione quasi sempre bilaterale. La diagnosi, fortunatamente, è molto semplice e si effettua con l'esecuzione del timpanogramma, esame innocuo che può essere praticato anche ai bambini: in caso di versamento nella cassa timpanica il timpanogramma risulta piatto. La terapia (medica, termale, chirurgica), precocemente instaurata, è nella grande maggioranza dei casi molto efficace.
Una malattia del tutto particolare, che comporta ipoacusia o sordità progressiva accompagnata da acufeni, dovuta a fissità della staffa, è costituita dall'otosclerosi. Si tratta di una distrofia della capsula labirintica con neoproduzione di osso circostante la finestra ovale e quindi la staffa. Le sue cause non sono ancora individuate, ma certamente sono in gioco fattori ereditari e ormonali. Questa malattia, oltre a determinare la rigidità della staffa, può interessare molto spesso l'orecchio interno, forse per la liberazione di sostanze tossiche (otosclerosi stapedio-cocleare); tuttavia l'intervento chirurgico (stapedioplastica) permette il recupero totale o subtotale della perdita uditiva in oltre il 95% dei casi.
Come già accennato, causa di ipoacusia o di sordità di trasmissione può essere il colesteatoma, costituito da una specie di cisti epidermica, formatasi per la penetrazione nell'orecchio medio della pelle del condotto uditivo esterno oppure per la proliferazione di germi epiteliali rimasti inclusi per errore nell'orecchio medio stesso durante lo sviluppo embriologico. È, dopo i tumori, la condizione patologica più grave dell'orecchio medio, perché espone il paziente a complicazioni (paralisi del facciale, perdita completa dell'udito e vertigini, meningite, ecc.) e può rappresentare per il chirurgo un difficile impegno, quando invade certi recessi difficilmente raggiungibili. Inoltre, tende a recidivare con una certa frequenza, specie nei bambini, o per lo sviluppo di piccoli frammenti lasciati inavvertitamente in situ dal chirurgo (colesteatomi residui), o per il ripristinarsi delle condizioni originarie della penetrazione dell'epidermide del condotto uditivo nell'orecchio medio (colesteatoma ricorrente).
4. Fondamenti tecnici per la ricostruzione dell'apparato di trasmissione
a) Premessa.
Per risolvere i principali problemi ricostruttivi dell'orecchio esterno e medio - allo scopo di ripristinare la funzione di quell'apparato di trasmissione che, in pratica, contribuisce per metà alla capacità uditiva globale dell'uomo - sono state messe a punto particolari procedure tecniche, praticabili isolatamente o in associazione tra di loro nei vari tipi di timpanoplastiche. Queste procedure sono rappresentate da: 1) canalplastiche (CPL), consistenti nella correzione o nella ricostruzione del condotto uditivo esterno; 2) miringoplastiche (MPL), consistenti nella riparazione parziale o nella sostituzione totale della membrana timpanica; 3) ossiculoplastiche (OPL), consistenti nella ricostruzione parziale o totale della catena ossiculare sulla staffa mobile o sulla sola platina mobile; 4) stapedioplastiche (SPL), consistenti nella ricostruzione o nella sostituzione della staffa; 5) tuboplastiche (TBPL), consistenti nell'ampliamento o nella ricostruzione della tuba di Eustachio ossea (protimpano e istmo).
Per l'esecuzione di tali interventi sono attualmente disponibili materiali biologici provenienti dallo stesso paziente (autotrapianti), o prelevati da cadavere (allotrapianti) o da animali (xenotrapianti): si tratta generalmente della fascia del muscolo temporale, della membrana timpanica e della catena ossiculare nei prelievi da cadavere, di osso e di cartilagine prelevati dallo stesso paziente o provenienti da donatori o da animali. Gli allotrapianti, e soprattutto gli xenotrapianti, per essere resi compatibili con il ricevente e non provocare quindi la reazione di rigetto, devono essere sottoposti a particolari trattamenti fisici e chimici. Peraltro, in particolare le cartilagini costali e la vena giugulare di vitello (Parmatymp) presentano il grande vantaggio di poter essere conservate per lunghi periodi e di costituire pertanto vere e proprie ‛bioprotesi' disponibili in ogni momento e per qualunque tipo di intervento (v. Zini e altri, 1986).
b) Canalplastiche.
Con questo termine si intendono tutte quelle manovre chirurgiche atte a modificare o a ricostruire parzialmente o totalmente il condotto uditivo esterno (CUE), la cui funzione, come si è detto, è quella di convogliare le onde sonore dall'ambiente esterno alla membrana timpanica. Il CUE normale è formato da uno scheletro, in parte cartilagineo e in parte osseo, e da un rivestimento di cute che si assottiglia progressivamente dall'esterno verso l'interno; il suo lume e la sua forma sono molto variabili da individuo a individuo. Dal punto di vista funzionale la sua ampiezza non risulta di particolare importanza: anche un condotto filiforme, ma pervio, può permettere un udito pressoché normale e un condotto molto ampio non aumenta la capacità uditiva.
L'ampiezza ideale del condotto è comunque compresa entro certi limiti minimi e massimi: al di sotto di un certo calibro il canale uditivo esterno può ostruirsi facilmente per ritenzione di cerume, di squame, o per infiammazione del rivestimento cutaneo, condizioni tutte facilitate dal cattivo ricambio dell'aria e dalle difficoltà di una corretta pulizia; al contrario, un CUE troppo ampio - come può risultare dopo interventi chirurgici demolitivi, quali le radicali e le timpanoplastiche aperte - può creare ugualmente problemi di ordine estetico e infiammatorio, ed essere causa di vertigini per variazioni brusche della temperatura ambientale, come nel passaggio da un ambiente caldo a uno freddo, o per penetrazione di acqua fredda durante una doccia o un bagno in mare o in piscina. Nella canalplastica si tende a realizzare un canale uditivo esterno di medie dimensioni, ben esplorabile e ripulibile, rivestito da un'epidermide piuttosto sottile. La CPL può costituire tutto l'intervento oppure un tempo di un intervento più complesso.
L'indicazione alla CPL semplice è essenzialmente rappresentata dalla stenosi od obliterazione totale o subtotale del lume del CUE, dovuta a: 1) malformazione congenita, minore o maggiore; 2) esostosi ostruenti; 3) tumori benigni; 4) cicatrici ostruenti o deformanti conseguenti a traumi o esiti impropri di precedenti interventi. L'intervento si esegue in anestesia generale o locale, e la via d'accesso può essere endocanalare semplice, endocanalare allargata (o endaurale) o retroauricolare, a seconda della patologia e dell'età del paziente. Si procede all'ampliamento delle pareti ossee per mezzo della fresa, e il rivestimento epidermico preesistente viene utilizzato per ricoprire il nuovo condotto. Se le aree scoperte sono cospicue vengono rivestite con innesti liberi di cute prelevata dietro il padiglione o all'inguine. È importante realizzare un sistema di tamponamento idoneo a prevenire infezioni e retrazioni cicatriziali.
La canalplastica eseguita per atresia maior è un intervento molto complesso ed è associato quasi sempre ad altri interventi, come la miringoplastica e/o l'ossiculoplastica.
Il problema ricostruttivo maggiore è quello del rivestimento cutaneo, che viene realizzato sia con lembi peduncolati che aiutano a formare il meato, sia con lembi liberi di cute retroauricolare o inguinale (v. anche chirurgia plastica, vol. X). L'inconveniente più frequente è la tendenza alla stenosi per rigenerazione ossea, per formazione di cicatrici connettivali o per granulazioni dovute spesso a infezioni. In questi casi può essere necessario intervenire nuovamente, una o più volte. La CPL, come tempo della timpanoplastica, si pratica quasi sempre in corso di timpanoplastica chiusa (ampliamento del CUE per calibratura di una o più pareti), sia per avere un miglior accesso all'orecchio medio, sia per creare un condotto ben aereato e ben controllabile. In questi casi di solito non sono necessari trapianti cutanei, perché i lembi peduncolati che si preparano lungo la via d'accesso assicurano una buona riepitelizzazione delle parti scoperte ed eventualmente della membrana timpanica.
Il problema è più complesso quando esistono più o meno ampie erosioni delle pareti ossee del condotto uditivo esterno, dovute alla patologia o praticate dal chirurgo per necessità curative, ed è di massimo grado nelle grosse distruzioni provocate dai colesteatomi o da pregressi interventi demolitivi (radicali e timpanoplastiche aperte): l'intervento in questi ultimi casi comporta anche la ricostruzione della membrana timpanica e della catena ossiculare e viene denominato ricostruzione dell'orecchio medio (ROM).
La ricostruzione parziale, necessaria di solito nella chirurgia del colesteatoma per evitare la recidiva a causa del formarsi di tasche cutanee di retrazione, si può eseguire con cartilagine prelevata nello stesso paziente (autogena) o proveniente da altri individui (allogenica), oppure con polvere d'osso impastata con colla di fibrina (Bone-paté), materiale quest'ultimo da noi preferito.
Per la ben più ampia ricostruzione di tutta la parete posteriore del condotto uditivo esterno sono stati sperimentati vari materiali biologici (osso, cartilagine) o non biologici (materie plastiche, metalli): la nostra esperienza, statisticamente valutata di recente su 280 casi, ci induce a preferire la cartilagine costale allogenica, perché consente la ricostruzione di qualsiasi breccia, con estrema precisione ed efficacia. Tuttavia, di recente stiamo sperimentando, in collaborazione con J. Magnan, protesi in titanio, metallo caratterizzato da ottima biocompatibilità e già impiegato largamente in altre specialità: se i risultati saranno almeno pari a quelli ottenuti con la cartilagine costale si potrà avere a disposizione una protesi preformata, evitando così il prelievo da cadavere e la conservazione della cartilagine. Tutti questi materiali ricostruttivi devono sempre essere ricoperti prima con tessuti connettivali e poi con la cute (v. Magnan e altri, 1996).
c) Miringoplastiche.
Perché possa svolgere la sua doppia funzione - di ‛barriera anatomica' fra condotto uditivo esterno e orecchio medio, e di membrana vibrante, capace di captare le onde sonore e trasferirle alla catena ossiculare - la membrana timpanica (MT) deve essere sufficientemente resistente alle infezioni e agli sbalzi di pressione, ma allo stesso tempo sottile e mobile. Essa è costituita da uno strato connettivale, che è la vera parte vibrante, rivestito all'interno da una sottile mucosa e all'esterno da una sottile epidermide.
L'intervento di miringoplastica (MPL) viene eseguito riparando o sostituendo con tessuto connettivo lo strato intermedio vibrante, che verrà poi rivestito per rigenerazione sulle due facce, interna ed esterna, rispettivamente dalla mucosa della cassa timpanica e dall'epidermide del condotto uditivo esterno; esso può rappresentare un atto chirurgico isolato (MPL semplice) quando la sola lesione è la perforazione o l'assenza della MT, mentre le altre strutture sono indenni, oppure costituire un tempo della timpanoplastica.
La miringoplastica semplice si esegue con vie d'accesso analoghe a quelle della canalplastica semplice e consiste nell'inserire il materiale di trapianto dopo aver sollevato o il solo strato epidermico dei resti di membrana timpanica e delle pareti adiacenti del condotto (tecnica overlay o sandwich), oppure tutti i resti timpanici (tecnica underlay). È utile, per ottenere una maggiore precisione e stabilità del neotimpano, utilizzare piccole quantità di colla di fibrina. Il condotto uditivo esterno viene adeguatamente tamponato per 15-20 giorni.
In caso di timpanoplastica più complessa, si sceglie la via d'accesso richiesta dalle necessità globali dell'intervento: quasi sempre, comunque, si tratta di una via retroauricolare. La tecnica è simile a quella di una MPL semplice, anche se quasi sempre si deve eseguire una ricostruzione totale.
Il materiale di trapianto più largamente usato in tutto il mondo da oltre trent'anni è la fascia del muscolo temporale che si trova in vicinanza della breccia chirurgica: i risultati che si ottengono sono nel complesso soddisfacenti. Tuttavia, l'esperienza, nostra e di molti altri, ha permesso di rilevare alcuni inconvenienti, specie in caso di MPL totale: 1) il prelievo nello stesso paziente costringe a praticare una via d'accesso più ampia o ad hoc; 2) in caso di reintervento, la fascia temporale risulta assente o di ampiezza insufficiente; 3) la fascia attecchisce rapidamente e contrae facilmente aderenze con le pareti della cassa timpanica e del condotto, dando origine a un neotimpano a ‛scodella'; 4) se la tuba non è perfettamente funzionante il neotimpano facilmente si riperfora o si ritrae in toto, formando tasche di retrazione che predispongono alla recidiva di colesteatoma. Per superare questi inconvenienti in molti centri è stato sviluppato il metodo degli allotrapianti da cadavere, con la costituzione delle ‛banche' dell'orecchio medio. Questo metodo comporta tuttavia non pochi problemi organizzativi e legali, e può essere utilizzato solo in casi selezionati.
Allo scopo di disporre di un materiale facilmente reperibile, resistente, utilizzabile in ogni condizione patologica e in ogni tipo di intervento, nel centro dell'Istituto di Scienze Otorinolaringologiche dell'Università di Parma è stata messa a punto nel 1975 una bioprotesi, denominata Parmatymp, ricavata dalla parete della vena giugulare di vitello (v. Zini e altri, 1976), che è stata utilizzata in oltre quattromila casi, per tutti i tipi di patologia dell'orecchio medio: malformazioni, traumi, esiti di interventi radicali, otiti croniche semplici o colesteatomatose, ecc. Le vene giugulari, prelevate subito dopo la morte dell'animale, sono assottigliate e poste in una soluzione tamponata di ficina (un enzima proteolitico) e poi in una di clorito di sodio; successivamente il materiale viene stabilizzato in dialdeide formica tamponata, sterilizzato e conservato in una soluzione di ossido di propilene e alcool etilico. È in tal modo possibile procedere, in una seconda fase, alla preparazione della vera e propria bioprotesi di membrana timpanica, mediante l'esposizione di un rettangolo di parete venosa a una fonte di calore su un modello di materia plastica o di metallo.
d) Ossiculoplastiche.
Per l'esecuzione delle ossiculoplastiche si utilizzano, quando possibile, gli ossicini del paziente opportunamente rimodellati. Se questi non sono disponibili o comunque non utilizzabili, in quanto erosi o invasi dalla patologia (specie nei colesteatomi estesi) oppure completamente assenti (come nelle ricostruzioni di orecchio medio in cavità residue di pregressa operazione radicale), si deve utilizzare un materiale alternativo estraneo all'orecchio del paziente. Noi abbiamo utilizzato per circa dieci anni (dal 1967 al 1977) un metodo personale, cioè protesi ricavate da radici dentarie allogeniche (v. Zini, 1970), successivamente protesi artificiali prefabbricate in plastipore con l'interposizione di una lamina cartilaginea fra protesi e neotimpano. Quest'ultima soluzione, molto più agevole da eseguire della precedente, era complessivamente seguita da buoni risultati funzionali, praticamente sovrapponibili a quelli ottenuti con le protesi di dentina. A medio e lungo termine, però, si verificava nel 15-20% dei casi l'estrusione della protesi. Sono stati allora sperimentati nuovi materiali, come le ceramiche e l'idrossiapatite, e sono state messe in commercio molte forme di protesi ossiculari (v. Zollner e altri, 1983; v. Grote, 1984).
Noi, come molti altri chirurghi, abbiamo invece gradatamente abbandonato le protesi artificiali per tornare ai materiali di origine biologica, e negli ultimi anni (dopo il 1984) impieghiamo preferibilmente cartilagine allogenica, già da tempo utilizzata con successo per la ricostruzione (parziale o totale) della parete posteriore del condotto e anche come materiale di interposizione fra neotimpano e protesi ossiculari. Fra le varie cartilagini prelevabili (setto nasale, menisco o costa) la più indicata si è rivelata la cartilagine costale per le sue caratteristiche fisico-meccaniche e per la possibilità che offre di confezionare ‛condroprotesi' di varie forme e dimensioni e di risolvere qualsiasi altro problema ricostruttivo in corso di timpanoplastica. Le condroprotesi da articolare sulla testa della staffa sono indicate con la sigla PORC (Partial Ossicular Replacement Chondroprosthesis), quelle atte a sostituire tutta la catena ossiculare dalla membrana timpanica alla platina della staffa con la sigla TORC (Total Ossicular Replacement Chondroprosthesis). In generale, le condroprotesi possono essere a forma di chiodo, a T, a L: i migliori risultati funzionali, e cioè il recupero uditivo totale su tutte le frequenze, li abbiamo sempre ottenuti con le protesi a T, forma che riproduce più efficacemente il movimento della catena ossiculare normale (v. Maffei e Zini, 1972; v. Zini e altri, 1986). Nel periodo 1984-1990 sono stati da noi operati con questo metodo 486 casi, comprendenti tutte le patologie dell'orecchio medio, tutti i tipi di timpanoplastiche e tutti i tipi di ricostruzione della catena ossiculare: nei controlli a cinque anni (v. Bacciu e altri, 1991) si è evidenziata un'alta percentuale di pazienti con un'eccellente funzionalità dell'apparato timpano-ossiculare (chiusura del divario fra via aerea e via ossea entro i 15 dB).
e) Stapedioplastiche.
Con questo termine indichiamo tutte le manovre chirurgiche che si eseguono sulla staffa per modificarne la forma, renderla mobile, sostituirla parzialmente o totalmente. Questi interventi si rendono necessari, come già ampiamente illustrato, sia nella cura chirurgica dell'otosclerosi, sia, anche se meno frequentemente, in quella dei processi infiammatori dell'orecchio medio e dei loro esiti.
L'intervento consiste di solito nel mobilizzare una staffa le cui branche siano fissate ai bordi della finestra ovale da briglie cicatriziali o da materiale timpanosclerotico; qualora ciò non sia possibile, si cerca di ottenere la mobilizzazione della sola platina mediante l'asportazione (con microfresa o con laser) dell'arco stapediale. Se la mobilizzazione non è agevole, se la platina è fissa o se si è di fronte a una recidiva della fissità, l'intervento definitivo sulla finestra ovale viene ‛stadiato' (rinviato a un secondo tempo) per consentire l'apertura del labirinto in condizioni di maggior sicurezza, e cioè con cassa timpanica chiusa e ben cicatrizzata oltre che libera da processi infiammatori in atto. Si può così attuare una delle due tecniche in uso per il trattamento dell'otosclerosi: platinotomia e ricostruzione con una protesi stapediale a pistone, oppure platinectomia (di solito totale) e ricostruzione con tessuto connettivo (POG, Parma Oval Graft) e protesi metallica (platino).
Le protesi stapediali vengono di solito agganciate alla lunga apofisi dell'incudine o al manico del martello. Se è presente solo il neotimpano, si deve eseguire forzatamente una platinectomia con interposizione venosa e ricostruire tutta la catena ossiculare con una condroprotesi tipo TORC, appoggiata sulla vena con la sua estremità mediale e sotto la membrana timpanica con la sua testa.
f) Tuboplastiche.
Con questo termine vengono indicate le tecniche chirurgiche volte a riabilitare una tuba obliterata, marcatamente stenotica o atresica. Occorre subito precisare che tale chirurgia interessa la porzione ossea (protimpano e istmo) della tromba di Eustachio, che è di gran lunga quella più frequentemente sede di patologia. La sua porzione fibrocartilaginea, per la quale non è ancora stato possibile mettere a punto tecniche ricostruttive, è suscettibile solo di una chirurgia indiretta, che si limita a liberare l'ostio rinofaringeo eventualmente ostruito da una patologia rinofaringea, di solito ipertrofia della tonsilla faringea (vegetazioni adenoidi) e/o delle tonsille peritubariche, cisti, tumori benigni.
Il primo intervento di chirurgia diretta sulla tuba ossea, consistente nell'apertura e nell'ampliamento del condotto attraverso la fossa cranica media, non ha avuto molto seguito soprattutto per la necessità di un accesso supplementare endocranico. Sono poi seguiti i primi tentativi di tuboplastica con accesso diretto attraverso il condotto uditivo esterno come tempo complementare di una timpanoplastica (v. Jansen, 1985; v. Zini, 1983; v. Morimitsu, 1985; v. Charachon e altri, 1986). La tecnica da noi messa a punto e impiegata nelle timpanoplastiche, sia aperte che chiuse, prevede i seguenti tempi: 1) rimozione dell'eventuale patologia che oblitera il lume della tuba (diaframmi congeniti o cicatriziali, polipi, colesteatoma, ecc.) asportando, se necessario, anche la mucosa alterata; 2) cateterismo della tuba con una sonda di plastica flessibile avente l'estremità conica di diametro compreso fra 0,6 e 1,5 mm; con questa manovra si lava la tuba fibrocartilaginea e si misura il diametro dell'istmo: se questo è compreso fra 0,9 e 1,5 mm viene considerato normale; se fra 0,6 e 0,9 mm è considerato ‛a rischio', ma non sottoposto a tuboplastica; se è inferiore a 0,6 mm viene considerato gravemente stenotico o atresico; 3) in quest'ultimo caso si procede alla tuboplastica vera e propria, allo scopo di evitare una radicale e di permettere quindi l'esecuzione di una normale timpanoplastica (5% dei casi totali).
Le tecniche di base per eseguire la tuboplastica comprendono la tuboplastica del canale del tensore del timpano e quella della parete antero-inferiore. La prima prevede il sacrificio del canale del muscolo del martello, che decorre parallelamente alla tuba ossea fin oltre l'istmo: per allargare il lume tubarico si svuota il canale dal muscolo e si abbatte il diaframma osseo che lo separa dal lume della tuba. La seconda può essere realizzata isolatamente o in associazione con la prima, e consiste nella fresatura ampia della parete esterna e inferiore del protimpano in modo da ampliarlo tutto, compreso l'istmo.
In tutti i casi di tuboplastica l'accorgimento che ne condiziona il risultato è l'utilizzo di un tutore che guidi la rigenerazione della mucosa, evitando la recidiva della stenosi. Dopo vari tentativi, abbiamo ottenuto i risultati migliori e più costanti ponendo in situ una protesi endo-tubarica ventilata ricavata dalla punta dello stesso catetere diagnostico; questa protesi viene estratta dopo 2 mesi per via naso-rinofaringea con l'aiuto di un endoscopio, oppure viene lasciata in situ, se l'orecchio medio non mostra segni di atelectasia, fino all'esecuzione del secondo tempo (6-12 mesi).
Molto spesso la patologia è localizzata a livello dell'ostio timpanico del protimpano, che può essere sede di polipi, colesteatomi, placche timpanosclerotiche e diaframmi congeniti o acquisiti, mucosi od ossei. Questi ultimi sono la causa di atelettasie globali e di colesteatomi anche molto estesi. La riapertura di un protimpano atresico o l'ampliamento di un ostio timpanico stenotico, denominati ‛tubotomia', è distinta in: superiore, la più frequentemente eseguita, specialmente nel trattamento del colesteatoma con tecnica chiusa, che consiste nel mettere in diretta comunicazione l'attico, opportunamente regolarizzato (atticoplastica), con il protimpano, in modo da creare un canale di drenaggio-aerazione dalla mastoide alla tuba attraverso l'attico al di sopra della catena ossiculare; inferiore, che consente di creare un altro importante canale di drenaggio-aerazione della mastoide verso la tuba, attraverso la timpanotomia posteriore, e l'ipotimpano.
g) Valutazione dei risultati.
Per valutare i risultati degli interventi di timpanoplastica si procede agli esami audiometrici, che forniscono dati funzionali della massima precisione. I tracciati audiometrici consentono di suddividere i soggetti sottoposti a un intervento in tre gruppi, a seconda del gap (divario tra via aerea e via ossea) medio residuo post-operatorio: 1) casi con gap medio residuo inferiore a 15 dB (eccellente funzionalità dell'apparato timpano-ossiculare); 2) casi con gap medio residuo inferiore a 25 dB (funzionalità dell'apparato timpano-ossiculare sufficiente per assicurare un udito utile per i rapporti sociali); 3) casi con gap medio residuo superiore ai 25 dB (insoddisfacente successo funzionale), candidati a un eventuale intervento di revisione.
5. Attuali indicazioni per la chirurgia della sordità
a) Microchirurgia dell'otosclerosi.
L'otosclerosi provoca la fissità della platina della staffa ai contorni della finestra ovale a causa della neoformazione di osso che inizia in prevalenza a livello della fissula ante-fenestram e può estendersi a tutta la fossa ovale. Il ripristino della normale trasmissione delle onde sonore alla perilinfa del vestibolo e quindi alla coclea è realizzabile con l'esecuzione delle stapedioplastiche.
Fino agli inizi degli anni ottanta la tecnica maggiormente in uso consisteva nella demolizione della sovrastruttura della staffa (branche e testa), nella platinectomia parziale o totale, nella ricopertura della finestra ovale con un lembo autogeno di vena o di pericondrio e nella sostituzione della staffa con una protesi ancorata alla lunga apofisi dell'incudine e appoggiata sul lembo venoso. La protesi stapediale era di varie forme e allestita con diversi materiali, metallici o sintetici, biocompatibili.
I risultati ottenuti con questa tecnica sono stati fin dall'inizio veramente ottimi, poiché in oltre il 95% dei casi era garantito il recupero della componente trasmissiva dell'ipoacusia. L'unico inconveniente era che l'ampia apertura del vestibolo esponeva in certi casi al rischio di fuoriuscita eccessiva di perilinfa e di penetrazione di sangue o di frammenti platinari nel vestibolo, con conseguente eventuale sindrome vertiginosa nei primi giorni dopo l'intervento e perdita totale dell'udito nell'1-2% dei casi.
Una variante della tecnica consiste nella creazione di un piccolo foro di 0,6-0,8 mm ricavato al centro o nella parte posteriore della platina lasciata in situ (platinotomia); la trasmissione dei suoni è assicurata da un pistone di calibro leggermente inferiore al foro, ancorato all'incudine e vibrante dentro questa piccola apertura senza necessità di interposizione di un lembo venoso (v. Martin e altri, 1966). Questa tecnica si è dimostrata vantaggiosa rispetto alla precedente per la diminuzione dei sintomi vertiginosi residui e degli incidenti a livello dell'orecchio interno (〈1%) ed è stata pertanto adottata da gran parte dei chirurghi. In qualche caso tuttavia è ancora indicata la platinectomia.
Viene anche praticata una platinotomia più ampia con interposizione di un lembo venoso fra apertura della platina e pistone (teflon-interposition; v. Causse e Causse, 1984). Nel 1977 abbiamo iniziato a utilizzare, come materiale di interposizione nei casi di platinectomia, uno xenotrapianto di vena (POG, Parma Oval Graft) modellato e conservato, che permette di evitare il prelievo del lembo venoso dal dorso della mano o del piede del paziente e assicura gli stessi risultati funzionali.
Più recentemente abbiamo adottato una tecnica di stapedioplastica con conservazione dell'articolazione incudo-stapediale e del tendine stapediale, la cosiddetta stapedioplastica senza stapediolisi. La conservazione del tendine stapediale permette di ottenere i seguenti vantaggi: maggiore stabilità alla staffa ricostruita, ripristino della funzione del riflesso stapediale in circa il 50% dei casi con miglioramento della funzione post-operatoria, migliori risultati sui toni acuti, migliore discriminazione vocale in presenza di rumore ambientale, protezione del labirinto in caso di brusche variazioni della pressione endotimpanica o atmosferica. Questa tecnica, da noi preferita, è tuttavia utilizzabile, per varie ragioni, solo nel 50% degli interventi.
b) Microchirurgia dei processi infiammatori dell'orecchio medio e dei loro esiti.
Fino al 1952 la cura chirurgica dei processi infiammatori cronici dell'orecchio medio comprendeva due interventi: la radicale classica e la radicale conservativa. La radicale classica aveva come unico obiettivo la guarigione clinica della malattia (o per lo meno la prevenzione delle sue complicazioni), e cioè la rimozione della mucosa ipertrofica, del colesteatoma, dei focolai di osteite. Ciò comportava la demolizione di tutte le strutture nobili dell'orecchio medio (compresi i residui di membrana timpanica e degli ossicini, eccettuata la staffa), delle pareti del condotto uditivo esterno e della mastoide. Si otteneva così una rimozione accurata e totale del processo patologico, ma si privava anche definitivamente l'orecchio di quel meraviglioso apparato meccanico, l'apparato timpano-ossiculare, che serve ad amplificare i suoni e a rendere molto più fine la funzione uditiva.
Un orecchio radicalizzato non solo perde circa il 60% della sua capacità uditiva nel campo dell'intensità, ma viene inoltre trasformato in una cavità molto ampia, in comunicazione con l'esterno, che richiede frequenti controlli e medicazioni e che spesso si reinfetta a causa della penetrazione diretta di germi. Inoltre, l'allargamento del meato acustico esterno e l'esposizione del labirinto non solo rappresentano un danno estetico, ma possono anche essere causa di vertigini nel passaggio da un ambiente caldo a uno freddo o per la semplice immersione in acqua di temperatura inferiore a quella corporea, e in molti casi ostacolano l'applicazione di una protesi acustica. La radicale conservativa, basata appunto sulla conservazione, in alcuni casi particolari, di strutture dell'orecchio medio non interessate dai processi patologici, permetteva di mantenere parzialmente la funzione uditiva ma non evitava tutti gli inconvenienti dell'ampia cavità.
Con l'avvento della microchirurgia, la guarigione di un orecchio affetto da otite cronica, semplice o colesteatomatosa, è ora possibile nella maggior parte dei pazienti (90%) senza più incorrere negli inconvenienti che abbiamo elencato, mentre la radicale classica e conservativa mantengono ancora le loro indicazioni solo in un numero limitato di casi. Infatti, in un'alta percentuale di casi le moderne timpanoplastiche raggiungono lo scopo non solo di guarire il processo patologico, ma anche di ripristinare condizioni anatomiche e funzionali normali o molto vicine alla norma.
Le timpanoplastiche sono state messe a punto per la prima volta in Germania Occidentale agli inizi degli anni cinquanta (v. Zollner, 1955; v. Wullstein, 1960) e si sono poi diffuse in vari centri europei e americani, ove un incessante e tenace lavoro di ricerca sperimentale e clinica, al quale anche gli otologi italiani hanno dato un valido contributo, ha reso possibili continui perfezionamenti tecnici e sempre migliori risultati. Le timpanoplastiche originarie costituivano solo un'evoluzione in senso funzionale della radicale conservativa: prevedevano, infatti, la ricostruzione di una nuova membrana timpanica che si adattava agli elementi ossiculari rimasti, delimitando una nuova piccola cassa timpanica, e la eventuale ricostruzione semplificata della catena ossiculare interrotta. I brillantissimi risultati funzionali così ottenuti dimostravano che l'orecchio medio può esercitare il suo ruolo, anche se modificato e semplificato, a patto, però, che si rispettino alcuni principî fondamentali: 1) la presenza di una membrana vibrante; 2) il collegamento solido di questa membrana alla finestra ovale con contemporanea protezione della finestra rotonda; 3) la mobilità delle due finestre labirintiche; 4) la presenza nella nuova cassa timpanica di aria rifornita dalla tuba alla stessa pressione di quella atmosferica.
Queste tecniche originarie prevedevano, però, in caso di esplorazione e pulizia di tutte le cavità posteriori (attico, antro, mastoide), la loro esteriorizzazione mediante l'abbattimento della parete posteriore del condotto uditivo, per creare un grande orecchio esterno rivestito da cute, con ampliamento del meato in modo proporzionale alle dimensioni della cavità, analogamente a quanto previsto nelle tecniche radicali. Queste tecniche di timpanoplastica vengono ora definite ‛timpanoplastiche aperte', per distinguerle dalle ‛timpanoplastiche chiuse' messe a punto una decina di anni più tardi (v. Sheehy e Patterson, 1967; v. Sheehy, 1970; v. Jansen, 1968). Tra queste, la cosiddetta ‛timpanoplastica chiusa per via combinata', ormai definitivamente affermata, permette di pulire perfettamente e in modo completo l'orecchio medio, dalla tuba fino alla parete della mastoide, pur conservando le sue strutture portanti (muro della loggetta e parete posteriore del condotto uditivo esterno), con la possibilità quindi di ricostruire sia la membrana timpanica nella sua posizione originaria, sia la catena ossiculare con sistemi funzionalmente efficaci e duraturi nel tempo, perché molto simili al modello creato dalla natura.
I risultati di questo intervento sono veramente sorprendenti: in oltre il 90% dei casi l'orecchio guarisce perfettamente e definitivamente, riacquistando un aspetto anatomico talvolta difficilmente distinguibile da quello normale, e nel 70% dei casi riacquista una capacità uditiva normale o molto vicina alla normalità, anche se la malattia, o la fase curativa dell'intervento, avevano portato alla distruzione completa della membrana timpanica e della catena ossiculare.
L'intervento può essere eseguito in un sol tempo, se non vi è infezione in atto e se si prevede una cicatrizzazione senza problemi, oppure a stadi (due o più tempi), quando il processo patologico ha distrutto estesamente la mucosa o quando la malattia da trattare è il colesteatoma. Se l'ipoacusia è causata da quest'ultima patologia si esegue in un primo tempo la sua rimozione e la correzione dei difetti anatomici che ne sono all'origine, quindi si ricostruiscono le pareti dell'orecchio medio (parete posteriore del condotto e membrana timpanica), lasciando all'interno della cavità una lamina di materia plastica (silastic) a scopo di drenaggio e di guida alla rigenerazione della mucosa. Trascorsi 12-18 mesi si riapre nuovamente l'orecchio, si asportano eventuali cisti di colesteatoma residuo (15-20% dei casi), si correggono eventuali difetti anatomici dovuti a imperfetta cicatrizzazione e si ricostruisce la nuova catena ossiculare per recuperare l'udito.
Dati gli ottimi risultati che si ottengono con queste timpanoplastiche più moderne, il campo delle loro indicazioni è attualmente molto esteso: il criterio preminentemente conservativo del passato, che consigliava di intervenire solo quando esisteva il pericolo di complicazioni, è attualmente soppiantato dalla tendenza a eseguire la timpanoplastica tutte le volte che le cure mediche non sono state sufficienti a risolvere il processo infiammatorio; non solo, ma anche nel caso di guarigione clinica ottenuta con mezzi farmacologici, si può ricorrere alla timpanoplastica per curare gli esiti dell'otite (perforazione della membrana timpanica, distruzione o fissità degli ossicini) e migliorare così l'udito.
Infine, si possono rioperare e recuperare anche orecchi precedentemente sottoposti a un intervento demolitore, come una radicale o una timpanoplastica aperta, con un'operazione eseguibile in due o più tempi denominata ‛ricostruzione dell'orecchio medio', consistente nel ricostruire con opportuni materiali le pareti del condotto uditivo esterno, la membrana timpanica e la catena ossiculare.
Si deve comunque tenere presente che in tutti gli interventi sull'orecchio, per curare una patologia e/o per ripristinare la funzione uditiva, vi è il rischio, anche nei centri più avanzati e attrezzati, della perdita totale della funzione uditiva nell'orecchio operato. Questo rischio va dall'1% nelle stapedioplastiche per otosclerosi al 2-3% nelle timpanoplastiche e nelle radicali; in caso di reintervento il rischio aumenta in modo minore o maggiore a seconda della complessità dei problemi da risolvere.
c) Chirurgia delle malformazioni congenite maggiori (atresia maior).
L'atresia maior è una complessa malformazione caratterizzata dall'associazione di atresia o microtia del padiglione auricolare, atresia totale del condotto uditivo esterno (soprattutto per assenza o malformazione dell'osso timpanico), assenza della membrana timpanica, malformazione della cassa e della catena ossiculare, talvolta malformazione del canale di Falloppio e della fossa ovale. In questi casi occorre eseguire un intervento anatomo-funzionale molto complesso, una canal-miringo-ossiculoplastica, praticabile non prima dei 5-6 anni di età e solo se l'indagine radiologica mediante TAC dimostra la normalità dell'orecchio interno e della finestra ovale e uno sviluppo della mastoide sufficiente a permettere la creazione del nuovo condotto uditivo esterno senza rischio di lesioni del nervo facciale.
Per questo difficile settore della chirurgia delle malformazioni congenite sono state proposte varie tecniche. Con l'affermazione delle timpanoplastiche chiuse si è cercato di accedere direttamente alla placca atresica, situata al posto della membrana timpanica, per formare il nuovo condotto uditivo esterno: tale procedura espone tuttavia all'inconveniente che una fresatura troppo spostata anteriormente, per l'assenza dell'osso timpanico, produca un condotto privo della sua parete anteriore e quindi a diretto contatto con la fossetta dell'articolazione temporo-mandibolare; d'altra parte, una fresatura eseguita più posteriormente per lasciare una protezione ossea anteriore potrebbe interessare un nervo facciale a decorso anormale e creare un neo-condotto troppo obliquo.
Da molti anni la nostra scuola ha adottato con risultati molto soddisfacenti una tecnica messa a punto da J. Marquet (v. Marquet e altri, 1988), consistente nell'aprire dapprima l'antro e l'attico per via transmastoidea per reperire la posizione della catena ossiculare e poi creare il nuovo condotto, tenendo conto di questo repere fondamentale. Per risolvere il problema dell'obliquità del neocondotto e dell'assenza di una parete anteriore che lo separi dall'articolazione temporo-mandibolare, è stata escogitata una nuova tecnica in due tempi: in un primo tempo si innesta un frammento osseo autogeno al posto dell'osso timpanico mancante, in modo da spingere in avanti l'articolazione temporo-mandibolare; dopo 6 mesi, una volta che questo innesto si è integrato, si esegue l'intervento principale, e cioè l'accesso diretto alla cassa timpanica, creando un nuovo condotto nella sua normale sede, fornito anche di una parete anteriore ossea.
L'esperienza acquisita con la ricostruzione della parete posteriore del condotto con protesi di titanio ha permesso un'ulteriore evoluzione di questo tipo di intervento. Si riapre il nuovo condotto uditivo, ampio e situato nella sua naturale sede anatomica, e si ricostruisce la sua parete anteriore con una protesi di titanio solidarizzata con microviti e rivestita di pasta d'osso e tessuto connettivo. I risultati molto incoraggianti finora ottenuti, se potranno essere estesi a una statistica più ampia, permetteranno di puntare su una tecnica anatomicamente più naturale ed eseguibile in un sol tempo, rispetto alle due precedentemente descritte: tale tecnica prevede la realizzazione del rivestimento cutaneo con lembi peduncolati per quanto riguarda il meato, con lembi liberi di cute prelevata dalla regione retroauricolare o dall'inguine per rivestire il resto del canale; e la ricostruzione della membrana timpanica con il Parmatymp. La catena ossiculare viene conservata, anche se malformata, se dimostra di essere continua e utile (presenza del gioco delle finestre), in caso contrario si esegue anche una ossiculoplastica utilizzando, per quanto possibile, gli ossicini dello stesso paziente oppure condroprotesi del tipo di quelle descritte in precedenza. Se la staffa è fissa si può o prevedere un secondo tempo - se all'indagine TAC la morfologia dell'orecchio interno risulta normale - oppure rinunciare al risultato funzionale, accontentandosi della ricostruzione anatomo-estetica del nuovo condotto, che potrà eventualmente accogliere una protesi elettroacustica. In nessun caso si esegue l'intervento anatomo-funzionale in associazione con l'otoplastica a scopo estetico (ricostruzione del padiglione auricolare), la quale è di solito affidata al chirurgo plastico, con cui si concorda l'ordine temporale dei due tipi di provvedimenti.
d) Altre indicazioni.
Esistono altre condizioni patologiche - oltre quelle descritte, che rappresentano le principali indicazioni della chirurgia dell'apparato di trasmissione dei suoni - per le quali è richiesto un atto chirurgico al tempo stesso curativo e funzionale.
1. Otite sieromucosa. - In questa forma, precedentemente descritta, si ricorre in una certa percentuale di casi all'intervento che viene denominato drenaggio transtimpanico, quando gli altri provvedimenti terapeutici non sono stati efficaci e la condizione patologica rischia di diventare irreversibile e di evolvere verso forme più gravi (otite cronica a timpano aperto, colesteatoma). Si tratta di una miringotomia eseguita nei quadranti anteriori della membrana timpanica, con aspirazione del muco, lavaggio terapeutico della cassa e della tuba e posizionamento di una protesi (drenaggio e aeratore) che mantiene beante la miringotomia, permettendo così la fuoriuscita di eventuali nuove secrezioni e soprattutto la penetrazione nella cassa timpanica di aria per il ripristino dell'equipressione, in attesa della risoluzione dei fattori patogenetici. A questo scopo spesso si associa l'adenoidectomia, onde migliorare la respirazione nasale e togliere un ostacolo al drenaggio tubarico. Questo provvedimento chirurgico permette di ripristinare un udito normale nei bambini durante la fase di sviluppo del linguaggio e il periodo scolastico.
2. Esiti di traumi. - I traumi cranici interessanti l'osso temporale possono essere causa di ipoacusia di trasmissione quando provochino perforazione della membrana timpanica e/o interruzione della catena ossiculare. Nel caso di perforazioni della membrana timpanica, prima di provvedere all'intervento di miringoplastica è necessario attendere almeno 6 mesi dal trauma, in quanto le perforazioni traumatiche hanno la tendenza, a volte sorprendente, alla riparazione spontanea; questa può essere favorita, in fase acuta, dalla ricopertura della membrana con una cartina da sigaretta e/o dall'instillazione nel condotto uditivo di sostanze stimolanti la rigenerazione tissutale. Anche nel caso di ipoacusie di trasmissione post-traumatiche a timpano chiuso conviene attendere lo stesso periodo di 6 mesi prima di intervenire, in quanto la causa può essere talvolta un versamento ematico riassorbibile.
La lesione più comune è la dislocazione dell'incudine, che può essere efficacemente trattata con la trasposizione della stessa incudine, opportunamente modellata, fra manico del martello e testa della staffa; in caso di lesioni più complesse della catena, si procede con le stesse tecniche di ossiculoplastica già descritte.
3. Tumori glomici (chemodectomi). - Si tratta di tumori benigni che si sviluppano da corpuscoli glomici situati a livello dell'orecchio medio o sulla parete del golfo giugulare: nel primo caso il tumore si sviluppa nella cassa timpanica e può diventare timpano-mastoideo (tumori glomici timpanici); nel secondo caso può svilupparsi a livello del foro lacero-posteriore e spingersi più o meno ampiamente all'interno dell'osso temporale, lungo la carotide interna, fino al clivus e al seno cavernoso, o nell'endocranio in posizione extradurale o intradurale (tumori glomici giugulari). Spesso un tumore di questo secondo tipo, usurando il setto che divide il golfo della giugulare dall'ipotimpano, può penetrare anche precocemente nella cassa timpanica (tumori timpano-giugulari). Il sintomo caratteristico dei tumori glomici timpanici e timpano-giugulari è un acufene pulsante sincrono col polso, e all'otoscopia si osserva per trasparenza una massa bluastra pulsante retrotimpanica. La diagnosi si conferma con le indagini neuroradiologiche (TAC, risonanza magnetica nucleare, arteriografia), che permettono di precisare esattamente la natura e la sede del tumore, accertamento fondamentale per la scelta della tecnica di exeresi.
Nei tumori glomici giugulari si esegue sistematicamente l'embolizzazione preoperatoria per diminuire il sanguinamento, che sarebbe altrimenti molto importante a causa della grande vascolarizzazione della massa tumorale. La chirurgia dei tumori glomici timpanici è molto simile a quella del colesteatoma: per via endocanalare o per via combinata (transcanalare e transmastoidea con ampia timpanotomia posteriore) si procede ad asportare la massa neoplastica, se possibile con conservazione della catena ossiculare, oppure ricorrendo alla ricostruzione della catena e talvolta anche della membrana timpanica.
La chirurgia dei tumori glomici giugulari o timpano-giugulari, molto più complessa, fa parte dell'otoneurochirurgia e della chirurgia della base cranica. Nel caso di tumori di notevoli dimensioni si deve sacrificare l'orecchio esterno e l'orecchio medio, consolidando o provocando una profonda ipoacusia di trasmissione, e talvolta anche l'orecchio interno, provocando così una sordità totale.
Negli stadi iniziali, quando il tumore è ancora localizzato al foro lacero-posteriore e nei dintorni, specie se penetra nell'orecchio medio, si possono utilizzare tecniche funzionali che permettono sia di rispettare la funzione uditiva, sia di ripristinarla: sono queste le vie occipito-temporali (OTA), che rappresentano un'estensione alla regione infralabirintica, al foro lacero-posteriore e al collo, con sacrificio spesso del seno sigmoideo, delle tecniche chiuse transmastoidee e retrolabirintiche. Esse comportano anche un'ampia craniotomia occipitale retrosigmoidea, che permette di divaricare la dura pre- e retrosigmoidea passando così sotto il facciale, che viene lasciato nel suo canale.
6. Impianti cocleari e nucleari
Abbiamo visto come attualmente la moderna microchirurgia consenta il recupero della funzione uditiva in ogni condizione patologica che comprometta l'apparato di trasmissione, mentre sia del tutto impotente nel caso di lesioni interessanti l'orecchio interno, cioè l'apparato di trasduzione dei suoni e, in modo particolare, le vie nervose dell'apparato uditivo. La possibilità di intervenire a livello della coclea per favorire la rigenerazione delle cellule sensoriali distrutte (sono in corso, per esempio, ricerche sul trapianto di cellule sensoriali) è allo stato attuale nulla più che una speranza.
La ricerca scientifica ha portato tuttavia a un risultato che qualche decennio fa sembrava una pura utopia: un metodo di sostituzione della coclea (l'impianto cocleare), che William House comunicò al Congresso mondiale di Venezia del 1973. I primi risultati suscitarono un enorme scalpore, e molti si mostrarono scettici se non addirittura increduli; in seguito, le applicazioni cliniche del gruppo di Los Angeles e di altri centri di ricerca dimostrarono il valore clinico di questa scoperta e l'evoluzione tecnologica ha poi consentito di costruire apparecchiature sempre più sofisticate, tanto che ora disponiamo di un metodo che permette di sostituire efficacemente la coclea completamente distrutta, purché persistano, almeno in parte, le terminazioni nervose del nervo cocleare. È questo senz'altro il primo tentativo riuscito di sostituzione permanente nell'uomo di un organo con un apparecchio protesico impiantabile.
L'apparecchiatura è costituita di due parti, una extracorporea e una impiantabile chirurgicamente. La parte impiantabile è costituita da una bobina che viene alloggiata a livello della mastoide e di un cavo coassiale contenente fino a 22 elettrodi isolati tra di loro e con l'estremità stimolante situata a diversa distanza dalla punta del cavo: questo viene collocato nella rampa timpanica della coclea passando attraverso la finestra rotonda, così che le estremità dei vari elettrodi vengano poste a contatto, in diversi punti della coclea, con le terminazioni nervose del nervo cocleare e siano quindi in grado di portare stimoli elettrici a diversi gruppi di fibre, riproducendo la distribuzione topografica delle frequenze del suono. L'apparecchiatura esterna ha il compito di ricevere i suoni con un microfono e di trasformarli in impulsi elettrici, che vengono poi opportunamente amplificati e integrati e quindi trasmessi per via transcutanea alla bobina interna. Una opportuna programmazione eseguita al computer permette di inviare ai vari elettrodi le frequenze appropriate, già codificate per quanto riguarda frequenza e intensità.
L'impianto cocleare è in definitiva una protesi che sostituisce al tempo stesso l'apparato di trasmissione e quello di trasduzione e permette pertanto di ridare l'udito a quei soggetti che lo hanno perso totalmente e bilateralmente. Questi pazienti, dopo un opportuno periodo di rieducazione, tornano così a riconoscere tutti i suoni dell'ambiente, a conversare quasi normalmente anche senza ricorrere alla lettura labiale, a seguire la televisione e anche a parlare per telefono. In particolare, i bambini che nascono sordi totali o lo diventano nei primissimi tempi, prima o durante l'acquisizione del linguaggio, possono essere rieducati e possono sviluppare un linguaggio similnormale. Le informazioni che queste nuove protesi forniscono al paziente, infatti, pur rudimentali rispetto a quelle provenienti da una coclea normale, permettono comunque un'efficace riabilitazione non solo degli adulti, ma anche dei bambini. La disponibilità di tali apparecchiature costituisce la più grande innovazione degli ultimi anni nel campo della riabilitazione delle sordità e il primo esempio di impianto definitivo di un organo artificiale nell'uomo.
Studi più recenti hanno permesso di dimostrare che si possono ottenere risultati analoghi se gli elettrodi terminanti in una placca vengono impiantati in prossimità dei nuclei uditivi del tronco encefalico (impianti nucleari). Questo metodo si può utilizzare in quei soggetti nei quali viene asportato un tumore bilaterale del nervo acustico e quindi viene sacrificato anche lo stesso nervo.
7. Preservazione della funzione uditiva nell'otoneurochirurgia
Come abbiamo già detto in sede introduttiva, la continua evoluzione verso tecniche caratterizzate da una funzionalità sempre maggiore riguarda non solo la chirurgia dell'orecchio medio, ma anche la otoneurochirurgia. Tuttavia, mentre la finalità della chirurgia dell'orecchio medio è sostanzialmente volta da un lato a preservare la funzione dell'orecchio interno e dall'altro a migliorare quella dell'apparato di trasmissione, il campo di applicazione della otoneurochirurgia è rappresentato dal trattamento delle patologie che colpiscono le strutture dell'apparato di percezione. Quando le manovre chirurgiche interessano tale livello, il miglioramento post-operatorio della funzione uditiva costituisce un evento eccezionale, per cui nella valutazione dei risultati sono considerati migliori quelli caratterizzati dalla preservazione del livello uditivo preoperatorio.
La descrizione dettagliata delle tecniche di otoneurochirurgia che permettono la preservazione della funzione uditiva sarebbe troppo lunga ed esulerebbe dagli scopi della presente trattazione: ci limitiamo pertanto a elencarle in una tabella riassuntiva (v. tab. I).
(L'autore desidera ringraziare Salvatore Bacciu, Angelo Gandolfi, Enrico Pasanisi e Fabio Piazza per la preziosa opera di collaborazione prestata nella stesura del presente articolo).
BIBLIOGRAFIA
Bacciu, S., Pasanisi, E., Serafini, S., Zini, C., Condroprotesi ossiculari: risultati a medio termine, in Atti del LXXVIII Congresso nazionale della Società Italiana di Otorinolaringologia e Patologia Cervico-Facciale, Rimini 1991, pp. 30-31.
Barany, R., Scott, S., Discussion on the diagnosis and treatment of infective labyrinthitis, in ‟British medical journal", 1910, II, pp. 1675-1685.
Brackmann, D. E., Shelton, C., Arriaga, M. A., Otologic surgery, Orlando, Flo., 1994.
Calogero, B., Audiologia, Bologna 1983.
Causse, J. B., Causse, J. R., Technique for otosclerosis, in ‟American journal of otology", 1984, V, pp. 392-396.
Charachon, R., Gratacap, B., Lerat, M., Chirurgie de la trompe d'Eustache osseuse et de l'histhme tubaire, in ‟Revue de laryngologie, otologie, rhinologie", 1986, CVII, pp. 45-48.
Cis, C., Notizie storiche sulla chirurgia della finestra ovale sino agli inizi del secolo XX, in ‟Archivio italiano di otologia, rinologia e laringologia", 1959, suppl. XL, pp. 1-22.
Cornelli, G., Tecnica e risultati della apertura del vestibolo labirintico attraverso la finestra ovale nella terapia delle otosclerosi, in ‟L'Ospedale Maggiore", 1949, XXXVII, pp. 55-62.
De Rossi, E., Contribuzione alla medicina operatoria dell'orecchio. Disarticolazione della catena degli ossicini, in ‟Atti dell'Accademia Medica di Roma", 1878, IV, pp. 16-52.
Grote, J. J., Tympanoplasty with calcium phosphate, in ‟Archives of otolaryngology", 1984, CX, pp. 197-199.
Holmgren, G., Some experiences in the surgery of otosclerosis, in ‟Acta oto-laryngologica", 1923, V, pp. 460-466.
Jansen, C., The combined approach for tympanoplasty, in ‟Journal of laryngology and otology", 1968, LXXXII, pp. 779-793.
Jansen, C. W., Functional repair of the Eustachian tube, in ‟American journal of otology", 1985, VI, pp. 231-232.
Jenkins, G. J., Otosclerosis: certain clinical features and experimental operative procedures, in Transactions of the 17th International congress of medicine, London 16 september 1913, London 1914, pp. 609-618.
Jenkins, G. J., The treatment of otosclerosis, in ‟Journal of laryngology and otology", 1914, XXIX, pp. 520-523.
Lempert, J., Improvement of hearing in cases of otosclerosis: a new, one-stage surgical technique, in ‟Archives of otolaryngology", 1938, XXVIII, pp. 42-97.
Maffei, G., Zini, C., Trapianti e impianti in otorinolaringoiatria, in Atti del LX Congresso nazionale della Società Italiana di Otorinolaringologia, Rimini 1972, pp. 371-611.
Magnan, J., Chays, A., Pencroffi, E., Locatelli, P., Bruzzo, M., Reconstruction of the ear canal wall, in Transplants and implants in otology III: proceedings of the Third international symposium on transplants and implants in otology, Bordeaux, France, June 10-14, 1995 (a cura di M. Portmann), Amsterdam-New York 1996, pp. 251-255.
Marquet, J. E., Declau, F., De Cock, M., De Paep, K., Appel, B., Moeneclaey, L., Congenital middle ear malformations, in ‟Acta oto-rhino-laryngologica belgica", 1988, XLII, pp. 117-302.
Martin, H., Gignoux, M., Caygfinger, M., Piston téflon transplatinaire, in ‟Annales d'oto-laryngologie", 1966, LXXXIII, pp. 843-846.
Morimitsu, T., Musculotubal canal approach for stenotic Eustachiantube, in Surgery and pathology of the middle ear. Antwerpen international conference, Groningen 1985, pp. 52-56.
Portmann, M., Claverie, G., Surgery of the windows of the labyrinth in otosclerosis, in ‟Annals of otology, rhinology and laringology", 1957, LXVI, pp. 49-66.
Rosen, S., Mobilization of the stapes to restore hearing in otosclerosis, in ‟New York State journal of medicine", 1953, LIII, pp. 2650-2653.
Shambaugh, G. E., The surgical treatment of deafness, in ‟Illinois medical journal", 1942, LXXXI, pp. 104-108.
Shea, J. Jr., Fenestration of the oval window, in ‟Annals of otology, rhinology and laryngology", 1958, LXVII, pp. 932-951.
Sheehy, J. L., The intact canal wall technique in management of aural cholesteatoma, in ‟Journal of laryngology and otology", 1970, LXXXIV, pp. 1-31.
Sheehy, J. L., Patterson, M. E., Intact canal wall tympanoplasty with mastoidectomy, in ‟Laryngoscope", 1967, LXXXIII, pp. 1594-1621.
Sourdille, M., Nouvelle technique chirurgicale pour le traitement des surdités de conduction, in ‟Annales d'oto-laryngologie", 1930, L, pp. 417-418.
Sourdille, M., Nouvelles techniques opératoires pour le traitement des surdités chroniques progressives ou otosclérose, in ‟Acta oto-laryngologica", 1931, XV, pp. 13-34.
Wullstein, H., Principles of tympanoplasty, in ‟Archives of otolaryngology", 1960, LXXI, pp. 329-337.
Zini, C., La microtympanoscopie indirecte, in ‟Revue de laryngologie, otologie, rhinologie", 1967, LXXXVIII, pp. 736-738.
Zini, C., Homotransplantation de dent en tympanoplastie, in ‟Revue de laryngologie, otologie, rhinologie", 1970, XCI, pp. 258-261.
Zini, C., Eustachian tube surgery: personal experience and techniques, Montreux 1983.
Zini, C., Gandolfi, A., Piazza, F., Occipito-temporal approach to tumors originating in the region of the posterior foramen lacerum with or without extension into the adjacent cranial fossa petrous bone and neck, in Skull base surgery. Anatomy, diagnosis and treatment (a cura di M. Saamii), Basel 1992, pp. 188-189.
Zini, C., Pasanisi, E., Bacciu, S., Gandolfi, A., Management of the auditory tube during closed techniques, in Otorhinolaryngology, head and neck surgery. Proceedings of the XIV World congress of otorhinolaryngology, head and neck surgery, Madrid 1989, pp. 3195-3201.
Zini, C., Sanna, M., Bacciu, S., Hétérogreffes tympaniques en tympanoplastie fermée: technique et résultats, in Comptes rendus du LXIII Congrès français d'otologie, rhinologie et laryngologie, Paris 1976, pp. 249-256.
Zini, C., Scandellari, R., Delogu, P., Matériaux et méthodes actuelles à Parme pour la reconstruction de l'appareil tympano-ossiculaire, in ‟Revue de laryngologie, otologie, rhinologie", 1986, CVII, pp. 190-193.
Zollner, C., Strutz, J., Beck, C. e altri, Verödung des Warzenfortsatzes mit poroser Trikalziumphosfatkeramik, in ‟Laryngologie, rhinologie, otologie", 1983, LXII, pp. 106-111.
Zollner, F., The principles of plastic surgery of the sound-conducting apparatus, in ‟Journal of laryngology and otology", 1955, LXIX, pp. 637-652.
Chirurgia del nanismo di Ignacio Ginebreda Martí e José María Vilarrubias Guillamet
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Biologia della riparazione ossea: a) osteogenesi in distrazione; b) fattori meccanici dell'allungamento osseo. 3. Indicazioni e controindicazioni all'allungamento chirurgico: a) difetto di crescita e displasia ossea; b) difetto di crescita senza displasia; c) controindicazioni all'allungamento chirurgico. 4. Applicazioni terapeutiche dell'allungamento chirurgico: a) tattica chirurgica; b) tecnica chirurgica per l'allungamento delle tibie; c) tecnica chirurgica per l'allungamento dell'omero; d) tecnica chirurgica per l'allungamento del femore e per la correzione dell'iperlordosi. 5. Considerazioni finali. □ Bibliografia.
1. Introduzione
La formazione di osso in distrazione è il fondamento delle tecniche chirurgiche di allungamento osseo. Questo argomento, dalla fine degli anni Ottanta a oggi, è stato il tema di numerosi lavori sperimentali, tendenti non solo a definire il metodo più efficace per ottenere un allungamento osseo corretto, ma anche a studiare a fondo i processi che si svolgono nelle parti molli di un arto allungato chirurgicamente e la sua funzionalità.
Le tecniche chirurgiche per l'allungamento degli arti hanno interessato i chirurghi ortopedici da varie decine di anni: inizialmente per la possibilità che offrivano di correggere le differenze di lunghezza delle estremità inferiori, dovute a fattori congeniti, post-traumatici e, in particolare, ai postumi della poliomielite; in seguito, grazie alle conoscenze più approfondite sull'osteogenesi in distrazione e sulla risposta delle parti molli in condizioni di stiramento, perché se ne è cominciata l'applicazione allo scopo di aumentare la statura di persone eccessivamente basse, superando la barriera dei dieci centimetri di allungamento per ogni segmento osseo. J. M. Vilarrubias ha svolto in Spagna un'attività pionieristica in questo campo, introducendo negli anni settanta le tecniche di allungamento osseo per migliorare la statura degli acondroplasici e di soggetti portatori di altri deficit staturali, basate su modifiche di quelle preesistenti, descritte da H. Wagner, e sostenute da concetti che sono validi tutt'oggi.
L'aggiornamento delle metodiche chirurgiche, la loro semplificazione, l'impiego di nuove tecnologie e una più approfondita conoscenza della biologia della riparazione ossea e dell'osteogenesi in distrazione hanno permesso di ridurre fortemente l'incidenza di patologie iatrogene conseguenti ai procedimenti chirurgici di allungamento osseo e, di conseguenza, di aumentare il numero di casi in cui ne è indicata l'applicazione. Pertanto, si può affermare che l'introduzione delle tecniche di allungamento osseo nei centri specializzati è oramai una realtà, e che una delle loro indicazioni è il trattamento del difetto di crescita. È importante ricordare che le tecniche di allungamento per il miglioramento della statura non sono certo una pratica abituale; tuttavia, la realizzazione di tali interventi per correggere dismetrie di eziologia sia congenita sia acquisita - post-traumatica o tumorale - è sempre più comune. Esistono però pochi centri specializzati in questo tipo di chirurgia e le casistiche a disposizione non sono abbondanti.
2. Biologia della riparazione ossea
Per capire i procedimenti dell'allungamento chirurgico è importante conoscere i meccanismi della riparazione ossea. Bisogna anzitutto tener presente che ogni allungamento è prodotto tramite la separazione controllata dei frammenti di un focolaio di frattura. Molti autori sono dell'opinione che il termine ‛corticotomia', proposto da G. A. Ilizarov (v. Ilizarov e Deviatov, 1971) per i suoi interventi di allungamento, che dovrebbe propriamente essere riferito a una sezione della sola corticale dell'osso che lasci intatta la midollare e non intacchi la vascolarizzazione intraossea, non rispecchi la realtà di tale procedimento chirurgico: l'opinione più diffusa è che in questo si produca una vera frattura, con interruzione completa della rete vascolare ossea tra i due frammenti.
a) Osteogenesi in distrazione.
L'associazione classica ‛stabilizzazione rigida-consolidamento osseo' ha cessato di essere un concetto irremovibile, visto che è ampiamente dimostrata la possibilità di ottenere un consolidamento osseo tramite sistemi di fissazione elastica. Questa circostanza ha dato origine allo studio della formazione dell'osso in distrazione.
1. Istologia del focolaio di allungamento. - I primi lavori noti sulla formazione dell'osso in distrazione sono dovuti a Ilizarov (v. Ilizarov e Soybelman, 1969): con esperimenti su cani egli dimostrò che, nello spazio che si crea dopo aver sezionato trasversalmente un osso e averlo posto lentamente e progressivamente in trazione utilizzando il fissatore esterno circolare a fili di Kirschner da lui messo a punto, è possibile ottenere la rigenerazione ossea, strutturata nella direzione della forza di trazione, purché si preservi l'apporto vascolare. Su quest'ultima condizione, peraltro, vi è tuttora una aperta controversia, cui accenneremo più avanti.
Lo studio di biopsie del callo di allungamento mette in luce risultati diversi, data l'influenza dei fattori di tipo meccanico, cioè localizzazione del processo di allungamento e momento in cui ha luogo. Ad esempio, Kojimoto, in studi sperimentali su conigli, ha riscontrato la presenza di un tipo di ossificazione membranosa, nonostante in alcuni casi si siano prodotti dei noduli cartilaginei (v. Kojimoto e altri, 1989). Plawecki (v., 1987) ha dimostrato che negli agnelli il callo di allungamento compare a partire da una proliferazione cellulare midollare ed endostale. Tajana, studiando biopsie del callo in allungamenti di tibie umane realizzati col metodo di Ilizarov, ha riscontrato la presenza di tessuto organizzato senza osservare in alcun momento tessuto cartilagineo. Da parte nostra (v. Ginebreda e altri, 1988), in biopsie praticate al termine di grandi allungamenti (15 cm) sia della tibia che del femore di pazienti acondroplasici, abbiamo riscontrato la presenza di un tessuto formato da fibre di collageno orientate nella direzione della forza di trazione e di nuclei di ossificazione di tipo fibroso, più abbondanti nelle zone prossimali agli estremi dell'osteotomia, e lo stesso fenomeno è stato descritto da altri autori in animali da esperimento; tuttavia, esistono alcune differenze strutturali tra i due tipi di osservazioni, poiché in condizioni sperimentali normalmente gli allungamenti della tibia e del femore sono inferiori rispettivamente a quattro e a dieci centrimetri.
L'opinione più diffusa è che ci si trovi in presenza di un'ossificazione di tipo membranoso orientata nella direzione della trazione a cui l'osso è sottoposto, e che l'attività osteogenetica sia molto attiva specialmente durante il primo anno, durante il quale si producono tutti i fenomeni di costruzione, riassorbimento, corticalizzazione e ricanalizzazione midollare (v. Ilizarov e Soybelman, 1969; v. Plawecki, 1987; v. Ginebreda e altri, 1988; v. Delloye e altri, 1989; v. Kojimoto e altri, 1989). Assai interessante è l'osservazione di Aronson sull'assenza di differenze istologiche e radiologiche nei calli di allungamento prodotti dal fissatore circolare a fili di Ilizarov e da quello monolaterale senza fili di Wagner (v. Aronson e altri, 1989).
Una delle caratteristiche più notevoli comune a tutti i processi di allungamento è che la mineralizzazione delle fibre di collageno avviene longitudinalmente secondo una direzione parallela alla forza di trazione esercitata dal fissatore esterno, il che sottolinea quanto siano importanti i fattori meccanici dei fissatori esterni.
2. Vascolarizzazione e callo di allungamento. - La proliferazione e la formazione del tessuto osseo non può avvenire in alcun caso in mancanza di un apporto vascolare adeguato. Secondo Korzinek e altri (v., 1990) solo nel 30% dei casi si riesce a eseguire la corticotomia mantenendo intatta la circolazione endomidollare, mentre il tasso di successi rilevato da Arrien (v., 1986) nei suoi studi angiografici sulle osteotomie diafisiarie percutanee scende addirittura al 10% dei casi. Secondo la nostra opinione, l'integrità della circolazione endomidollare non ha alcuna importanza nel caso in cui l'osteotomia si realizzi a livello metafisario, dato che in questo punto l'arteria midollare è molto ramificata e il suo calibro assai minore; riteniamo, pertanto, inesatto l'uso del termine corticotomia, cioè sezione della sola corticale, quando tale sezione si effettui nella regione metafisaria, dato che in questo caso si realizza una vera e propria osteotomia, o una frattura controllata.
Nei suoi primi lavori sperimentali, Ilizarov (v. Ilizarov e Soybelman, 1969) sosteneva che la circolazione endomidollare - che a suo parere si manteneva intatta nell'intervento di osteotomia percutanea e attiva durante il processo di distrazione - rappresentasse la struttura fondamentale per l'osteogenesi del callo di allungamento. In seguito, molti altri autori hanno messo in evidenza come il fattore più importante nella formazione del callo esterno, indipendentemente dal fatto che la circolazione endomidollare sia interrotta o meno, sia invece il periostio, e quindi la circolazione periostale (v. Kojimoto e altri, 1989; v. Cara del Rosal, 1992).
3. Formazione di osso corticale e ricanalizzazione. - Per far sì che il segmento osseo allungato assuma le caratteristiche meccaniche dell'osso normale, si debbono assicurare le condizioni idonee all'orientamento dell'architettura trabecolare secondo il suo assetto originale. Una volta terminato il periodo di allungamento e avvenuta l'ossificazione del focolaio di allungamento, l'osso è in condizione di mantenersi dritto, ma non è in grado di sopportare stimoli o sollecitazioni come la pressione, la flessione o la torsione. Perché questo avvenga è necessaria la formazione dell'osso corticale, che si ottiene applicando progressivamente stimoli di carico sull'osso allungato. In questa fase è molto importante sottoporre l'osso all'azione di stimoli meccanici, sia interni, rappresentati da mobilizzazioni articolari attive tramite la stessa muscolatura inserita sul segmento allungato, sia esterni, consistenti nell'applicazione, anche nelle fasi di allungamento, di carichi progressivi attraverso il fissatore esterno. La cruciale importanza di questa fase ha spinto a migliorare i sistemi di fissazione esterna, che sono stati quindi progettati tenendo conto dei concetti di biocompressione, introdotto da Lazo (v. Lazo e altri, 1990), e di dinamizzazione dei fissatori (v. De Bastiani e altri, 1987; v. Ilizarov, 1989).
Poiché i metodi radiologici tradizionali offrono soltanto delle immagini di delimitazione dell'osso rigenerato nel focolaio di allungamento, nelle quali si può apprezzare la continuità o la discontinuità della mineralizzazione e dei suoi limiti marginali, è opportuno sottoporre i pazienti a tomografie diafisarie trasverse a risonanza magnetica nucleare per documentare la comparsa di osso corticale, ossia se si sta producendo una vera apposizione di minerale nei margini che formano la corticale. Comunque, secondo la maggioranza degli autori l'impiego sistematico di questa indagine nei processi di allungamento non è necessario, e la pratica clinica coadiuvata dalla radiologia tradizionale può da sola risultare sufficiente. Allo stesso modo, non si è rivelato di particolare interesse, per determinare la formazione della corticale nell'osso allungato, l'impiego della densitometria ossea.
La ricanalizzazione ossea del focolaio di allungamento si verifica solo quando il segmento osseo può essere sottoposto alle abituali sollecitazioni meccaniche dell'osso diafisiario: la deambulazione attiva con carico progressivo orienterà, pertanto, la trabecolazione corticale, e in una seconda fase potrà realizzarsi la ricanalizzazione e la comparsa del midollo osseo. Questo fenomeno è stato dimostrato osservando pazienti sottoposti a osteotomia diafisiaria correttiva dopo un intervento di allungamento osseo, i quali presentavano una più ampia formazione periostea, un osso corticale molto vascolarizzato e un calibro midollare ridotto. La misurazione radiologica della midollare del segmento tibiale nei casi di allungamento osseo superiore ai 10 cm e con periodo di evoluzione di più di due anni non presenta differenze sostanziali con quella dell'osso iniziale.
b) Fattori meccanici dell'allungamento osseo.
1. Tipo e livello dell'osteotomia. - Nell'ambito delle tecniche chirurgiche di allungamento di un osso lungo, i modi di realizzare l'osteotomia descritti dalla letteratura scientifica sono molteplici. In un primo momento, con le procedure a ‛cielo aperto' (v. Wagner, 1977) furono eseguite osteotomie oblique e a forma di ‛zeta', o altre tecniche di ‛slittamento' nella regione metafisaria. Nelle attuali tecniche di allungamento si utilizzano l'osteotomia percutanea trasversale e la cosiddetta osteotomoclasia, la cui esecuzione con perforazioni praticate sul piano trasversale richiede un limitato distacco del periostio.
Secondo studi sperimentali effettuati da Arrien (v., 1986) per confrontare i vari livelli e i tipi di osteotomia, l'osteotomia percutanea induce un'ossificazione di tipo fibroso, mentre nelle osteotomie aperte l'ossificazione è mista, dato che coesistono zone di ossificazione endocondrale e fibrosa. Un'altra caratteristica istologica dell'osteotomia percutanea è la comparsa di fibre di collageno organizzate parallelamente nella direzione della forza di trazione.
Nell'ambito di un nostro riesame di osteotomie praticate per allungare la tibia, il femore e l'omero di 34 pazienti acondroplasici (il che comportava un totale di 136 segmenti ossei), abbiamo constatato l'esistenza di una relazione tra esito dell'intervento e livello dell'osteotomia: quanto più l'osteotomia è metafisaria, tanto migliore è il callo di allungamento; non abbiamo però riscontrato differenze fra i diversi tipi di osteotomia (trasversale, obliqua corta e frattura).
2. Inizio dell'allungamento. - I primi autori che si sono occupati dei procedimenti di allungamento osseo consigliavano di iniziare la distrazione già nel secondo giorno dopo l'osteotomia. Attualmente, la tendenza più diffusa è quella di iniziare l'allungamento tra i 5 e i 15 giorni dopo l'operazione: questo differimento consente l'inizio della fase di organizzazione e di rigenerazione del callo di frattura. Kawamura e i suoi colleghi, nel 1968, sostenevano che nel caso in cui la frattura venga realizzata con una lesione minima delle parti molli non è necessario rimandare l'allungamento (v. Kawamura e altri, 1981).
Noi abbiamo potuto constatare che, nel caso di allungamenti di ossa lunghe di acondroplasici con diafisi ed epifisi ancora non saldate, non si riscontrano differenze nella formazione ossea se l'allungamento viene effettuato 24 ore dopo l'intervento o posticipato di 10 giorni. Tuttavia, nel caso di acondroplasici adulti o di allungamenti di ossa non displasiche con diafisi ed epifisi già saldate, è consigliabile iniziare l'allungamento dieci giorni dopo l'operazione.
3. Biomeccanica dell'allungamento. - Per dar luogo alla formazione di tessuto osseo, un processo di allungamento deve realizzarsi in condizioni di stabilità, in quanto l'instabilità provoca dislocazioni dei frammenti e formazione di tessuto fibroso al posto del tessuto osseo (v. Ilizarov, 1989). Nei sistemi che possono trasmettere un'elasticità in senso assiale una adeguata combinazione delle condizioni di stabilità dei meccanismi di fissazione esterna sembra in grado di garantire le migliori condizioni per la rigenerazione ossea.
È stato dimostrato da molti autori che i micromovimenti in direzione assiale sono un fattore importante nell'osteogenesi. I risultati di uno studio sperimentale effettuato su agnelli, nel corso del quale venivano applicati differenti sistemi di allungamento variando il grado di rigidità e di dinamizzazione dei montaggi (v. Aguirre, 1990), hanno dimostrato che, in un allungamento realizzato con un fissatore esterno che permetta la dinamizzazione elastica tramite lo spostamento di una leva a basso attrito e una molla anticollasso, si ottiene una consolidazione dell'osso sei settimane dopo la fine del processo di allungamento, con un avanzato stato di rimodellamento e formazione di un callo ipertrofico nei piccoli allungamenti.
Il comportamento delle forze durante i processi di allungamento è un tema interessante, che Forriol ha studiato approfonditamente su animali da esperimento. Con l'impiego di un fissatore monolaterale, equipaggiato con adeguata strumentazione, e monitorizzando il processo durante le ventiquattro ore, è stato analizzato il modello delle forze che entrano in gioco durante l'allungamento (v. Cañadell e Forriol, 1993): lo studio indica che le forze massime aumentano ogni giorno dopo la distrazione e valuta che il picco di tali forze si ha tra il ventunesimo e il ventiduesimo giorno dopo l'intervento, quando la leva del fissatore ha raggiunto un centimetro e mezzo di allungamento e si rilevano valori di 7,5 kg. Inoltre, la forza massima giornaliera inizia a diminuire un'ora dopo aver raggiunto il suo picco, calando progressivamente d'intensità fino ad assestarsi a un livello leggermente superiore a quello del giorno precedente; pertanto i valori medi delle forze aumentano giorno dopo giorno.
3. Indicazioni e controindicazioni all'allungamento chirurgico
Prima di prendere la decisione di realizzare un allungamento chirurgico per migliorare la statura di un individuo è necessario verificare che siano soddisfatte una serie di condizioni che permettono di valutare praticamente per ogni paziente se tale procedimento è il più adeguato. Perciò, è utile che nei centri ospedalieri in cui vengono effettuati interventi di questo tipo vi siano équipes multidisciplinari impegnate nello studio della patologia della crescita, composte da specialisti di pediatria, endocrinologia infantile, psicologia, riabilitazione e chirurgia ortopedica. Innanzittutto, si deve escludere l'esistenza di ogni tipo di patologia di base che possa rappresentare una controindicazione all'intervento chirurgico o a un lungo periodo di immobilità. Inoltre, si devono valutare le condizioni psichiche del paziente, le sue aspettative di vita e le condizioni familiari. È consigliabile che i pazienti in età scolare siano messi nelle condizioni di continuare a svolgere le loro attività durante i vari processi di allungamento, e che i periodi di ricovero ospedaliero siano i più brevi possibile (v. Vilarrubias e Ginebreda, 1988; v. Vilarrubias e altri, 1990). L'obiettivo che l'allungamento chirurgico cerca di raggiungere, infatti, è quello di migliorare le condizioni funzionali del paziente affetto da difetto di crescita affinché la sua integrazione sociale sia il più possibile adeguata sotto tutti punti di vista.
Per quanto riguarda le proporzioni e la morfologia, tra gli individui con difetti di crescita vanno distinti quelli che, oltre a essere di bassa statura, hanno una displasia ossea e quelli che, avendo una configurazione ossea normale, sono di bassa statura, ovvero al di sotto dei parametri considerati nella norma nella distribuzione di statura; inoltre, si può valutare il grado di proporzione tra i differenti segmenti corporei, distinguendo le basse stature armoniche o proporzionate da quelle disarmoniche. Per ciascuno di questi gruppi si devono stabilire regole terapeutiche differenti.
a) Difetto di crescita e displasia ossea.
L'allungamento osseo degli arti di un paziente con displasia ossea deve mirare a vari obiettivi differenti: quello primario è il conseguimento di una corretta funzionalità, e per raggiungerlo è necessario che migliorino le condizioni iniziali dell'apparato locomotore, relativamente sia alla dimensione che alla forma degli arti. È assolutamente necessario, perciò, valutare prima dell'operazione le deformità esistenti, alcune delle quali potranno essere corrette durante l'allungamento stesso, mentre altre, specie nel caso di pazienti affetti da displasie epifiso-metafisarie, necessiteranno di un intervento chirurgico preliminare che ponga gli arti in condizioni adeguate a subire l'allungamento (v. Vilarrubias e Ginebreda, 1988).
Altro obiettivo fondamentale è che il paziente raggiunga una statura accettabile. Per conseguirlo è necessario che la tecnica chirurgica di allungamento possa portare a incrementi globali di statura compresi tra i 30 e i 35 cm: infatti, per un individuo la cui statura al termine dell'accrescimento potrebbe essere di 1,20 m non è di alcuna utilità sottoporsi a un intervento chirurgico che gli offra un incremento di soli 10 o 15 cm, come sostengono invece alcune scuole (v. Bailey, 1970; v. Ginebreda e altri, 1988; v. Vilarrubias e Ginebreda, 1988; v. Villarubias e altri, 1990). Quanto agli individui affetti da acondroplasia (che costituiscono la gran parte dei pazienti con displasia ossea e di bassa statura che vengono selezionati per un intervento di allungamento osseo), poiché la loro altezza al termine dell'accrescimento, nel migliore dei casi, non può raggiungere più di 1,30 m, consideriamo che l'allungamento debba essere compreso tra i 25 e 35 cm per gli arti inferiori e tra i 9 e i 12 cm per quelli superiori. A nostro parere gli interventi di allungamento osseo negli acondroplasici sono utili non solo per migliorarne la statura, ma anche per correggere il loro apparato locomotore, spesso deformato da iperlordosi e genu varum, così da evitare i gravi inconvenienti che tali deformità possono comportare nel corso della loro vita adulta.
Per vari motivi l'età più adatta per intraprendere l'operazione chirurgica è considerata quella compresa tra i 9 e i 12 anni: a questa età, infatti, la struttura ossea delle ossa lunghe presenta un'ampiezza metafisaria sufficiente perché si possa effettuare un corretto aggancio osseo dei chiodi, in modo da rispettare la cartilagine di accrescimento, e perché l'osteotomia si possa effettuare nella zona metafiso-diafisiaria; inoltre, il paziente si trova in una fase della crescita tale che il processo di osteogenesi nel focolaio di allungamento è caratterizzato da notevole vivacità; infine, dal punto di vista della maturazione psicologica, dal bambino di questa età si può ottenere un buon grado di collaborazione.
Le principali indicazioni all'allungamento globale degli arti sono le condrodisplasie di tipo rizomelico, come l'acondroplasia e l'ipocondroplasia. I casi di nanismi dismorfici e di displasie epifiso-metafisarie possono essere comunque candidati a interventi di allungamento osseo, purché non presentino gravi alterazioni articolari o forti cifoscoliosi associate e purché si preveda di raggiungere alla fine dell'operazione una statura superiore ai 90-100 cm.
b) Difetto di crescita senza displasia.
I pazienti di bassa statura senza displasia ossea si rivolgono in genere all'unità di patologia della crescita una volta terminato il loro accrescimento fisiologico, durante il quale non di rado sono stati sottoposti a terapie mediche che, tuttavia, non sono riuscite a far loro raggiungere una statura accettabile. In questo gruppo di pazienti vengono diagnosticate frequentemente sindrome di Turner (per l'assenza o la modestia della displasia ossea), pubertà precoce, bassa statura costituzionale e, in casi eccezionali di soggetti che non sono stati sottoposti a trattamento medico o lo hanno iniziato tardi, carenza di ormone della crescita, GH. Vanno inclusi in questo gruppo casi meno frequenti, come pazienti affetti da sindrome di Laron, dato che la caratteristica di questa patologia è la bassa statura relativamente proporzionata e un grado di displasia scarso o presente unicamente in qualche segmento osseo (v. Ginebreda e Vilarrubias, 1994).
Una volta verificata l'assenza di tutte le controindicazioni di tipo medico generale e ortopedico, i pazienti di questo gruppo vengono sottoposti a uno studio delle proporzioni tra gli arti inferiori e il tronco e tra i due segmenti degli arti inferiori. Nella maggior parte di tali individui si riscontra, tra la lunghezza del femore e quella della tibia, una differenza eccessiva, di 9 o 10 cm a favore del primo, mentre normalmente dovrebbe essere di 7 o 8. È stato provato che, se si uguaglia la lunghezza di entrambi i segmenti o se la lunghezza della tibia supera di 1 cm quella del femore, non viene a crearsi una sproporzione corporea eccessiva, né si determinano disfunzioni meccaniche. In tal modo, con un solo intervento chirurgico si può aumentare dai 10 ai 13 cm la statura di questi pazienti. Aldegheri e Trivella propongono di effettuare, in tali casi, l'allungamento incrociato del femore e della tibia controlaterale, incrementando la lughezza di ciascun osso dai 6 agli 8 cm (v. Aldegheri e altri, 1989).
Attualmente sono disponibili programmi informatici che rendono possibile, manipolando un'immagine fotografica, visualizzare l'effetto dell'allungamento desiderato e confrontare l'immagine così ottenuta con quella reale, in modo da avere un'idea più precisa delle relazioni di proporzione in seguito all'allungamento di un determinato segmento.
c) Controindicazioni all'allungamento chirurgico.
Vi sono alcune controindicazioni di carattere medico generale che rendono sconsigliabile effettuare l'allungamento chirurgico, in quanto l'intervento implicherebbe un elevato rischio di vita; anche le condizioni psicofisiche del paziente possono controindicare l'operazione. È evidente che la qualità di vita del candidato all'intervento è condizione prioritaria: sarebbe del tutto assurdo sottoporre un soggetto con deficienze mentali a un processo di allungamento osseo, vista la speciale collaborazione che viene richiesta durante il processo di allungamento, che in determinate occasioni può durare fino a 10 o 12 mesi.
Vi sono inoltre controindicazioni di carattere ortopedico. Risulta rischioso sottoporre a grandi processi di allungamento pazienti che abbiano superato il ventesimo anno di età, i quali andrebbero incontro a maggiori difficoltà di rigenerazione ossea nel focolaio di allungamento e le cui parti molli non sono altrettanto elastiche di quelle dei bambini.
Se si prevede che la statura al termine dell'accrescimento non superi i 90 o 100 cm, può essere controindicato procedere a un allungamento chirurgico, che, al massimo, non può essere superiore a 30-35 cm, corrispondente cioè a un modesto beneficio funzionale. Inoltre, i pazienti la cui prognosi circa la statura è così negativa presentano spesso anche gravi alterazioni spondilo-epifisarie che rendono sconsigliabile l'allungamento chirurgico.
Non sono eseguibili allungamenti chirurgici in pazienti la cui struttura ossea sia eccessivamente porotica, o affetti da displasie del tipo osteogenesi imperfetta, poiché in tali casi la capacità di rigenerarazione dell'osso in un focolaio di allungamento è incerta.
Vi può essere infine un interrogativo nel caso di pazienti affetti da rachitismo. Se si tratta di adulti, bisogna considerare l'alta probabilità che la fase di consolidazione di un segmento allungato si prolunghi oltremisura, dato che i fenomeni di osteogenesi in questi pazienti sono nettamente ridotti. Nella maggior parte dei casi è necessario un secondo intervento chirurgico, per realizzare, mediante chirurgia aperta, un innesto osseo e per applicare materiale di osteosintesi interna, con aumento dei rischi di complicazioni chirurgiche. Abbiamo però esperienza di allungamenti degli arti in pazienti affetti da rachitismo vitamina D-resistente: in questi casi è possibile ottenere buoni risultati sia di correzione assiale sia di allungamento delle tibie e dei femori, purché gli interventi siano eseguiti su ossa con metafisi ed epifisi non ancora saldate; in pazienti di età superiore ai 19 anni, invece, non si conseguono risultati altrettanto soddisfacenti ed è sempre necessario l'apporto di innesto.
4. Applicazioni terapeutiche dell'allungamento chirurgico
a) Tattica chirurgica.
È importante sottolineare che l'allungamento degli arti al fine di migliorare un caso di bassa statura non è un atto chirurgico che si limita all'intervento su un segmento osseo, ma è un procedimento prolungato di allungamento di tutto l'arto nel suo complesso, ossa e parti molli. Si deve perciò stabilire una tattica chirurgica atta a procurare il maggior numero di benefici al paziente nel modo più semplice possibile e con il minor numero di rischi (v. Allan, 1963; v. Bailey, 1970; v. Ilizarov e altri, 1972; v. Wagner, 1978; v. Vilarrubias e Ginebreda, 1988; v. Cattaneo e altri, 1990; v. Villarubias e altri, 1990).
Per i pazienti condrodisplasici che debbono essere sottoposti ad allungamento chirurgico degli arti superiori e inferiori, la nostra pianificazione prevede che il processo inizi con l'allungamento delle due tibie in uno stesso intervento. Vi sono anche altre tre opzioni possibili: l'allungamento incrociato (femore destro e tibia sinistra), gli allungamenti lineari (femore e tibia dello stesso arto) oppure l'inizio del processo con l'allungamento di entrambi i femori. Queste ultime possibilità presentano però tutte una controindicazione: infatti, nel caso in cui il paziente per un motivo qualsiasi non potesse operarsi di nuovo, rimarrebbe affetto da gravissime alterazioni funzionali che gli renderebbero assai difficoltosa la locomozione e la capacità di effettuare movimenti.
I segmenti da allungare in un secondo tempo, una volta completata la riabilitazione conseguente all'allungamento delle tibie, sono generalmente i femori; ciò nonostante, in alcuni casi, se non si è riusciti a completare la suddetta riabilitazione, può essere consigliabile eseguire l'allungamento degli omeri. In pazienti acondroplasici giovani adulti è per lo più consigliabile effettuare prima l'allungamento globale delle estremità inferiori e una volta portata a termine questa fase concludere con l'allungamento degli omeri, visto che durante quest'ultimo processo sono limitate solo le attività fisiche, mentre è possibile svolgere tutte le attività quotidiane di tipo scolastico.
b) Tecnica chirurgica per l'allungamento delle tibie.
Nell'intervento, che si esegue in anestesia epidurale o totale, le manovre chirurgiche sono per la maggior parte percutanee e tali da conservare il più possibile tutte le strutture anatomiche. In primo luogo si realizza una fissazione peroneo-tibiale distale tramite l'introduzione percutanea di un chiodo sottile a testa piatta, che viene fatto progredire dalla zona sopramalleolare esterna fino alla tibia. La correttezza della posizione del chiodo si verifica radiologicamente mediante immagini in proiezione laterale ottenute utilizzando amplificatori di brillanza. In seguito, attraverso un'incisione cutanea di 2,5 cm praticata sulla faccia laterale della gamba (a livello del terzo medio-inferiore), si realizza un'osteotomia-resezione diafisaria del perone che sarà più ampia nei bambini acondroplasici, per evitare che si consolidi precocemente, e più ridotta negli adulti.
Successivamente, si opera la tenotomia percutanea del tendine di Achille: attraverso minime incisioni, anch'esse percutanee, si effettuano piccoli tagli a scalino sul tendine di Achille per operarne lo stiramento, in modo da evitare che durante il processo di allungamento esso si accorci provocando una deformità del piede, rendendolo cioè equino. In questo caso, infatti, prima di poter procedere con l'allungamento osseo si renderebbe necessario un nuovo intervento per allungare il suddetto tendine.
Effettuati questi passi preliminari si procede all'infissione nell'osso di due chiodi prossimali e di due distali per l'applicazione del distrattore. Nel caso in cui vi sia cartilagine di accrescimento attiva, questa va sempre rispettata. Infine, nella regione prossimale della tibia, attraverso una piccolissima incisione (1 cm), si pratica l'osteotomia con uno scalpello di piccole dimensioni. Si rompono le corticali mediale e laterale e con un movimento di rotazione si completa la rottura della corticale posteriore. L'intervento termina con l'applicazione di uno stivaletto di gesso o di una ortesi in modo che la caviglia sia mantenuta a 90 gradi rispetto alla gamba, e infine con l'applicazione del distrattore, la cui corretta disposizione è di grande importanza per correggere le deformità preesistenti della tibia e per evitare possibili deviazioni assiali durante l'allungamento. I distrattori utilizzati per questa tecnica chirurgica sono monolaterali senza fili di Kirschner, di semplice applicazione, e offrono la possibilità di effettuare correzioni assiali in senso varo-valgo e recurvatum-antecurvatum; ve ne sono di due tipi, con una capacità di allungamento rispettivamente di 11 o di 15 cm a seconda della grandezza, ma entrambi possono essere riconvertiti per conseguire allungamenti maggiori.
Nel caso di pazienti condrodisplasici, 24 ore dopo l'intervento si inizia l'allungamento, in ragione di ∀ mm ogni 12 ore. L'allungamento va differito di 10 giorni nel caso di difetto di crescita non displasico. Inoltre, i familiari debbono essere informati sulle cure giornaliere, da realizzarsi nelle condizioni di massima asepsi possibile, e sugli esercizi di fisioterapia che il paziente dovrà effettuare quotidianamente. È consigliabile che i pazienti sottoposti ad allungamento delle tibie effettuino esercizi in stazione eretta sui due piedi sotto carico controllato, eseguendo anche alcuni passi; essi devono però restare abitualmente seduti, tenendo le ginocchia estese, al fine di evitare la ritrazione dei muscoli flessori ischiotibiali, circostanza questa che costringerebbe a interrompere il processo di allungamento o a diminuirlo fino a che non fosse possibile effettuarne nuovamente l'estensione completa. Il controllo radiologico va effettuato mensilmente.
Una volta terminato l'allungamento programmato, bisogna lasciar passare un certo lasso di tempo (circa tre mesi, a seconda dell'età e del numero di centimetri di allungamento) durante il quale possa formarsi l'osso nel focolaio di allungamento. Quando è radiologicamente dimostrabile la formazione ossea in tutto il focolaio di allungamento, con le corticali ben definite (è utile, per maggiore sicurezza, eseguire una TAC), si procede all'estrazione dei fissatori esterni e si collocano alcune protezioni gessate, al fine di iniziare la normale deambulazione assistita con stampelle. Questo periodo è necessario perché nel nuovo osso finisca di formarsi la struttura trabecolare e corticale tramite le sollecitazioni meccaniche alle quali esso deve venir sottoposto progressivamente. Quando il controllo radiologico mette in evidenza un aspetto di solidità meccanica, si tolgono le protezioni gessate e si autorizza la deambulazione libera. A partire da questo momento inizia un programma completo di riabilitazione per recuperare le diverse funzioni: statica, controllo del nuovo centro di gravità, propriocezione e rieducazione alla deambulazione.
L'analisi delle principali complicazioni dell'intervento di allungamento delle tibie, in uno studio realizzato nel 1993, ha dato i seguenti risultati. Su un totale di 454 segmenti tibiali allungati sono state osservate 25 (5,5%) deviazioni assiali per la cui correzione si è reso necessario un intervento, nonché 17 (3,7%) fratture da sovraccarico, verificatesi dopo la rimozione dei fissatori esterni e l'inizio della deambulazione, le quali sono state trattate mediante correzione e immobilizzazione in gesso. In 39 casi (8,5%), tutti di adulti in giovane età, si è riscontrata una riduzione nella mobilità della caviglia. La paresi del nervo sciatico popliteo si è presentata in 4 (0,8%) casi, tre dei quali hanno recuperato spontaneamente senza postumi, mentre in uno è residuato un deficit di estensione delle dita. In 5 casi di pazienti acondroplasici si è verificato un consolidamento precoce del perone, che ha richiesto un nuovo intervento chirurgico di osteotomia per poter proseguire con l'allungamento. Infine, in 4 casi di pazienti affetti da sindrome di bassa statura senza displasia si è prodotta una deviazione in valgo della parte posteriore del piede, per la cui correzione è stato necessario praticare un'osteotomia del tarso.
c) Tecnica chirurgica per l'allungamento dell'omero.
Nella maggior parte dei pazienti affetti da condrodisplasia si riscontra una sproporzione tra braccio e avambraccio, a favore di quest'ultimo. Molti presentano un deficit di estensione del gomito che può superare i 30 gradi. Questi fattori provocano un'incapacità funzionale che si manifesta nello svolgimento di attività quotidiane, come attendere all'igiene personale, al punto che questi pazienti, in certi casi, sono dipendenti da un'altra persona. Inoltre, la necessità di avere arti superiori più lunghi aumenta se si è stati sottoposti a un allungamento di quelli inferiori.
Poiché l'intervento deve puntare più al risultato funzionale che a quello estetico, invece di realizzare un allungamento proporzionato di braccio e avambraccio è preferibile risolvere il problema praticando quello del solo omero, che è tecnicamente più semplice e comporta meno rischi per il paziente.
Poiché nel braccio vi è un solo osso, la tecnica chirurgica risulta più semplice rispetto a quella impiegata nell'allungamento della tibia. È però necessaria una serie di accorgimenti tecnici che mettano il paziente in condizione di svolgere la maggior parte delle sue funzioni quotidiane durante l'allungamento. Per questo intervento, in contrasto con le scelte operate da altre scuole, noi utilizziamo sistematicamente un fissatore esterno monolaterale con chiodi di 4 mm di spessore.
L'omero dell'acondroplasico presenta delle caratteristiche anatomiche che rendono necessaria molta precisione nel collocare i chiodi. I più distali devono essere posti sulla faccia laterale, il primo nell'epicondilo, giusto sopra alla fossetta olecranica, e il secondo immediatamente sopra, alla minima distanza permessa dalla guida del fissatore. Eseguendo l'inserzione di questo chiodo si deve tenere presente la vicinanza del nervo radiale. I chiodi prossimali si collocano attraverso la massa muscolare del deltoide, anch'essi sulla faccia laterale, subito al di sotto della testa dell'omero. Una volta collocati i chiodi si può procedere all'osteotomia, che viene effettuata attraverso un'incisione di 1 cm sulla faccia anterolaterale del braccio, all'altezza della prominenza ossea di inserzione del pettorale. Questa, nel paziente acondroplasico, è particolarmente voluminosa, il che giova notevolmente all'allungamento: l'osso rigenerato in tale processo, infatti, avrà in tutta la sua lunghezza l'ampiezza del tubercolo, dando come risultato un omero più spesso di quello caratteristico dell'acondroplasico. Completata l'osteotomia all'altezza indicata, viene collocato il distrattore monolaterale preparato per un allungamento di 11 cm.
Nel periodo immediatamente successivo all'intervento il paziente deve effettuare ogni possibile tipo di movimento con le articolazioni dell'arto superiore (polso, gomito e spalla), a cui non bisogna porre alcun tipo di immobilizzazione. Il paziente può compiere i gesti abituali per mangiare, scrivere, lavarsi, ecc. La velocità di allungamento è, come nel caso precedente, di 1 mm al giorno diviso in due volte e l'entità totale dell'allungamento è compresa tra i 9 e gli 11 cm. La maggior parte degli autori riferisce che la formazione ossea nell'omero è abbondante per quanto riguarda i primi 6 cm di allungamento, mentre a partire dai 7 cm diminuisce un poco e si possono anche creare delle lacune ossee nel focolaio di allungamento, in particolar modo nel caso di pazienti adulti ma di giovane età. Ciò significa che un allungamento compreso tra i 9 e gli 11 cm è assai prossimo al limite delle possibilità di allungamento di un omero di acondroplasico. Terminata la fase di consolidamento osseo i fissatori esterni vengono estratti in ambulatorio, senza bisogno di ricoverare il paziente. Non c'è neanche bisogno di utilizzare gessi di protezione, visto che l'omero non deve essere sottoposto a notevoli carichi di peso.
In un gruppo di acondroplasici sottoposti a intervento di allungamento dell'omero sono state osservate queste complicazioni: in un caso (1,8%) si è avuta, in seguito a un trauma, rottura di uno dei chiodi, e lo si è dovuto sostituire per continuare l'allungamento; in 4 casi (7,4%) si è verificata una deviazione assiale, corretta con lo stesso distrattore, in anestesia totale; in altri 4 casi, durante la settimana successiva all'estrazione del fissatore si è prodotta una frattura, trattata con riduzione manuale e gesso. Infine, in un caso si è verificata la paresi del nervo radiale, risoltasi spontaneamente a partire dalla sesta settimana dopo l'operazione, senza bisogno di interrompere il processo di allungamento.
d) Tecnica chirurgica per l'allungamento del femore e per la correzione dell'iperlordosi.
A causa delle sue caratteristiche anatomiche, il femore è un osso sottoposto a notevoli forze di carico e tensioni muscolari, della cui azione si deve quindi tener conto durante il processo di allungamento, al fine di prevenire la comparsa di possibili complicazioni, quando si intende eseguire il relativo intervento.
Una delle principali caratteristiche fisiche predominanti del paziente acondroplasico è l'iperlordosi lombare, che può comportare gravi conseguenze durante la sua vita adulta; tale patologia a partire dalla terza decade di vita provoca spesso una compressione del canale midollare, dando origine a paraparesi degli arti inferiori e sindromi di incontinenza. L'allungamento del femore consente di realizzare una serie di modifiche nella struttura dell'anca, le quali, unite al controllo adeguato delle tensioni muscolari, sortiranno durante l'allungamento l'effetto di correggere l'iperlordosi lombare; la correzione si renderà del tutto manifesta nel momento in cui il paziente avrà terminato il processo di consolidamento e potrà assumere la normale stazione eretta, senza fissatori esterni.
Il collocamento dei chiodi si effettua attraverso la faccia laterale della coscia. Il più prossimale si inserisce nel piccolo trocantere, il secondo in una posizione leggermente posteriore, affinché nel momento del suo allineamento dopo l'osteotomia produca un effetto di estensione dell'anca. I chiodi distali vanno inseriti nella regione sopracondilea, perpendicolarmente all'asse del femore. L'osteotomia si realizza attraverso una mini-incisione cutanea nel terzo prossimale della faccia interna della coscia, preferibilmente all'altezza della regione metafiso-diafisaria dell'estremità prossimale del femore. Si approfitta di questa stessa incisione per effettuare una sezione trasversa della fascia lata, che faciliterà l'allungamento evitando la contrattura in flessione del ginocchio. Nello stesso modo si realizzano tenotomie percutanee dell'adduttore medio nella regione inguinale, del retto anteriore e dell'inserzione del muscolo sartorio sulla spina iliaca anterior-superiore. Queste tenotomie, oltre a ridurre le tensioni muscolari, hanno lo scopo di facilitare l'allungamento nell'asse corretto, dato che una tensione eccessiva dell'adduttore può deviare in varo tutto l'osso allungato; inoltre, esse contribuiscono alla correzione pelvica utile alla modificazione della lordosi lombare.
La velocità di allungamento è sempre di 1 mm al giorno, frazionato. A partire dal terzo giorno dopo l'intervento si può permettere ai pazienti la stazione eretta, e nei giorni successivi essi possono provare a camminare aiutati da un apparecchio protesico deambulatore o da stampelle. Questo esercizio è appropriato, perché da un lato aiuta a ridurre progressivamente la lordosi, dall'altro lato lo stimolo meccanico del carico favorisce la formazione ossea nel focolaio di allungamento. Come per l'allungamento delle tibie, i successivi controlli radiologici, che vanno effettuati mensilmente, permettono di seguire l'evoluzione del processo, fino al momento in cui si decide di estrarre i fissatori e di applicare dei cosciali di gesso per proteggere il callo osseo durante i due mesi seguenti. Dopo l'allungamento femorale i pazienti dovranno seguire una terapia specifica di riabilitazione funzionale che rieduchi la postura, la locomozione e il controllo del nuovo centro di gravità.
In un gruppo di pazienti sottoposti ad allungamento bilaterale del femore, le complicazioni più frequenti sono risultate distribuite nel modo seguente: in 17 casi (6,2%) deviazione assiale in varo, corretta mediante intervento chirurgico; in 18 casi (6,6%), tutti relativi a pazienti nei quali l'allungamento era stato realizzato in età superiore a 15 anni, limitazione della mobilità del ginocchio; 7 fratture prodottesi dopo l'allungamento; 5 infezioni profonde nella sede di infissione dei chiodi, 3 sublussazioni del ginocchio e altre 3 della rotula.
5. Considerazioni finali
In chirurgia ortopedica, la maggior esperienza nell'uso di tecniche chirurgiche di allungamento degli arti è stata acquisita nel campo della correzione delle dismetrie. In tutti i numerosi lavori pubblicati nella letteratura scientifica si fa riferimento alla grande quantità e alla varietà delle complicazioni che possono conseguire a tali interventi, pur se i risultati funzionali ottenenuti sono considerati buoni. Le pubblicazioni riguardanti l'impiego di queste tecniche nella correzione dei difetti di crescita sono più rare, e la maggior parte dei lavori si riferisce ad allungamenti eseguiti in pazienti acondroplasici. Vi sono assai poche informazioni sull'applicazione sistematica dell'allungamento delle estremità ai casi di bassa statura di origine non displasica.
La maggior parte degli autori con esperienza di allungamenti totali degli arti effettuati per migliorare i casi di bassa statura concordano nel classificare le complicazioni insorte (che nelle nostre statistiche ammontano a circa il 15%) in due gruppi: rientra nel primo tutta una serie di incidenti intrinseci ai processi di allungamento, dovuti al prolungarsi del trattamento e al fatto che i pazienti sono costretti a portare per mesi un fissatore esterno; tali incidenti, tuttavia, vengono normalmente risolti senza che vi siano ripercussioni sul risultato finale per ciò che riguarda la funzionalità. Appartengono invece al secondo gruppo alcune complicazioni importanti che necessitano, per essere risolte, di un intervento chirurgico minore (v. Bailey, 1970; v. Jones e Moseley, 1985; v. Ginebreda e altri, 1988; v. Vilarrubias e Ginebreda, 1988; v. Vilarrubias e altri, 1990; v. Aquerreta e altri, 1994; v. Ginebreda e Vilarrubias, 1994).
Vale la pena sottolineare che la tecnica chirurgica qui descritta ha permesso, grazie all'impiego dei fissatori monolaterali, di ridurre in maniera sostanziale il periodo di permanenza nell'ospedale, rendendo di conseguenza più economico il processo. Ciò non avviene se vengono utilizzate altre tecniche, ad esempio quelle che impiegano fissatori esterni di tipo circolare con fili di Kirschner, le quali necessitano di un periodo di permanenza in ospedale assai lungo, che danneggia evidentemente i pazienti da un punto di vista sia economico che psicologico. Il periodo medio di permanenza in ospedale richiesto per un intervento di allungamento di entrambe le tibie nei casi esaminati è stato di 3,2 giorni, mentre per l'allungamento di entrambi gli omeri solo di 1,5 giorni, e per quelli bilaterali dei femori di 3,8. A seconda delle necessità dei pazienti, vanno stabiliti controlli radiologici mensili e un regime di visite ambulatoriali.
Attualmente le tecniche di allungamento osseo sono di semplice applicazione. Tuttavia, bisogna stabilire una differenza tra i piccoli allungamenti, che mirano alla correzione di dismetrie, e i grandi allungamenti, intesi come opzione terapeutica per il difetto di crescita. Per portare a termine grandi allungamenti è necessaria una pianificazione più complessa, poiché sono numerosi i fattori che entrano in gioco. Ogni persona che voglia sottoporsi a un allungamento degli arti per migliorare la sua statura deve essere a conoscenza, insieme ai suoi familiari, della natura del procedimento, delle complicazioni che possono insorgere, del modo in cui queste possono essere evitate o risolte, e dei risultati dell'intervento. Di grande utilità per preparare all'intervento i pazienti e i genitori si è rivelato un supporto psicologico, sia sotto forma di organizzazione di gruppi di contatto - in cui i pazienti candidati a un allungamento comunicano direttamente con quelli che stanno subendo un processo di allungamento o lo hanno terminato - sia attraverso dei test e il lavoro di uno psicologo specializzato che segue il paziente. È anche molto importante sapere quali sono le aspettative dei pazienti e dei familiari sull'intervento, e chiarire che l'unico obiettivo che si raggiunge con l'intervento è un aumento di statura e la conseguente correzione di eventuali deformità dell'apparato locomotore. Qualunque altro tipo di aspettativa, come ad esempio sperare di migliorare lo scarso livello di accettazione sociale causato dal difetto di accrescimento, deve essere abbandonato.
La decisione dell'intervento deve interessare un gruppo di persone legate al paziente, comprendente la famiglia, la scuola, il pediatra di famiglia, inclusa un'unità multidisciplinare di un centro specializzato in patologia della crescita che abbia esperienza di allungamenti chirurgici. L'assistenza psicologica prima e durante il trattamento di allungamento è imprescindibile per il buon fine del processo.
BIBLIOGRAFIA
Abott, L. C., The operative lengthening of the tibia and fibula, in ‟Journal of bone and joint surgery", 1987, IX, pp. 128-152.
Aguirre, M., Efectos de la dinamización axial sobre la consolidación ósea del callo de elongación, Tesi di dottorato, Università di Navarra, 1990.
Aldegheri, R., Renzi-Brivio, L., Agostini, S., The callostasis method of limb lengthening, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1989, CCXLI, pp. 137-145.
Allan, F. G., Simultaneus femoral and tibial lengthening, in ‟Journal of bone and joint surgery: British volume", 1963, XLV, p. 206.
Aquerreta, J. D., Forriol, F., Cañadell, J., Estudio prospectivo de la elongación de los segmentos óseos y de sus complicaciones, in ‟Revista de ortopedía y traumatología", 1994, XXXVIII IB, 1, pp. 1-11.
Aronson, J., Harrison, B. H., Stewart, C. H. e altri, The histology of distraction osteogenesis using different external fixators, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1989, CCXLI, pp. 106-116.
Arrien, A., Estudio comparativo de las osteotomías a cielo abierto y percutáneas en la elongación ósea, Tesi di dottorato, Università di Navarra, 1986.
Bailey, J. A., Orthopaedic aspects of Achondroplasia, in ‟Journal of bone and joint surgery", 1970, LII, pp. 1-258.
Cañadell, J., Forriol, F., Aspectos mécanicos de la elongación, in Fijación externa monolateral, Pamplona 1993.
Cara del Rosal, J. A., Influencia de la vascularización sobre el callo de elongación, Tesi di dottorato, Università di Navarra, 1992.
Cattaneo, R., Villa, A., Catagni, M. A., Bell, D., Lengthening of the humerus using the Ilizarov technique, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1990, CCL, pp. 117-124.
De Bastiani, G., Aldegheri, R., Renzi-Brivio, L. R., Trivella, G., Limb lengthening by callus distraction (callostasis), in ‟Journal of pediatric orthopedics", 1987, VII, pp. 129-134.
Delloye, C., Delefortrie, G., Noel, H. e altri, Histogenesis of bone regenerate formation in lengthened cortical bone, in ‟Transactions of the annual meeting of the Orthopaedic Research Society", 1989, XIV, p. 565.
Ginebreda, I., Jimeno, E., Cavaliere, P., Vilarrubias, J. M., Alargamiento de las extremidades. Tecnica ICATME, in ‟Aparato locomotor", 1988, XX, pp. 4-44.
Ginebreda, I., Vilarrubias, J. M., Contribució de la cirurgia en el tractament de la talla baixa, in Introducció als trastorns del creixement (a cura di E. Vicens-Calvet), Tarragona 1994, pp. 237-254.
Ilizarov, G. A., The tension-stress effect on the genesis and growth of tissues. Part I. The influence of stability of fixation and soft tissue preservation. Part II. The influence of the rate and frequency of distraction, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1989, CCXXXVIII-CCXXXIX, pp. 249-281 e 263-285.
Ilizarov, G. A., Deviatov, A. A., Operative elongation of the leg, in ‟Ortopediya traumatologiya i protezirovaniye", 1971, XXXII, pp. 20-25.
Ilizarov, G. A., Deviatov, A. A., Trokhova, V. G., Surgical lengthening of the shortened lower extremities, in ‟Vestnik khirurgii im. i. i. grekova", 1972, CVII, p. 100.
Ilizarov, G. A., Soybelman, L. M., Some clinical and experimental data on the bloodles lengthening of the lower limbs, in ‟Eksperimental 'naya khirurgiya i anesteziologiya", 1969, IV, pp. 27-32.
Jones, D. C., Moseley, C. F., Subluxation of the knee as a complication of femoral lengthening by Wagner technique, in ‟Journal of bone and joint surgery: British volume", 1985, LXVII, pp. 33-35.
Kawamura, B., Hososno, S., Jakohosi, T., Tomita, R., The principles and techniques of limb lengthening, in ‟International orthopaedics", 1981, V, pp. 69-83.
Kojimoto, H., Yasui, N., Sasaki, A. e altri, Blood supply during experimental bone lengthening by callus distraction, in ‟Transactions of the annual meeting of the Orthopaedic Research Society", 1989, XIV, p. 564.
Korzinek, K., Tepic, S., Perren, S. M., Limb lengthening and threedimensional deformity correction. A retrospective study, in ‟Archives of orthopaedic and trauma surgery", 1990, CIX, pp. 334-340.
Lazo, J., Lazo, J. M., Mozo, F. e altri, La biocompresión en las elongaciones óseas, in Elongación osea. Estado actual y controversias (a cura di J. Pablos e J. Cañadell), Pamplona 1990.
Plawecki, S., La méthode d'Ilizarov appliquée aux alongements et corrections axiales des membres inférieurs chez l'enfant, Tesi di dottorato, Università di Grenoble, 1987.
Vilarrubias, J. M., Ginebreda, I., À propos de 500 allongements des membres inférieurs par une technique personelle chez l'achondroplase, in ‟Acta orthopaedica belgica", 1988, LIV, pp. 384-390.
Vilarrubias, J. M., Ginebreda, I., Jimeno, E., Lengthening of the lower limbs and correction of hyperlordosis in achondroplasia, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1990, CCL, pp. 143-149.
Wagner, H., Surgical lengthening or shortening of the femur and tibia. Techniques and indications, in ‟Progress in orthopaedic surgery", 1977, I, pp. 71-94.
Wagner, H., Operative lengthening of the femur, in ‟Clinical orthopaedics and related research", 1978, CXXXVI, pp. 125-142.
Chirurgia plastica di Nicolò Scuderi
SOMMARIO: 1. Definizione e generalità. 2. Cenni storici. 3. Patologie congenite: a) malformazioni dell'estremo cefalico; b) malformazioni della mano; c) malformazioni dei genitali esterni; d) altre malformazioni. 4. Patologia traumatica: a) traumi da cause meccaniche; b) traumi da vari agenti fisici. 5. Patologia tumorale: a) epiteliomi; b) melanoma. 6. Problemi estetici. 7. Tecniche specialistiche: a) lembi e innesti; b) lembi espansi e prefabbricati; c) immunità e biocompatibilità; d) la guarigione delle ferite. □ Bibliografia.
1. Definizione e generalità
La chirurgia plastica (dall'aggettivo greco plastikòs, che plasma, che conforma) è la disciplina che si occupa di modificare, correggere, ricostruire le forme del corpo umano. Il suo campo di applicazione si estende quindi dalla eliminazione degli inestetismi (chirurgia plastica estetica) alla correzione di dismorfismi sia acquisiti che congeniti (chirurgia plastica correttiva o ortomorfica), fino alla ricostruzione di strutture corporee assenti o amputate (chirurgia plastica ricostruttiva). La chirurgia plastica, come presupposto essenziale, salvaguarda l'integrità delle strutture operate e, quando possibile, provvede a un miglioramento o al ripristino dello stato fisiologico.
Per raggiungere le sue finalità, la chirurgia plastica deve, di norma, intervenire sul rivestimento cutaneo, che costituisce il contenitore esterno e visibile del corpo umano, ma spesso, specialmente in alcune regioni (estremo cefalico, arti), deve anche modificare i tessuti profondi. In particolare, in tutti gli interventi di modellamento del profilo corporeo si agisce sulle strutture sottotegumentarie, così come spesso, per motivi funzionali, si eseguono plastiche su tendini, aponeurosi, muscoli, ossa, pareti di cavità interne, visceri cavi, articolazioni, orifizi e così via. Si potranno avere, pertanto, plastiche ‛allarganti' o ‛restringenti' (per la cura di stenosi o ectasie), di ‛allungamento' o di ‛accorciamento' (per tendini, ossa, visceri cavi), ‛deostruenti' (per la correzione di atresie congenite o cicatriziali), di ‛rinforzo' (per la ricostruzione di strutture di contenimento come la parete addominale), di ‛modellamento' (per il miglioramento dell'aspetto corporeo), la gran parte delle quali realizzata a scopo ortomorfico.
2. Cenni storici
Disciplina chirurgica fra le più antiche, la chirurgia plastica ha le sue radici in pratiche tramandate dai tempi più remoti e originariamente applicate al regno vegetale, dal quale, del resto, molta della corrente terminologia specialistica discende più o meno direttamente (si pensi a termini come innesto, impianto, coltura, ecc.). Essa trae origine dall'innata tendenza dell'uomo a curare ferite e deformità inflitte dai propri simili o dalla natura, ed era già praticata nell'area mesopotamica 2.000 anni prima di Cristo, epoca alla quale risalgono i primi interventi di plastica nasale. Le prime accurate descrizioni di interventi di chirurgia ricostruttiva, tuttavia, si trovano nei Veda, libri sacri indiani databili tra il XV e il VI secolo a.C., il cui autore, Sušruta, tratta l'argomento della ricostruzione della piramide nasale, dopo amputazione traumatica, da effettuarsi con un lembo di cuoio capelluto e cute frontale.
Interventi di chirurgia plastica vengono attribuiti anche a scuole chirurgiche della Magna Grecia, quali quelle di Empedocle ad Agrigento, Filistone a Catania e Alcmeone a Crotone. Aulo Cornelio Celso (25 a.C. - 50 d.C.) descrisse tecniche per la correzione dell'entropion palpebrale e dell'ipospadia, nonché alcuni lembi di avanzamento per la ricostruzione di difetti facciali.
La chirurgia plastica, dopo un periodo di scarso sviluppo, rinasce al termine del Medioevo nel meridione d'Italia: tecniche di sutura estetica delle ferite furono descritte dalla Schola Medica Salernitana, mentre in Sicilia Gustavo e Antonio Branca praticarono con successo, tra il Trecento e il Quattrocento, la ricostruzione nasale, prima con il metodo indiano e poi utilizzando un lembo di cute trasferito dal braccio. Tale tecnica, utilizzata cento anni dopo anche dai Vianeo in Calabria e ampiamente descritta poi nel 1597 da Gaspare Tagliacozzi (1549-1599) nel suo De curtorum chirurgia per insitionem, ha rappresentato una pietra miliare nella storia della chirurgia plastica mondiale, giungendo infine a essere definita ‛rinoplastica all'italiana'.
Nel corso degli ultimi due secoli la chirurgia plastica mostra uno sviluppo vertiginoso, a partire dalla riscoperta e utilizzazione del metodo indiano per la ricostruzione del naso, a opera del chirurgo inglese Joseph Carpue, nel XIX secolo; nello stesso periodo, sulla base degli studi sperimentali di Cesare Baronio e con il contributo di numerose esperienze cliniche maturate in tutto l'Occidente, fu messa a punto e rifinita la tecnica di prelievo degli innesti di cute e ne furono precisate le indicazioni.
Nel XX secolo anche la chirurgia plastica estetica cominciò a essere ampiamente praticata, e tra i pionieri vanno ricordati Y. Joseph in Germania e madame S. Noël in Francia. L'impulso decisivo per il moderno sviluppo della disciplina è stato dato dalle esperienze belliche maturate nei due conflitti mondiali. La prima guerra mondiale, combattuta in trincea, produsse un'enorme quantità di gravi lesioni facciali e spinse molti chirurghi a specializzarsi nel loro trattamento, mettendo insieme le diverse esperienze specialistiche da cui provenivano. Illustri chirurghi come il francese H. Morestin, il britannico H. D. Gillies, gli statunitensi V. H. Kazanjian e V. P. Blair, il tedesco E. Lexer, l'austriaco Y. F. S. Esser e il cecoslovacco F. Burian acquistarono negli anni venti e trenta fama internazionale come chirurghi plastici. In Italia G. Sanvenero-Rosselli istituì il primo corso di insegnamento della disciplina e curò la pubblicazione di una rivista internazionale intitolata ‟Plastica chirurgica".
Durante la seconda guerra mondiale, soprattutto per il massiccio impiego del mezzo aereo, le lesioni traumatiche e le ustioni al volto e alle mani fornirono un ulteriore potente stimolo alla crescita della chirurgia plastica così come oggi la conosciamo. Negli ultimi decenni la tecnologia e la maggiore affidabilità delle tecniche di anestesia hanno offerto la possibilità di sviluppare nuovi settori della chirurgia plastica, come la chirurgia plastica cranio-facciale, soprattutto a opera del francese Paul Tessier, e quella della mano; sono inoltre divenute di uso comune le tecniche di microchirurgia ricostruttiva, che consentono di raggiungere livelli di accuratezza fino a ieri assolutamente impensabili (v. anche chirurgia: Microchirurgia ricostruttiva, vol. VIII).
Attualmente, la chirurgia plastica si occupa prevalentemente della correzione delle patologie congenite, della riparazione della patologia traumatica, della terapia della patologia tumorale cutanea e degli interventi di ordine estetico.
3. Patologie congenite
In virtù delle sue finalità ricostruttive, correttive ed estetiche, la chirurgia plastica si è da sempre interessata alle malformazioni esterne, specie quelle a carico del viso, delle mani, dei genitali esterni.
a) Malformazioni dell'estremo cefalico.
Queste malformazioni, la cui classificazione è tuttora discussa ed estremamente intricata, comprendono la labiopalatoschisi, le cisti e fistole del collo, le malformazioni delle palpebre e del padiglione auricolare, nonché le cosiddette malformazioni complesse, come la sindrome di Crouzon, la sindrome di Apert e la microsomia emifacciale. Il meccanismo patogenetico comune di queste malformazioni, per buona parte delle quali è stato possibile individuare chiaramente anomalie genetiche di tipo ereditario, sembra in ogni caso schematicamente riconducibile a due alterazioni, l'una a carico dei meccanismi di unione delle strutture embriogenetiche, l'altra dello sviluppo di intere strutture o di parti di esse.
La più comune tra le malformazioni del viso è la labiopalatoschisi, che è l'associazione di due distinte malformazioni, che possono riscontrarsi separatamente, la labioschisi e la palatoschisi. La labioschisi, o labbro leporino, o cheiloschisi, che può essere mono- o bilaterale, è caratterizzata dalla presenza di una fissurazione del labbro superiore in posizione paramediana. La palatoschisi, invece, è costituita dalla presenza di una comunicazione tra cavità orale e nasale, dovuta alla mancata chiusura delle strutture che compongono il palato.
La labiopalatoschisi, che è tra le malformazioni più frequenti in assoluto, presentando un'incidenza media di 1 su 750-800 nati vivi, colpisce più frequentemente il sesso maschile. Nella sua trasmissione è dimostrata la presenza di una componente genetica: le possibilità di generare un figlio malformato, che sono dello 0,12% in una coppia normale, divengono del 4% se uno dei genitori è affetto da schisi o se da genitori sani è già nato un figlio con schisi, del 9% nel caso di genitori sani con due figli con schisi, e raggiungono il 17% nel caso di un genitore con schisi che ha già avuto un figlio con la stessa malformazione. Dal punto di vista terapeutico, gli obiettivi da raggiungere sono il ripristino della funzionalità del labbro, un miglioramento estetico e il corretto orientamento delle strutture al fine di consentirne un armonico sviluppo. Tale risultato è conseguibile per mezzo dell'accostamento dei monconi del muscolo orbicolare delle labbra, accompagnato dal riposizionamento delle cartilagini dell'ala nasale del lato interessato dalla schisi e dalla ricostruzione del filtro labiale mediante un lembo di rotazione della cute mediale della schisi, che viene congiunto a un altro di avanzamento della cute laterale.
La palatoschisi, a differenza della labioschisi, pone l'immediato problema dell'alimentazione del neonato, poiché a causa della comunicazione oro-nasale questi pazienti sono incapaci di succhiare; problemi accessori sono costituiti dalla facile insorgenza di flogosi delle prime vie aeree, dalla impossibilità di una corretta fonazione, dall'accrescimento asimmetrico delle strutture mascellari con turbe della masticazione, e infine dai problemi estetici conseguenti all'iposviluppo del terzo medio della faccia. L'intervento chirurgico correttivo, allo scopo di ricostruire la continuità del palato e di garantire la necessaria mobilità del palato molle, viene eseguito precocemente. Vengono praticate due incisioni ai margini della schisi e vengono scollati e suturati sulla linea mediana due lembi di fibromucosa, chiudendo la schisi, dal lato nasale e orale; il palato molle e l'ugola vengono ricostruiti accostando i muscoli e la relativa mucosa sulla linea mediana. Intorno ai tre anni si rende poi necessaria l'assistenza di un foniatra e di un logopedista, e in fase tardiva, se necessario, si può far ricorso a ulteriori interventi per migliorare l'estetica o correggere l'articolato dentario. In circa il 10% dei casi, infine, si rende necessario un ulteriore intervento di natura funzionale per correggere l'eventuale incapacità del palato molle di separare efficacemente la cavità orale da quella nasale durante la fonazione (incontinenza velo-palatina); in questo caso si allestisce un lembo mucoso dalla parete posteriore della faringe, che viene suturato al bordo libero posteriore del palato molle, riducendo permanentemente lo spazio di comunicazione tra bocca e naso (faringoplastica).
b) Malformazioni della mano.
Le malformazioni di questo tipo costituiscono un capitolo particolarmente vasto e complesso; vengono generalmente divise in malformazioni per difetto oppure per eccesso di accrescimento, per mancata divisione o per errore di forma dei singoli elementi. Molte di queste hanno carattere ereditario e spesso si associano a malformazioni esterne complesse o interne, specie cardiache. Tra le più frequenti citiamo la polidattilia e la sindattilia.
La polidattilia è caratterizzata dalla presenza di uno o più raggi digitali o di loro parti in soprannumero, e viene classificata in sottogruppi sulla base della localizzazione dell'elemento soprannumerario: polidattilia radiale, ulnare o da dita intercalate. Può essere completa o incompleta. L'intervento chirurgico correttivo consiste nell'amputazione dell'elemento soprannumerario, correttamente identificato per mezzo di esami radiografici e angiografici.
La sindattilia è caratterizzata dalla fusione totale o parziale di due o più dita. Colpisce circa un bambino su 500 nati, con una certa maggior frequenza nel lato sinistro. La correzione viene effettuata separando gli elementi e ricostruendo la cute con plastiche a Z multiple, o, nei casi più gravi, con innesti cutanei a spessore parziale.
c) Malformazioni dei genitali esterni.
Queste malformazioni costituiscono una patologia di frequente riscontro, suscettibile in molti casi di trattamento chirurgico ricostruttivo. Rientrano in questo settore anche gli stati intersessuali, i cosiddetti ermafroditismi e pseudoermafroditismi, e le altre anomalie congenite del sesso, come pure altre frequenti patologie quali le ernie inguinali o la ritenzione del testicolo. La fimosi è un'alterazione, in genere acquisita e non congenita, costituita dal restringimento dell'orifizio prepuziale con impossibilità dello scorrimento del prepuzio; il suo trattamento chirurgico consiste nell'asportazione del prepuzio (circoncisione) e si rende normalmente necessario come profilassi delle balanopostiti ricorrenti e per le difficoltà che i pazienti incontrano nei rapporti sessuali. In alcuni casi è possibile eseguire un intervento con mantenimento parziale del prepuzio, al fine di risparmiarne la funzione protettiva, detto ‛postectomia'.
L'ipospadia è un'alterazione dello sviluppo dell'uretra maschile, il cui sbocco esterno si trova in posizione più o meno prossimale rispetto all'apice del glande, sulla superficie ventrale del pene. È la più frequente delle malformazioni genito-urinarie, e si manifesta in media in un caso ogni 400 nati maschi. Frequentemente, in oltre il 40% dei casi, allo sbocco anomalo dell'uretra si associano la stenosi del meato urinario e l'incurvamento ventrale dell'asta. Il trattamento chirurgico, consistente nella ricostruzione del tratto di uretra mancante, viene in genere effettuato tra i 3 e i 5 anni di età. La neouretra viene allestita con un lembo a isola di cute prepuziale dorsale, che viene trasposto ventralmente, tubulizzato su un tutore e suturato in continuità alla vecchia uretra.
Tra le anomalie congenite del sesso vanno annoverate le più comuni malformazioni complesse dell'apparato genitale di interesse anche chirurgico. La sindrome di Turner, definita anche ‛sindrome della gonade rudimentale', è caratterizzata dal mancato sviluppo di gonadi funzionanti, con genitali esterni differenziati in senso femminile e quadro eterosomico X-0. Frequentemente è associata a malformazioni quali labiopalatoschisi, amastia o ipomastia, pterigium colli, deformità articolari. La sindrome di Klinefelter è caratterizzata dalla presenza di uno o più cromosomi X soprannumerari e fenotipo maschile: i portatori sono in genere alti, con ginecomastia, iposviluppo dei genitali esterni e ritardo mentale. Il trattamento prevede la correzione chirurgica della ginecomastia e l'introduzione eventuale di protesi testicolari in silicone a fini esclusivamente estetici e psicologici. Lo pseudoermafroditismo femminile è uno stato intersessuale caratterizzato dalla presenza di gonadi femminili con fenotipo differenziato in senso maschile, ed è conseguenza di un abnorme tasso di androgeni durante la vita intrauterina. Il trattamento è basato sulla somministrazione esogena di cortisolo e sulla femminilizzazione chirurgica; nei casi in cui si sia costituito un atteggiamento psicologico maschile, si procede invece alla virilizzazione e all'asportazione di utero e annessi. Lo pseudoermafroditismo maschile è caratterizzato dalla presenza di testicoli più o meno normali con fenotipo ambiguo o chiaramente femminile: la sua forma più tipica è la sindrome di Morris, ereditaria, con corredo cromosomico XY e cromatina sessuale negativa. I soggetti presentano un fenotipo chiaramente femminile, e vengono in genere sottoposti a un trattamento femminilizzante di tipo sia ormonale che chirurgico. L'ermafroditismo vero è una rara malformazione dovuta alla contemporanea presenza nello stesso soggetto di tessuto ovarico e testicolare. Nella maggior parte dei casi si tratta di individui cromosomicamente femminili con cromatina sessuale positiva; il fenotipo è ambiguo, con sviluppo mammario e genitali esterni maschili o femminili. Il trattamento, che dovrebbe essere effettuato in età prepubere, è normalmente orientato alla femminilizzazione, essendo insoddisfacenti i risultati della mascolinizzazione.
d) Altre malformazioni.
Tra le malformazioni esterne di particolare interesse per la chirurgia plastica vanno ancora ricordati i nevi giganti, le malformazioni vascolari arteriose e/o venose e le malformazioni linfatiche. Il nevo gigante si presenta clinicamente come una lesione di notevoli dimensioni, spesso estesa a vaste zone del tronco o degli arti, notevolmente pigmentata, molto spesso ricoperta da peli. Poiché è dimostrata una notevole incidenza, circa il 10%, di melanomi maligni a insorgenza nel contesto del nevo, l'escissione chirurgica viene generalmente indicata come necessaria; essa è seguita dalla plastica cutanea mediante innesti, espansione cutanea, o utilizzando cute coltivata.
Le malformazioni vascolari e linfatiche vanno distinte dagli angiomi e dai linfoangiomi, con cui per anni sono state associate e confuse a causa di una nomenclatura imprecisa e non standardizzata. Le malformazioni vascolari sono sempre presenti al momento della nascita e crescono lentamente, o, più correttamente, aumentano le loro dimensioni di pari passo con quelle generali del bambino. Sono classificate come tali numerose sindromi malformative complesse, tra cui la sindrome di Sturge-Weber (associazione di malformazioni vascolari encefalo-trigeminali con glaucoma e lesioni calcifiche intracraniche), la sindrome di Klippel-Trenaunay (malformazioni vascolari degli arti associate a ipertrofia ossea e dei tessuti molli nei distretti interessati) e la sindrome di Kasabach-Merritt (malformazioni vascolari di grandi dimensioni che determinano trombocitopenia e coagulazione intravasale disseminata, spesso con esito infausto).
Gli angiomi sono lesioni generalmente non presenti alla nascita, che divengono evidenti nella prima settimana di vita e sono caratterizzate da una crescita rapidissima; il loro aspetto può essere abbastanza diverso in base alla collocazione cutanea superficiale o profonda, con un colore tipicamente rosso vivo che può giungere fino al bluastro. La loro crescita comincia, di norma, a rallentare intorno ai sei-dodici mesi, e generalmente entro il quinto o sesto anno di vita si verifica una regressione spontanea che non lascia che minime tracce di tessuto fibroso. Il loro trattamento è di semplice attesa e osservazione, a meno che non vengano coinvolte sedi particolari, come per esempio le palpebre, dove gli angiomi, a causa del loro volume, possono essere di ostacolo meccanico al corretto sviluppo di determinate funzioni, come la vista, costringendo a un intervento terapeutico precoce.
4. Patologia traumatica
La patologia traumatica rappresenta senz'altro il più antico campo di applicazione della chirurgia plastica, come della chirurgia in generale. Nella trattazione vanno distinti i traumi da cause meccaniche e i traumi da altre cause fisiche o chimiche.
a) Traumi da cause meccaniche.
Questi traumi comprendono i vari tipi di ferite: contusioni, escoriazioni, ferite da taglio o da punta, ferite da arma da fuoco, ferite a lembo, ferite lacero-contuse, ferite con perdita di sostanza. Il trattamento, dipendente dal quadro clinico, può generalmente essere schematizzato in: ispezione, detersione e disinfezione, rimozione di eventuali corpi estranei, sutura, trattamento farmacologico (terapia antibiotica, profilassi antitetanica, ecc.). Le tecniche di chirurgia plastica vengono sempre più spesso richieste nel caso di lesioni complesse, o se sono interessate aree esposte (viso-mani), per cui, in conseguenza del danno traumatico, insorgono problemi estetici che rendono necessari non solo la ricostruzione funzionale, ma anche il ripristino della migliore morfologia possibile affinché il paziente possa condurre una normale vita di relazione.
b) Traumi da vari agenti fisici.
Nell'ambito degli agenti fisici, il calore elevato è il principale responsabile di danno corporeo. Si definisce ustione il processo patologico conseguente all'esposizione a temperature eccessive; la gravità di un'ustione è legata alla temperatura raggiunta dai tessuti e alla durata della loro esposizione all'agente termico. Fugaci esposizioni a temperature fino a 50-70° producono solo modificazioni funzionali, mentre temperature più elevate provocano denaturazione delle proteine complesse, danno cellulare e infine necrosi. Un importante fattore che incide sulla gravità delle ustioni è lo spessore della cute, in particolar modo dello strato corneo; a parità di altri fattori si avranno ustioni più gravi nel bambino che nell'adulto, nel viso rispetto alla pianta del piede. Le ustioni vengono generalmente classificate in base alla loro profondità e in base alla loro estensione: si distinguono pertanto ustioni di primo, secondo o terzo grado che interessano rispettivamente l'epitelio, il derma a varia profondità, e la cute a tutto spessore; per quanto riguarda l'estensione, le ustioni si classificano in base alla percentuale di superficie corporea interessata dal danno (dall'1 al 100%).
Le ustioni epiteliali e dermiche superficiali guariscono normalmente per riepitelizzazione spontanea, mentre le ustioni dermiche profonde o a tutto spessore della cute vanno incontro a demarcazione spontanea dei tessuti necrotici e all'eliminazione per colliquazione con sovrainfezione batterica, e richiedono quindi un intervento di riparazione plastica cutanea. L'attuale orientamento terapeutico è comunque quello di eliminare precocemente, entro i primi giorni dal trauma, il materiale necrotico (escarectomia chirurgica precoce o precocissima) e ricoprire i tessuti sani con innesti cutanei a spessore parziale.
Allorché l'estensione di un'ustione supera il 20% della superficie corporea di un adulto o il 10% in un bambino, si verificano alterazioni di tipo sistemico che configurano il quadro della malattia da ustione. In questa situazione l'ustione cessa di essere un fatto prevalentemente locale, e richiede, soprattutto nella prima fase, delicati processi rianimatorii, basati su un'adeguata somministrazione di liquidi per infusione venosa fino al ripristino della volemia, sul monitoraggio della diuresi oraria, sull'eventuale terapia dello shock e dell'acidosi e su una opportuna terapia analgesica e sedativa. Per tale motivo sono stati istituiti in tutto il mondo i Centri ustione, dedicati esclusivamente al trattamento di questi delicatissimi casi, che necessitano di personale particolarmente addestrato e di ambienti in cui venga mantenuta l'asepsi più rigorosa.
Un cenno particolare meritano altre lesioni da agenti fisici, e propriamente le folgorazioni, conseguenti al contatto con corrente elettrica di elevata intensità, i congelamenti, dovuti a esposizione a basse temperature, le radiodermiti, in genere conseguenti a terapie radianti di aree interessate da tumori maligni.
5. Patologia tumorale
Nel campo dell'oncologia la chirurgia plastica ha un duplice ruolo: si interessa del trattamento delle neoplasie benigne o maligne della cute e delle parti molli (basaliomi, spinaliomi e melanomi maligni), effettuando le complesse ricostruzioni chirurgiche necessarie a correggere i dismorfismi più o meno importanti provocati dalla loro asportazione. Inoltre, la chirurgia plastica collabora con altre specialità oncologiche per la ricostruzione di regioni anatomiche (mammelle, arti, ecc.) demolite o danneggiate in seguito al trattamento (chirurgico, radiante o altro).
a) Epiteliomi.
Il basalioma, o epitelioma basocellulare, o carcinoma a cellule basali, è la neoplasia più frequente in assoluto, e rappresenta da solo oltre il 50% delle neoplasie cutanee maligne. Colpisce con lieve preferenza il sesso maschile, con la massima incidenza tra i sessanta e gli ottant'anni. È ormai ampiamente dimostrato come l'esposizione cronica e prolungata alle radiazioni solari sia strettamente collegata all'insorgenza di questo tumore, che compare per il 90% in aree fotoesposte, viso in particolare, in pazienti che per motivi professionali o geografici sono esposti alle radiazioni ultraviolette molte ore al giorno. Il quadro clinico della lesione è più frequentemente quello di un'erosione cutanea che si evolve fino a un aspetto francamente ulcerativo con margini netti e callosi, fondo crostoso e facilmente sanguinante. L'accrescimento è lento, e la metastatizzazione rarissima, ma la neoplasia è comunque in grado di portare a morte il paziente infiltrando strutture vitali come l'encefalo o grossi vasi. La terapia consiste nell'asportazione radicale del tumore.
Lo spinalioma, o epitelioma spinocellulare, o carcinoma a cellule squamose, è una neoplasia maligna che può insorgere su qualsiasi epitelio, costituita da cellule che tendono alla cheratinizzazione. Dopo il basalioma è il tumore cutaneo più frequente, e colpisce con netta prevalenza il sesso maschile (80%), tra i sessanta e i settant'anni di vita. Tra i fattori predisponenti vanno considerate le radiazioni solari, le radiazioni ionizzanti, gli agenti chimici come paraffina o catrame, le cicatrici distrofiche, le ulcere flebostatiche, le aree di flogosi cronica. Tipicamente si presenta come un nodulo ulcerato o un'erosione, dotati di notevole rapidità di sviluppo e capacità di dar luogo a metastasi. Il trattamento prevede l'ampia escissione chirurgica (margine sano di almeno 1 cm), con linfoadenectomia se necessaria, e/o eventualmente terapia palliativa chemioterapica o radiante.
b) Melanoma.
Il melanoma maligno rappresenta, pur con un'incidenza più bassa rispetto ai carcinomi cutanei, la più comune causa di morte tra le neoplasie della cute. Secondo le teorie più diffuse, origina dalla trasformazione dei melanociti che si trovano nella cute normale e, in quantità molto maggiore, nei nevi. Il principale fattore predisponente sembra essere, anche in questo caso, l'esposizione alle radiazioni ultraviolette, prolungata od occasionale ma intensa, con una maggiore incidenza nei soggetti a carnagione chiara che vivono in aree geografiche di forte insolazione. In base all'aspetto clinico il melanoma viene distinto in vari tipi: a crescita superficiale, nodulare, su lentigo maligna, lentigginoso delle estremità. È in genere caratterizzato da pigmentazione scura irregolare, sanguinamento spontaneo, sintomatologia soggettiva di prurito o dolore e modificazioni rapide di forma e colore. Lo stadio clinico della malattia viene valutato sulla base della classificazione istologica in livelli di invasione (di W. H. Clark) o mediante la classificazione di A. Breslow della profondità di infiltrazione misurata in millimetri. Con gli attuali criteri terapeutici (ampia escissione chirurgica con eventuale linfoadenectomia e terapia di supporto) la maggior parte delle casistiche riporta una sopravvivenza a cinque anni vicina al 100% nei casi meno avanzati, evidenziando così l'estrema importanza di una diagnosi precoce.
6. Problemi estetici
Ricade infine nell'ambito della specialità il trattamento di tutti i processi patologici o parafisiologici che modificano le fattezze dell'organismo, nonché la correzione delle deviazioni dalla norma dell'aspetto esteriore giudicate inestetiche. La chirurgia plastica ha assunto un suo ruolo sempre più importante e ben definito in quella che, definita come chirurgia estetica, si è sempre più avvicinata alla chirurgia ricostruttiva. Le motivazioni che spingono i pazienti a sottoporsi a interventi di chirurgia estetica, infatti, possono essere rappresentate da inestetismi oggettivamente evidenti, o anche avvertiti solo soggettivamente, che comunque comportano problemi psicologici nella vita di relazione tali da giustificare il ricorso alla terapia chirurgica; un caso limite è rappresentato dalle malformazioni craniofacciali, nelle quali gravi motivazioni di ordine funzionale all'intervento chirurgico correttivo coesistono con necessità di miglioramento estetico che spesso, nei desideri dei pazienti, prevalgono sulle prime. Ovviamente la maggior parte degli interventi di chirurgia estetica viene eseguita per inestetismi del viso (rinoplastica, blefaroplastica, lifting), in virtù dell'estrema dominanza del volto nella normale vita di relazione, in misura minore per la correzione del contorno corporeo (lipoaspirazione, addominoplastica, mastoplastica). Intuitiva è la distinzione tra la chirurgia plastica estetica dei difetti costituzionali e quella dell'invecchiamento, che tende a correggere i dismorfismi (rughe, pliche cutanee, ecc.) che si rendono manifesti in modo più o meno evidente con il trascorrere del tempo in età adulta o avanzata.
7. Tecniche specialistiche
La chirurgia plastica è una disciplina chirurgica non regionale, che (a differenza delle discipline di organo) privilegia lo studio e il perfezionamento delle metodiche ricostruttive piuttosto che il semplice approfondimento degli aspetti patologici. In particolare sono parte integrante del patrimonio culturale della materia: la biologia dei processi di guarigione e di rigenerazione, il trapianto dei tessuti, la biocompatibilità e le tecniche di impianto dei materiali alloplastici, l'approfondimento dei meccanismi molecolari dei processi di riparazione. Tutti questi settori hanno avuto negli ultimi anni un progresso notevole, dovuto alla ricerca biomedica di base, per la quale la chirurgia plastica rappresenta un insostituibile laboratorio di applicazione clinica.
a) Lembi e innesti.
Lo studio delle tecniche di trapianto dei tessuti rappresenta uno dei cardini su cui si fonda il corpo dottrinario della specialità. Per ‛trapianto' in senso stretto si intende il trasferimento di un organo, ripristinandone la vascolarizzazione, da un individuo a un altro (trapianto di cuore, rene, ecc.); tuttavia in senso lato, e in chirurgia plastica, si considera trapianto qualunque trasferimento di tessuto da una sede (donatrice) a un'altra (ricevente), oppure da un individuo a un altro. Vengono così distinti, nel campo dei trapianti, i lembi e gli innesti. Nella terminologia corrente si definisce trasferimento di un lembo il trapianto di uno o più tessuti dotati di un apporto vascolare proprio (peduncolo), la cui continuità viene rispettata, il che garantisce la sua sopravvivenza. Si chiama innesto il trasferimento di tessuti privati di ogni connessione vascolare con la sede donatrice, e destinati all'attecchimento per opera del letto in cui sono collocati nell'area ricevente. È pertanto evidente come l'impiego di un lembo sia sempre sinonimo di ‛autoplastica', cioè ricostruzione con tessuti dello stesso individuo, e come sia invece possibile l'impiego di innesti di provenienza anche diversa dall'individuo che li riceve.
Gli innesti possono essere quindi classificati, rispetto alla provenienza del tessuto, come autoinnesti (prelevati dallo stesso soggetto che li riceve), omoinnesti (prelevati da individui della stessa specie), eteroinnesti (prelevati da individui di specie diversa dal ricevente, eventualmente biologicamente inferiore); sono destinati all'attecchimento definitivo i soli autoinnesti, mentre gli altri vanno, dopo un breve periodo di tempo, incontro a rigetto per motivi immunitari o a trasformazione fibrosa. Un'ulteriore classificazione è possibile in base ai tessuti costituenti l'innesto (cute, adipe, osso, tendine, fascia, nervo, ecc.).
I lembi, a loro volta, possono essere suddivisi in base a molteplici caratteristiche: a) l'apporto vascolare (assiali, quando sono dotati di un identificabile peduncolo vascolare arterioso e venoso, oppure random, in assenza di questo); b) i tessuti che li costituiscono (cutanei, muscolari, miocutanei, fasciali, fasciocutanei, fasciomiocutanei, ossei, osteocutanei, osteomiocutanei); c) il movimento che effettua il tessuto durante il trasferimento (rotazione, avanzamento, trasposizione); d) la forma del lembo stesso (a Z, a W, lobato, bilobato, tubulato, di Limberg, ecc.); e) la loro provenienza anatomica (di vicinanza o a distanza). Un tipo particolare di lembo, reso possibile dal perfezionamento delle tecniche di anastomosi microchirurgica, viene definito ‛libero', ed è costituito da un tradizionale lembo assiale il cui peduncolo viene interrotto e successivamente riconnesso in altra sede anatomica. In questo caso è particolarmente evidente l'analogia con i trapianti d'organo comunemente intesi, che vengono effettuati in maniera pressoché identica, ed è probabile che, come per questi, il futuro renda possibile l'impiego di donatori diversi dal ricevente (omotrapianti), grazie ai miglioramenti in atto nelle terapie di controllo del rigetto immunitario (v. anche immunologia: Istocompatibilità, vol. XI).
b) Lembi espansi e prefabbricati.
Un altro campo che negli ultimi anni ha consentito di ampliare le tecniche riparative a disposizione del chirurgo è quello della biologia della cute e dei suoi processi di riparazione. Infatti sono state sviluppate tecniche che permettono di ‛distendere' e aumentare la superficie cutanea utilizzabile per realizzare un lembo mediante un meccanismo biologico, la cosiddetta ‛espansione tissutale', o mediante un meccanismo biofisico, il cosiddetto stretching.
La tecnica di espansione tissutale prevede l'impianto sottocutaneo di palloncini gonfiabili in silicone (espansori cutanei) riempiti progressivamente, nell'arco di settimane o mesi, con soluzione fisiologica, così da provocare un aumento della sovrastante superficie cutanea, e infine rimossi all'atto dell'intervento finale di allestimento del lembo con l'utilizzazione della cute eccedente. Sempre più spesso si ricorre anche all'espansione cutanea intraoperatoria, o stretching, ottenuta in tempi brevissimi (una o due ore), stirando la cute con appositi dispositivi meccanici, generalmente a vite. Tale tecnica sfrutta le caratteristiche di elasticità proprie del tessuto cutaneo.
Queste metodiche hanno dato vita a un tipo nuovo di lembi, i cosiddetti ‛lembi espansi', che a loro volta fanno parte del nuovissimo gruppo dei ‛lembi prefabbricati', nei quali prima di procedere al trapianto del lembo si prepara attraverso vari artifizi il tessuto, per renderlo il più possibile idoneo alla ricostruzione.
Si può, per esempio, incidere e sollevare un lembo, ricoprire con un innesto cutaneo il suo verso cruento e attendere la guarigione prima di utilizzare, nell'intervento finale, questo lembo prefabbricato, dotato di una doppia superficie cutanea. Un'altra possibilità è quella di trasferire un lembo assiale ben vascolarizzato intorno a una struttura che si desidera utilizzare in altra sede, ma che non è dotata di un suo proprio indipendente apporto vascolare. In tale modo, dopo un'adeguata attesa, la struttura viene vascolarizzata dal lembo e può essere trapiantata impiegando il peduncolo di questo lembo prefabbricato (è questo il caso, per esempio, del trasferimento di un lembo di fascia temporale su un'articolazione interfalangea del piede, per poi ritrasferire l'intera articolazione con i suoi nuovi vasi utilizzandola per la ricostruzione di un'articolazione interfalangea della mano).
c) Immunità e biocompatibilità.
Le tecniche di immunosoppressione hanno consentito l'utilizzo di tessuti di donatore diverso dal ricevente per periodi prolungati e in assenza di rigetto. Queste tecniche, oggi di impiego universale, sono state sviluppate sulla base degli studi sugli innesti di cute, e quindi applicate ai trapianti d'organo proprio da un chirurgo plastico, Joseph Murray, che nel 1990 ottenne il premio Nobel per aver effettuato il primo trapianto di rene sull'uomo. Attualmente l'attenzione degli sperimentatori è principalmente volta alla produzione di tessuti autologhi od omologhi coltivati in vitro, ‛colture tissutali' che proprio in chirurgia plastica hanno cominciato a trovare il loro impiego clinico per la cura di ustioni gravi ed estese o per la ricostruzione di tessuti particolarmente specializzati (congiuntiva, uretra). Nella pratica si coltivano in vitro, partendo da piccoli frammenti, superfici più estese del tessuto di partenza, fino a ottenere dei veri e propri innesti della dimensione desiderata, costituendo così quella che è la premessa per la futura creazione di estese ‛banche di tessuti'.
In chirurgia plastica si utilizzano numerosi materiali biocompatibili sintetici per impianto (si parla di impianto quando si fa uso di materiale non organico per la sostituzione, l'integrazione o il supporto di strutture organiche). Gli impianti vengono normalmente utilizzati per il rimodellamento corporeo in chirurgia estetica (protesi mammarie, zigomatiche, mentoniere, ecc.), nonché per la riparazione di strutture ossee di sostegno, in particolare nel distretto facciale e della mano, o per la sintesi di osteotomie e fratture (placche e viti); si impiegano anche per la ricostruzione di intere articolazioni (per es. nella mano), e per la correzione delle perdite di sostanza di più varia natura. Il materiale alloplastico più comunemente impiegato è il silicone medical grade (protesi mammarie, protesi articolari, espansori tissutali e altro), sebbene in epoca abbastanza recente siano sorte polemiche intorno alla sua specifica utilizzazione sotto forma di gel come materiale di riempimento delle protesi mammarie. Per tale motivo sono in studio nuove protesi mammarie radiotrasparenti, non pericolose in caso di rottura, dotate di una consistenza più naturale.
Per la ricostruzione dei tessuti connettivi altamente specializzati, sono disponibili materiali in grado di rimpiazzare strutture tendinee, legamentose o fasciali. Per esempio, il politetrafluoroetilene espanso (ePTFE) presenta una notevole resistenza tensile accoppiata a una struttura microporosa che ne consente una notevole integrazione nei tessuti biologici, grazie alla popolazione della microstruttura da parte del tessuto connettivo.
Il tessuto osseo, a seconda delle esigenze, viene di volta in volta consolidato con resine sintetiche, reti o protesi metalliche (in titanio, tantalio, lega di vitallium, ecc.) e integrato con colla di fibrina miscelata a idrossiapatite, o sostituito da vari tipi di protesi in porcellana o in microsfere porose.
Di particolare rilievo la ricerca nel settore dei materiali sintetici biocompatibili riassorbibili, che, utilizzati ad esempio per la fissazione di fratture ossee, vengono eliminati dall'organismo in tempi più o meno brevi.
d) La guarigione delle ferite.
I notevoli progressi della biologia molecolare consentono oggi di conoscere meglio l'evoluzione dei processi di riparazione, e in chirurgia plastica si tenta di applicarli in vari settori, tra i quali spicca quello dei processi di guarigione delle ferite. Negli ultimi venti anni è stato possibile isolare e clonare un notevole numero di composti polipeptidici in grado di indurre la moltiplicazione e/o il differenziamento cellulare: tali peptidi, chiamati genericamente ‛fattori di crescita', intervengono in maniera rilevante nell'oncogenesi, nell'embriogenesi e nei processi di rigenerazione tissutale e guarigione delle ferite. Tra questi l'EGF (Epithelial Growth Factor) e il KGF (Keratinocyte Growth Factor, o fattore di crescita dei cheratinociti), che, isolato nel 1989, ha manifestato una altissima specificità per la cute. L'obiettivo cui tendono queste nuove tecnologie è quello di produrre farmaci o biomateriali che possano concretamente accelerare o modulare i processi di guarigione. Inoltre, tali metodologie si integrano con altre tecniche ricostruttive: una recente metodica, ad esempio, consente la trasformazione di lembi di tessuti molli, in genere muscolari, in autentici innesti di osso autologo sagomato esattamente secondo le necessità, di fatto destinando a un rapido superamento i più avanzati impianti in materiale sintetico appena descritti.
La chirurgia plastica, pur conservando, nel rispetto delle sue antichissime origini, un approccio non distrettuale e quindi non limitato a un singolo organo o apparato, occupa un posto di primo piano nella sperimentazione e nella utilizzazione di tecniche innovative. Le finalità terapeutiche della disciplina sono complesse, in quanto essa si propone di integrare il ripristino della funzione e della morfologia delle strutture sulle quali opera.
BIBLIOGRAFIA
Grabb, W. C., Smith, S. W. (a cura di), Plastic surgery, Boston 1979 (tr. it.: Chirurgia plastica, Napoli 1991).
McCarthy, J., Plastic surgery, Philadelphia, Pa., 1990.
Mathes, S. J., Nahai, F., Clinical atlas of muscle and musculocutaneous flaps, St. Louis, Mo., 1979.
Mathes, S. J., Nahai, F., Clinical applications for muscle and musculocutaneous flaps, St. Louis, Mo., 1982.
Micali, G., Soma, P. F., Siragò, P. e altri, I tumori delle palpebre, Milano 1989.
Radovan, C., Tissue expansion in soft tissue reconstruction, in ‟Plastic and reconstructive surgery", 1984, LXXIV, pp. 482-490.
Rees, T. D., La Trenta, J., Aesthetic plastic surgery, Philadelphia, Pa., 1994.
Scuderi, N., Chirurgia plastica, Padova 1985.
Scuderi, N., Chirurgia plastica, in Enciclopedia medica italiana, Agg. I, Firenze 1989, coll. 1527-1537.
Scuderi, N., Applicazione in chirurgia ricostruttiva dei progressi della ricerca biomedica, in ‟Bollettino e atti dell'Accademia Medica di Roma", 1992-1993, CXVII, pp. 109-113.
Scuderi, N., D'Andrea, F., Rubino, C., Tagliacozzi's ancestors: the origins of plastic surgery in Western civilization, in International symposium on plastic surgery, Bologna, 20-22 ottobre 1988, Padova 1991, pp. 65-71.
Scuderi, N. e altri, Chirurgia plastica, in Chirurgie specialistiche (a cura di G. Zannini), vol. II, Firenze 1987, pp. 336-354.
Tagliacotii, G., De curtorum chirurgia per insitionem (1597), Bologna 1992.
Implantologia dentale di Raphaël Cherchève
SOMMARIO: 1. Introduzione: a) definizione e generalità; b) cenni storici. 2. Gli impianti: a) generalità; b) classificazione. □ 3. Le protesi: a) generalità; b) riabilitazione protesica; c) posizionamento della protesi. 4. Tecnica implantologica: a) principî generali; b) requisiti essenziali dell'implantologo; c) il complesso osso-impianto-protesi; d) cenni di chirurgia implantologica. 5. Possibilità e limiti dell'implantologia: a) indicazioni; b) controindicazioni. 6. Considerazioni conclusive: a) valutazioni prognostiche; b) l'implantologia in questa fine di secolo. □ Bibliografia.
1. Introduzione
a) Definizione e generalità.
L'implantologia dentale è la disciplina che studia la possibilità e le tecniche di realizzare protesi dentarie fisse, ancorate a pilastri inseriti nelle zone edentule dei mascellari.
Gli impianti dentari hanno apportato un'autentica rivoluzione nel campo odontostomatologico, le cui ragioni sono individuabili in una serie di fattori di varia natura: anatomica, fisiologica, psicologica. Sin dal remoto passato, le alterazioni del distretto orale hanno esercitato una notevole influenza sul comportamento degli uomini: la sola parola ‛dentiera', ‛rastrelliera', suscitava il raccapriccio di molti che ne erano semplicemente minacciati. Alcuni portatori di protesi non vi si sono mai adattati, e molti di loro in realtà non le hanno mai accettate. Così, dal momento che esistono uomini con denti vulnerabili, ci si è preoccupati o di sostituirli con denti artificiali, reimpianti o trapianti, o di ricreare, utilizzando materiali inorganici, gli elementi assenti con inclusioni alloplastiche.
La chirurgia implantologica dispone di due tipi di impianti: quelli biologici e quelli alloplastici. È a questi ultimi, al loro sviluppo, alla loro realizzazione che è essenzialmente dedicata la presente trattazione.
Il primo approccio con lo specialista è dominato dalla tendenza popolare ad attribuire al suo intervento il significato emozionale particolarmente importante di un possibile attentato all'integrità del corpo. Questa angoscia provocata dalla perdita di una parte di noi stessi è chiamata simbolicamente dagli psicanalisti ‛complesso di castrazione', e nel caso specifico è tanto più vivamente sentita in quanto l'apparato stomatognatico è inconsciamente associato negli esseri umani alla potenza maschile e all'avvenenza femminile. Cosicché, dal momento che ogni lesione dell'integrità dell'apparato è interpretata come una sorta di diminuzione della virilità e dell'efficienza, finora la figura del dentista è stata in qualche modo identificata con quella del ‛castratore'. Poiché oggi la nuova dimensione della scienza odontostomatologica permette al paziente di acquisire una nuova integrità dopo la menomazione causata dalla malattia, prevale attualmente il ruolo del medico riparatore. Da ciò si comprende la persistenza nell'arte odontoiatrica del vecchio sogno di realizzare impianti fissi, un sogno reso finalmente possibile dal progresso della scienza e della tecnica che è alla base della moderna implantologia. Questa disciplina, perché abbia successo, deve necessariamente basarsi sulla completa autonomia: deve, cioè, non essere frammentaria o limitata all'adozione di un solo metodo, bensì essere eclettica e totale. Il carattere innovatore e profondamente riparatore dei moderni impianti lascia prevedere un ulteriore progressivo sviluppo di tecniche e metodiche, malgrado prevedibili difficoltà e ostacoli.
b) Cenni storici.
Il problema della riabilitazione implantologica si può giustamente inquadrare sulla base delle conoscenze storiche. ‟La storia della scienza è la scienza stessa", diceva Alexander Fleming. L'evoluzione dell'implantologia dentale può essere compresa suddividendo la sua storia in due periodi: quello fino al 1940, e quello che va dal 1940 ai nostri giorni. Non si può parlare di transizione tra i due periodi, ma piuttosto di un grande balzo, di un vero e proprio sconvolgimento teorico e pratico.
I tentativi di ricostituire dentature normali risalgono a epoche antichissime: sono stati rinvenuti crani dell'era precolombiana nei quali elementi dentali erano stati sostituiti con ciò che noi oggi chiamiamo ‛impianto'; gli egittologi hanno fornito una ricca documentazione, esposta nei vari musei, di inclusioni metalliche nelle ossa mascellari, e sono ben note le protesi dentarie realizzate dagli Etruschi. Tuttavia, piuttosto che un'arida elencazione di date e reperti, sembra preferibile tratteggiare una breve storia degli impianti, o meglio, per usare le parole di A. A. Cournot nelle sue Considerazioni sulla marcia delle idee, la ‟eziologia storica" dell'implantologia.
La storia, ‟la scienza delle cose che non si ripetono" secondo P. Valéry, è in medicina la scienza dei molteplici tentativi che si sono ripetuti fino al giorno in cui sono stati coronati da successo. Tralasciando la descrizione dei numerosi tentativi di impianti naturali illustrati da vari autori, è importante sottolineare che Léger-Dorez - nel lungo capitolo dedicato all'implantologia del suo trattato di protesi dentarie, edito nel 1920 - evidenzia implicitamente tre elementi essenziali, che saranno riscoperti molto più tardi: la necessità di utilizzare impianti alloplastici, quella di operare soltanto su alveoli perfettamente cicatrizzati, quella di limitare quanto più possibile il danno ai tessuti e di non ricorrere ad alcuna legatura o sutura.
Il radicale mutamento nelle concezioni delle protesi dentarie è stato realizzato, dopo il 1940, dallo stomatologo italiano Manlio Formiggini, che seppe superare molte concezioni ritenute allora ‛dogmi' o tabù. In quel tempo, il campo d'azione dell'odontoiatria, salvo qualche caso particolare, era limitato alle cure conservative e all'eventuale utilizzazione di un dente come pilastro in caso di edentulismo: l'assenza di un pilastro al quale ancorare la protesi, infatti, rendeva impossibile o limitava grandemente l'attuabilità dell'intervento. Le protesi sostitutive ponevano enormi problemi che si tentava di risolvere con mezzi primitivi, quali molle di ancoraggio per l'apparecchio superiore e quello inferiore (riuniti a distanza) - rispettivamente al mascellare e alla mandibola -, polveri, colle adesive, ecc. Formiggini riuscì a includere nell'osso mascellare o mandibolare spirali elicoidali metalliche che, collocate secondo determinate modalità, potevano essere tollerate dall'organismo ospite senza provocare reazioni infiammatorie o dolorose. Di formazione chirurgica, egli, senza conoscere le esperienze precedentemente acquisite da altri autori sulle inclusioni mascellari, nel 1938 aveva effettuato numerosi tentativi originali. Perso il contatto con i propri pazienti a causa degli eventi bellici, Formiggini poté tuttavia avere notizia dei lavori di G. Dahl, che nel 1942 aveva progettato e posizionato una protesi perduta fissando a livello della cresta del mascellare una barra di stellite da cui emergevano 4 perni, 2 canini e 2 molari, che perforavano la mucosa e fungevano da pilastri per una protesi extratessutale. In seguito, come egli stesso illustrò in un suo lavoro (v. Formiggini, 1947), il caso lo aiutò, fornendogli inaspettatamente il punto di partenza per le sue ricerche: un suo paziente, al quale aveva estratto un canino superiore e introdotto nell'alveolo uno zaffo di garza iodoformica, anziché tornare per la medicazione il giorno seguente, si presentò dopo due mesi; con sorpresa Formiggini constatò che la mucosa orale era perfettamente normale, la cavità alveolare quasi totalmente colma e il tamponcino fermamente trattenuto, tanto che la sua rimozione risultò dolorosa e causa di sanguinamento. La constatazione che la garza non era stata espulsa come un corpo estraneo e non aveva provocato alcuna reazione infiammatoria fu all'origine dei tentativi compiuti dal chirurgo italiano di impiantare nelle ossa mascellari tubi e spirali di acciaio inossidabile, che segnarono l'inizio della moderna implantologia. Nello stesso tempo negli Stati Uniti altri autori, proseguendo gli studi intrapresi da Dahl, realizzarono impianti applicabili nell'osso senza bisogno di perforarlo, utilizzando cioè la superficie ossea, alla quale venivano apposti, anziché la profondità per esservi avvitati.
Nel 1957, in un congresso a Miami, R. Cherchève illustrò un progetto di impianto coordinato endosseo che vinse l'iniziale, generale scetticismo: era questo il prototipo di quegli impianti che sono oggi i più estesamente impiegati, ma che richiedono per il loro posizionamento particolari condizioni, prima fra tutte l'individuazione di una quantità di osso residuo sufficientemente consistente. Non esistono impianti miracolosi, e il loro successo dipende soprattutto dal terreno che deve accoglierli (v. Muratori, 1964 e 1988; v. Cherchève, 1977; v. Linkow e Dorfman, 1991; v. Peltola e altri, 1991).
2. Gli impianti
a) Generalità.
Il successo e la durata dell'impianto dipendono dalla sua accettazione da parte del tessuto osseo naturale o modificato con materiale estraneo, quale idrossiapatite o altro, o con un lembo di innesto; la vita dell'osso condiziona, quindi, quella dell'impianto.
La varietà degli impianti, dei materiali di cui sono costituiti e della loro morfologia è assai vasta, e si accresce ogni giorno; il successo del loro impiego è basato anzitutto su una valida applicazione dell'implantologia, che richiede una conoscenza profonda della struttura ossea. Alcune ossa presentano caratteristiche tali per le quali non vi è impianto inappropriato: è questo il caso, ad esempio, del tessuto osseo quasi unicamente di tipo corticale di alcuni individui anziani, che, al contatto con un impianto endosseo, acquista una nuova giovinezza, finendo per costituire una piramide ossea alveolare che letteralmente si arrampica attorno all'impianto.
Le trasformazioni e i miglioramenti subiti progressivamente dagli impianti originali non hanno modificato i principi biologici, fisiologici e meccanici che costituiscono la base della pratica implantologica. Fondamentalmente l'impianto deve essere biologicamente neutro e non traumatizzante, e deve essere in grado di svolgere un lavoro interamente volto al sostegno della sua protesi, tale che, in condizioni di perfetto equilibrio, risulti a sua volta garantita la tenuta stessa dell'impianto: tale equilibrio è realizzabile soltanto facendo in modo che le pressioni agenti a livello impianto-protesi-osso siano correttamente esercitate e ripartite. In ultima analisi, la connessione tra materia vivente e materia non vivente è un problema non tanto di tolleranza biologica, quanto di ripartizione ottimale delle pressioni esercitate.
b) Classificazione.
Come si è già accennato, gli impianti si dividono fondamentalmente in due tipi: biologici e alloplastici.
Gli impianti biologici comprendono il reimpianto di denti naturali, il trapianto di denti a completo sviluppo, quello di germi dentali. Il reimpianto può essere eseguito ad esempio dopo traumatismi, al fine di restaurare l'integrità anatomica e funzionale delle arcate e di mantenere i denti vicini e gli antagonisti in buona posizione. Se l'evento traumatico si verifica in giovane età, il reimpianto consente altresì il proseguimento della normale crescita fino all'età in cui sia possibile realizzare in buone condizioni una protesi fissa. Per quanto riguarda il trapianto, infine, esistono oggi in molti paesi banche dei denti che conservano denti sterilizzati e di varie misure calibrate.
Gli impianti alloplastici sono costituiti da elementi di varia forma e dimensione, realizzati con materiali biocompatibili, che, inseriti con la loro porzione intratessutale nelle zone edentule dei mascellari, fungono con la loro porzione libera extratessutale da pilastri per l'appoggio e l'ancoraggio delle protesi. Gli impianti alloplastici possono essere endossei, con la porzione intratessutale inserita in una cavità alveolare naturale o artificialmente creata, e iuxtaossei, con la porzione intratessutale fissata a diretto contatto della superficie ossea della zona edentula.
I primi impianti endossei a vite, realizzati da Cherchève nel 1962, erano caratterizzati dalla forma elicoidale e dalla struttura a vuoto centrale: l'architettura elicoidale, così comune in natura e tipica del DNA, è il risultato di osservazioni biofisiologiche e conferisce all'impianto le prerogative di un ‛ruttore di pressione'; il vuoto centrale è stato concepito per favorire un drenaggio iniziale (v. Cherchève, 1962). Questo tipo di impianto endosseo è stato adottato da numerosi autori, ed è servito da modello per la realizzazione di nuovi tipi.
Poiché per realizzare un impianto endosseo è indispensabile disporre di uno spessore osseo utilizzabile di almeno 8 mm, M. Cherchève ideò un tipo di impianto chiamato ‛cresta sottile' inseribile in creste ossee di spessore inferiore, il quale presenta anche il vantaggio di avere una base flessibile che permette di stabilire senza difficoltà un perfetto parallelismo tra i differenti elementi (v. Cherchève e Cherchève, 1967).
Tra gli altri impianti endossei vanno ancora menzionati quelli ad ago e quelli a lama. I primi, introdotti da J. Scialon e diffusamente impiegati, consentono, purché correttamente posizionati in base a precise indicazioni, di ottenere buoni risultati: sono caratterizzati da un fascio di lunghi aghi disposti a tripode e devono essere inseriti avendo cura di evitare le cosiddette zone tabù, quali il seno mascellare e il nervo mandibolare, ma la loro apparente facilità di applicazione ha in realtà nuociuto più che giovato al progresso dell'implantologia. Gli impianti a lama, ideati da L. Linkow e variamente modificati dai vari autori, possono essere inseriti correttamente solo dopo lo scollamento della fibromucosa che consenta un'ampia visuale dell'osso (v. Maurel, 1960; v. Linkow, 1969 e 1970; v. Muratori, 1969; v. Babbush, Endosteal ..., 1986; v. Cranin e altri, 1977; v. Keller, 1995).
Più recentemente è stato introdotto da implantologi svedesi un altro tipo di impianto endosseo, detto osteintegrato, realizzato tramite l'inserzione nei mascellari di elementi a vite in titanio puro, le cosiddette fixtures, opportunamente sagomati e provvisti di microscanalature che col tempo vengono riempite di osso trabecolare apparentemente normale. L'integrazione dell'impianto con il tessuto osseo ha luogo senza interposizione di tessuto molle, e il titanio si è rivelato praticamente privo di tossicità e in grado di formare un legame chimico con i tessuti con i quali è a contatto (v. Brånemark e altri, 1977; v. Haraldson e Carlsson, 1977; v. Adell e altri, 1981; v. Albrektsson e altri, 1981; v. Albrektsson, 1988; v. Weinlaender, 1991; v. Kent, 1992). In realtà, il concetto di osteointegrazione non era una novità assoluta, poiché sullo stesso principio era in fondo basato l'impianto endosseo a vite realizzato da Cherchève, anche questo in titanio: la differenza fondamentale tra i due sistemi consiste nel fatto che mentre quest'ultimo prevede la fissazione della protesi all'impianto subito dopo che questo è stato inserito nell'osso - che in tal modo è stimolato all'accrescimento e alla condensazione attorno all'impianto stesso dalle forze occlusali e dai carichi masticatori che su di esso immediatamente cominciano a esercitarsi - in quello svedese il trattamento protesico ha luogo alcuni mesi dopo l'inserimento degli impianti, quando si presume che sia già avvenuta l'integrazione ossea.
Gli impianti alloplastici iuxtaossei, di impiego più recente di quelli endossei, trovano particolare indicazione in tutti i casi nei quali non sia possibile sfruttare la profondità dell'osso. Grazie alle attuali possibilità di ottenere rapidamente impronte di grande precisione delle creste ossee, di realizzare le griglie e di posizionare l'impianto nella stessa giornata, di disporre di un materiale altamente biocompatibile e a bassa densità, cioè il titanio puro, il loro impiego è generalmente coronato da successo. Superata l'originaria modalità di inserimento delle griglie iuxtaossee sfruttando la più ampia superficie possibile, che comportava la necessità di interventi più cruenti e di impianti più voluminosi, si è successivamente constatato che era possibile ridurre la zona di inserzione e le dimensioni della struttura metallica senza comprometterne la stabilità.
3. Le protesi
a) Generalità.
L'elemento protesico, da ancorare al pilastro costituito dalla porzione extratessutale dell'impianto, deve sostituire il dente naturale mancante, e perciò rispondere a precisi requisiti di vario ordine: estetico, anatomico, funzionale. La realizzazione delle protesi è quindi necessariamente basata sulla perfetta conoscenza dell'apparato stomatognatico, costituito dai denti coi loro tessuti di sostegno, dalla muscolatura masticatoria, dalle articolazioni temporo-mandibolari. Elementi protesici adeguatamente progettati e realizzati sono di importanza fondamentale per il ripristino delle normali funzioni masticatoria e fonatoria e per il mantenimento di un rapporto ottimale tra i denti naturali residui.
Le protesi dentarie sono realizzate con vario materiale: leghe di metalli nobili e non nobili, resine, porcellane. Attualmente, queste ultime sono largamente impiegate per le loro ottime caratteristiche estetiche, la leggerezza, la facilità di lavorazione, la stabilità chimica e l'elevato livello di inalterabilità nel cavo orale.
b) Riabilitazione protesica.
Lo scopo principale della riabilitazione protesica è quello di far lavorare gli impianti nelle migliori condizioni. Gli impianti sono di forma cilindrica e ricordano a grandi linee le radici naturali, ma non sono come queste circondati da un apparato legamentoso che garantisce il grande vantaggio della connessione, cosicché si trovano esposti alle sole forze di pressione. Occorre inoltre tenere presente che gli impianti non sono in grado di equilibrarsi, di lavorare e di trasmettere le sollecitazioni allo stesso modo delle radici naturali, e che l'osso di sostegno ha inevitabilmente subito trasformazioni, naturalmente o a opera del chirurgo. Tutto ciò dimostra la necessità, nella progettazione della riabilitazione protesica, di considerare l'occlusione dentale nel suo complesso.
Per poter ripartire omogeneamente le forze sulla superficie di sviluppo di forma cilindrica di ciascun impianto, l'architettura protesica deve essere programmata in modo che le forze stesse vengano trasmesse essenzialmente a livello dell'interfaccia dei setti interimplantari e solo moderatamente sui tavolati vestibolare e del seno mascellare, evitando di ledere la tenuta dei denti antagonisti. Non va dimenticato che alcuni individui divengono prematuramente edentuli perché, per varie ragioni, il rapporto tra elementi dentali e base ossea non è ottimale: lo stesso motivo può causare la perdita degli impianti.
c) Posizionamento della protesi.
Il punto di partenza della ricostituzione è rappresentato dalla registrazione, eseguita in assenza di pressione muscolare, della posizione perfettamente centrata dei condili temporo-mandibolari nelle cavità glenoidi. Le successive registrazioni delle inclinazioni dei condili, riprodotte in modelli montati su un articolatore, consentono di rispettare scrupolosamente la fisiologia del paziente e di ottenere una protesi ottimamente equilibrata: diviene in tal modo possibile evitare le occlusioni in posizione eccentrica, causa di traumatismi e del molesto bruxismo.
Perché la protesi risulti bene equilibrata, deve essere rigorosamente posizionata nella cosiddetta ‛zona neutra protesica', corrispondente a un punto precisamente definito dello spazio protesico, ossia del volume delimitato dalla lingua e dalla banderella buccinato-labiale in fase dinamica. L'individuazione della posizione corretta, sul piano frontale e sagittale, delle superfici occlusali può essere fornita dalla piezografia. Spazio protesico e rapporti occlusali sono gli elementi fondamentali che occorre prendere in considerazione al momento della realizzazione della protesi, il cui equilibrio è indispensabile ai fini estetici e funzionali (v. anche Lamoral e altri, 1990; v. Chen e altri, 1994).
4. Tecnica implantologica
a) Principî generali.
L'implantologia, con la sua concezione essenzialmente riparatrice, ha mutato radicalmente il tradizionale approccio chirurgico odontostomatologico e ha introdotto nuovi elementi nei rapporti tra il dentista e il paziente. L'introduzione nei tessuti viventi di un materiale inerte o biocompatibile pone infatti due ordini di problemi: quello biologico, legato alla tolleranza da parte dell'organismo di sostanze a esso comunque estranee, che vi si debbono adattare; e quello psicologico, individuabile nell'accettazione o meno dell'impianto da parte del paziente.
Per quanto riguarda il primo problema, la disponibilità di materiali biocompatibili largamente sperimentati e la consolidata esperienza maturata in vari paesi consentono di affermare che si tratta di un problema ormai totalmente risolto. Solo la scelta del tipo di impianto può variare in funzione delle condizioni strutturali delle zone edentule.
La massima cura deve essere invece posta per garantire il rispetto della personalità e della sensibilità del paziente: l'implantologo deve esporre senza reticenze, con la maggior chiarezza possibile, le finalità, i vantaggi, le considerazioni prognostiche dell'intervento, ponendo su basi profondamente umane i suoi rapporti con l'assistito.
b) Requisiti essenziali dell'implantologo.
Requisito essenziale dell'implantologo specializzato è la perfetta conoscenza delle principali tecniche esistenti, onde poter scegliere nei singoli casi il procedimento più indicato e limitare quanto più possibile il rischio di insuccessi. Una buona preparazione di base e un'ampia documentazione tecnico-scientifica consentiranno allo specialista di operare ogni volta scelte corrette di metodi e di materiali.
Alla base della formazione chirurgica dell'implantologo deve essere collocata la sua preparazione nel campo della struttura normale e patologica e della fisiopatologia del tessuto osseo: è infatti indispensabile che egli conosca le modalità di reazione e di riparazione, i meccanismi di accrescimento, le cause di atrofia, i processi metabolici dell'osso, sul quale si svolge essenzialmente la sua opera chirurgica. La pratica costante, la valutazione scrupolosa dei successi e degli insuccessi affineranno la sua tecnica, mentre le conoscenze mediche e microbiologiche gli consentiranno di seguire il paziente dopo l'intervento e di programmare una buona igiene postimplantare.
c) Il complesso osso-impianto-protesi.
Dopo aver sommariamente descritto impianti e protesi, è indispensabile prendere in considerazione il complesso osso-impianto-protesi, tenendo presenti alcuni concetti fondamentali: l'impianto è in realtà un elemento intermediario per trasferire le forze, così che a ogni micro-superficie di lavoro sul versante occlusale corrisponde una micro-superficie di lavoro a livello osso-impianto; è necessario proteggere in modo prioritario il legame osso-impianto; è necessario programmare il legame impianto-protesi in modo che possa essere rivedibile nel tempo.
La scelta dell'impianto deve essere programmata prendendo in considerazione da un lato il volume osseo disponibile e le migliori possibilità di realizzare un legame osso-impianto, dall'altro il ventaglio delle disponibilità protesiche e della loro adattabilità all'impianto prescelto. Il compito dello specialista è oggi facilitato dalla grande varietà di materiali e modelli esistenti, compresi i materiali di rivestimento e quelli di sostituzione osteogenici, e dalla possibilità di differire la loro messa in funzione. In linea generale, sono senz'altro preferibili le riabilitazioni implanto-protesiche che necessitano dello stesso tipo di cure della dentatura normale e che meglio si adattano alle necessità e alle abitudini di vita del paziente.
Dopo il posizionamento definitivo della protesi, una radiografia ortopanoramica di controllo consente di apprezzare la validità del complesso osso-impianto-protesi realizzato e costituisce la base di confronto per quelle che verranno effettuate successivamente ogni anno: in queste condizioni è possibile garantire il lavoro eseguito nella cavità orale per dieci anni.
Occorre ancora ricordare che attualmente la tomografia e l'ecografia rappresentano un ausilio prezioso per operare la scelta della zona ottimale di inserimento dell'impianto prescelto, e che i materiali di riempimento disponibili, per la loro capacità di concorrere a evitare l'attecchimento di microrganismi, si rivelano un incontestabile elemento di sicurezza.
d) Cenni di chirurgia implantologica.
L'inserimento degli impianti alloplastici endossei si esegue in anestesia locale o regionale procedendo, dopo l'incisione della fibromucosa gengivale, alla messa a nudo della cresta ossea edentula sulla quale si praticano, con appositi strumenti, le cavità o i solchi destinati ad accogliere gli impianti. Nel caso degli impianti a lama, questi vanno inseriti facendo penetrare la lama, mediante leggera percussione, nell'alloggiamento a solco praticato nell'osso, quindi si procede alla sutura della ferita operatoria e dopo alcuni giorni si ancora la protesi.
Gli impianti alloplastici osteointegrati vengono invece inseriti in due tempi, il primo dei quali - essenzialmente simile al procedimento descritto a proposito degli altri impianti endossei - comprende il posizionamento nella zona ossea prescelta delle fixtures autofilettanti, che vengono poi ricoperte da piccole viti; dopo circa sei mesi le viti di copertura vengono messe allo scoperto e rimosse dalle fixtures e al loro posto vengono fissati i pilastri. Avvenuta la cicatrizzazione dei tessuti molli, all'incirca dopo quindici giorni, è possibile ancorare le protesi agli impianti.
Per l'applicazione degli impianti iuxtaossei è necessario operare in modo da mettere ampiamente a nudo la cresta ossea edentula, che va accuratamente regolarizzata. Si prende quindi l'impronta della superficie ossea servendosi degli ottimi materiali attualmente disponibili e la si invia in laboratorio per la realizzazione della griglia. Non appena questa è pronta, generalmente in tempi assai brevi, la si posiziona adeguatamente, affondandola progressivamente con qualche leggero colpo fino ad avvertire un lieve crepitio: a questo punto si può essere certi che l'impianto è inserito in modo irreversibile. I due tempi dell'intervento vanno eseguiti in anestesia loco-regionale. La ricostruzione protesica può essere realizzata dopo circa un mese.
È opportuno ricordare che per inserire gli impianti endossei in alcuni casi è necessario ricorrere a interventi più impegnativi e complessi quali: a livello del mascellare, il cosiddetto innalzamento del seno, realizzabile con l'inclusione di un lembo da innestare dopo aver sollevato la mucosa, onde evitare la perforazione della parete sinusale (v. Raghoebar e altri, 1993; v. Small e altri, 1993); a livello della mandibola, lo spostamento in basso del nervo alveolare inferiore, manovra da eseguire comunque con estrema circospezione, poiché eventuali danni subiti dal nervo sono causa di parestesie e di altre notevoli complicazioni (v. Berberi e altri, 1993; v. Jensen e altri, 1994; v. Hirsch, 1995). La transfissione totale, praticabile nei casi di accentuato riassorbimento osseo della mandibola, è seguita da eccellenti risultati: se correttamente operata, la cicatrice esterna si confonde nel solco sottomentale al punto da essere appena percettibile quattro mesi dopo l'intervento.
5. Possibilità e limiti dell'implantologia
a) Indicazioni.
Si è già detto che la condizione indispensabile per procedere a un intervento implantologico è un'adeguata preparazione del paziente sul piano psicologico, tale da renderlo pienamente disposto ad accettare l'impianto e a collaborare serenamente con lo specialista. Sul piano clinico l'implantologia, mentre ha scarse e trascurabili applicazioni nella sostituzione di singoli denti, trova oggi larghe indicazioni nella riparazione dell'edentulismo distale e soprattutto dell'edentulismo totale della mandibola: in tale condizione, infatti, e segnatamente nei casi in cui la cresta ossea è più o meno riassorbita e assottigliata, le forze di eiezione superano di gran lunga quelle di ritenzione, così che una protesi mobile, non ancorata a un impianto di sostegno fisso, subirebbe spostamenti squilibrati, finendo per divenire una massa fluttuante che ostacola la masticazione e la fonazione. Inoltre, nell'edentulismo totale della mandibola è possibile inserire gli impianti, in particolare gli iuxtaossei, nelle regioni anteriori, il che presenta indubbi vantaggi nelle operazioni di rilievo dell'impronta della cresta e nelle manovre chirurgiche.
b) Controindicazioni.
Le controindicazioni all'applicazione di impianti alloplastici sono di ordine generale e locale. Tra le prime vanno comprese tutte le condizioni patologiche in grado di alterare le capacità reattive dell'organismo e di rendere rischiosa l'esecuzione di interventi chirurgici: malattie infettive acute e croniche, tumori e malattie sistemiche, malattie endocrine e metaboliche, emopatie, cardiopatie, arteriosclerosi e ipertensione maligna.
Per valutare l'esistenza di controindicazioni di ordine locale vanno presi in considerazione i denti residui, il parodonto, le inserzioni muscolari, le mucose, nonché i vari fattori di ordine biomeccanico. Le patologie dentali che controindicano l'applicazione dell'impianto sono rappresentate da ascessi, cisti, ameloblastomi, cementomi, odontomi; quelle a carico del parodonto comprendono gengiviti e parodontiti di varia eziologia; i disordini biomeccanici, infine, comprendono le malocclusioni e le disfunzioni delle articolazioni temporo-mandibolari.
Un cenno particolare, per concludere, merita una condizione di ordine generale che può costituire una grave controindicazione alle manovre chirurgiche sul tessuto osseo e, naturalmente, all'applicazione di impianti alloplastici, cioè l'osteoporosi. In considerazione della relativa frequenza con la quale tale patologia ossea si riscontra nelle donne dopo la menopausa e in soggetti che fanno eccessivo consumo di tabacco e di alcool, è necessario inserire nel programma implantologico un tempo preventivo di ricerca dell'eventuale esistenza di osteoporosi. Attualmente, comunque, è possibile ottenere soddisfacenti risultati nel trattamento dell'osteoporosi sia mediante regimi igienici preventivi, sia mediante l'uso di farmaci a base di calcitonina e di bifosfonati.
6. Considerazioni conclusive
a) Valutazioni prognostiche.
La nascita dell'implantologia ancora relativamente recente ha in una certa misura impedito, finora, la formulazione di giudizi prognostici sicuri, malgrado l'evidenza dei brillanti risultati immediati ottenuti. Tuttavia, cominciano ora a essere rese note, da parte di vari ricercatori, osservazioni a termine abbastanza lungo da consentire valutazioni oltremodo favorevoli sul destino degli impianti alloplastici. Quello che inizialmente appariva come l'elemento negativo più pericoloso per la stabilità dell'impianto, ossia la comunicazione permanente della sua base a contatto con l'osso con la cavità orale - e quindi con l'ambiente esterno, potenzialmente in grado di convogliare materiale settico nel tessuto osseo -, si è dimostrato in realtà più ipotetico che reale.
Le attuali disponibilità di materiali biocompatibili utilizzabili non solo per la realizzazione della protesi, ma anche per compensare il riassorbimento dell'osso alveolare, consentono di formulare previsioni ottimistiche sulla stabilità e sulla tollerabilità degli impianti.
b) L'implantologia in questa fine di secolo.
Si è già ripetutamente fatto cenno alla disponibilità di materiali caratterizzati da particolari, elevate qualità che ha reso possibile il considerevole progresso registrato negli ultimi anni nel settore dell'implantologia. Disponiamo oggi di biomateriali in grado di influenzare la rapidità e la direzione dell'accrescimento delle cellule ossee, con i quali è possibile realizzare una osteogenesi simile a quella ottenuta con innesto autologo: impiegati nelle operazioni di ricostruzione ossea, consentono di risolvere completamente, in breve tempo, i problemi prospettati da perdite di tessuto osseo anche estese. Tra i materiali che hanno consentito i grandi progressi dell'implantologia di fine secolo vanno ricordati l'idrossiapatite e il calcigraft: la prima, applicata sulla superficie della parte da ricoprire con il metodo dell'arcoplasma, è impiegata nelle tecniche cosiddette di rivestimento; il calcigraft è una vetroceramica bioattiva altamente compatibile con l'osso, semiriassorbibile, in grado di indurre una efficace neoformazione ossea. I vantaggi dell'impiego del titanio nella realizzazione degli impianti endossei sono, d'altra parte, un'autentica conquista delle tecniche implantologiche (v. Babbush, Titanium ..., 1986; v. Babbush e altri, 1986; v. Krauser, 1989; v. Kay, 1992; v. Yukna, 1992; v. Misch, 1993; v. Block e Kent, 1994).
In conclusione, l'implantologia dentale ha ormai perduto il carattere di eccezionalità che aveva contrassegnato i suoi esordi e poggia su sicure basi scientifiche e su consolidate esperienze chirurgiche. Dalla ricerca sui biomateriali in grado di garantire al massimo livello la qualità e la durata degli impianti possono essere ulteriormente migliorate le sue prospettive nel prossimo futuro.
BIBLIOGRAFIA
Adell, R., Leckholm, U., Rokler, B., Brånemark., P. I., A 15-year study of osseointegrated implants in the treatement of the edentulous jaw, in ‟International journal of oral surgery", 1981, X, pp. 387-416.
Albrektsson, T., A multicenter report on osseointegrated oral implants, in ‟Journal of prosthetic dentistry", 1988, LX, pp. 75-84.
Albrektsson, T., Brånemark, P. I., Hansson, H. A., Lindström, J., Osseointegrated titanium implants. Requirements for ensuring a long-lasting, direct bone-to-implant anchorage in man, in ‟Acta orthopaedica scandinavica", 1981, LII, pp. 155-170.
Babbush, C. A., Endosteal blade-vent implants, in ‟Dental clinics of North America", 1986, XXX, pp. 97-115.
Babbush, C. A., Titanium plasma spray screw implant system for reconstruction of the edentulous mandible, in ‟Dental clinics of North America", 1986, XXX, pp. 117-131.
Babbush, C. A., Kent, J. N., Misiek, D. J., Titanium plasma-sprayed (TPS) screw implants for the reconstruction of the edentulous mandible, in ‟Journal of oral and maxillofacial surgery", 1986, XLIV, pp. 274-282.
Berberi, A., Le Breton, G., Mani, J., Woimant, H., Nasser, J., Lingual paresthesia following surgical placement implants: report of a case, in ‟International journal of oral and maxillofacial implants", 1993, VIII, pp. 580-582.
Block, M. S., Kent, J. N., Long-term follow-up on hydroxylapatite coated cylindrical dental implants: a comparison between development and recent periods, in ‟Journal of oral and maxillofacial surgery", 1994, LII, pp. 937-943.
Brånemark, P. I., Hansson, B. O., Adell, R., Breine, U., Lindström, J., Hallén, O., Ohman, A., Osseointegrated implants in the treatement of the edentulous jaw. Experience from a 10-year period, in ‟Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery", 1977, XI, suppl. 16, pp. 1-132.
Chen, J., Lu, X., Paydar, N., Akay, H. U., Roberts, W. E., Mechanical simulation of the human mandible with and without an endosseous implant, in ‟Medical engineering and physics", 1994, XVI, pp. 53-61.
Cherchève, R., Les implants endo-osseux, Paris 1962.
Cherchève, R., L'implantologie de sécurité, Paris 1977.
Cherchève, R., Cherchève, M., L'implant crête mince, in ‟Information dentaire", 1967, IL, pp. 511-515.
Cranin, A. N., Rabkin, M. F., Garfinkel, L., A statistical evaluation of 952 endosteal implants in humans, in ‟Journal of the American Dental Association", 1977, XCIV, pp. 315-320.
Formiggini, M., Protesi dentaria a mezzo di infibulazione diretta endoalveolare, in ‟Rivista italiana di stomatologia", 1947, II, pp. 193-199.
Haraldson, T., Carlsson, G. E., Bite force and oral function in patients with osseointegrated oral implants, in ‟Scandinavian journal of dental research", 1977, LXXXV, pp. 200-208.
Hirsch, J. M., Fixture stability and nerve function after transposition and lateralization of the inferior alveolar nerve and fixture installation, in ‟British journal of oral and maxillofacial surgery", 1995, XXXIII, pp. 276-281.
Jensen, J., Reiche-Fishcel, O., Sindet-Pedersen, G., Nerve transposition and implant placement in the atrophic posterior mandibular alveolar ridge, in ‟Journal of oral and maxillofacial surgery", 1994, LII, pp. 662-668.
Kay, J. E., Calcium phosphate coatings for dental implants. Current status and future potential, in ‟Dental clinics of North America", 1992, XXXVI, pp. 1-18.
Keller, E. E., Reconstruction of the severely atrophic edentulous mandible with endosseous implants: a 10-year longitudinal study, in ‟Journal of oral and maxillofacial surgery", 1995, LIII, pp. 305-320.
Kent, G., Effects of osseointegrated implants on psychological and social well-being: a literature review, in ‟Journal of prosthetic dentistry", 1992, LXVIII, pp. 515-518.
Krauser, J. T., Hydroxylapatite-coated dental implants. Biologic rationale and surgical technique, in ‟Dental clinics of North America", 1989, XXXIII, pp. 879-903.
Lamoral, Y., Quirynen, M., Peese, P., Vanneste, F., Lemahieu, S. F., Bert, A. L., Steenberghe, D. van, Computed tomography in the preoperative planning of oral endo-osseous implants surgery, in ‟RöFo, Fortschritte auf dem Gebiete der Roentgenstrahlen und der neuen bildgebenden Verfahren", 1990, CLIII, pp. 505-509.
Linkow, L. I., The endosseous blade implant and its use in orthodontics, in ‟International journal of orthodontics", 1969, VII, pp. 149-154.
Linkow, L. I., Endosseous oral implantology: a 7-year progress report, in ‟Dental clinics of North America", 1970, XIV, pp. 185-199.
Linkow, L. I., Dorfman, J. D., Implantology in dentistry. A brief historical perspective, in ‟New York State dental journal", 1991, LVII, pp. 31-35.
Maurel, G., Les implants sous-périostés, Paris 1960.
Misch, C. M., Hydroxylapatite-coated implants. Design considerations and clinical parameters, in ‟New York State dental journal", 1993, LIX, pp. 36-41.
Muratori, G., Evoluzione storica degli impianti alloplastici in stomatologia, in ‟L'Arcispedale S. Anna di Ferrara", 1964, XVII, pp. 1335-1349.
Muratori, G., L'impianto endosseo, Parma 1969.
Muratori, G., L'evoluzione storico-scientifica dell'implantologia orale, in Actes du XXXI Congrès internationale d'histoire de la médicine, Bologna 1988, pp. 975-979.
Peltola, J., Happonen, R. P., Lehtinen, R., Oksala, E., Clinical aspects of oral implantology, in ‟Proceedings of the Finnish Dental Society", 1991, LXXXVII, pp. 271-286.
Raghoebar, G. M., Brouwer, T. J., Reintsema, H., Van Oort, R. P., Augmentation of the maxillary sinus floor with autogenous bone for the placement of endosseous implants: a preliminary report, in ‟Journal of oral and maxillofacial surgery", 1993, LI, pp. 1198-1203.
Small, S. A., Zinner, I. D., Panno, F. V., Shapiro, H. J., Stein, J. L., Augmenting the maxillary sinus for implants: report of 27 patients, in ‟International journal of oral and maxillofacial implants", 1993, VIII, pp. 523-528.
Weinlaender, M., Bone growth around dental implants, in ‟Dental clinics of North America", 1991, XXXV, pp. 585-601.
Yukna, R. A., Placement of hydroxylapatite-coated implants into fresh of recent extraction sites, in ‟Dental clinics of North America", 1992, XXXVI, pp. 97-115.
Laringectomia ricostruttiva di Italo Serafini
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Cenni storici. 3. Riabilitazione del laringectomizzato. 4. Evoluzione in senso funzionale della chirurgia oncologica della laringe. 5. Laringectomia ricostruttiva: a) principî dell'intervento; b) indicazioni; c) controindicazioni; d) tecnica chirurgica; e) decorso post-operatorio; f) risultati. 6. Considerazioni conclusive. □ Bibliografia.
1. Introduzione
In alcune gravi patologie, l'unica possibilità di guarigione dell'ammalato è rappresentata dall'asportazione chirurgica dell'organo colpito. Mentre l'asportazione di organi vitali (cuore, polmoni, fegato, ecc.) richiede di necessità la loro immediata sostituzione con ripristino funzionale completo, quella di altri organi e apparati (vescica, tratti dell'apparato digerente, arti, organi di senso, mammella, apparato sessuale, laringe, ecc.), pur senza pregiudicare la vita, causa gravi menomazioni funzionali; è nata pertanto l'esigenza che il tempo chirurgico demolitivo sia seguito da un tempo ricostruttivo.
Il ripristino funzionale dopo interventi chirurgici demolitivi, avvertito come esigenza prioritaria fin dai primordi di questo tipo di chirurgia, è stato realizzato utilizzando organi artificiali (protesi), omotrapianti e ricostruzione chirurgica autoplastica.
L'asportazione completa della laringe (laringectomia totale), richiesta essenzialmente nella patologia tumorale, comporta la separazione della via digestiva da quella respiratoria con abboccamento della trachea a un foro praticato nella pelle della regione anteriore del collo (tracheostoma). Ne conseguono la perdita della voce e la respirazione per via preternaturale. La consapevolezza della gravità di questa menomazione fisica ha indotto, fin da tempi remoti, a ricercare il ripristino funzionale, parziale o completo, dopo l'esecuzione di un intervento così gravemente demolitivo.
2. Cenni storici
Il cancro della laringe, per quanto riguarda le sue manifestazioni cliniche e la sua evoluzione, era noto fin dall'antichità (Asclepiade di Bitinia, 91 a.C.; Galeno, 180 d.C.). Per lungo tempo il suo trattamento chirurgico, meramente palliativo e teso a evitare il soffocamento, consistette nella sola tracheotomia, che, attribuita ad Asclepiade di Bitinia, fu descritta dettagliatamente per la prima volta nel trattato di chirurgia di Guido Guidi nel 1544 e introdotta sistematicamente nella pratica da A. Trousseau (v., 1837) nel 1840.
Il primo intervento diretto sulla laringe, la cui anatomia era stata accuratamente descritta da G. Casserio (v., 1600-1601), fu la laringotomia, realizzata per la prima volta nel 1788 da P. J. J. Pelletan (v., 1810). Dopo gli esperimenti di J. H. Albers (v., 1829), la prima laringectomia totale nell'uomo, erroneamente attribuita a C. A. T. Billroth che la praticò nel 1873 (v. Gussenbauer, 1874), fu eseguita da P. H. Watson nel 1866 in un malato di cancro (v. Holmes, 1887). Contemporaneamente ebbero inizio le prime ricerche sulla possibilità di ripristino della respirazione per le vie naturali dopo l'exeresi della laringe. V. Czerny, allievo di Billroth, dimostrò che l'applicazione a cani laringectomizzati di una particolare cannula metallica a due vie consentiva agli animali di emettere nuovamente la voce e un altro allievo di Billroth, Gussenbauer, per la prima volta riuscì a ripristinare nell'uomo, dopo laringectomia totale, la fonazione e la respirazione per le vie naturali mediante l'impiego di una protesi metallica; analoghi risultati ottenne l'italiano A. Caselli (v. Jemmi, 1957) impiegando lo stesso metodo. Tuttavia, gli entusiasmi iniziali furono non poco raffreddati dall'elevatissima mortalità registrata all'epoca nei pazienti operati di laringectomia totale, al punto che la stessa utilità dell'intervento fu, per anni, messa in seria discussione.
In epoche più recenti, le ricerche sperimentali e cliniche sulle possibilità di ripristinare le elementari funzioni della laringe dopo la sua asportazione hanno seguito diversi indirizzi. Le ricerche relative all'impiego di laringi artificiali e al trapianto della laringe sono sostanzialmente ancora in fase sperimentale e la loro applicazione clinica appare lontana. Maggiori successi sono stati ottenuti nel campo dell'utilizzo di fistole e protesi fonatorie, e in quello della ricostruzione chirurgica.
Una più sicura affermazione ha avuto il ripristino chirurgico della fonazione ottenuto sfruttando l'aria espirata dai polmoni, originato da una osservazione casuale del foniatra romano D. Scuri (v., 1930) che constatò come un laringectomizzato, portatore di una comunicazione accidentale postchirurgica (fistola) fra trachea ed esofago, riuscisse a parlare occludendo il tracheostoma durante l'espirazione. Furono escogitati e messi a punto interventi tesi a creare fistole fonatorie, attualmente perfezionati dalla possibilità di inserire nelle fistole stesse piccole valvole unidirezionali che consentono di ovviare ai disturbi nella deglutizione dei liquidi e della saliva.
Un obiettivo che numerosi chirurghi si sono prefissi è stato quello di arrivare alla ricostruzione chirurgica della laringe. Pioniere del mantenimento della continuità aerea tracheo-faringea nell'intervento di laringectomia fu certamente O. Foederl (v., 1899), che in un paziente affetto da carcinoma laringeo operò una laringectomia subtotale, abboccando l'apertura superiore della trachea, anziché alla cute della regione cervicale anteriore, direttamente alle parti conservate della porzione superiore della laringe e tramite queste alla faringe subito sotto la base della lingua: l'intervento ebbe esito favorevole, con ripristino della respirazione e della fonazione per le vie naturali. Tuttavia, l'intervento di Foederl non ebbe diffusione, soprattutto per l'elevata mortalità, che incideva allora anche nei pazienti sottoposti a semplice intervento di laringectomia totale classica, e fu completamente dimenticato per oltre mezzo secolo.
Nel 1947, M. Hofmann-Saguez (v., 1954) ristabilì la continuità del canale faringo-tracheale dopo laringectomia per stenosi, impiegando il pericondrio laringeo esterno avvolto su una protesi tubulare di materia plastica di sostegno mantenuta in sede fino alla rigenerazione di cartilagine rigida. L'intervento, sebbene seguito da successo, fu però ripreso solo dopo 12 anni da E. H. Majer e W. Rieder (v., 1959), che in sei pazienti affetti da cancro laringeo eseguirono una laringectomia subtotale, con conservazione della cricoide in basso e di parte del vestibolo laringeo in alto, e ristabilimento della continuità faringo-tracheale mediante fissazione della cricoide ai residui del vestibolo laringeo e all'osso ioide (‛crico-ioidopessia'). Tale intervento non ebbe però seguito per l'elevato numero di recidive tumorali.
Nel 1965 I. Serafini ottenne incoraggianti risultati in una serie di ricerche sperimentali effettuate sul cane e sulla scimmia per indagare le possibilità di ripristinare la continuità aerea tracheo-faringea dopo asportazione della laringe, elevando la trachea e fissandone l'apertura all'epiglottide conservata e all'osso ioide (‛tracheo-ioidopessia'). Questa metodica fu allora applicata all'uomo (v. Serafini, 1970): l'intervento ebbe subito larga eco e una certa diffusione, ma i risultati funzionali furono incostanti e il decorso post-operatorio risultò gravato da importanti complicanze. Tuttavia l'intervento, denominato ‛laringectomia subtotale ricostruttiva', perfezionato negli anni successivi grazie ai contributi di molti chirurghi della laringe, soprattutto europei, trova oggi larga applicazione clinica.
3. Riabilitazione del laringectomizzato
Attualmente, il paziente che ha subito un intervento di laringectomia può respirare attraverso la tracheostomia e alimentarsi normalmente, ma, ovviamente, non è più in grado di parlare. Per il reinserimento nella normale vita di relazione si rende quindi necessaria una riabilitazione vocale che gli consenta buone possibilità di comunicazione.
Il metodo più diffuso di rieducazione vocale del laringectomizzato è quello ‛erigmofonico': esso consiste nell'insegnare al paziente a eruttare aria precedentemente ingoiata nello stomaco, provocando così la vibrazione della mucosa a livello della bocca dell'esofago, punto di passaggio fra esofago e ipofaringe, e ad articolare a livello dell'orofaringe e del cavo orale il suono prodotto da questa vibrazione in modo da ottenere l'emissione vocale (‛voce esofagea'). Ancora oggi, questo rimane il ripristino vocale più semplice e fisiologico dopo laringectomia totale; la voce esofagea, infatti, pur non raggiungendo la perfezione della voce normale, risulta socialmente valida e consente di comunicare in modo ben comprensibile anche a distanza. Purtroppo, però, svariati motivi - quali alterazioni anatomo-funzionali delle prime vie digestive, insufficiente distribuzione territoriale delle scuole logopediche, demotivazione, rifiuto psicologico della fonazione ‛eruttata', ecc. - rendono difficile imparare a parlare con la voce esofagea e solo una minoranza di operati di laringectomia totale riesce in questo intento.
Una valida alternativa alla voce esofagea è la voce ottenibile con l'impiego della fistola tracheo-faringea e dell'impianto fonatorio, che consentono nella maggior parte dei casi un ripristino vocale immediato e anch'esso socialmente valido. Esistono inoltre protesi laringee di vario tipo che consentono un buon ripristino della funzione vocale, ma presentano una serie di inconvenienti legati alle modalità d'uso e alla manutenzione.
Ove possibile, la laringectomia ricostruttiva rimane dunque l'unico intervento in grado di consentire la conservazione di tutte le funzioni della laringe, permettendo al laringectomizzato una buona qualità di vita.
4. Evoluzione in senso funzionale della chirurgia oncologica della laringe
All'inizio, come abbiamo visto, la chirurgia oncologica della laringe fu solo palliativa; essa tendeva, cioè, non alla guarigione, ma solo al prolungamento della sopravvivenza del malato, evitandone il soffocamento. La creazione di una via respiratoria preternaturale a livello cervicale attraverso l'apertura della laringe (laringotomia) o della trachea (tracheotomia) era nell'antichità l'unica possibilità di cura chirurgica dei soggetti con cancro della laringe.
L'intervento demolitivo totale della laringe, che segnò l'inizio dell'era della chirurgia curativa del cancro laringeo, non ebbe subito grande diffusione e fu messo in discussione per l'elevatissima mortalità post-operatoria e per la grave mutilazione funzionale cui i pazienti venivano sottoposti. Per evitare danni funzionali così gravi, nel 1878 Billroth eseguì per la prima volta l'asportazione di metà laringe per un carcinoma della corda vocale (emilaringectomia verticale); tale intervento fu poi ripreso da T. Gluck, il quale asportava verticalmente metà laringe (compreso il suo scheletro cartilagineo) con creazione di un'ampia apertura verso la cute del collo (laringostoma), che veniva chiusa in un secondo tempo. Questa chirurgia parziale laringea era tuttavia rivolta esclusivamente all'estirpazione dei tumori della corda vocale e della regione sottocordale.
Gli insuccessi quasi costanti registrati sul piano oncologico portarono i chirurghi laringei a considerare in modo estremamente critico questa chirurgia parziale funzionale, così che per molti anni il trattamento chirurgico elettivo del cancro laringeo rimase la laringectomia totale.
La chirurgia parziale verticale della laringe fu ripresa negli anni trenta da A. Hautant (v., 1929), che cercò di precisare con maggior rigore le indicazioni agli interventi eseguiti mediante laringofissura verticale sulla corda vocale carcinomatosa (cordectomia) e sull'emilaringe (emilaringectomia); essa, tuttavia, deve il suo grande rilancio a J. Leroux-Robert (v., 1957), che nel 1956 descrisse la sua tecnica di laringectomia fronto-laterale.
Anche per i tumori situati nel vestibolo laringeo, al di sopra delle corde vocali, fu prospettata la possibilità di una chirurgia parziale funzionale, sopracordale (sopraglottica), i cui pionieri furono W. Trotter (v., 1920) e P. C. Huet (v., 1938), che introdussero, rispettivamente, la faringolaringectomia parziale e la epiglottidectomia. La grande rivoluzione rappresentata dall'introduzione delle tecniche parziali funzionali nel trattamento chirurgico del cancro sopraglottico è però legata al nome di J. Alonso di Montevideo (v., 1947), che dimostrò come l'asportazione della laringe sopracordale (laringectomia sopraglottica), nei carcinomi del vestibolo laringeo, fosse un intervento oncologicamente altrettanto radicale della laringectomia totale, ma nello stesso tempo in grado di consentire il completo ripristino delle funzioni laringee. Le indicazioni alla laringectomia sopraglottica furono in seguito ampliate anche ai tumori sopracordali che debordano dai limiti del vestibolo laringeo con l'allargamento dell'exeresi a una corda vocale (laringectomia ‛tre quarti' di Ogura: v. Ogura e altri, 1980) e alla faringe (laringectomie sopraglottiche allargate: v. Bocca, 1974).
Dal 1950 in poi la laringectomia totale è stata sostituita in una percentuale sempre maggiore di casi dagli interventi parziali che, senza pregiudicare la radicalità oncologica, consentono il ripristino delle funzioni laringee. Gli interventi chirurgici parziali oggi più praticati sono la cordectomia, l'emilaringectomia, la laringectomia fronto-laterale, la laringectomia sopraglottica (semplice o allargata).
Dall'inizio degli anni ottanta, alcuni di questi interventi parziali funzionali possono essere eseguiti anche per le vie naturali con il laser a CO2 (laserchirurgia endoscopica). A partire dal 1970 il bagaglio terapeutico per il cancro della laringe si è arricchito di un nuovo intervento chirurgico molto demolitivo, ma allo stesso tempo funzionale, in grado di ridurre ulteriormente il numero delle laringectomie totali: la laringectomia ricostruttiva.
5. Laringectomia ricostruttiva
a) Principî dell'intervento.
La laringectomia subtotale ricostruttiva può esser considerata la seconda rivoluzione, dopo la laringectomia sopraglottica secondo Alonso, verificatasi nel campo della chirurgia oncologica funzionale della laringe, in quanto consente il ripristino funzionale completo della laringe anche dopo interventi altamente demolitivi praticati per tumori intrinseci in fase avanzata. Come abbiamo sopra ricordato, il grande rilancio di questa chirurgia, dopo i precedenti sporadici tentativi, si verificò negli anni settanta in seguito alle nostre ricerche prima in campo sperimentale sull'animale, poi direttamente in campo clinico (v. Serafini, 1967, 1969, 1970 e 1972).
La tecnica chirurgica, proposta e attuata per la prima volta nell'uomo nel 1970, consisteva nell'asportazione di tutta la laringe con l'eccezione della porzione superiore dell'epiglottide e nell'abboccamento dell'apertura tracheale all'ipofaringe mediante fissaggio del primo anello tracheale al residuo epiglottico e all'osso ioide (tracheo-ioidopessia). Tuttavia, le complicanze post-operatorie e i frequenti insuccessi funzionali ottenuti nei primi casi indussero molti chirurghi della laringe, soprattutto europei, a cercare di migliorare i risultati dell'intervento modificandone la tecnica.
La modifica tecnica più importante fu la conservazione della cartilagine inferiore della laringe, la cricoide, di forma anulare, in diretta continuità con la trachea cervicale (v. Calearo e Teatini, 1972; v. Alajmo, 1974), e di una delle due aritenoidi, cartilagini posteriori che assicurano la motilità delle corde vocali (v. Labayle e Bismuth, 1971), associata, nei casi di tumori limitati al piano glottico, anche a quella della porzione superiore dell'epiglottide (v. Piquet e altri, 1974): la cricoide conservata (con o senza un'aritenoide) viene fissata alla base della lingua (o al moncone epiglottico, se conservato) e all'osso ioide (crico-ioidopessia) e in tal modo abboccata all'ipofaringe.
I miglioramenti funzionali ottenuti con tali modifiche tecniche, riguardanti soprattutto la respirazione (maggiore pervietà della comunicazione tracheo-faringea per la presenza dell'anello cricoideo) e la deglutizione (miglior meccanismo sfinterico per la presenza di un'aritenoide ed eventualmente dell'epiglottide), hanno favorito la grande diffusione in campo clinico della laringectomia subtotale ricostruttiva, soprattutto in Europa, a partire dagli anni ottanta.
Lo schema dell'intervento può essere così delineato: 1) asportazione di gran parte della laringe con il suo astuccio cartilagineo, con conservazione, se è oncologicamente possibile, di una o di entrambe le aritenoidi e/o della porzione superiore dell'epiglottide; 2) ricostruzione della continuità tracheo-faringea mediante crico-ioidopessia (o crico-ioido-epiglottopessia); 3) asportazione contemporanea di tutte le catene linfonodali cervicali nei casi di tumori metastatizzanti.
b) Indicazioni.
L'intervento è indicato in tutti i casi di tumore intrinseco della laringe non trattabili con la chirurgia parziale funzionale e quindi altrimenti destinati alla laringectomia totale, in particolare nei tumori delle corde vocali estesi bilateralmente, nei tumori insorti sulla commessura anteriore fra le corde vocali tendenti a invadere in profondità la cartilagine tiroidea, nei tumori cordali infiltranti in profondità lo spazio paraglottico inferiore (corda vocale fissa); inoltre, trovano indicazione all'intervento i tumori in fase più avanzata, estesi dalle corde vocali al vestibolo laringeo o dal vestibolo laringeo alle corde vocali con infiltrazione in profondità degli spazi paraglottici (tumori transglottici), purché non estrinsecati dalla laringe.
I casi di tumori cordali o commessurali anteriori nei quali sia conservata bilateralmente la motilità laringea consentono la conservazione, oltre che della cricoide, anche delle due aritenoidi e della porzione superiore dell'epiglottide, mentre quelli di tumori cordali che presentino fissità di un'emilaringe consentono la conservazione dell'aritenoide corrispondente all'emilaringe mobile e della porzione superiore dell'epiglottide (crico-ioido-epiglottopessia con conservazione di una o di entrambe le aritenoidi).
Nel trattamento dei tumori transglottici (coinvolgenti le regioni sopraglottica e glottica) associati a fissità di un'emilaringe (segno di invasione profonda) è possibile la conservazione dell'aritenoide corrispondente all'emilaringe mobile (crico-ioidopessia con conservazione di una aritenoide); nei casi di tumori transglottici che presentino fissità (o ridotta motilità) di entrambe le emilaringi è invece possibile la conservazione della sola cartilagine cricoidea (crico-ioidopessia).
c) Controindicazioni.
Le controindicazioni alla laringectomia subtotale ricostruttiva sono di ordine oncologico e di ordine generale.
Le controindicazioni oncologiche sono rappresentate essenzialmente dall'estensione di un tumore intrinseco alla sottoglottide e dall'estrinsecazione tumorale dalla laringe. La regione sottoglottica della laringe (ipoglottide) inizia circa un centimetro al di sotto del bordo libero delle corde vocali e corrisponde alla cartilagine cricoidea. Poiché per rispettare i limiti di sicurezza della radicalità oncologica è necessario che la linea inferiore dell'exeresi disti almeno mezzo centimetro dal margine tumorale, i tumori che si estendono oltre mezzo centimetro al di sotto del bordo libero delle corde vocali rappresentano una precisa controindicazione all'intervento di laringectomia ricostruttiva, malgrado la possibilità di asportare per via sottopericondrale interna la mucosa del cono ipoglottico (questa manovra viene attuata per aumentare i limiti di sicurezza delle exeresi e la mucosa asportata viene sottoposta a esame istologico estemporaneo). L'estensione sottocordale del tumore e l'infiltrazione dello spazio paraglottico inferiore devono essere accuratamente studiate preoperatoriamente con le moderne tecniche di imaging, così da escludere una possibile estrinsecazione tumorale inferiore fra le cartilagini tiroidea e cricoidea che rappresenterebbe una precisa controindicazione alla conservazione della cricoide e quindi all'intervento ricostruttivo.
L'estrinsecazione tumorale dalla laringe può avvenire lungo la superficie della mucosa, in corrispondenza dei limiti superiori dell'organo, verso la faringe e la base della lingua, oppure in profondità attraverso la sottomucosa (spazi paraglottici e preepiglottico) o le cartilagini verso la base linguale, i seni piriformi, la regione retrocricoidea e i tessuti prelaringei. L'estrinsecazione tumorale, accertabile preoperatoriamente sia da segni clinici, sia con l'imaging radiologica, rappresenta un'altra controindicazione assoluta all'intervento.
Infine, la laringectomia subtotale ricostruttiva è controindicata nei casi di metastasi linfonodali massive con rottura della capsula linfonodale e infiltrazione dei tessuti molli del collo, per il cui trattamento è richiesta la radioterapia post-operatoria precoce, che complica il ripristino funzionale dopo l'intervento.
Vi sono inoltre controindicazioni generali alla laringectomia subtotale ricostruttiva con ripristino funzionale, che può risultare impossibile o comportare gravi complicazioni in soggetti affetti da particolari condizioni morbose: gravi bronco-pneumopatie con insufficienza respiratoria (enfisema polmonare, silicosi, esiti di tubercolosi, ecc.) per il pericolo rappresentato dalla possibile comparsa di broncopolmonite ab ingestis alla ripresa dell'alimentazione spontanea; gravi cardiopatie comportanti il pericolo di scompenso cardio-circolatorio; gravi dismetabolismi come il diabete, in grado di ostacolare e ritardare la guarigione del campo operatorio; malattie nervose degenerative associate a turbe dei meccanismi di deglutizione, causa di ritardato o impossibile ripristino dell'alimentazione spontanea; l'età avanzata nella quale sono più frequenti le complicazioni post-operatorie e maggiori le difficoltà nel ripristino funzionale.
Anche alcune abitudini voluttuarie (etilismo) e malattie psichiche (sindromi ansioso-depressive, deliri, oligofrenie, schizofrenia, ecc.) rappresentano una controindicazione all'intervento, perché responsabili della mancanza di collaborazione durante la rieducazione funzionale post-operatoria.
d) Tecnica chirurgica.
La tecnica dell'intervento, che va praticato in anestesia generale con intubazione oro-tracheale, può essere riassunta nelle seguenti fasi.
1. Ampia incisione dei tegumenti precervicali ‛a grembiule', allargata lateralmente quando si rendono necessari gli svuotamenti linfonodali; scollamento dal piano muscolare verso l'alto del lembo a cerniera superiore, costituito dalla cute, dal tessuto sottocutaneo e dai muscoli pellicciai, fino al bordo inferiore della mandibola e al polo inferiore delle ghiandole parotidi con esposizione delle strutture situate nelle regioni anteriore e laterali del collo.
2. Solo nei casi di tumori metastatizzanti (infiltranti, transglottici), svuotamento linfonodale cervicale bilaterale di tipo funzionale (asportazione delle fasce e del tessuto cellulare lasso con tutte le catene linfonodali contenute, preservando le strutture muscolari, nervose e vascolari).
3. Incisione dei muscoli precervicali (sottoioidei) alla base del collo e loro scollamento dal piano sottostante verso l'alto fino alla cartilagine tiroidea con ampia scopertura della regione del giugulo, della ghiandola tiroide e della cricoide.
4. Isolamento, legatura e sezione delle vene tiroidee inferiori, preservando le arterie tiroidee inferiori e i nervi ricorrenti (laringei inferiori), con esposizione della trachea cervicale; tracheostomia a livello del 6°-7° anello tracheale).
5. Dopo il trasferimento nel tracheostoma del tubo d'anestesia, sezione dei muscoli sottoioidei lungo il bordo inferiore dell'osso ioide e svuotamento del contenuto della loggia tiro-io-epiglottica (spazio pre-epiglottico).
6. Sezione dei muscoli costrittori inferiori lungo il bordo posteriore della cartilagine tiroidea e loro scollamento dalla cartilagine e dalle pareti laterali dei seni piriformi; sezione del corno inferiore della cartilagine tiroidea, al di sotto del quale si sfiocca il nervo laringeo inferiore, la cui preservazione è indispensabile per conservare la motilità dell'aritenoide.
7. Asportazione della laringe sopracricoidea con conservazione dell'aritenoide dal lato meno interessato dal tumore e con sacrificio di tutta l'epiglottide nei casi di tumore transglottico, come nel caso illustrato; nei casi di tumore cordale anteriore possono essere conservate entrambe le aritenoidi, in quelli di tumore strettamente limitato al piano cordale può essere conservata la porzione superiore dell'epiglottide.
8. Ricostruzione mediante sutura della continuità mucosa lungo la faccia anteriore dell'aritenoide conservata e stiramento in avanti della mucosa anteriore dell'imbocco dei seni piriformi, che viene fissata al bordo superiore della cricoide lateralmente.
9. Sutura dell'anello cricoideo, anteriormente, e della mucosa faringea, bilateralmente, rispettivamente alla base della lingua (o al bordo inferiore dell'epiglottide, se conservata) e alla mucosa laterale dell'orofaringe (solco amigdalo-glosso) con punti circondanti anche il corpo e le grandi corna dell'osso ioide (v. fig. 4F); legatura di questi punti di sutura con realizzazione della crico-ioidopessia.
10. Seconda sutura, di rinforzo, fra il bordo superiore della ghiandola tiroide e la parte inferiore dei muscoli sopraioidei; l'applicazione dei drenaggi aspirativi, il completamento del tracheostoma e la sutura della cute in due piani completano l'intervento.
e) Decorso post-operatorio.
Il decorso post-operatorio è alquanto impegnativo e richiede particolare assistenza. Oltre al trattamento medico abituale per tutti gli interventi di questa entità, l'operato necessita di assistenza specifica per il controllo dei drenaggi, per le periodiche aspirazioni tracheo-bronchiali attraverso la cannula tracheotomica, per l'umidificazione dell'aria respirata, per l'alimentazione attraverso la sonda naso-esofagea, per le medicazioni giornaliere.
La ripresa funzionale, perseguita fin dai giorni immediatamente seguenti l'intervento da personale paramedico specializzato (in genere, logopedisti), deve rispettare alcune tappe temporali prestabilite: già in prima giornata l'operato va mobilizzato dal letto; in terza giornata si procede all'allontanamento della cannula tracheotomica cuffiata (introdotta al momento dell'intervento per impedire l'aspirazione di saliva nella trachea durante i primi giorni) e alla sua sostituzione con una cannula normale di calibro inferiore, la cui otturazione temporanea consente di attuare i primi tentativi di respirazione per le vie naturali e di fonazione; appena possibile, in genere in quarta-quinta giornata, viene occlusa la cannula tracheotomica, così da favorire la respirazione per le vie naturali per periodi più o meno lunghi e l'eloquio spontaneo. In ottava giornata, tolti i punti di sutura e i drenaggi aspirativi, va iniziata la rieducazione deglutitoria con esercizi fisici linguali e faringei e con atti controllati di deglutizione della saliva. In dodicesima giornata si dà inizio ai primi tentativi assistiti di deglutizione di boli alimentari (cibi solidi, capo e busto flessi in avanti); dopo un paio di giorni si passa alla deglutizione dei liquidi (acqua). Quando l'alimentazione per le vie naturali risulta sufficiente (in genere 15-20 giorni dopo l'intervento), dopo l'estrazione della sonda alimentare naso-esofagea, l'operato può essere dimesso con cannula tracheotomica di piccolo calibro occlusa. Dopo 20-30 giorni, in assenza di disfunzioni e complicanze, l'operato può essere sottoposto ambulatoriamente alla plastica di chiusura del tracheostoma in anestesia locale: clinicamente guarito, la sua rieducazione fonetica va proseguita ambulatoriamente per alcune settimane.
f) Risultati.
La ripresa funzionale completa dopo laringectomia subtotale ricostruttiva (respirazione per le vie naturali sufficiente con chiusura definitiva del tracheostoma, deglutizione valida, fonazione socialmente adeguata) è ottenuta nella stragrande maggioranza degli operati; solo nel 5% dei casi si riscontrano disturbi funzionali tali da richiedere la ‛totalizzazione' con creazione del tracheostoma definitivo.
La persistenza in alcuni casi di una modesta difficoltà nella deglutizione dei liquidi, che si manifesta nella necessità di assumere i cibi liquidi a piccoli sorsi, costituisce un inconveniente generalmente ben tollerato.
La ripresa della fonazione avviene precocemente in tutti gli operati: la qualità dell'emissione vocale è nettamente migliore dopo l'intervento meno demolitivo con crico-ioido-epiglottopessia, mentre negli operati che abbiano subito l'asportazione dell'epiglottide e di una o di entrambe le aritenoidi la fonazione risulta meno sonora e richiede un periodo più o meno lungo di rieducazione fonetica; anche in quest'ultimo gruppo di soggetti, tuttavia, la voce diviene alla fine accettabile per la vita di relazione (v. Arslan e Serafini, 1972).
Per quanto riguarda la guarigione dalla malattia oncologica, i risultati sono soddisfacenti, tenuto conto che questa chirurgia è impiegata anche in casi con tumori in fase avanzata: il tasso di sopravvivenza a cinque anni dall'intervento è intorno all'80%.
6. Considerazioni conclusive
Il trattamento delle neoplasie laringee è attualmente volto all'eradicazione completa del tumore e, ove possibile, al ripristino funzionale dell'organo. La chirurgia esclusivamente demolitiva ha lentamente ceduto il passo alla laringectomia ricostruttiva, favorendo il pieno recupero funzionale di un gran numero di pazienti prima costretti a supplire al deficit post-operatorio con l'aria esofagea o con i vari tipi di protesi. Il progresso della tecnica chirurgica oncologica della laringe si traduce, di riflesso, per i vantaggi recati ai laringectomizzati sul piano psichico oltre che su quello fisico, in un notevole beneficio sociale.
BIBLIOGRAFIA
Alajmo, E., La laryngectomie reconstructive avec crico-hyoidopexie, in ‟Revue de laryngologie-otologie-rhinologie", 1974, XCV, pp. 53-57.
Albers, J. H., Die Pathologie und Therapie der Kehlkopfkrankheiten, Leipzig 1829.
Alonso di Montevideo, J., Conservative surgery of cancer of the larynx, in ‟Transactions of the American Academy of Ophthalmology and Otolaryngology", 1947, LI, pp. 633-642.
Arslan, M., Serafini, I., Restoration of laryngeal functions after total laryngectomy. Report on the first 25 cases, in ‟Laryngoscope", 1972, LXXXII, 7, pp. 1349-1360.
Bocca, E., La laryngectomie sus-glottique élargie. Indications et possibilités, in ‟Nuovo archivio italiano di otologia, rinologia e laringologia", 1974, II, pp. 252-256.
Calearo, C., Teatini, G. P., Unsere Erfahrung mit der supraglottischen Teilresektion des Kehlkopfes, in ‟HNO: Wegweiser für die Fachärztliche Praxis", 1972, XX, pp. 11-15.
Casserio, G., De vocis auditusque organis historia anatomica, Ferrariae 1600-1601.
Foederl, O., Zur Technick der Larynx-Exstirpation, in ‟Archiv für klinische Chirurgie", 1899, LVIII, pp. 803-814.
Gussenbauer, C., Über die erste durch Th. Billroth am Menschen ausgeführte Kehlkopf-Exstirpation und die Anwendung eines künstlichen Kehlkopfes, in ‟Archiv für klinische Chirurgie", 1874, XVII, pp. 343-356.
Hautant, A., À propos du traitement du cancer du larynx, in ‟Annales des maladies de l'oreille et du larynx", 1929, XLVIII, pp. 671-674.
Hofmann-Saguez, M., La laryngectomie reconstitutive, in ‟Annales d'oto-laryngologie", 1954, LXXI, pp. 405-415.
Holmes, G., Histoire des progrès de la laryngologie de ses origines jusqu'à nos jours, Bruxelles 1877.
Huet, P. C., Présentation de malades. Cancer de l'épiglotte hyo-thyro-épiglottectomie, in ‟Annales d'oto-laryngologie", 1938, LVII, pp. 1052-1055.
Jemmi, C., Azzio Caselli (1847-1898) precursore della laringo-faringectomia totale e geniale ideatore della protesi laringea, in Atti del XLIV congresso della Società Italiana di Laringologia, Otologia e Rinologia. Bologna 27-30 settembre 1956 (a cura di P. Carcò), vol. II, Comunicazioni, Roma 1957, pp. 378-387.
Labayle, J., Bismuth, R., Laryngectomie totale avec reconstitution, in ‟Annales d'oto-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale", 1971, LXXXVIII, pp. 219-228.
Leroux-Robert, J., La chirurgie conservative par laryngofissure ou laryngectomie partielle dans les cancers du larynx, in ‟Annales d'oto-laryngologie", 1957, LXXIV, pp. 40-80.
Majer, E. H., Rieder, W., Technique de laryngectomie permettant de conserver la perméabilité respiratoire (Le crico-hyoïdo-pexie), in ‟Annales d'oto-laryngologie", 1959, LXXVI, pp. 677-681.
Ogura, J. H., Marks, J. E., Freeman, R. B., Results of conservation surgery of cancers of the supraglottis and pyriform sinus, in ‟Laryngoscope", 1980, XC, pp. 591-600.
Pelletan, P. J. J., Clinique chirurgicale, t. 1, Paris 1810.
Piquet, J. J., Desaulty, A., Hoffmann, Y., Decroix, G., La chirurgie subtotale reconstructive dans le traitement des cancers du larynx, in ‟Annales d'oto-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale", 1974, XCI, pp. 311-320.
Scuri, D., Nuovo contributo alla rieducazione del linguaggio nei laringectomizzati, in ‟Archivio italiano di otologia, rinologia e laringologia", 1930, XLI, pp. 577-584.
Serafini, I., Ripristino della respirazione per le vie naturali, della deglutizione e della fonazione in cani sottoposti a laringectomia totale, in ‟Annali di laringologia ed otologia, rinologia e faringologia", 1967, LXVI, pp. 241-256.
Serafini, I., Restoration of laryngeal function after laryngectomy. Experimental research in animals, in ‟Advances in oto-rhino-laryngology", 1969, XVI, pp. 95-122.
Serafini, I., Laringectomia totale con mantenimento della respirazione per le vie naturali. Resoconto sul primo caso recentemente operato, in ‟Minerva otorinolaringologica", 1970, XX, pp. 73-84.
Serafini, I., Laryngectomie reconstructive, in ‟Revue de laryngologie", 1972, I, 2, pp. 23-38.
Trotter, W., A method of lateral pharyngotomy for the exposure of large growths in the epylaryngeal region, in ‟Journal of laryngology and otology", 1920, XXXV, pp. 289-295.
Trousseau, A., Traité pratique de la phtisie laryngée, de la laringite chronique et des maladies de la voix, Paris 1837.