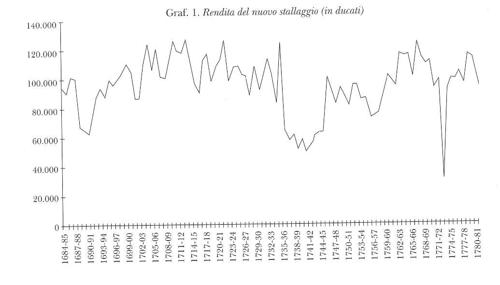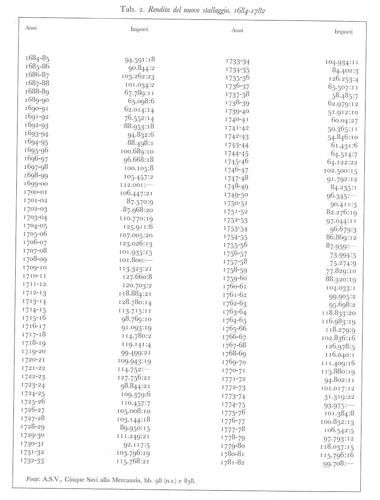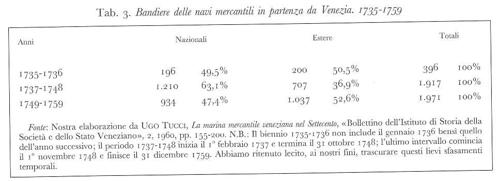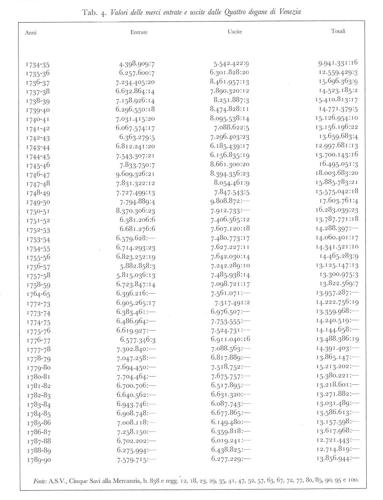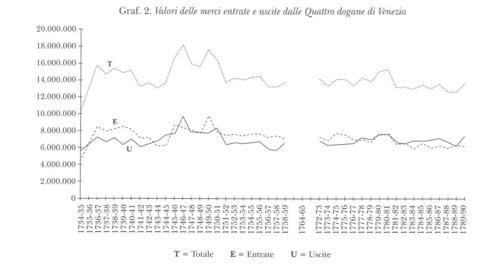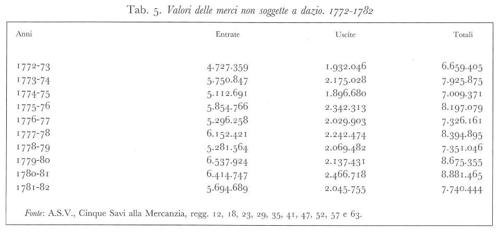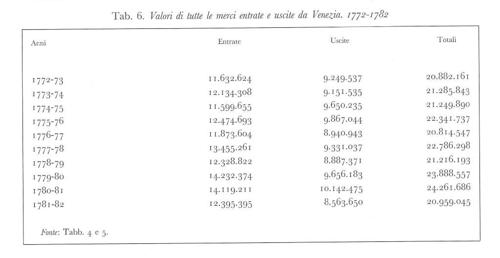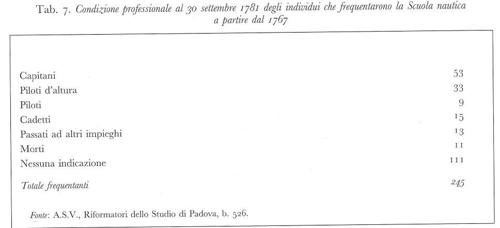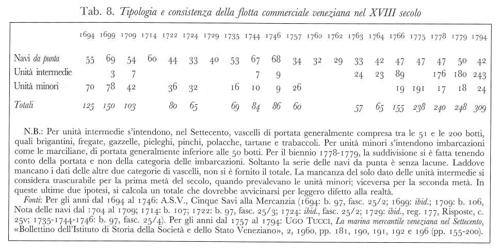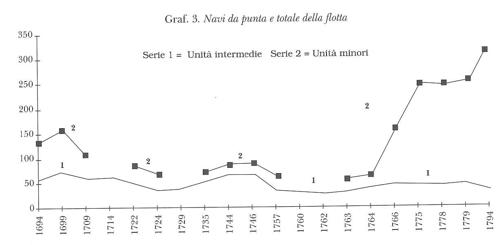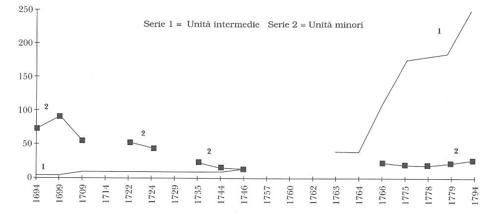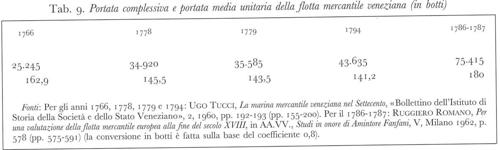Commercio e marina
Commercio e marina
Il Mediterraneo all’inizio del XVIII secolo
L’ultimo secolo di vita della Serenissima, considerata nel suo aspetto storicamente più significativo, vale a dire dal punto di vista marittimo e commerciale, si svolse sotto il segno di un inarrestabile declino relativo.
Declino relativo e non assoluto, perché i dati disponibili non indicano regressi e tanto meno drastiche cadute, bensì una generale tenuta e in alcuni casi addirittura una crescita, che però dimostrano tutta la loro debolezza sul piano comparativo, in rapporto al contemporaneo, straordinario sviluppo dei centri europei del versante nord-occidentale.
Un declino che si inserisce a pieno titolo e senza contraddizioni nel quadro della profonda ristrutturazione generata dalle grandi scoperte geografiche, che dilatarono lo spazio economico a livello tendenzialmente planetario, spostandone il baricentro dal Mediterraneo all’Atlantico, ovvero dalla Penisola italiana (Venezia innanzitutto) al Portogallo, alla Spagna, all’Olanda, alla Francia e all’Inghilterra.
Preparata da un durissimo scontro con l’Olanda, sia sul piano commerciale, attraverso il rigido indirizzo esclusivista dei Navigation Acts del 1651 e del 1660, sia su quello militare, attraverso tre guerre marittime tra il 1652 e il 1674, l’egemonia inglese si sviluppò nell’ultimo quarto del secolo XVII, specialmente dopo il definitivo assestamento politico indotto dalla «gloriosa» rivoluzione del 1688. Alla fine della guerra di successione spagnola, nel 1713, essa era ormai un fatto compiuto (1).
Il Settecento si aprì dunque in uno scenario che vedeva concludersi la prima fase dell’espansione europea a livello mondiale, nella quale i Paesi Bassi erano diventati il «magazzino del mondo», e delinearsi quella successiva, contrassegnata dal lungo primato economico e militare dell’Inghilterra, già assurta al ruolo di massima potenza marittimo-commerciale e prossima ad assumere anche quello di «officina del mondo».
Finiva così il ruolo esclusivo delle città (dapprima Venezia, poi Anversa e infine Amsterdam) nella definizione e nella gestione delle varie configurazioni dell’economia-mondo e si affermava quello degli stati nazionali (2). Amsterdam, e con essa le Province Unite, pur continuando a svolgere un ruolo di tutto rispetto nei traffici internazionali e addirittura crescente nell’intermediazione finanziaria, risultavano ormai nettamente subalterne all’Inghilterra, che si presentava come il nuovo centro di un sistema imperialistico su scala mondiale.
L’unica nazione in grado di competere con essa era la Francia, forte, talvolta in misura anche maggiore, delle proprie dimensioni territoriali, delle proprie risorse umane e materiali e del proprio mercato interno, oltreché del robusto sostegno dello stato all’economia. Ma la sua persistente ruralità e la debolezza del ceto imprenditoriale ne appesantivano il passo e la trattenevano in ambito continentale, limitandone lo sviluppo marittimo, che restò sempre un gradino al di sotto dei livelli d’Oltremanica e dunque, in ultima analisi, insufficiente a reggere il durissimo confronto, che tuttavia si prolungò per quasi tutto il secolo, fino al trattato di Eden del 1786.
Questo sancì, rendendola evidente, la sconfitta della Francia nella lotta per l’egemonia: un esito che era già maturo nel modo in cui l’Inghilterra, appena tre anni prima, a Versailles, usciva dall’apparente umiliazione della perdita delle colonie americane e che il velleitario tentativo napoleonico del 1811 (blocco continentale antibritannico) non poté rimettere in discussione (3). Ma forse bisogna risalire, per la Francia come per l’Olanda, al 1713: anche se, a differenza della seconda, la prima seppe risollevarsi dalla terribile prostrazione postbellica e riprendere la lotta ancora per un buon settantennio, fu allora che, per entrambe, risultò irrevocabilmente decisa la condizione di inferiorità sul piano marittimo e coloniale di fronte alla «superiorità addirittura schiacciante» correlativamente acquistata in quel lungo periodo di conflitti dalla rivale d’Oltremanica (4).
Il dinamismo delle nuove potenze marittime dell’Europa nord-occidentale non si limitò alla pur straordinaria espansione oceanica, che costituì nei secoli dell’età moderna un aspetto complessivamente ancora minoritario – sebbene in notevole crescita, di forte peso specifico e prospetticamente decisivo (5) –, del traffico mondiale, ma si impose anche nel declassato mare interno.
Per le flotte atlantiche, e per quelle inglesi innanzitutto, l’antico spazio mediterraneo restava, infatti, un mercato di primaria importanza, sia dal lato dell’offerta, per le sue peculiari e talora esclusive materie prime (seta, cotone, lino, canapa, indaco, olio, vino, uva passa) e per i suoi particolari prodotti di qualità e financo di lusso (tessuti in lana, seta e oro-seta), sia, soprattutto, dal lato della domanda, che si rivolgeva verso un’ampia gamma di materie prime (di riesportazione: spezie, tè, caffè, zucchero, tabacco, cacao; di esportazione: piombo, stagno, pesce salato) e di prodotti finiti (di riesportazione: tessuti bianchi e colorati – stampati e non – di cotone, lacche, porcellane; di esportazione: tessuti leggeri in lana e lana-cotone, o new draperies). Al principio del secolo, l’Inghilterra importava più del doppio ed esportava/riesportava più del quintuplo in area europea e mediterranea rispetto a quanto faceva in tutti gli altri continenti (6).
Nel mare interno, diversamente dalle estese periferie della nuova economia-mondo, soprattutto da quelle estremo-orientali non colonizzate, le navi dell’Europa nord-occidentale non entravano mai a stive completamente vuote o zavorrate: grazie a una domanda regionalmente anche assai disomogenea, ma complessivamente elevata – la più elevata del pianeta –, le merci di provenienza atlantica trovavano mercati in grado di assorbirle. Ne derivava, per l’Olanda come per l’Inghilterra, un traffico che – anche a prescindere dalle «partite invisibili», come i noli dei servizi marittimi, le provvigioni delle commissioni mercantili e i proventi delle attività di cambio, i cui introiti tendevano a pareggiare i conti con l’estero – non era mai totalmente né sistematicamente in passivo e che perciò non generava un deflusso massiccio e unilaterale di metalli preziosi.
Adesso i velieri atlantici ripercorrevano in senso inverso, attraverso Gibilterra, le rotte aperte quattro secoli addietro dalle galere genovesi e veneziane (dirette a Bruges o Anversa) ed entravano nel Mediterraneo con i loro carichi. Non paghi di avere già sottratto ai vecchi centri, e in particolare a Venezia, il commercio internazionale a lunga distanza, attivarono nei loro confronti una durissima e implacabile concorrenza perfino nei traffici intramediterranei, attaccando posizioni consolidate e dissolvendo, sia pure gradualmente e non completamente, antiche sfere d’influenza.
Il plurisecolare monopolio marittimo della Serenissima, messo progressivamente in discussione dall’avvento delle nuove potenze oceaniche all’indomani delle grandi scoperte geografiche, risultava, già alla fine del XVI secolo, definitivamente spezzato in un policentrismo diffuso su scala europea e ad egemonia atlantica, ora specificamente britannica (7).
La penetrazione inglese nel mare interno si avvalse di una serie di elementi favorevoli: progresso nelle costruzioni navali (velieri) e nelle tecniche di navigazione (rilevazione astronomica), equipaggi ben addestrati e mediamente meno numerosi, eccellente capacità difensiva (per l’elevata potenza di fuoco installata sui legni mercantili e per l’efficace protezione-deterrenza esercitata da agguerriti vascelli di scorta o da veloci e combattive squadre di pattugliamento) (8).
Da questo primo gruppo di fattori altri ne conseguivano di altrettanto importanti e forse decisivi per garantire la straordinaria competitività della marina mercantile britannica: noli, premi di assicurazione e costi del personale nettamente più bassi rispetto a quelli cui soggiaceva la concorrenza mediterranea.
Il dinamismo delle marinerie atlantiche e il tradizionalismo della nautica mediterranea
Il progresso tecnico capitalizzato dalle flotte dei centri marittimi dell’Europa atlantica – attraverso innumerevoli modifiche, adattamenti e perfezionamenti suggeriti o imposti da oltre due secoli di navigazione oceanica – aveva portato, come esito pressoché definitivo della nautica preindustriale, precedente cioè alla rivoluzione indotta dalla nuova tecnologia del ferro e del vapore, all’avvento di un tipo di vascello – il veliero – straordinariamente più evoluto della sua antenata medievale (nave tonda o cocca) e nettamente superiore, ormai, all’altro tipo di imbarcazione di tradizione mediterranea (nave lunga o galera).
Rispetto alle prime navi tonde, lente e impacciate perché dotate di una sola vela quadra inutilizzabile senza il vento in poppa, il progresso era stato enorme. Gli alberi erano diventati quattro, a quello di maestra essendosi aggiunti quelli di mezzana, di trinchetto e di bompresso, e le vele, di varia forma e dimensione, giungevano alla decina: un’attrezzatura ricca e funzionale, che conferiva al veliero una velocità di crociera e una facilità di manovra fino ad allora sconosciute.
Il confronto con la tipica imbarcazione mediterranea, la galera grossa da mercato o sottile da guerra, che aveva dominato la scena dell’economia-mondo tardomedievale scandendone i tempi e allargandone gli spazi al ritmo e sotto la spinta dei colpi dei remi veneziani, mostrava, all’alba del XVIII secolo, l’evidentissima superiorità tecnica ed economico-gestionale già conseguita dalla nuova nave tonda di origine atlantica.
Il veliero, alla cui tipologia appartenevano peraltro varie categorie di navi, da un lato, infatti, non richiedeva rematori, dall’altro, grazie all’introduzione del timone assiale di poppa e alla moltiplicazione di vele, velacci e controvelacci, non presentava particolari difficoltà di navigazione, nemmeno in caso di vento contrario o, addirittura, di bonaccia. Questa, che afflosciava la vela e bloccava la corsa delle vecchie navi tonde, era così frequente nel mare interno da costituire uno dei principali motivi della tenace resistenza opposta dalle imbarcazioni a propulsione mista all’avvento di quelle a propulsione esclusivamente eolica. Ma ora l’enorme e multiforme superficie velica dispiegata dai vascelli atlantici era in grado di raccogliere e sfruttare il più piccolo alito e la più sfavorevole direzione di vento.
Minori costi di retribuzione e minori spese alimentari per un equipaggio più ridotto stavano alla base del netto vantaggio che anche sotto l’aspetto economico-gestionale manifestavano le nuove navi tonde rispetto a quelle lunghe, in una fase caratterizzata, per giunta, dall’aumento dei prezzi e dei salari (9).
Più a lungo di ogni altro centro dell’area mediterranea, Venezia rimase fedele alla tradizione marittima medievale, fondata sulla galera come mezzo di trasporto e sul binomio bussola-carta nautica come strumento di navigazione.
Ancor più delle galere grosse da mercato – che costituirono, con i loro viaggi regolari verso Levante e verso Ponente, il fulcro della sua organizzazione commerciale nei secoli XIV e XV e che pur sopravvissero fino a Cinquecento inoltrato (10) – furono le galere sottili da guerra a durare, perfino al di là di ogni ragionevole considerazione tecnica. Ritenute strumento irrinunciabile della strategia militare veneziana, perché legate all’epopea marittima della Serenissima, mantennero il loro posto in Armata fino al tramonto della Repubblica.
Ma nella sfera commerciale, ove le spietate ragioni della concorrenza non erano suscettibili di rimozione alcuna, neppure attraverso processi collettivi di elaborazione del mito, la crisi si avvertì pesantemente già dopo Lepanto (1571), una grande vittoria navale che non arrestò il trend discendente della marina mercantile veneziana.
Non a caso, il settore che risultò più colpito nel lungo periodo fu quello delle costruzioni navali, ove nessuna congiuntura internazionale e nessuna politica di incentivi potevano risolvere il problema alla radice, perché le cause erano strutturali: scarsità crescente di legname e aumento dei costi di produzione (11).
Nemmeno l’acquisto di navi straniere, che nel 1627, dopo un nuovo collasso dell’industria cantieristica, il governo prese a sussidiare, era in grado di arrestare il declino della marineria veneziana. Non bastava, infatti, disporre di velieri atlantici, quando non c’erano uomini capaci di usarli. In effetti, la crisi economica era anche una crisi di mentalità: ci si era attardati nell’uso delle tecniche tradizionali, trascurando le innovazioni della navigazione oceanica.
All’aprirsi del XVIII secolo, la nautica mediterranea, apparentemente senza eccezione alcuna, rimaneva ancora estranea al processo di unificazione tra teoria e pratica felicemente avviatosi nei maggiori centri dell’Europa atlantica, attraverso l’applicazione dell’astronomia, della fisica e della matematica ai problemi posti dalle nuove dimensioni e dalle nuove caratteristiche dei traffici marittimi in età moderna.
Sotto questo aspetto, mentre in Portogallo, Spagna, Olanda, Francia e Inghilterra la nautica diventava via via una scienza, nei vecchi centri del mare interno, e a Venezia in particolare, essa rimaneva irrimediabilmente un’arte (12).
In qualche misura, tuttavia, e a parte le cause profonde che attengono alla progressiva marginalizzazione del ruolo marittimo di Venezia nella nuova geografia dei traffici internazionali, tale conservatorismo poggiava su motivi anche diversi dal culto della tradizione e non privi di un certo valore reale.
Non si può negare, infatti, che a lungo, nelle acque del Mediterraneo, specialmente in quelle orientali tanto frequentate dalle navi veneziane, ci si poteva affidare alla pura e semplice esperienza.
La memoria dei luoghi attraversati, che esentava il personale di bordo da un’aggiornata preparazione teorica e dall’uso dei nuovi strumenti, restò il fondamento della navigazione nel mare interno almeno fino a metà Seicento, allorché i moderni metodi di navigazione, legati alla nuova configurazione e propulsione delle navi (velieri) e al calcolo della posizione nelle lunghe traversate oceaniche (navigazione astronomica), raggiunsero un livello di precisione adeguato alle esigenze di uno spazio considerevolmente più ristretto (13).
Per indurre Venezia ad abbandonare metodi consacrati da un glorioso passato, tuttavia, non bastavano pur importantissime considerazioni di carattere tecnico: occorreva la definitiva presa di coscienza, sia da parte del governo che degli armatori e dei mercanti della piazza realtina, dell’enorme deficit di competitività accumulato dalla marina mercantile veneziana nei confronti delle flotte atlantiche per il più elevato costo delle costruzioni navali, dei noli, delle assicurazioni, degli equipaggi, delle scorte di viveri ecc.
Questa consapevolezza venne raggiunta soltanto nel corso degli anni Settanta del XVII secolo, quando, con il persistere della crisi dopo la fine della guerra di Candia, diventò finalmente evidente che le difficoltà non dipendevano dal pur durissimo conflitto con il Turco, bensì da cause più strutturali, di ordine sia tecnico che economico (14).
Libertà di commercio e porti franchi
Il successo dell’espansionismo commerciale delle nuove potenze atlantiche nel Mediterraneo non si spiegherebbe senza il concorso di ulteriori fattori, diversi da quelli generali fin qui esaminati (ridislocazione del potere marittimo, rivoluzione nei mezzi e nei metodi di navigazione, abbattimento dei costi di trasporto).
In particolare, la penetrazione delle flotte olandesi e inglesi nel mare interno non avrebbe potuto rompere equilibri lungamente sedimentati, né spostare consolidate direttrici di traffico, se non anche facendo contraddittoriamente leva su un principio drasticamente negato nella propria sfera d’influenza: la libertà di commercio.
La loro superiorità tecnica e gestionale, seppure notevole, non poteva di per sé bastare e doveva essere messa in condizione di esprimersi, perché il Mediterraneo, anche sotto l’aspetto commerciale, non era affatto uno spazio vuoto a disposizione dei nuovi entrati.
Bisognava fare i conti con la fitta ed estesa rete di relazioni politiche e commerciali tessuta nel basso medioevo dalle città marinare italiane, che tuttavia si era fortemente ristretta e allentata tra il XVI e il XVII secolo proprio sotto l’incalzare della nuova economia atlantica, che aveva ormai incorporato il traffico oceanico a lunga distanza e metteva già le mani sui collegamenti marittimi tra Nord e Sud dell’Europa attraverso Gibilterra.
L’indebolimento dei centri della Penisola – costretti in un ambito che, se non era già regionale, come nella quasi totalità dei casi, non fuoriusciva comunque più dai limiti del mare interno – consentì tra il XVII e il XVIII secolo a Olanda e Inghilterra di assicurarsi la libertà di cui avevano bisogno per estendere e perfezionare il ruolo di mediazione degli scambi tra il Mediterraneo e l’Europa centro-settentrionale e, all’interno stesso di quel bacino, tra i vari paesi che vi si affacciano.
La regionalizzazione delle funzioni portuali, con la tendenza a svolgere un ruolo di transito per l’economia dell’immediato entroterra, da un lato, e l’espansionismo commerciale delle potenze atlantiche, interessate alla liberalizzazione dei traffici altrui, dall’altro, convergevano nel determinare le condizioni più favorevoli per l’istituzione dei porti franchi, strumento mercantilistico al servizio dell’industria «nazionale» per gli uni, semplice base di appoggio per il deposito e la redistribuzione di merci per gli altri, insidia mortale per chi, unico tra i vari centri mediterranei, ancora ambiva a un ruolo marittimo suo proprio: Venezia.
Pur avendo perso, con Candia, l’ultimo grande tassello del suo impero marittimo, Venezia continuava infatti a svolgere un ruolo non trascurabile sulle antiche rotte levantine, a partire dall’intatta base adriatica (il Golfo, per antonomasia). Sebbene il suo stesso spazio economico fosse più ristretto di quello tardomedievale, essa non intendeva comunque rinunciare ad esercitare l’intero ciclo commerciale, dal negozio al trasporto delle merci. Perciò, diversamente dagli altri scali della Penisola, rimaneva sede di un commercio e di una navigazione propri, luogo di attiva intermediazione degli scambi, e tale voleva restare.
L’istituzione del porto franco sulle rive della laguna, nelle gravissime condizioni di inferiorità tecnica, economica e professionale dell’organizzazione marittima veneziana più volte sottolineate, rischiava di consegnare alle nuove potenze atlantiche la pur modesta quota di traffico internazionale ancora intercettato dallo scalo realtino.
Tuttavia, Venezia non era pregiudizialmente chiusa a misure di riforma del proprio sistema protezionistico, in particolare di quello doganale, come è testimoniato dalla vigile e costante attenzione prestata alle politiche commerciali degli scali concorrenti e, perfino, dalla vera e propria sperimentazione, tra il 1662 e il 1684, del cosiddetto «portofranco», che tuttavia si limitava a liberalizzare l’entrata e che finì per causare perdite fiscali senza incrementare il movimento del porto (15).
Un’ulteriore testimonianza di disponibilità (se non di volontà) riformatrice in materia di politica commerciale venne nel 1736 con l’instaurazione di un sistema doganale «aperto», caratterizzato cioè da basse tariffe di entrata e di uscita, che peraltro confermò l’esito del precedente tentativo (16).
Certo, all’Inghilterra, che pretendeva una completa libertà di traffico in laguna, il governo veneziano rispose negativamente, ma soltanto dopo il rifiuto opposto dai negoziatori d’Oltremanica a stipulare un trattato che contemplasse l’elementare principio della reciprocità (17). In realtà, gli Inglesi, come gli Olandesi, concepivano l’istituto della franchigia come strumento di penetrazione e di egemonia commerciale in centri ridotti a mera funzione di transito.
Altri scali, talora privi di storia, potevano trovare conveniente un ruolo siffatto, che si risolveva in una pura e semplice movimentazione del porto – non Venezia–, per la quale i vantaggi virtuali della franchigia non valevano la rinuncia a quelli reali di una presenza autonoma sul mare. Così, tra Sei e Settecento, il fenomeno dei porti franchi si estese dalle rive del Tirreno (Marsiglia, Livorno, Genova, Nizza-Villafranca, Civitavecchia, Napoli e Messina) a quelle adriatiche (Ancona, Punta di Goro, Trieste e Fiume), isolando il centro lagunare e stringendolo come in una morsa.
L’ordinanza imperiale del 2 giugno 1717, che rivendicava alla marina austriaca non soltanto libertà di traffico, sempre tollerata da Venezia, ma perfino l’armamento di flotte militari nelle proprie basi adriatiche; la concessione nel 1719, da parte dello stesso Carlo VI, della patente di porto franco a Trieste e Fiume; la stipulazione, nello stesso anno, di trattati commerciali con i Barbareschi; il privilegio accordato nel 1722 alla compagnia di Ostenda per i viaggi delle Indie di fare scalo a Trieste: l’insieme di questi atti segnalava ormai esplicitamente il maturare nella monarchia asburgica di un indirizzo, non privo di fondamento, che, da un lato, candidava i due ancor piccoli centri del litorale a punti di riferimento di un retroterra (quello danubiano) che non poteva e non voleva più gravitare soltanto su Venezia, dall’altro, apriva un contenzioso con la vecchia Repubblica marinara sulla questione del dominio del Golfo (18).
Dalla parte di Sottovento, le cose non andavano meglio: l’istituzione, con editto papale del 1732, del porto franco di Ancona, che in pochi anni moltiplicò il suo traffico e spostò il baricentro del commercio pontificio dal Tirreno all’Adriatico, e le insidiose contestazioni romane circa la legittimità della giurisdizione veneziana suonavano aperta sfida all’egemonia commerciale e militare della Serenissima (19).
Nei primi decenni del Settecento andava realizzandosi, proprio sul terreno della libertà di navigazione e di commercio, una convergenza in funzione antiveneziana tra nazioni atlantiche, monarchie continentali con nascenti velleità marittime e stati regionali italiani. Questa saldatura risultava particolarmente evidente in area adriatica, dove, proprio per lo stridente contrasto tra quell’obiettivo di carattere generale e il contesto storico-politico, l’intesa imperial-pontificia assumeva un carattere eversivo di un antico assetto di potere.
In realtà, esaminando il problema sul piano puramente economico, la diffusione dei porti franchi lungo le coste della Penisola e dello stesso versante adriatico danneggiava meno i traffici veneziani di quanto i Veneziani stessi temessero. Non solo, ma essa non fu, neppure per i centri direttamente interessati, quella soluzione miracolosa che i loro fautori decantavano con enfasi.
Al di là dell’aura di mito che si era conquistato, il porto franco tendeva sempre più a presentarsi come ingranaggio subalterno agli interessi commerciali delle grandi potenze marittime (20).
E vero che, grazie all’ampia disponibilità di scali franchi, le navi olandesi, francesi o inglesi potevano evitare di spingersi fino a Venezia; ma dove, se non nel vecchio emporio realtino, avrebbero potuto effettuare, pur pagando dazio, un carico rapido e completo senza peregrinare di porto in porto? Per quanto riguarda Trieste, poi, i tempi non erano ancora maturi per una seria alternativa a Venezia e nemmeno il porto franco poteva anticiparla di un secolo.
Cause peculiari del declino marittimo di Venezia
Oltre alle cause di carattere generale fin qui esaminate – sviluppo dell’economia atlantica e marginalizzazione dell’area mediterranea, progresso tecnico nelle costruzioni navali e nei metodi di navigazione, penetrazione delle nuove potenze marittime nel mare interno e proliferazione dei porti franchi – il declino di Venezia va ricondotto a fattori più specifici, peculiari alla sua collocazione geografica, alla sua vicenda storica e alla sua evoluzione economica.
Ben prima dell’espansionismo commerciale atlantico, essa subì quello militare ottomano, il quale la investì con un’implacabile, lunghissima offensiva, che finì per distruggere il suo impero marittimo. Con la pace di Passarowitz, essa usciva economicamente esausta e politicamente umiliata da «un secolo di dura lotta», come Roberto Cessi definì l’ultimo ciclo (1645-1718) dell’immane conflitto (21).
In questo periodo, che fu testimone di tre durissime guerre, Venezia fu costretta a mobilitare enormi risorse umane e materiali e a produrre un rilevante sforzo finanziario per ripianare il debito pubblico – dilatato, oltre che dalle spese belliche, da costosissime neutralità armate di fronte alle guerre di successione che insanguinavano il Continente –, con il risultato finale di gravissime mutilazioni territoriali (perdita di Candia) e di crescenti pretese egemoniche sulla sua stessa sovranità nazionale (da parte dell’Austria).
L’aperta ostilità turca e la subdola, ma non meno pericolosa, pressione asburgica assorbirono le declinanti energie veneziane in logoranti sforzi militari, politici e diplomatici, distraendole da più utili impieghi.
Venezia subiva, inoltre, l’intermittente insidia della guerra da corsa, che con rinnovato vigore, tra una guerra «vera» e l’altra, veniva portata alle sue unità mercantili da flottiglie barbaresche (algerine, tunisine e tripoline), coadiuvate da imbarcazioni di altri centri della costa nord-africana, delle isole Egee e, perfino, del basso e alto Adriatico (Dulcigno, porto albanese in mano ai Turchi, e Signa, quartier generale degli Uscocchi, profughi serbo-bosniaci rifugiati e protetti, in funzione antimusulmana, nella Dalmazia austriaca) (22).
Il fenomeno era anche più allarmante, e sorprendente, in quanto non di rado vedeva coinvolti nella pratica criminosa non soltanto ciurme reclutate alla pirateria dalla grande miseria dei luoghi di origine, ma perfino navi ed equipaggi di re cristiani (inglesi, francesi, spagnoli) (23).
Il danno consisteva non soltanto nelle perdite umane e nella cattura dei legni e dei relativi carichi – danni peraltro gravissimi – ma anche nei costi aggiuntivi per la difesa e l’assicurazione, i quali pesavano forse di più, e comunque con maggiore continuità, sull’economia dei trasporti marittimi in quanto tale, contribuendo ad elevare il deficit di competitività della flotta mercantile veneziana rispetto a quelle atlantiche (24).
Le maggiori tra queste, infatti, si erano apertamente accordate con i Barbareschi, stipulando trattati che assicuravano l’immunità alle loro navi in cambio del pagamento di un tributo annuo, o tacitamente risolte a reciproci trattamenti di favore. Venezia pagava con l’isolamento e il massimo di esposizione di fronte all’insidia corsara la propria determinazione di non scendere a patti con i pirati africani.
Dopo lunghe esitazioni, dettate dalla volontà di risolvere il problema attraverso la mediazione turca, coerentemente con il principio di considerare diplomaticamente scorretto e politicamente poco dignitoso patteggiare e diventare tributari di reggenze formalmente sottoposte al dominio ottomano, anche Venezia si risolse al negoziato diretto.
I trattati di Barberia (1763-1765) aprirono, con quasi mezzo secolo di ritardo – il riferimento è alla fine delle guerre veneto-turche – una fase di sviluppo per la marina mercantile veneziana, che fu posta finalmente in condizione di trarre tutti i vantaggi ad essa consentiti dalla scelta strategica della pace con il Turco e della neutralità in Europa, in un contesto di ripetuti conflitti tra le grandi potenze e di rinnovate opportunità per la bandiera nazionale (25).
Altro problema particolarmente sentito a Venezia, per l’alto numero di uomini mediamente impiegato a bordo delle navi, era quello relativo al reclutamento e alla discliplina degli equipaggi. Calcolato in funzione della lunghezza della nave, il numero dei marinai oscillava tra le 20 e le 45 unità per imbarcazione (26); di essi, almeno la metà dovevano essere sudditi.
Nelle navi atte, di cui parleremo più avanti, l’organico era di una quarantina di uomini (marinai più soldati), contro la ventina dei vascelli olandesi o inglesi, un rapporto che, tradotto in termini monetari e perciò di costo del personale, equivaleva a 50o ducati al mese contro 240 (27).
Da parecchio tempo la marina veneziana soffriva di una grave crisi di risorse umane, a cui si era cercato di porre rimedio, nel 1539, con l’imposizione ai corpi di mestiere di un contingente di rematori, poi sostituito da un apposito tributo, la tansa; nel 1545, con la scelta di consentire l’impiego di condannati in luogo di uomini liberi (coscritti o volontari) e, nel 1682, con i Capitoli di regolazione della marina mercantile, che finalmente disciplinarono lo status giuridico ed economico dei lavoratori del mare, stabilendo diritti e doveri e fissando paghe e panatiche (28). Ma la perdita definitiva di tanta parte del dominio d’Oltremare rinsecchì le fonti tradizionali di reclutamento in Grecia e in Albania, lasciando soltanto l’Istria e la Dalmazia, e il problema della carenza di equipaggi si trascinò per il resto del secolo, al di là di quello della loro qualificazione tecnica e professionale, che pure si presentava con altrettanta gravità.
Altri fattori legati alla peculiarità del caso veneziano possono avere contribuito, in diverso modo ed importanza, al declino di lungo periodo e ai problemi specifici della sua funzione marittimo-commerciale nel Settecento (esaurimento delle fonti di approvvigionamento del legname necessario per le costruzioni navali, resistenze corporative alle riforme e alle innovazioni, tradizionalismo della politica di governo ecc.). Un ulteriore elemento, in particolare, non può non essere sottolineato: lo spostamento dell’orizzonte economico del ceto aristocratico dominante dal mare alla terra.
Dalla seconda metà del Cinquecento, crescenti risorse finanziarie furono indirizzate verso la costituzione di immense proprietà fondiarie nelle campagne venete, inaugurando una stagione, comune a gran parte della Penisola, di «ritorno alla terra» (29) e di rinnovato interesse per l’agricoltura. Nell’esperienza veneziana, questo processo assunse in modo particolarmente marcato i caratteri di uno sviluppo estensivo, finalizzato all’aumento delle superfici coltivate (bonifiche) e della produzione in quanto tale, piuttosto che al rinnovamento dell’organizzazione e delle tecniche produttive (30).
Nel generale clima di restaurazione o di riscoperta dei valori della vita agreste, la nobiltà veneziana ebbe modo di distinguersi rispetto alle altre per una maggiore integrazione tra residenza signorile e territorio agricolo, tra arte e cultura umanistica, da un lato, ed economia, dall’altro, ciò che fece appunto la differenza tra «civiltà della villa» nella Terraferma veneta e «civiltà della villeggiatura» nel resto d’Italia (31). Ma, a ben vedere, il rapporto di dipendenza e consequenzialità tra investimenti in Terraferma e declino marittimo può essere rovesciato, nel senso che fu proprio la fine del primato commerciale della Serenissima, con l’assottigliarsi dei margini di profitto e l’aumento dei rischi della navigazione, a indurre il patrizio veneziano a trasformarsi da mercante, armatore e navigatore in proprietario fondiario, e non viceversa.
Le risposte alla crisi: il sostegno alla cantieristica
Venezia non restò affatto passiva di fronte al lungo declino del proprio ruolo marittimo-commerciale, come vorrebbe un modo preconcetto o decadentistico di rappresentare il tramonto della Repubblica.
Il senato e i competenti organi politico-amministrativi mostrarono una costante attenzione in materia, non risparmiando informazioni, relazioni, inchieste, analisi e sperimentazioni dei possibili rimedi.
Una risposta alla crisi, dunque, non soltanto ci fu, ma si articolò in un ampio ventaglio di provvedimenti, alcuni dei quali in sintonia con il passato tardomedievale – che, comprensibilmente, costituì sempre un modello di perfezione cui attingere nelle difficoltà del presente –, altri (la maggioranza) di carattere decisamente innovativo.
Gli archivi settecenteschi delle magistrature sovrintendenti mostrano con quanta cura si conservasse, tenendolo bene in evidenza, il sommario della legislazione sugli imprestiti così come si era venuta sviluppando tra il XV e il XVIII secolo. La cosa potrebbe apparire addirittura un po’ patetica, visto che le politiche di sostegno alle costruzioni navali cui allude quel termine – tipico del pregnante vocabolario amministrativo veneziano – non erano più in uso dalla metà del Seicento e che le stanche suppliche dei parcenevoli (armatori) non riuscivano a strappare niente più di un privilegio, pur importante, quale la fornitura privilegiata di legname (assegnazione di roveri nazionali e autorizzazione all’importazione di roveri forestieri).
Tuttavia, non era per mancanza di volontà politica che il sistema dei prestiti – i quali erano in realtà dei premi di fabbricazione, che a un certo punto giunsero a un livello talmente alto da sfiorare la copertura del costo dello scafo (32) – si inceppò e venne alfine abbandonato, bensì per l’esaurirsi di un ciclo storico in cui la costruzione di navi mercantili utilizzabili a fini militari cessò di costituire una necessità per la strategia marittima veneziana e un’opportunità, artificiosa ma conveniente, per gli armatori della piazza realtina (33).
La svolta avvenne nel 1644, con la presa d’atto che «li vasselli di maggior portata di botte 600 non servono a tempi presenti», perché «si trattengono lungamente alle scale, non trovando così pronto il carico» (34). Il commercio mediterraneo, sottratto al monopolio veneziano e aspramente conteso da più potenze marittime, non poteva essere ulteriormente esercitato con grandi navi che raggiungevano, e talvolta superavano, le 1.200 botti (quasi 1.000 tonnellate) (35): cominciava l’era dei piccoli e medi tonnellaggi, che consentivano una maggiore autonomia e flessibilità di esercizio, soste più rapide, equipaggi ridotti e, in definitiva, minori costi di gestione.
Ora, i cinque savi alla mercanzia suggerivano e il consiglio dei pregadi deliberava di destinare gli imprestiti a vascelli anche forestieri (come concesso innovativamente nel 1627), ma in ogni caso non inferiori a 400 né superiori a 600 botti, cioè compresi tra 320 e 480 tonnellate (36). Era il canto del cigno degli imprestiti – che non saranno più rinnovati, per lo meno nella forma e nell’entità che avevano conosciuto fino ad allora –, ma la sollecitazione per unità da 400-600 botti rimase, come nuova dimensione strategica sei-settecentesca delle navi da punta della marina veneziana (navi mercantili «ad uso di guerra», potenziali destinatarie della politica di sostegno all’industria cantieristica e all’imprenditoria marittima).
Armatori e mercanti propendevano tuttavia per unità più piccole, marciliane o tartanelle di portata non superiore alle 300 botti (240 tonnellate). Il senato non poteva che prendere atto di questa opzione, imponendo però il limite di Zante al primo tipo di imbarcazione e di Candia al secondo (37).
Per navigare nelle acque al di là di Candia, fino a Smirne, Alessandria, Tripoli di Siria, Cipro e Costantinopoli, e ancor più nei mari di Ponente, bisognava disporre di vere e proprie navi – le unità minori non avevano diritto a questo nome – costruite nei cantieri nazionali o acquistate all’estero.
Ma, a questo proposito, tra il 1644 e il 1736, anno in cui nuovi provvedimenti determinarono un’ulteriore svolta nella storia della marina mercantile veneziana, il quadro è decisamente sconsolante. Il contrasto tra il dover essere di una politica economica che a lungo assicurò il primato marittimo alla città lagunare e l’impossibilità quotidianamente sperimentata di farla rivivere nella gestione del presente non poteva presentarsi in modo più acuto agli uomini di governo della Repubblica.
Pochissimi erano disposti a rischiare i loro capitali nel traffico a media-lunga distanza.
Lo stato, assorbito da uno sforzo bellico e finanziario senza precedenti – il secolo di dura lotta di cui parla Roberto Cessi –, pareva quasi rassegnato alla semiparalisi del settore e, per il reperimento di navi «ad uso di guerra», ricorse insistentemente al mercato internazionale (38). Sembrava non esserci tempo né mezzi per rendere plausibile l’obiettivo della ricostruzione di una flotta mercantile degna di questo nome.
A guerra ormai finita, negli anni Venti del Settecento, gli operatori della piazza (mercanti e parcenevoli) chiesero che fosse rinnovato «l’uso delle prestanze pubbliche», facilitata la «provisione de’ roveri nello stato», agevolata «l’introduzione de’ roveri forestieri» e consentito di poter «col danaro de gl’imprestiti comprar bastimenti esteri» (39).
Ma erano essi i primi a riconoscere che le condizioni correnti delle finanze pubbliche non consentivano alcuna illusione circa una ripresa del sistema degli imprestiti (40): non rimaneva che concentrarsi sul punto – importante ma insufficiente – delle forniture di legname.
Regolata nel 1707 l’attribuzione delle magre risorse nazionali (41), con qualche problema per i piccoli armatori esclusi dalle forniture privilegiate, si dovette fronteggiare l’opposizione dell’Arte dei segadori all’importazione, concessa per la prima volta nel 1694 ma non ancora avviata, di roveri necessariamente già trattati (segati) nei luoghi di origine (42).
Ne nacque un conflitto durissimo, che si trascinò per parecchi anni: gli uni (gli operai) denunciavano la violazione di un diritto esclusivo, che giustificava l’esistenza stessa della loro corporazione; gli altri (gli imprenditori e i magistrati) la grettezza del particolarismo di mestiere, che ostacolava il soddisfacimento di interessi generali. Il contrasto, che assunse toni anche molto accesi (43), fu infine superato (nel 1718) grazie alla mediazione del reggimento dell’Arsenal: si potevano importare roveri segati, ma in «fettoni di oncie almeno otto», riservando all’Arte le ulteriori riduzioni (44).
Il fatto, altrimenti sorprendente, che un esiguo corpo di operai privilegiati riuscisse a tenere bloccato così a lungo un provvedimento considerato importante per il rilancio di un settore strategico come la cantieristica va collocato e compreso nella realtà storica del tempo, in cui l’associazionismo di mestiere costituiva, al di là dei suoi difetti sempre più evidenti, la forma ancora dominante di organizzazione produttiva, di tutela economica e di partecipazione sociale della forza lavoro urbana. L’Arte dei segadori era un anello, piccolo e disprezzato quanto si vuole, di una catena imponente, la cui rottura, da un lato, avrebbe costituito un precedente che nessuno di quel vasto mondo corporativo, tanto meno lo straordinario agglomerato artigiano dell’Arsenale, era disposto a concedere, dall’altro, un obiettivo che lo stesso ceto aristocratico non era interessato a perseguire con decisione, specie in un ambiente produttivo così carico di significati esistenziali per l’antica Repubblica marinara. Nel 1720, infine, si riservò al cantiere di stato ciò che restava dei boschi veneti, friulani ed istriani (45).
Se sui criteri di assegnazione dei roveri si affannavano, beccandosi tra loro come i capponi di manzoniana memoria, da un lato armatori e segadori, dall’altro armatori piccoli e meno piccoli (di grandi non ce n’erano), e se sulla più generale questione dei sussidi alla cantieristica si spendevano suppliche rituali quanto rassegnate, su altre due richieste battevano concordi gli operatori della piazza: la sicurezza della navigazione e il protezionismo commerciale.
Le risposte alla crisi: sicurezza e protezionismo
La perdita della Morea, sancita a Passarowitz nel 1718, riattivò le basi corsare che infestavano l’area e contribuì a limitare il raggio d’azione della decaduta flotta commerciale veneziana entro l’Adriatico e le isole Ionie.
Nel 1721 fu perciò necessario riprendere la pratica dei convogli, che era stata abbandonata nel 1684 dopo sei anni di infelice sperimentazione. L’inizio delle ostilità contro il Turco aveva fornito l’occasione per questa rinuncia, che trovava i suoi veri motivi, da un lato, nell’eccessiva lentezza del viaggio (otto-dodici mesi invece dei tre o quattro previsti), con la conseguenza di maggiori costi d’esercizio e minore rigiro di capitale; dall’altro, nelle perturbazioni di mercato determinate dall’arrivo simultaneo di numerose navi, con il risultato di un’impennata dei prezzi d’acquisto e un crollo di quelli di vendita. Questi inconvenienti, che si rivelarono insanabili per un’organizzazione marittima e commerciale non più all’altezza dei tempi, superavano nettamente, nel bilancio costi-benefici del mercante-armatore (nel caso veneziano le due figure generalmente coincidevano), il pur considerevole vantaggio della sicurezza e dei conseguenti bassi premi di assicurazione (46).
Il sistema, nella sua configurazione originaria, prevedeva il raduno delle navi mercantili a Corfù, dal cui porto, base della flotta militare, esse avrebbero dovuto salpare due volte l’anno (a febbraio e a luglio), scortate da due unità da guerra. Meta dell’intero convoglio era Smirne: lì, esso si divideva in due gruppi, uno dei quali proseguiva, senza difesa, verso Costantinopoli, in acque ormai tranquille; l’altro, invece, continuava a viaggiare scortato in direzione di Alessandria, Siria e Cipro, lungo una rotta che era la più esposta agli attacchi dei pirati barbareschi. Al ritorno, che avveniva non prima di due mesi, si ricostituiva il convoglio, ripercorrendo in senso inverso l’itinerario ora descritto, fino alle «porte dell’Adriatico» (Corfù e le isole Ionie) (47).
L’assenza, già nel 1676, di convogli per la parte di Ponente, sia basso (Messina, Palermo, Napoli, Livorno, Genova e Marsiglia) che alto (Spagna mediterranea ed Europa nord-occidentale), la dice lunga sulle condizioni della marina mercantile veneziana dell’epoca.
Nel 1721, alla ripresa di fatto del sistema (talmente inviso agli operatori della piazza da indurre a cancellare la parola «convogli» dal lessico ufficiale e a ricorrere ad eufemismi, come «unioni di navi scortate», che tradivano comunque la vera essenza del fenomeno), non soltanto non era cambiato nulla nei traffici di Ponente che potesse giustificarne l’istituzione, ma perfino il convoglio di Levante venne limitato alla direttrice Smirne-Costantinopoli, tagliando il più rischioso tratto nord-africano e cipriota, sul quale nessun legno osava più avventurarsi esibendo il vessillo di San Marco. Sulle rotte indifese di Ponente e di Barberia, le navi veneziane dovevano alzare la bandiera di Francia per eludere l’insidia corsara: nel 1722 se ne contarono 22 delle 44 di cui era composta l’intera flotta (48).
Dopo qualche anno di stentata sopravvivenza, andò progressivamente esaurendosi anche questo secondo ciclo di navigazione in convogli: un sistema teoricamente obbligato e tuttavia ampiamente eluso da mercanti e armatori con i pretesti più vari, tanto che le navi effettivamente coinvolte non furono mai più di 3 o 4 per viaggio; una riproposizione inutile, che non aggiunse niente di nuovo alla prima esperienza, se non la conferma dell’irriducibile ostilità del ceto imprenditoriale.
Per la classe di governo, non c’era che un insegnamento da trarre: il problema della sicurezza doveva essere affrontato e risolto contestualmente alle altre cause che stavano alla base dell’inarrestabile declino marittimo della Serenissima.
Neppure un’altra categoria di provvedimenti, quali l’istituzione e l’intensificazione di misure protezionistiche, dai circoli mercantili e armatoriali veneziani ben diversamente apprezzate, poteva invertire la lunga tendenza depressionaria dei traffici.
Il paradosso stava nel fatto che politiche esclusiviste e trattamenti preferenziali, spesso superflui nell’era del monopolio marittimo, mostravano di non funzionare proprio nel momento del bisogno. In effetti, Venezia non poteva più permettersi di fare a meno del concorso degli operatori stranieri, che non solo non dovevano essere ostacolati con pratiche vessatorie, ma andavano accolti e incoraggiati senza preclusioni.
Del resto, la presenza di mercanti e armatori greci, tedeschi, inglesi, olandesi, armeni ed ebrei era una realtà ormai riconosciuta della piazza realtina (49) e contribuiva, con l’apporto determinante dei nuovi gruppi capitalistici locali, a compensare almeno in parte la rinuncia del vecchio ceto aristocratico.
Il modello allora imperante nelle relazioni internazionali era però quello ultramercantilistico dei Narigation Acts e occorre riconoscere che non era facile, per una potenza non più di primo piano ma ancora gelosa della propria sovranità, rassegnarsi a concessioni unilaterali.
Tuttavia, tra la rinuncia liberistica a un ruolo autonomo nell’economia europea e la meschina riproposizione di misure inutilmente discriminatorie, c’era ampio spazio per una politica realisticamente disposta ad aprirsi sul piano commerciale e contestualmente decisa a rilanciare la propria presenza sul mare in termini strutturali (dimensioni e composizione della flotta), organizzativi (rappresentanze consolari all’estero) e funzionali (aggiornamento tecnico e professionale).
Non era con il divieto di caricare uve passe a Zante e Cefalonia o con il raddoppio del dazio di uscita dei frumenti dalla Morea (finché rimase veneziana) che si potevano costringere le navi straniere a venire in laguna e non era con la riconferma dei privilegi di anzianità (preferenza di carico negli scali dello stato) che si poteva salvare la bandiera nazionale, come indulgevano a pensare non soltanto i gruppi direttamente interessati, ma anche i massimi organi istituzionali (50).
I dazi, strumento fondamentale delle politiche protezionistiche, non erano più utilizzabili per promuovere lo sviluppo dei traffici propri attraverso ulteriori vessazioni di quelli altrui, in una fase in cui la stessa fiscalità ordinaria veniva posta radicalmente sotto accusa.
Nel 1733, i cinque savi prendevano atto con viva preoccupazione che il movimento portuale si era ridotto a «quanto abbisogna per il nostro consumo, e non per il consumo di tutto lo stato, ma poco più che per la sola Dominante» (51). Nella visione di questa magistratura la stessa dimensione regionale, che lo scalo lagunare era andato assumendo tra Sei e Settecento, era messa in discussione dalla trionfale concorrenza dei porti franchi. Ma la severa condanna del regime protezionistico, che periodicamente si alzava dalle istituzioni veneziane, non contribuiva a risolvere il problema più di quanto non facesse la fiducia nelle sue virtù taumaturgiche. Al punto in cui si era arrivati, non esisteva più alcun margine per cullarsi in facili illusioni, occorrevano provvedimenti incisivi, realistici e complessivi.
La riforma del 1736
Il nuovo indirizzo maturò alla metà degli anni Trenta, sulla base della consapevolezza della necessità di far convergere le risposte settoriali in un progetto unitario. Nella delibera senatoria del 21 luglio 1736, che raccolse gli studi e le proposte delle magistrature competenti, il tentativo di uscita dalla crisi venne affidato a un nuovo tipo di imbarcazione: le navi atte.
Con la loro realizzazione avrebbero trovato soluzione unitaria: 1) le esigenze di sostegno alle costruzioni navali, attraverso l’impiego gratuito, per tre mesi, delle maestranze dell’Arsenale e l’assegnazione di 200 roveri a prezzo di favore; 2) il bisogno di conferire maggiore sicurezza alla navigazione, attraverso il prestito gratuito dei cannoni, la fornitura a tariffa ridotta della polvere da sparo e la copertura a carico dello stato di una parte del costo della milizia; 3) gli obiettivi di liberalizzazione tariffaria, attraverso misure a favore della bandiera nazionale, quali l’esenzione della metà del dazio d’uscita per le merci destinate al Levante e totale per quelle dirette al Ponente, la riduzione del 15 per cento del dazio d’entrata per le importazioni dal Levante e del 50 per quelle dal Ponente alto, l’abbuono del 15 per cento sui dazi di carico/scarico delle merci, di sosta delle navi in dogana e sui diritti consolari di Smirne e Costantinopoli (52).
Le navi atte – lunghe più di 24 metri ed equipaggiate con almeno 40 marinai e 24 cannoni – dovevano poter assolvere i compiti di autodifesa dagli attacchi corsari, viaggiare su ogni tipo di rotta (anche di Ponente e di Barberia) e recuperare competitività grazie ai privilegi fiscali e finanziari ad esse riservate e ai minori costi di assicurazione che sarebbero derivati dalla loro idoneità al combattimento.
La realtà si rivelò forse inferiore alle attese, ma sicuramente non mancò qualche buon risultato. Affrancata dal peso dei convogli, la marina mercantile veneziana riprese a navigare, in piena autonomia, sui mari di Levante e di Ponente, riaffacciandosi al di là di Gibilterra. Pur con qualche problema, relativo alla scarsità di maestranze, di legname e di artiglierie, la costruzione di navi dai requisiti richiesti si avviò in modo promettente (Tab. 1).
Nel periodo tra il 1736 e il 1744 furono fabbricate o acquistate 37 navi(53) che, sommate alle 30 sopravvissute alle insidie dell’età, dei naufragi e dei pirati e alle 17 imbarcazioni minori (polacche, gazzelle, caicchi, fregadoni e marciliane), portarono a 84 la consistenza totale della flotta mercantile (54). Le navi da punta complessivamente intese (atte e non) erano dunque 67: 14 in più rispetto a prima. Due anni dopo (nel 1746) ne erano in servizio 68, ma più che il totale delle navi da punta, che aumentava di una sola unità, cresceva vistosamente la quota di navi atte (da 23 a 31), segnalando un notevole successo della riforma nel suo primo decennio di applicazione.
Delle opportunità offerte dai nuovi provvedimenti trassero beneficio, quindi, quegli operatori che erano disposti a spostare sulla media-lunga distanza i confini della propria iniziativa, costruendo e utilizzando il nuovo tipo di nave mercantile armata (sussidiata e privilegiata).
Demetrio Perulli, armatore-mercante tra i più intraprendenti della piazza realtina, appaltatore del partito dei sali di Santa Maura, decise nel 1737 di investire una parte dei suoi capitali nel traffico di Ponente. Per questo rinunciò a costruire due marciliane – che avevano poco da invidiare a parecchie navi quanto a portata (400 botti = 320 tonnellate) e dimensioni (75 piedi =26 metri) previste, ma, disponendo di «poca o niuna difesa», non avrebbero potuto intraprendere «quei viaggi che sono permessi alle navi di maggior rango» – e optò, fatti i debiti conti, per una nave atta.
Tre anni dopo, la deputazione al commercio lodò pubblicamente l’imprenditore greco-veneziano per aver egli già «spedito una nave in Amsterdam» e un’altra ad Amburgo e per averne un’altra ancora, quella appena costruita, in procinto di partire per Londra con un carico di olio e uva passa. Per ogni eventualità, Demetrio Perulli procurò di conservare per sé e per il figlio Spiridione l’appalto del sale sulla più modesta ma famigliare rotta Venezia-isole Ionie (55).
A questo rinnovato fervore di iniziative e ai positivi risultati raggiunti avevano concorso, tuttavia, non soltanto la riforma del 1736, ma anche una congiuntura internazionale eccezionalmente favorevole per la bandiera di San Marco, la cui neutralità traeva profitto dalla guerra di successione austriaca. Entrambi i fattori ebbero la loro importanza, ma decisivo fu senz’altro il secondo. Con la conclusione del conflitto, nel 1748, si posero infatti le condizioni per la fine del boom del commercio marittimo veneziano e il suo ritorno ai più modesti livelli dei tempi di pace.
Per avviare e consolidare la tendenza recessiva fu però necessario un ulteriore elemento: la rinnovata aggressività dei pirati algerini, tunisini, tripolini, dulcignotti e candiotti, i quali presero ad affrontare le navi atte non più con singole imbarcazioni, ma con flottiglie veloci e agguerrite. Insomma, alla metà del secolo, erano già ricomparse sulle acque del mare interno sia le flotte mercantili europee che le squadre corsare, alle cui diverse imprese (traffici e scorrerie) il ritorno della pace riapriva immediatamente il campo.
Dalla riconferma del carattere strutturale della crisi (e, per converso, del carattere occasionale dei periodi di ripresa) non venne al governo veneziano uno stimolo a perfezionare i provvedimenti del 1736, bensì ad affossarli. I loro difetti (che il ceto imprenditoriale individuava nel costo del numeroso equipaggio e nel sacrificio imposto al carico mercantile dalle attrezzature militari e dall’organizzazione dello spazio di bordo ai fini dell’autodifesa) vennero ingigantiti fino a considerarli la causa determinante delle difficoltà del presente, con un evidente slittamento o riduzionismo nell’attribuzione delle responsabilità, ben radicate nella dinamica di lungo periodo dell’economia marittima veneziana (56).
Nel giugno 1751, alle navi (atte e non) dirette ad Alessandria, Siria e Cipro fu assegnata la scorta di due unità da guerra, riesumando così la fallimentare esperienza dei convogli. Nel settembre dello stesso anno il sistema fu anche formalmente ristabilito, tra le proteste di mercanti e armatori, che ottennero dopo qualche mese (aprile 1752) il ripristino dell’esenzione delle navi atte, secondo i privilegi accordati nel 1736. L’indecisione degli organi di governo incoraggiava il malcontento degli operatori marittimi e viceversa, in una spirale apparentemente senza sbocco.
Il ritorno ai convogli non poteva non confermarsi deleterio per il commercio veneziano, mentre l’incertezza politica non incoraggiava i circoli imprenditoriali a percorrere con la convinzione necessaria l’unica alternativa realmente praticabile: quella indicata dalla riforma. Stretta tra il rifiuto drastico dei convogli e la paralizzante sfiducia nelle navi atte, la marina mercantile veneziana imboccò la via del vantaggio immediato, del più miope opportunismo e anche, in senso proprio, del piccolo cabotaggio, disperdendosi sulle rotte più disparate pur di sfuggire alle insidie corsare e, soprattutto, alle proprie responsabilità.
Mercanti e armatori della piazza realtina non si risolvevano a prendere atto che, in uno scenario mediterraneo, europeo e mondiale di dura concorrenza tra una pluralità di centri marittimi, non era più possibile (se mai lo fu) fare completo affidamento sul sostegno dello stato – che pure a Venezia non mancò mai –, non tanto a motivo della sua ormai cronica irresolutezza e scarsa incisività, quanto perché era necessario uscire dall’inerte attesa di sovvenzioni e privilegi e assumersi la propria parte di responsabilità nelle scelte d’investimento, nella gestione d’esercizio e nelle decisioni strategiche dell’attività marittimo-commerciale: in breve, occorreva farsi carico di una quota almeno del rischio d’impresa, affrancandosi dalla logica senza prospettive della tutela e dell’assistenzialismo.
La svolta degli anni Cinquanta-Sessanta: restaurazione doganale e pace con i Barbareschi
La liberalizzazione tariffaria e l’istituzione di navi mercantili capaci di autodifesa, che costituivano il fulcro dei provvedimenti del 1736, vennero sottoposte a una profonda revisione nel corso degli anni Cinquanta, per rispondere alla crisi insorta nel commercio marittimo veneziano con la fine della guerra di successione austriaca e con la ripresa in grande stile della guerra da corsa.
La riforma doganale del 1736, che pure restava strutturalmente protezionistica in quanto i notevoli abbattimenti fiscali si rivolgevano alla bandiera nazionale e soprattutto alle navi atte di cui si voleva promuovere l’adozione, venne criticata perché colpiva l’Erario senza migliorare il movimento portuale. Si ripeteva, settant’anni dopo, lo stesso tipo di analisi che portò alla soppressione del primo cosiddetto «portofranco» (1662-1684) – il secondo era, appunto, sempre per «comune e volgar» modo di dire, quello del 1736-1751.
La regolazione del 6 novembre 1751, che entrò in vigore quasi un anno dopo (57), si proponeva di ristabilire le rendite del nuovo stallaggio (quella tra le Quattro dogane mercantili di Venezia adibita alle entrate via mare) suscettibili di non ostacolare il commercio marittimo e le esportazioni nazionali. La scure fiscale si abbatté così sui prodotti destinati ai consumi interni, vittime sacrificali del protezionismo commerciale e industriale e dell’eterna pregiudiziale anti-imposizione diretta della tutt’altro che disinteressata classe dirigente veneziana.
Al rischio che dazi tanto elevati favorissero il contrabbando per via di terra da Genova, Livorno, Ancona e Trieste, si rispose graduando le tariffe a seconda della distanza delle varie province dal più vicino tra quei porti franchi (dai quali Venezia si sentiva virtualmente assediata) (58).
Il tono protezionista venne dato, questa volta, da un aggravio del 10 per cento (considerato alternativo, e non aggiuntivo, al dazio specifico ordinario e perciò applicato come aliquota massima totale) su tutte le merci condotte a Venezia non direttamente da porti e da navi dei luoghi d’origine. Si trattava, peraltro, di una tipica misura di politica doganale discriminatoria ed esclusivista nell’era dei Navigation Acts.
Le serie storiche che qui siamo in grado di presentare, e che abbiamo ricavato da una pluralità di documenti contenuti nel fondo archivistico dei cinque savi alla mercanzia, non sembrano confermare interamente la diagnosi cui pervennero alla metà del secolo gli organi di governo della Serenissima.
Questi assegnavano alle politiche tariffarie un ruolo esorbitante nel determinare le diverse fortune del commercio marittimo. Ma proprio il caso veneziano dimostra con estrema chiarezza che non erano le presunte virtù taumaturgiche (o, al contrario, i difetti catastrofici) delle regolazioni doganali a muovere le congiunture, bensì, come sostiene Ugo Tucci, fattori esogeni di natura occasionale (guerra o pace in Europa, sicurezza o meno della navigazione).
Dalla Tab. 2 Rendita del nuovo stallaggio, si ricava che il gettito della dogana da mar cadde in media dai 103-104 mila ducati annui del decennio precedente la riforma del 1736 ai 59-60 mila del decennio successivo, per effetto della semiliberalizzazione del traffico nazionale e del suo maggior peso nel movimento complessivo della piazza (indicato dalla Tab. 3 Bandiere delle navi mercantili in partenza da Venezia, che mostra come la quota di bastimenti nazionali passò da circa la metà nel biennio 1735-1736 al 64 per cento nel periodo 1735-1748, con ulteriori minori entrate fiscali nonostante l’aumento dei traffici).
Nel 1746-1747, però, senza aspettare la nuova regolazione doganale, nella fase culminante della guerra europea, ci fu un vero e proprio boom del commercio e della marina nazionali, segnalato dall’impennata del nuovo stallaggio (che, nonostante il regime di semi-franchigia per la bandiera veneziana, risalì ai livelli pre-riforma (59)), dell’attività della flotta (che, con 223 partenze, raggiunse e superò il 66 per cento di quelle totali (60)) e della sua consistenza quantitativa e qualitativa (in quello che si può considerare il momento magico delle navi atte (61)).
D’altra parte, se è vero che la regolazione del 1751-1752 impedì da allora in poi(62) all’Erario di scendere ai livelli di sofferenza del periodo 1736-1746, essa non segnò per qualche tempo alcun progresso rispetto all’ultima fase (1746-1751) del regime doganale precedente. Per il resto degli anni Cinquanta si può anzi parlare di ristagno, se non di vera e propria flessione, del gettito doganale (63).
In realtà, il nuovo sistema tariffario, e in particolare l’inasprimento dei dazi di consumo che ne costituiva l’asse portante, determinò, innestandosi sugli elementi negativi esistenti (ritorno delle flotte europee, ripresa della guerra da corsa e crisi delle navi atte), una severa contrazione delle importazioni nazionali. Lo si vede bene dalla Tab. 4 Valori delle merci entrate e uscite dalle Quattro dogane di Vénezia: nuovo stallaggio (o intrada da mar), intrada da terra, uscita ordinaria (da terra e da mar) e fontico (per il traffico con la Germania).
La statistica non include le merci esenti da dazio, delle quali è disponibile soltanto una serie decennale (v. Tab. 5) che non è facile estendere – ci ha provato Giordano Campos – all’intero periodo (che copre oltre mezzo secolo, dal 1734-1735 al 1789-1790, dopodiché i registri doganali cominciano a fornire soltanto le quantità e non più anche i valori) (64).
La tabella 6 riporta quindi il movimento doganale complessivo, utile non soltanto in sé, ma anche per lo studio, che qui ci interessa, dell’ordine di grandezza e delle variazioni del commercio marittimo, perché la quota relativa (l’intero volume di entrata del nuovo stallaggio più le esportazioni marittime incluse nell’uscita ordinaria) è nettamente superiore a quella del commercio terrestre (intero volume dell’intrada da terra, esportazioni terrestri dell’uscita ordinaria e commercio di entrata e uscita del fontico).
Ebbene, il valore totale del traffico registrato dalle Quattro dogane mercantili di Venezia scese mediamente dagli oltre 15 milioni di ducati annui del periodo della semi-liberalizzazione (1736-1751) ai neppure 14 del periodo successivo (1752-1759), con una contrazione del 9 per cento. Ma la contrazione diventa vero e proprio tracollo (17 per cento) se del primo periodo si prende in considerazione soltanto l’ultima fase (1746-1751), caratterizzata da un volume di traffico prossimo ai 17 milioni di ducati all’anno.
Insomma, tra l’ultimo quinquennio del regime tariffario introdotto dalla riforma del 1736, caratterizzato dal boom del commercio marittimo veneziano, e la fase successiva alla regolazione del 1751-1752, segnata da una crisi quasi decennale sia nei volumi di traffico che nelle entrate fiscali, ci fu un passaggio non riducibile a semplici fattori tariffari. Sul ciclo espansivo 1746-1751 agirono in modo convergente gli effetti della guerra europea e della politica delle navi atte. Quest’ultima, in particolare, prolungò l’alta congiuntura di un biennio oltre il ritorno della pace, fino alla recessione del 1751.
Soltanto allorché fu del tutto evidente – sotto la sferza della guerra corsara – che il beneficio dell’autodifesa delle navi mercantili non compensava più il costo necessario per garantirla, ci si adattò a un orizzonte strategicamente più limitato, pensando a salvare almeno i dazi, senza rischiare i capitali. In questa ottica, la regolazione del 1751-1752 fu l’esito di una scelta rinunciataria sia del ceto politico che di quello imprenditoriale, entrambi rassegnati a un ruolo di secondo piano sulla scena del potere marittimo internazionale.
Tuttavia, l’inversione della congiuntura, segnalata dalla secca diminuzione del volume dei traffici, non consentì alla manovra tariffaria di riportare il gettito doganale ai livelli sperati – che per il nuovo stallaggio non potevano non superare i 100 mila ducati, come in epoca precedente alla riforma del 1736 –, in quanto la caduta dei consumi interni, sommandosi alle crescenti difficoltà della marina mercantile veneziana per il ritorno della concorrenza e della pirateria, vanificò i benefici derivanti al fisco dall’aumento dei dazi. A questo punto, non restava altro da fare che dirimere, con la guerra o con la pace, la questione barbaresca.
Sulla congruità delle due soluzioni si fronteggiavano, da molto tempo, due opposti partiti, l’uno preoccupato di far valere le ragioni del prestigio e della fermezza nella condotta internazionale, e perciò propenso all’azione militare, l’altro più pragmaticamente disposto ad affidarsi allo strumento della trattativa. La divergenza non verteva soltanto sui mezzi giudicati più idonei per far cessare l’offesa, ma investiva l’analisi del fenomeno corsaro, nel quale i fautori della via negoziale vedevano l’espressione della disperata miseria di intere popolazioni e non una «costituzionale scelleratezza» da affrontare con «misure di polizia» (65).
La tradizionale capacità di lettura dei fenomeni internazionali, il realismo politico e gli interessi economici del ceto dominante veneziano, in un quadro strategico di ferma neutralità, non potevano non far pendere la bilancia decisamente sull’opzione diplomatica.
Il primo approccio con le reggenze barbaresche venne tentato nel 1753, ma fallì più per l’interessata opposizione degli stati cristiani (Spagna, Santa Sede, Toscana, Regno di Napoli e Francia) che per le pretese della controparte. I contatti vennero ripresi nel 1761, in un quadro internazionale più propizio, e, dopo laboriose e sempre incerte trattative, si conclusero positivamente tra il 1763 e il 1765 con gli accordi di Tunisi, Algeri, Tripoli e Marocco.
In cambio di gravose indennità annue (dai 15 ai 50 mila zecchini) alle varie reggenze barbaresche, Venezia ottenne esenzioni doganali, riconoscimenti giurisdizionali e rispetto della bandiera (la sospirata sicurezza di navigazione).
Come c’era da aspettarsi, la pace non fu così solida da impedire lo scoppio di periodici incidenti, se non di vere e proprie crisi. In occasione della più grave tra queste, nel 1784, la Repubblica sperimentò, con Angelo Emo, l’estrema illusione di vincere la pirateria con una «dimostrazione navale» anziché con misure diplomatiche, pur consegnando alla storia la sua ultima impresa militare, simboleggiata dal fuoco delle batterie galleggianti veneziane contro Tunisi e gli altri centri corsari (66).
Le risposte alla crisi: la qualificazione tecnico-professionale degli uomini di mare
Quando i Veneziani, negli anni Settanta del XVII secolo, raggiunsero la sofferta consapevolezza del carattere non congiunturale della crisi del proprio ruolo marittimo, uno dei primi aspetti ad essere preso in considerazione fu quello dell’istruzione tecnico-professionale dei quadri della flotta.
A quel tempo, la «rendita di posizione» della nautica mediterranea, e veneziana in particolare, che continuava ad esercitarsi sulle famigliari rotte levantine con i metodi e gli strumenti ereditati dai secoli del basso medioevo (bussola, quadrante, astrolabio e balestriglia), appariva ampiamente erosa dai progressi tecnico-scientifici conseguiti da quella atlantica nella dura lotta per l’egemonia su scala mondiale. Il loro grado di precisione era ormai tale che nello stesso mare interno, quanto meno nella sua parte occidentale, non si poteva più prescinderne (67).
Nel 1667 l’Arsenale aveva iniziato a costruire navi a quattro alberi – il nuovo tipo di imbarcazione scaturito dall’evoluzione tecnica dei secoli XVI e XVII – destinate ad affiancarsi alle unità minori (marciliane, tartane, polacche, trabaccoli, pieleghi, checchie) e, soprattutto, alle vecchie galere cui Venezia non volle mai rinunciare, almeno per quanto riguarda l’Armata.
Ma non bastava aggiungere navi di linea alla flotta mercantile: occorreva disporre di capitani e piloti in grado di condurle sulle rotte di Ponente, lontano dai tanti punti di riferimento costieri o insulari dell’Adriatico, dello Ionio e dell’Egeo che consentivano di attardarsi in una sorta di cabotaggio permanente e perfino di trascurare le nuove tecniche di navigazione astronomica.
Per determinare la posizione (latitudine e longitudine) della nave nei lunghi viaggi d’alto mare, negli ampi spazi ove l’esperienza non poteva surrogare la preparazione tecnico-professionale dei comandanti, era necessario saper utilizzare i nuovi strumenti forgiati dalla nautica europea del versante atlantico: il doppio quadrante, o quadrante di Davis, per misurare l’altezza del sole a mezzogiorno; la carta piana, o di Mercatore, per tener conto della curvatura della terra; le tavole di declinazione magnetica, per conoscere gli scarti tra meridiana e ago della bussola; le tavole nautiche, per avere l’esatta indicazione delle distanze, delle maree, delle meridiane ecc., con appendici logaritmiche e trigonometriche (68).
Nel contrastato clima di nuove opportunità offerte dalla fine della guerra di Candia e di crescenti difficoltà prodotte dalla concorrenza europea, Venezia si decise ad aprire il capitolo della qualificazione tecnica e professionale della propria marina.
Il problema non era più circoscrivibile alla formazione dei giovani aristocratici destinati alla carriera marittima, come si era fatto nella prima metà del secolo con l’istituzione di un corso di nautica all’interno dell’Accademia dei nobili alla Giudecca. Sorta nel 1619, questa scuola era riservata ai figli della nobiltà povera di età compresa tra dieci e diciotto anni, poi portati a venti.
La legislazione marittima veneziana assegnava il comando delle unità dell’armata a due nobili, ai quali, dopo quattro anni di servizio, veniva attribuita la carica di sopracomito. Con l’andare del tempo, sempre meno erano i giovani patrizi disposti a prendere la via del mare, tanto che, dopo la pace di Passarowitz (1718), le navi veneziane furono esonerate dall’obbligo di reclutarli. Ma, all’inizio del Seicento, la mancanza di conoscenze teoriche nelle più alte cariche di bordo doveva apparire grave rispetto alle esigenze dei tempi e imbarazzante nei confronti degli ufficiali di rango inferiore (comito, padrone, pilota, ecc.).
Per porre rimedio a questi inconvenienti, si inserì nel programma dell’Accademia, oltre all’istruzione di base (leggere, scrivere e far di conto) e all’educazione umanistica (lettere, retorica e filosofia), anche lo studio di alcuni elementi della scienza nautica. Queste nozioni, tuttavia, non andavano molto al di là della tradizionale «carta da navigar».
Fornita di una fitta rete di raggi e di rombi, essa permetteva di stabilire la giusta direzione, attraverso l’uso della bussola, e di determinare la distanza tra due porti, attraverso l’uso del righello e del compasso (69). Assieme alla bussola, la carta nautica fu alla base della rivoluzione tecnica medievale. I due strumenti erano strettamente collegati: «per seguire, valendosi della bussola, la rotta che congiungeva due punti, la carta sulla quale essi erano stati determinati in base a rilevazioni fatte con tale strumento serviva nel modo migliore» (70). L’affermarsi della navigazione astronomica arricchì la cartografia marittima di nuovi segni convenzionali, come i meridiani e i paralleli, che permettevano di determinare la posizione della nave. Ma nel Mediterraneo, e specialmente a Venezia, le carte «levate alla bussola» continuarono ad essere preferite fino all’aprirsi del XVIII secolo (71).
Il governo veneziano era ancora convinto che l’abilitazione alle funzioni di comando dovesse venire più dall’esperienza diretta che da un serio e aggiornato percorso formativo. I principali limiti di questo primo tentativo di istruzione nautica risiedevano perciò nel carattere particolarmente ristretto dell’utenza e nel rigido conservatorismo del progetto educativo. Attivato nel 1635 con l’incarico al capitano Francesco Natta, il corso all’interno dell’Accademia si interruppe con la morte del maestro nel 1654. Fu ripreso un secolo più tardi, nel 1750, dal capitano Giovanni Siron, che lo prestò fino al 1766 nel tempo (due giorni la settimana) che gli lasciava libero la Scuola nautica di recente istituzione (72).
Anche il nuovo ciclo di insegnamento in Accademia fu impostato secondo un indirizzo eminentemente pratico, con le consuete applicazioni tecniche sulla bussola, sulla carta geografica, sulla manovra, sulla segnaletica e sulle costruzioni navali, con il supporto di elementari nozioni di geometria, trigonometria e sfera, «applicate pur queste all’uso della navigazione pratica» (73).
Questa scelta confermava, a metà Settecento, l’estemporanea propensione veneziana a un’istruzione tecnico-professionale spoglia di ogni finalità formativa e di ogni contenuto scientifico, nella rassegnata convinzione che la «nuda teoria» fosse ormai inutile per la marina nazionale, «rarissimo essendo il caso d’esercitarla» (74).
Nel 1782, il riordinamento dell’Accademia portò, nel quadro di un generale riflusso conservatore, all’eliminazione di ogni spunto utilitario e antiretorico nel progetto educativo e alla conseguente soppressione della cattedra di nautica (75).
Finiva così, assieme ai pur cauti tentativi di riforma che agitarono la società e lo stato veneziano nella seconda metà del Settecento anche in materia scolastica (76), l’esperienza di un corso di formazione professionale all’interno di un collegio per giovani aristocratici. Del resto, la figura del patrizio veneziano mercante e navigatore non esisteva più da tempo: non a caso, pur lasciando meno spazio agli individui che ai movimenti reali, senza trascurare il ruolo dei diversi gruppi sociali, specialmente della nobiltà, nelle vicende economiche, la nostra storia (quella che stiamo scrivendo) è praticamente muta sull’argomento. L’antico ceto dominante, già prima che iniziasse l’ultimo secolo di vita della Repubblica, aveva ormai cancellato la carriera marittima dal proprio orizzonte economico, culturale ed esistenziale.
Negli anni immediatamente successivi alla guerra di Candia, quando Venezia dovette aprire gli occhi sul carattere strutturale del proprio declino marittimo e tentare di rispondervi a partire dal punto della riqualificazione tecnico-professionale della flotta, la questione non poteva più essere riproposta nei troppo angusti limiti (sia sociali che educativi) del corso di nautica in Accademia.
Se il problema della formazione e dell’avviamento professionale dei giovani aristocratici stava risolvendosi per autoconsunzione, così non era per l’ufficialità di bordo e la marinarezza nel suo insieme. Per rimediare alla pratica, a seconda dei casi indecorosa o pericolosa, di ricorrere a piloti stranieri o inesperti, occorreva aprire «una scuola per istruir li sudditi nell’arte del navigare» (77). Con questa secca dichiarazione d’intenti, il senato apriva nel gennaio del 1672 un capitolo lungo e tormentato, che si realizzerà soltanto a Settecento assai inoltrato: quello dell’istituzione di una vera e propria Scuola nautica nella Serenissima. Un capitolo emblematico del profondo divario esistente a Venezia tra astratta volontà politica e reale capacità operativa.
L’idea del magistrato all’armar, incaricato con il reggimento all’Arsenal di eseguire la delibera di massima, fu di articolare la Scuola in due sezioni, una nella Dominante, con due maestri, l’altra nel Levante suddito, con uno (78). Ma l’iniziativa non venne dagli organi di governo, bensì da un fiammingo residente a Venezia, Giovanni Clare, che si offrì, nel 1673, di «ritrovar due soggetti di paese estero, peritissimi in tal professione», da utilizzare come maestri sotto la sua personale supervisione (79).
Il programma educativo restava ancorato alla nautica tradizionale e ai suoi strumenti canonici: bussola, carta da navigar, compasso e balestriglia. Tuttavia, il progetto del fiammingo non fallì per i suoi limiti intrinseci – non contemplava, tra l’altro, che una sola sezione, quella centrale –, quanto piuttosto per i problemi di copertura delle spese d’esercizio (pur rigidamente circoscritte ai soli aspetti retributivi degli insegnanti e del soprintendente). Approvato dal senato nel settembre 1680, non poté realizzarsi per l’impossibilità di avvalersi dei fondi della Scuola di S. Nicolò de’ marinari, l’istituto di assistenza e previdenza degli uomini di mare, che era stato indicato come ente finanziatore e che risultava invece appena in grado di sostenere le proprie spese.
Non era ancora maturo il concetto che vede la scuola come servizio pubblico di interesse generale, da finanziare con imposte pagate da tutti in rapporto alla personale capacità contributiva, a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio stesso. Si insisteva in una visione dell’istruzione come servizio per i diretti interessati, che dovevano perciò sopportarne (come categoria) l’intero peso economico. Se, dunque, il tentativo di collegare il funzionamento della Scuola nautica ai contributi della fraglia dei marinai è storicamente comprensibile, meno logica appare l’insistenza del governo veneziano su una soluzione rivelatasi subito impraticabile (80).
L’interesse per la formazione tecnico-professionale della gente di mare si riaccese nei primi anni del Settecento, inducendo il senato a rinnovare l’ordine di erezione della Scuola nautica, ma l’unico risultato del nuovo decreto fu la riforma della confraternita di S. Nicolò, considerata propedeutica a quell’istituzione (81). Essa venne attuata tra il 1704 e il 1710 con l’apertura dell’ingresso (dapprima riservato) e il risanamento amministrativo dell’ente. Il suo bilancio dava ora un avanzo di circa 400 ducati annui, sufficiente a retribuire uno solo dei tre maestri: per la necessaria integrazione finanziaria si contava sul... «mecenatismo del senato» (82).
Con l’attenuarsi delle difficoltà economiche vennero in primo piano i problemi didattico-organizzativi, a partire dal reclutamento degli insegnanti. Trovare a Venezia tre soggetti che unissero la conoscenza teorica all’esperienza pratica non era facile, per gli stessi motivi per cui si voleva istituire la Scuola nautica: la bassa qualificazione di capitani e piloti. Il senato, che non ignorava il problema, ordinò di estendere «alla parte di Ponente» la ricerca dei maestri e mobilitò in tal senso gli ambasciatori veneti in Olanda e Inghilterra (83). Dieci anni dopo, nel 1720, la questione del reclutamento degli insegnanti era ancora aperta e nemmeno la decisione di affiancare i riformatori dello Studio di Padova al magistrato all’armar risultò efficace, anche se coinvolse in modo valido e duraturo quella magistratura universitaria nella gestione educativa della Scuola nautica (84). Passarono così altri vent’anni di tentativi fiacchi e inconcludenti, durante i quali, peraltro, venne aperta la sezione distaccata di Corfù.
Ultima base marittima dopo la perdita di Candia, la maggiore delle isole Ionie ospitava nel suo porto fortificato la flotta militare veneziana e costituiva perciò la sede naturale della Scuola nautica nel Levante. Affidata nel 1734 al maestro Francesco Bronza, esperto capitano perastino al servizio della Repubblica, funzionò ininterrottamente fino al 1748 (85).
La situazione si sbloccò nella Dominante soltanto alla fine degli anni Trenta, con la nomina a maestro del capitano Giovanni Siron e con l’entrata in scena del ceto mercantile.
Nato a Venezia, Siron aveva svolto un lungo tirocinio sui mari di Ponente alto, compiendo anche diverse traversate atlantiche. Nel 1739, al momento dell’incarico, era capitano di rispetto della marina di San Marco (86).
I capi di piazza, da parte loro, non si limitarono a fornire, come di consueto, informazioni e pareri ai magistrati competenti, ma presero in mano l’intero progetto, condizionandone l’indirizzo. Erano disposti a finanziare una sorta di contratto quadriennale di formazione-lavoro, concepito come fase intermedia tra un corso di studi biennale e l’avviamento al mestiere. Ai giovani allievi offrivano una modesta retribuzione mensile e l’opportunità (condivisa con il proprietario della nave) di confermare o sciogliere il rapporto di apprendistato, che, nella prima ipotesi, si sarebbe trasformato in un normale rapporto di lavoro. L’obiettivo era di soddisfare, nel giro di sei anni, le esigenze di riqualificazione della marina veneziana, affrancandola dalla necessità di ricorrere a piloti stranieri al di là di Gibilterra (87).
Questa impostazione si scontrò con il progetto educativo preesistente, elaborato dai riformatori dello Studio di Padova e dai professori di quella Università, in particolare da Giovanni Poleni, che proponeva un insegnamento fortemente caratterizzato in senso scientifico e, coerentemente, indicava come maestro il matematico Bernardino Zendrini, che tuttavia rifiutò per i troppi impegni (88).
Vinsero i rappresentanti del ceto mercantile e ne risultò un tipo di scuola destinato all’istruzione professionale dei figli della gente del mestiere, ai quali si assicurava, come nel comune garzonato, il mantenimento nella fase del tirocinio e l’assunzione in qualità di pilota della nave previa approvazione del maestro e del capitano: una scuola chiusa, pertanto, a chi avesse voluto intraprendere la carriera marittima per esclusiva inclinazione personale.
A un’ipotesi formativa di livello superiore qual era il progetto dei circoli accademici padovani, pur criticabile per la scissione tra teoria e pratica nel processo educativo, si preferì quindi un indirizzo tecnico-professionale che si giudicava sufficiente a coprire le ormai modeste esigenze della marina veneziana, senza alcuna intenzione o velleità di rilancio.
Sicuramente pubblica sotto il profilo della gestione (direzione e controllo spettavano ai riformatori), la Scuola nautica si presentava altrettanto indiscutibilmente privata, o meglio particolare, sotto quello dell’utenza, nel senso che era strettamente riservata ai figli dei capitani e dei marinai sudditi.
I caratteri ad essa imposti – numero chiuso (18 studenti), tempo pieno, elevato carico di studio, duro tirocinio, forte selettività – riflettevano la decisa volontà dei riformatori di garantire una preparazione seria ed accurata.
I capi di piazza intervenivano innanzitutto nella fase del reclutamento degli allievi (ne accertavano la capacità di leggere, scrivere e far di conto e valutavano i servizi prestati dai loro genitori all’ombra della bandiera nazionale). Come nella generalità delle istituzioni economiche e sociali del tempo, anche nella Scuola nautica, accanto a embrionali criteri di merito (una rudimentale alfabetizzazione), permanevano nei criteri di accesso le consuete logiche corporative volte ad assicurare la trasmissione del mestiere per via parentale.
Il coinvolgimento dei rappresentanti del ceto mercantile era particolarmente intenso nell’organizzazione e nel finanziamento del tirocinio, che si presentava come la fase decisiva del processo di formazione professionale e di avviamento al mestiere.
Anche nel momento conclusivo dell’intero iter scolastico, i capi di piazza giocavano un ruolo importante, nominando i quattro capitani destinati ad affiancare il maestro nella commissione d’esame.
Al centro del complesso sistema formativo stava però il capitano-maestro. Durante il primo ciclo, egli insegnava nautica tutti i giorni della settimana escluso il giovedì e tutti i mesi dell’anno esclusi quindici giorni in ottobre. Considerato il basso livello di partenza degli allievi, l’insegnamento non poteva essere propriamente scientifico e doveva basarsi più sull’acquisizione di tecniche strumentali che di concetti matematici.
Durante il secondo ciclo, quello del tirocinio a bordo delle navi, il maestro manteneva un legame periodico con i giovani cadetti, poi sottopiloti. Questo rapporto era mediato dai diari, o giornali di bordo, che essi erano tenuti a compilare durante i viaggi in mare e che riguardavano sia la navigazione che l’approdo nei porti, con le annotazioni e le rilevazioni espressamente previste dal regolamento (89).
Alla fine del quadriennio di navigazione, il maestro contribuiva ad accertare, in sede d’esame, la qualificazione professionale dei giovani allievi, abilitandoli al ruolo di piloti della flotta veneziana.
Così come impostata, la Scuola nautica di Riva degli Schiavoni funzionò senza inconvenienti e anzi con apprezzabili risultati dal 1739 al 1766, anno della morte di Giovanni Siron (90).
Dalle relazioni trimestrali del capitano-maestro apprendiamo che il corso iniziava con l’insegnamento dell’aritmetica, della geometria, della sfera, della trigonometria e dei logaritmi. Proseguiva con lo studio della navigazione e degli strumenti necessari alla determinazione della direzione e della posizione. In particolare, si imparava a determinare la longitudine e la latitudine, confrontando la stima di quest’ultima – ottenuta osservando l’altezza sull’orizzonte della stella polare o del sole a mezzogiorno – con il valore teorico calcolato sulle tavole. Il biennio si concludeva con lo studio teorico, accompagnato da applicazioni pratiche, del giornale di bordo (91).
Dai curricula professionali di ex allievi si ricava l’impressione che lo scopo per il quale la Scuola nautica venne istituita – un adeguamento del bagaglio tecnico dei quadri di comando della flotta veneziana – fosse sostanzialmente raggiunto. Aperta subito dopo l’avvio dell’esperienza delle navi atte – a bordo delle quali avveniva il tirocinio –, ne favorì il buon esito, mettendo a disposizione di mercanti e armatori uomini capaci di affrontare i viaggi di altura, come risulta dalle soddisfatte dichiarazioni degli stessi rappresentanti della piazza circa il buon numero e la perizia dei piloti abilitati.
I limiti dell’offerta educativa (chiusura corporativa degli accessi, inserimento e avvicendamento continuo di individui già occupati desiderosi di un qualche aggiornamento, carattere tecnico-professionale e assenza di finalità formative) riflettevano i limiti della domanda, che proveniva da un’organizzazione marittima orientata a coprire un ruolo internazionale di medio profilo, seppure, in quella fase di rinnovato slancio inaugurata dalla riforma del 1736 e proseguita fino ai primi anni Cinquanta, non ancora rassegnata alla dimensione regionale.
Nell’ultimo trentennio di vita della Repubblica, tra il 1767 e il 1797, Si avvicendarono sulla cattedra che era stata di Giovanni Siron due maestri inglesi: Arthur Edgcombe e il figlio Tommaso. Il primo aveva un lungo e solido curriculum di capitano nella flotta di Sua Maestà e di insegnante nella Scuola nautica di Portsmouth (92).
La scelta di un forestiero, suddito della potenza marittima allora più evoluta, non era dettata dall’ambizione di alzare il livello educativo della Scuola veneziana, quanto dall’esito negativo delle ricerche svolte in ambito nazionale. D’altra parte Edgcombe era, al pari di Siron, un capitano-maestro: in più, aveva precedenti didattici; in meno, la conoscenza della lingua.
E vero che in alcune scuole inglesi, come il Collegio navale di Portsmouth, si saldavano un indirizzo scientifico e una specializzazione professionale, tuttavia il carattere formativo risultava non soltanto dal collegamento tra studio teorico e applicazione pratica, ma anche dalla compresenza di una pluralità di materie (scienza nautica, inglese, francese, latino, musica, pittura, ballo, scherma) e di insegnanti (93).
Edgcombe non insegnava in quel Collegio, bensì in una scuola ad esclusivo indirizzo tecnico-scientifico, priva, forse quanto l’omologa istituzione veneziana, di larghe ambizioni educative e però, diversamente da quella, completamente autonoma dalla sfera professionale. Questo distacco gli consentiva una maggiore attenzione agli aspetti teorici rispetto a quelli pratici e un insegnamento rivolto più alla nautica come scienza che come mestiere. In riva alla laguna, ove apprendimento e tirocinio erano strettamente finalizzati al mercato del lavoro e gli imprenditori marittimi tendevano a gestire direttamente sia l’istruzione professionale che l’accesso al mestiere, il maestro inglese non poteva che ripercorrere le orme del suo predecessore veneziano in direzione di una scuola tecnico-professionale senza alcuna velleità scientifica e formativa.
Anche nel «periodo inglese» ci fu piena soddisfazione degli operatori marittimi e degli organi di governo per il funzionamento della Scuola nautica di Venezia. Una rilevazione delle condizioni professionali degli ex allievi nel 1781 (Tab. 7) evidenzia in effetti una ragguardevole disponibilità di ufficiali qualificati, sui quali la flotta veneziana poteva allora contare.
Tuttavia, il fatto che non più della metà del totale dei frequentanti (110 su 245) risultasse sicuramente introdotto ai vari livelli di carriera segnalava, nel periodo 1767-1781, uno squilibrio non trascurabile tra domanda e offerta di lavoro qualificato, in altre parole, uno spreco di risorse e, forse, una vera e propria disoccupazione o, meglio, un flusso di emigrazione di forza lavoro qualificata, di cui, appunto, non restava «nessuna indicazione» nei registri delle magistrature veneziane e dei rappresentanti del ceto mercantile-armatoriale.
Queste difficoltà confermano l’ipotesi di un trend negativo del commercio marittimo veneziano che, salvo un occasionale rialzo nel biennio 1779-1781, si prolungò fino agli ultimi anni di vita della Repubblica (Tab. 4), flettendo il movimento doganale complessivo dai circa 15 milioni di ducati del periodo delle navi atte (1736-1756) ai 13 e tre quarti di quello successivo (1772-1790).
Negli anni Ottanta, la struttura e la funzione della Scuola nautica si presentavano con caratteri ormai ben definiti, a seguito di alcune modifiche e adattamenti. La differenziazione stagionale dell’orario, con un ritorno dalle ore 20 alle 23 nei mesi non invernali, consentì di fare scuola serale all’aperto per osservare il cielo e apprendere l’uso degli strumenti di rilevazione astronomica. L’innalzamento dell’età di ingresso dai 12 ai 15 anni muoveva dalla considerazione che una scuola professionale degna di questo nome non poteva essere equiparata ad un semplice apprendistato.
Ma nella realtà dell’organizzazione marittima veneziana continuavano a pesare i tradizionali meccanismi di accesso al mestiere, basati essenzialmente sull’ereditarietà e sulla cooptazione, e perciò sull’avviamento al lavoro attraverso una precoce pratica di bordo che eludeva o limitava, deformandola, ogni ipotesi di scolarizzazione.
A causa di questi condizionamenti, e di quello derivante dalla stagionalità del lavoro marittimo, risultavano infatti compromesse sia la durata che la continuità della frequenza al corso di studi, e perfino l’effettuazione o il completamento del tirocinio, reso superfluo e comunque impedito dalla fretta di trovare lavoro.
Di conseguenza, la Scuola nautica tese a configurarsi come un centro di riqualificazione permanente: a un ristretto nucleo di giovani allievi, che seguivano gli studi con regolarità, si affiancarono folti gruppi di lavoratori, caratterizzati da notevoli discontinuità di frequenza ed eterogeneità di età e qualifica. Invece di un insegnamento unico per tutti, si imposero momenti diversi di studio e di applicazione pratica, con conseguente scissione del corso in due indirizzi: di «scienza e arte» e di «pura arte». Essi non costituivano gli stadi di un unico processo educativo, bensì percorsi distinti e separati, che implicavano fin dall’inizio scelte alternative (e definitive) da parte degli studenti (94).
Il processo di adattamento della Scuola nautica alla realtà (e ai limiti) dell’organizzazione marittima veneziana era difficilmente contrastabile, data la scarsa determinazione degli organi di governo nel perseguire coerentemente e fino in fondo gli obiettivi di riqualificazione da essi stessi proclamati e dato l’interesse dei ceti imprenditoriali a un aggiornamento eminentemente pratico della preparazione professionale dei marinai sudditi.
Questo esito attenuò il potenziale carattere di rottura del nuovo sistema di istruzione professionale rispetto alla tradizione corporativa dell’addestramento sul luogo di lavoro, ma non impedì che la Scuola nautica di Venezia funzionasse con continuità ed efficacia fino alla caduta della Repubblica, ed anche oltre, assolvendo egregiamente al compito fondamentale per il quale fu istituita: assicurare alla flotta veneziana quelle competenze tecniche e professionali capaci di affrancarla dai piloti stranieri sui mari di Ponente.
Il «Codice» per la veneta mercantile marina
Un’imponente operazione di raccolta, rielaborazione e coordinamento della sparsa, frammentaria e a volte contraddittoria legislazione marittima veneziana fu intrapresa in seguito alla delibera senatoria del 16 marzo 1748, che incaricava i cinque savi alla mercanzia e i provveditori all’armar di raccogliere in «una sola terminazione» tutta la normativa in materia (95).
Si partì, dunque, da un obiettivo di mera collezione di testi prodotti nel tempo da numerosi consigli e magistrature (senato, consiglio dei dieci, consoli dei mercanti, ufficiali al cattaver, patroni, provveditori e inquisitori all’Arsenal, provveditori sopra dazi, provveditori e sopraproweditori alla sanità, provveditori di comun ecc., oltre, naturalmente, ai due uffici sopra citati, che assommavano le principali competenze in materia marittima e commerciale), allo scopo di mettere a disposizione dei funzionari pubblici e degli operatori privati un testo unico di facile consultazione, che rendesse più spedita e meno incerta l’applicazione del diritto.
Il Codice che vide infine la luce quasi quarant’anni dopo – e precisamente il 21 settembre 1786 – fu, quindi, il risultato inizialmente non previsto di un processo lungo e complesso che si sviluppò per via empirica e in modo autonomo – come dice Giorgio Zordan, «le cose sarebbero maturate da sole» (96) –, partendo dall’esigenza in sé modesta – ma, evidentemente, suscettibile di complicarsi strada facendo – di approntare una raccolta cronologica di disposizioni legislative che coprivano un arco temporale amplissimo e perciò spesso ormai di difficile reperibilità. Un’operazione non facile, anche perché non poteva esimersi dal far valere, nella selezione dei testi, i necessari requisiti di «specialità e autonomia» propri del diritto marittimo (97).
In ogni modo, non c’è da stupirsi dei tempi così dilatati di maturazione del progetto, prima, e di sua esecuzione, poi, quando per la Scuola nautica – l’abbiamo appena visto occorsero settant’anni di gestazione e in altri casi avvenne più o meno lo stesso, a riprova di una costante della vita politico-istituzionale veneziana: la lentezza. Il bisogno di emulazione dei paesi esteri in ciò che appariva fattore di progresso si scontrava non solo con la tradizionale prudenza, ma anche con quella scarsa determinazione di cui abbiamo già avuto modo di parlare in questa stessa sede. Alla volontà politica, che in linea generale non ci sembra giusto disconoscere al ceto dominante veneziano, non corrispondeva una capacità realizzatrice, specialmente in quei settori ove mancava, o era venuto a mancare, come nel caso del commercio marittimo, un interesse diretto, non ideologico, come si era portati a fare idealizzando il passato, ma effettivo, capace cioè di tradursi in investimenti di risorse umane e di capitale.
Un precedente di scarsa o nulla rilevanza giuridica era stata la stesura, nel 1682-1683, dei Capitoli di regolazione della marina mercantile, che avevano finito per sovrapporsi, puramente e semplicemente, alla normativa esistente. Redatti sul modello colbertiano dell’ Ordonnance touchant la marine del 1681, i Capitoli segnalavano tuttavia un’altra costante della politica veneziana: l’estrema attenzione per le novità emergenti a livello internazionale e la convinta disponibilità a riprenderle, sperimentarle e adattarle alla propria realtà, per aggiornarla e razionalizzarla nel rispetto della tradizione (conservatorismo dinamico).
Si trattava di quello stesso pragmatismo che indusse nel 1748 il senato ad affidare la raccolta della legislazione marittimo-commerciale alle due più importanti magistrature di governo del settore, non all’ufficio specificamente preposto alla compilazione delle leggi (soprintendenti alla formazione del sommario delle leggi) (98). Anche in questa occasione, la vigile sensibilità veneziana alle nuove d’oltre confine – il Reale editto o sia regolamento per la navigazione de’ bastimenti mercantili, emanato a Napoli nel 1741, e l’Editto di marina e navigazione mercantile toscana, promulgato dal Granduca nello stesso 1748 – ebbe modo di giocare un ruolo importante nell’avvio dell’opera di raccolta e compilazione di un testo unico.
Ma, al di là degli impulsi esterni, il cui peso risulta pure così evidente, è la congiuntura marittima veneziana a dare un senso alla sequenza dei fenomeni, ricomponendoli in un quadro di relazioni storico-funzionali senza apparenti sfasature: riforma del 1736 e introduzione delle navi atte, Scuola nautica del 1739, ripresa marittimo-commerciale degli anni Quaranta, delibera di massima del 16 marzo 1748 per l’avvio della raccolta legislativa, fine della guerra di successione austriaca e delle ragioni occasionali del buon andamento dei traffici, recrudescenza della guerra corsara, restaurazione doganale del 1751, crisi del commercio marittimo negli anni Cinquanta-Sessanta, concomitante paralisi dei lavori di compilazione del testo unico, pace con i Barbareschi del 1765, immediata ripresa del commercio marittimo e dei lavori di raccolta legislativa.
La prima struttura ad essere chiamata in causa dal rinnovato impegno delle due magistrature centrali (cinque savi e provveditori all’armar) fu proprio l’organizzazione diplomatica. Richiesto di informare sulla normativa marittima inglese, il residente veneto a Londra, Cesare Vignola, rispose prontamente con l’invio a Venezia di numerosi volumi e di «incisive considerazioni personali» in materia (99).
Anche la nuova Ordonnance concernant la marine di Luigi XV (1765) e le omologhe raccolte di Ragusa, Pisa e Livorno finirono sul tavolo dei magistrati veneziani. Ma gli ambasciatori fecero comodamente in tempo a inviare loro anche l’Editto politico di navigazione mercantile austriaca, uscito nel 1774, che la «regolazione della veneta mercantile marina», la cui compilazione era stata nel frattempo affidata a due deputati in rappresentanza delle rispettive magistrature, era ancora in alto mare (100).
Già nel 1767, peraltro, ai due deputati sembrava «indecoroso» che la Repubblica, «nata sul mare», fosse ancora priva di un’idonea raccolta legislativa, quando nazioni venute «dopo molti secoli nello studio del commercio e della navigazione» vi avevano già provveduto (101).
Si era anche attivato, con decreto 22 settembre 1768, un insegnamento di diritto marittimo e commerciale presso l’Università di Padova, ma si trattava della solita mezza misura: aggregato alla cattedra di diritto feudale, finì soffocato dal prevalente interesse accademico per questa disciplina (102).
In questa fase, inoltre, si andò realizzando la svolta decisiva nel tipo di operazione in atto, con un significativo passaggio da interessi essenzialmente disciplinari nei confronti di capitani e marinai a tematiche più generali e soprattutto con l’evoluzione da un’ottica meramente compilatoria a una prospettiva dinamica, volta non solo a raccogliere norme esistenti, ma anche a rielaborarle e a introdurne di nuove in relazione alle mutate circostanze storiche (103).
Questi sviluppi subirono una brusca interruzione nel 1775, in seguito a una delibera del maggior consiglio che sopprimeva, senza eccezione alcuna, tutte le conferenze ancora aperte. Così, anche quella istituita tra i cinque savi e i provveditori all’armar per la «regolazione della veneta mercantile marina» cadde vittima del drastico provvedimento, volto a bonificare la pubblica amministrazione dalla pletora (ne furono contate 134) di istituzioni intermagistraturali, formalmente a termine in relazione al compito loro assegnato, di fatto eterne (104).
Nel 1776, il lavoro di compilazione/rielaborazione poté riprendere sotto la direzione di un collegio di nove senatori, in pratica dei suoi tre presidenti (105). In questo modo, da un lato, si poneva la questione sotto il diretto controllo di un organo non settoriale, che poteva perciò esprimere più validamente che non la vecchia conferenza un punto di vista generale ed immediatamente politico, dall’altro, si rischiava di creare una frattura tra l’indirizzo precedente e quello in fieri, anche se il pericolo venne sensibilmente attenuato con la nomina nell’ufficio di presidenza di due protagonisti della vecchia gestione e, soprattutto, assicurandosi la collaborazione di fatto dei cinque savi alla mercanzia.
Nel 1778, la redazione della raccolta – o, meglio, del progetto di codice – era completata: si trattava di un testo che, abbandonati i tradizionali criteri cronologici, rielaborava sistematicamente l’intera materia, suddividendola in tre parti e 759 articoli. Un testo «moderatamente innovativo» nei contenuti, ma «decisamente rivoluzionario» nella formulazione, in quanto accoglieva senza incertezze i moderni criteri di brevità, precisione e chiarezza (106).
Ma il cammino dal progetto al Codice vero e proprio fu ancora lungo e accidentato e ancora di più lo sarebbe stato se, nel 1780, non si fosse imposta la competenza esclusiva dei cinque savi (107).
In questa fase – non brevissima, ma comunque conclusiva – ci fu anche il coinvolgimento dei rappresentanti dei ceti mercantili e armatoriali, che non fu affatto formale e si esercitò su una linea protezionistica e grettamente corporativa, accanendosi, ad esempio, contro i piccoli traffici dei marinai, ai quali si vollero vietare le tradizionali portate, ottenendo soddisfazione su questa come su altre questioni (108).
Il testo definitivo ottenne la ratifica del senato il 21 settembre 1786 (109). Seppure riformulato per tenere conto delle osservazioni dei ceti imprenditoriali, il Codice conservava intatto l’impianto complessivo del progetto del 1778, mantenendo invariati i titoli e la loro distribuzione in parti. Di queste, la prima si occupava dell’armamento navale e della gente di mare (Fabbrica dei bastimenti, Capitani, Patenti, Marineri, Scrivani, Nocchieri, Piloti, Chirurghi, Cappellani, Cadetti, Parcenevoli e Consoli), la seconda delle obbligazioni relative all’esercizio della navigazione (Rassegne, Perizie, Grazie, Portate e mesa dei marinari, Accordi paghe e panatiche dei marinari, Contratti a cambio marittimo ossia a rischio di mare, Sicurtà, Naufragi, Getti, Prove di fortuna, Avaree), la terza delle operazioni portuali e della navigazione di breve corso (Polizze di carico, Noleggi, Carichi e scarichi, Ammiragli dei porti del Lido e di Malamocco, Piloti d’Istria, Peotte ed altre barche da remurchio, Testamenti e successioni di quelli che muoiono in mare, Ancoraggio, Savorra e Navigazione limitata) (110).
Il numero degli articoli scese invece da 759 a 666, grazie ad un apprezzabile sforzo di semplificazione espositiva, quando non di vera e propria selezione, accorpamento e sintesi di formule superate, ripetitive o ridondanti.
Il risultato più evidente fu dunque «l’elaborazione organica e razionale» di una normativa confusa e frammentaria, accumulatasi in un tempo lunghissimo (oltre mezzo millennio) e perciò spesso dispersa, contraddittoria o addirittura introvabile (111).
Il rinvio all’uso corrente della piazza per fattispecie non previste manifestava la disponibilità ad accogliere quale fonte integrativa del diritto la consuetudine, espressione consolidata, ma vivente e perciò mutevole, della materia oggetto di codificazione, confermando il tradizionale pragmatismo del sistema giuridico veneziano.
Inutile cercare nel Codice una messa in discussione della tradizionale gerarchia di potere della società veneziana nei suoi riflessi sull’organizzazione marittimo-commerciale: nonostante alcune concessioni ai nuovi ceti capitalistico-borghesi, particolarmente evidenti nei rimedi adottati per l’indisciplina e l’imperizia dei capitani e nel divieto delle portate dei marinai, l’impianto complessivo rimase nettamente conservatore.
La sua modernità giuridico-formale dovette convivere con l’intrinseco tradizionalismo dei contenuti, in una combinazione di efficientismo e moderatismo che rifletteva fedelmente il clima politico dominante e scontava l’esaurimento di ogni pur cauto impulso riformatore.
In ogni modo, nel suo imprevedibile passaggio da semplice raccolta legislativa a fonte giuridica complessa e sistematica, il Codice marittimo costituì uno dei risultati più significativi del tardo Settecento veneziano.
Mancate risposte
Pur difettando di determinazione nel passaggio dall’astratta dichiarazione di volontà politica alla sua pratica realizzazione, ovvero dalla fase deliberativa a quella esecutiva, il governo veneziano, come abbiamo visto, non trascurò di prendere in esame alcun provvedimento volto ad alleviare le proprie difficoltà, in particolare quelle attinenti al commercio marittimo. A quanto già detto sull’argomento, dalle navi atte al Codice della marina mercantile, possiamo aggiungere altre considerazioni, relative a progetti come la Scuola di architettura navale, la camera di commercio e le compagnie commerciali, che ebbero tardiva, parziale o mancata realizzazione.
Il problema della formazione professionale nel campo delle costruzioni navali non ebbe uno sviluppo analogo a quello della navigazione, anche se non ne mancavano i presupposti. Al pari della flotta, infatti, l’Arsenale mancava di personale qualificato in senso tecnico-scientifico e la necessità di unire la preparazione teorica alla pratica del mestiere era fortemente avvertita a bordo delle navi come nella fabbrica di stato.
Non bastava più l’apprendistato sul luogo di lavoro, che stava alla base della formazione professionale delle maestranze veneziane in genere e, integrato da studi individuali, anche di quella caratteristica figura ad elevato contenuto tecnico-professionale che era il proto, «pubblico ingegnere» sul quale si appoggiava la capacità progettuale e realizzativa dei settori tecnico-produttivi dell’apparato statale della Serenissima.
Con il notevole incremento delle ordinazioni seguito ai provvedimenti del 1736 a favore delle navi atte, l’Arsenale riprese nuovo slancio e tornò a riaffacciarsi il problema della qualificazione professionale.
Una prima risposta, rivolta alle qualifiche superiori, fu l’istituzione di una cattedra universitaria di teoria nautica ed architettura navale, attivata a Padova nel 1745 ma soppressa nel 1750 per il trasferimento a Milano del suo titolare, Gian Rinaldo Carli.
Per i quadri intermedi, tuttavia, c’era bisogno di una scuola che unisse teoria e pratica nel processo di formazione professionale. Questa fu istituita soltanto nel 1777, con l’apertura presso l’Arsenale di un corso quinquennale di studi fisico-matematici relativi alla navale architettura. L’insegnamento venne affidato a Gianmaria Maffioletti, che poté avvalersi della consulenza di Simone Stratico, professore di matematica e nautica all’Ateneo patavino (112).
Grazie all’attività della Scuola, si crearono le condizioni per una profonda trasformazione organizzativa dell’Arsenale, non accompagnata però da una sua altrettanto decisa ristrutturazione tecnico-produttiva. La caduta della Repubblica colse il cantiere di stato nel pieno di una difficile fase di transizione dal vecchio al nuovo.
L’esito di questo tentativo fu inficiato sia dal ritardato avvio della Scuola di architettura navale, sia dai limiti sempre più evidenti (conformismo e scarsa incisività) del livello politico-amministrativo, nel caso specifico dei patroni, provveditori e inquisitori all’Arsenal (113).
Di una camera di commercio sul modello francese si cominciò a parlare a Venezia nel 1713 su iniziativa dei deputati al commercio, magistratura che integrò durante la prima metà del secolo il ruolo dei cinque savi alla mercanzia, al fine precipuo di studiare i mezzi più idonei per migliorare i traffici (114).
Il progetto era di unificare in un corpo permanente la rappresentanza dei circoli mercantili, dispersa in una molteplicità di organi settoriali e impossibilitata a far sentire la propria voce se non in modo occasionale ed extra istituzionale. Si giunse così ad approvare, l’8 luglio 1713, la costituzione di un’unione mercantile, composta dai capi di piazza più due rappresentanti per ciascuna scala di Levante e di Ponente e incaricata di coordinare la raccolta delle informazioni e l’elaborazione delle proposte da sottoporre al magistrato competente (115). Sebbene giunto a uno stadio assai avanzato, il progetto fu abbandonato per il sopraggiungere dell’ultima guerra veneto-turca e ripreso soltanto mezzo secolo più tardi, in concomitanza con le trattative di pace con i Barbareschi.
La nuova iniziativa dei cinque savi (30 luglio 1763) partiva dalla più che matura consapevolezza della necessità di superare il dilagante particolarismo dei gruppi capitalistici locali in una prospettiva unitaria, che favorisse la ripresa del commercio nazionale nel rispetto degli interessi generali del paese (116).
La proposta riprendeva sostanzialmente quella del 1713, articolandola in modo da coprire l’intero teatro dei traffici veneziani. Ne scaturiva una camera di 24 membri, ciascuno dei quali in rappresentanza di 18 scale marittime e terrestri (Genova e Livorno; Napoli e Sicilia; Smirne ed Arcipelago; Costantinopoli e Salonicco; Inghilterra; Olanda e Amburgo; Portogallo; Spagna; Francia e Svizzeri; Grecia; Morea; Alta e Bassa Germania; Lombardia estera; Egitto; Stato veneto da terra; Capo d’Istria e Dalmazia; Isole suddite; Cipro, Soria e Aleppo) e di 6 corpi o rappresentanze di settore (officio della seda; camera del purgo; parcenevoli; cambisti; assicuratori; Arte vetraria) (117).
Anche questa volta, tuttavia, le resistenze conservatrici ebbero la meglio sull’impulso riformatore: il 30 luglio 1768, a un lustro esatto dalla riproposizione fattane dai cinque savi, il senato tagliava le stesse proprie delibere istitutive della camera di commercio (118).
Approvato in linea di massima per ben due volte nel corso del 1764, il progetto, ormai definito anche nella sua composizione nominativa, era rimasto fermo per altri quattro anni, bloccato da eccezioni di legittimità in relazione alla nomina di alcuni membri, cittadini veneti di origine straniera. Si trattava di fobie o cavilli che non potevano essere sottovalutati, in quanto esprimevano la sorda opposizione degli interessi colpiti. Inizialmente sulla difensiva, questi ebbero il tempo di riorganizzarsi: la sentenza di incostituzionalità, pronunciata infine dal senato sia pure con un leggerissimo scarto di voti, ne sanciva il definitivo trionfo.
I vari consorzi d’Egitto e i vari uffici della seta, «con provvidi oggetti dalla sapienza de’ nostri maggiori istituiti per servir di lume e fondamento ai consigli delle magistrature e che composti sono di persone l’interesse particolar de’ quali s’uniforma per l’ordinario al vero bene della nazione», erano salvi (119).
Al riabilitato particolarismo delle rappresentanze settoriali e alla restaurata sovranità del senato si sacrificava un progetto di ammodernamento e razionalizzazione, giudicato «contrario» alla costituzione politica veneziana.
Sul piano generale, lo «spirito dei lumi» non era ancora rifluito e continuava anzi ad agire su più di un versante dell’economia, della società e della cultura della Repubblica. Si poteva patrocinare l’apertura dei corpi di mestiere, sostenere la necessità di una svolta in senso utilitario e antiretorico del sistema educativo, perseguire con intransigenza una linea giurisdizionalista nei confronti della Chiesa, ma quando si arrivava a toccare il punto della rappresentanza, sia pure non direttamente politica, dei nuovi ceti economico-sociali, scattava nel vecchio ceto dominante un riflesso condizionato, che riusciva a saldare il fronte conservatore nel rifiuto di ogni riforma, considerata letteralmente eversiva della tradizionale struttura di potere.
La camera di commercio di Venezia dovette aspettare il nuovo secolo e un regime straniero per aprire finalmente i battenti.
Parte dei motivi che indussero la classe dirigente veneziana a stroncare sul nascere l’organo rappresentativo dell’intero ceto mercantile della piazza realtina possono essere rintracciati nell’atteggiamento non positivo mostrato nei confronti di un’altra istituzione economica del capitalismo commerciale: la compagnia di commercio.
Il senso di diffidenza e di sospetto e l’aura di segretezza da cui appare sempre avvolta la trattazione della materia testimoniano infatti di una preoccupazione politica radicata e non occasionale.
Peraltro, il motivo fondamentale per cui a Venezia non vennero istituite, se non in termini assolutamente trascurabili, tali compagnie non è riconducibile, se non in seconda istanza, a scelte politico-istituzionali, bensì, essenzialmente, alla mancata partecipazione veneziana alla nuova fase di sviluppo dell’economia mondiale nell’epoca successiva alle grandi scoperte geografiche.
L’espansione europea dei secoli XVI-XVIII avvenne ad opera delle nuove potenze atlantiche, alcune delle quali (Olanda, Inghilterra e Francia) fecero largo uso del nuovo strumento, che l’evoluzione della tecnica giuridica andava mettendo a disposizione del capitalismo commerciale. Quest’ultimo, nella sua mondializzazione, si trovò a dover affrontare problemi finanziari, organizzativi e militari di enormi dimensioni, che lo stato non era ancora in condizione di dominare e che dovette perciò delegare alla nuova istituzione, archetipo della moderna società per azioni.
Nella compagnia coloniale comparvero per la prima volta insieme e integralmente gli elementi caratteristici di quel tipo di società: limitazione della responsabilità dei soci e divisione del capitale sociale in quote uguali e negoziabili (azioni). Il primo elemento si era già presentato nelle società in accomandita, come privilegio spettante a una sola delle due categorie di soci di cui essa era composta, gli accomandanti, i quali partecipavano all’investimento e agli utili d’impresa, ma non alla sua gestione. La limitazione del rischio al solo capitale conferito, storicamente preclusa al socio accomandatario e quindi all’intero ceto mercantile medievale che vediamo chiaramente dietro l’esile schermo di questa figura giuridica, venne riconosciuta alla generalità dei soci soltanto nella compagnia di commercio. Anche il secondo elemento – la divisione in azioni – nacque nel corso del progressivo sviluppo dalle forme più arcaiche delle «compagnie regolate», sul modello dei merchant adventurers, alle più evolute configurazioni societarie delle «compagnie stabili» o joint stock companies, sul modello delle varie compagnie delle Indie.
Da un lato, quindi, il beneficio della responsabilità limitata indusse i mercanti ad affrontare i rischi gravissimi del commercio a grande distanza con possibilità di profitti enormi e di perdite limitate; dall’altro, il sistema azionario offrì un ulteriore vantaggio agli investitori che già godevano di quel beneficio, consentendogli di disporre delle quote di capitale sociale come di un qualsiasi bene mobile. Il mercato azionario (borsa) contribuì così in modo decisivo a risolvere il problema della capitalizzazione della grande compagnia coloniale, convogliando verso di essa le risorse finanziarie di ceti diversi da quello mercantile (120).
Venezia fu più volte tentata di istituire compagnie di commercio. L’aspetto più interessante di queste società era visto nella loro attitudine a raccogliere un «pingue capitale» che servisse da fondo «fermo e perpetuo» per l’esercizio di attività economiche capaci di sostenere la concorrenza internazionale. Ma gli aspetti negativi erano prevalenti: essi derivavano essenzialmente dal carattere semipubblico delle compagnie e dai poteri speciali (monopolio commerciale e quote di sovranità su un determinato territorio) che il governo veneziano non intendeva loro concedere o delegare.
Ritorna, in queste obiezioni, il tema dell’esclusivismo politico del ceto aristocratico dominante, che conservò intatto l’impianto costituzionale dello stato fino al suo crollo e che impedì ogni riconoscimento e apertura ai nuovi ceti produttivi. In questo senso, camera e compagnie di commercio fecero tutt’uno: il concetto di delega di determinate funzioni, anche solo consultive, a organi rappresentativi di forze economiche e sociali diverse dal patriziato non riuscì a entrare nel lessico politico veneziano.
Una rapida rassegna dei tentativi abortiti o presto falliti di creare compagnie di commercio a Venezia basterà a illustrarne la modesta dimensione e il corto orizzonte, limiti che non valsero comunque a rimuovere diffidenze e sospetti di parte governativa nei loro confronti. Non si parlerà di casi formalmente analoghi, ma sostanzialmente assai diversi, come la compagnia di nuova istituzione del 1720: più che un’istituzione commerciale, intendeva essere una società industriale multisettoriale (lana, seta, vetro e concia delle pelli) sottratta ai vincoli corporativi delle Arti cittadine (121).
Dell’istituzione di una compagnia marittima si ebbe notizia fin dal 1662-1663 (122), ma si sa che questa prima esperienza «andò a terminare nell’anno 1664 col portofranco» (123). In effetti, uno degli argomenti più frequentemente usati contro le nuove società commerciali era, paradossalmente per uno stato mercantilista come quello veneziano, la «molteplicità dei vincoli» che esse avrebbero introdotto, laddove servivano «facilità e agevolezze» (124). Insomma, si contrapponeva la liberalizzazione delle dogane ai privilegi delle compagnie. Si era, peraltro, nel periodo più duro della guerra di Candia e il cosiddetto «portofranco» del 1662, nelle sue mitizzate finalità espansive, non poteva che apparire incompatibile con la contemporanea compagnia marittima, che rischiava invece di introdurre elementi esclusivistici, potenzialmente restrittivi del movimento marittimo realtino.
Nel 1681, sul finire della deludente esperienza di semifranchigia doganale e nel rapido consumarsi della crisi dei convogli, il senato approvò un progetto di compagnia di assicuratori, avanzato nel 1680 da «persone secrete» (125) e che «non sortì alcun effetto» (126).
Nel 1688, nel clima di riscossa antiturca culminato con l’effimera conquista della Morea e nella favorevole congiuntura delle guerre europee contro la Francia, a un privato imprenditore nacque l’idea di una compagnia per il negozio di Cipro, Soria ed Alessandria una rotta infestata dai pirati e impraticabile da isolati operatori dopo la sospensione dei convogli. Dotata di un capitale iniziale di 200 mila ducati, già quasi interamente sottoscritto da «non pochi» mercanti di Terraferma e di Venezia, l’istituenda società vide però «prima i funerali che la nascita» (127).
Un caso particolarmente interessante è rappresentato dal progetto di compagnia per il negozio con la Danimarca, nel senso che fu oggetto di intense trattative diplomatiche, ben presto estese alla Russia per il traffico con la Moscovia. Le due iniziative, la prima delle quali includeva un’ipotesi di commercializzazione dei prodotti minerari della Norvegia, si sarebbero integrate in una prospettiva unitaria di rilancio della presenza veneziana nelle acque più settentrionali d’Europa, dal mare del Nord al mare Baltico.
La peculiarità di questo tentativo stava nel coinvolgimento diretto dello stato nella stipula di trattati commerciali, dei quali le progettate compagnie sarebbero state la base finanziaria e lo sbocco organizzativo. Lo scopo primario era di allargare l’asfittico spazio commerciale della Serenissima, attraverso la negoziazione diretta di clausole di favore per la marina nazionale. Le compagnie erano viste come puro strumento di raccolta del capitale sociale – che, per le dimensioni dell’impresa, non poteva non trascendere le singole disponibilità individuali –, da un lato, e di gestione mercantile, dall’altro, senza alcuna delega di potere da parte dello stato.
Le difficoltà alla realizzazione del trattato non vennero dalla parte veneziana: a Copenhagen si paventava l’ostilità dell’Olanda a un accordo che, stabilendo rapporti diretti tra Europa settentrionale ed area mediterranea, avrebbe danneggiato il ruolo di mediazione commerciale svolto da quel paese. La condotta veneziana fu in questa occasione ineccepibile, ma la buona volontà dei deputati al commercio e dello stesso senato, che approvò nel 1710 il progetto di massima della compagnia, venne frustrata dagli ostacoli frapposti dalla controparte danese, che non volle rischiare di perdere il vecchio partner commerciale (Olanda) per il nuovo (Venezia) (128).
Tuttavia, l’idea di stabilire solidi rapporti commerciali con il versante europeo settentrionale sopravvisse a questo primo insuccesso, a dimostrazione di un non effimero interesse veneziano per un forte punto d’appoggio a Nord che assicurasse una ricaduta positiva sul resto dei traffici di Ponente. Si pensava che soltanto un’integrazione della tradizionale, ma decaduta, rotta euroatlantica con l’area baltica avrebbe potuto giustificare un ritorno in grande stile della bandiera di San Marco al di là di Gibilterra.
Nel 1745, su iniziativa del mercante Isacco Treves, venne istituita una compagnia del Baltico, che contava di sviluppare un interscambio di materie prime e prodotti mediterranei con minerali russi e scandinavi. Ma, come osserva Bruno Caizzi, in quei mari lontani e poco famigliari alle navi veneziane, gli operatori nazionali non disponevano di alcun punto di riferimento: non consoli, non commissionari, non agenti di commercio, nemmeno un simulacro di organizzazione marittima. Lo stato, geloso delle proprie prerogative sovrane, non si limitò a non delegarle, ma nemmeno si peritò di esercitarle direttamente, lasciando un vuoto che, peraltro, nessuna società commerciale seppe colmare (129).
Mentre nel resto d’Europa il ruolo delle grandi compagnie era già al tramonto e gli imperi coloniali si accingevano a riprendere nelle proprie mani, ora diventate più forti, il bastone di comando dell’economia in termini globali, a Venezia la staffetta non era mai iniziata, perché il vecchio ceto aristocratico dominante si rifiutava di passare il testimone, sia pure per un breve tratto intermedio, a classi sociali più fresche. Queste, d’altra parte, non seppero farsi strada con la necessaria intraprendenza, colmando i vuoti lasciati dalla pubblica inadempienza e imponendo una qualche forma di partecipazione al chiuso sistema politico-istituzionale.
Ma il conservatorismo politico e la scarsa intraprendenza dei ceti mercantili non spiegano tutto: anch’essi, come le mancate riforme che ne furono la diretta conseguenza, possono essere visti come effetti di un fenomeno più ampio e decisivo: la dimensione strutturalmente mediterranea, al massimo euroatlantica, dello spazio economico veneziano. Nell’epoca dell’espansione planetaria del capitalismo commerciale europeo, a Venezia bastò non soltanto la nautica tradizionale, appena integrata da un limitato aggiornamento tecnico-professionale, ma anche le tradizionali forme di organizzazione e di finanziamento dei traffici internazionali. I tentativi di fuoriuscita da questa situazione non furono trascurati, ma urtarono contro la rigidità del nuovo equilibrio marittimo internazionale che, seppure oggetto di contesa tra le grandi nazioni europee, non lasciava molti margini di manovra a una potenza regionale come si poteva ormai considerare la Repubblica adriatica.
Nel 1762, alla vigilia dei trattati con i Barbareschi, le navi da punta erano ridotte a 29 (Tab. 8). L’imprevista obsolescenza delle navi atte, rivelatesi improvvisamente vulnerabili dopo un quindicennio di buona prova, aveva certamente inciso sul loro declino. Ma più ancora erano diminuite le altre navi, di costruzione forse meno recente delle navi atte e non più rimpiazzate dopo la crisi degli anni Cinquanta e il conseguente blocco del turn over per disarmo, naufragio o cattura.
Dal 1764 – a pace già in vigore con Algerini, Tunisini e Tripolini –, il trend risalì sui valori medi del secolo (47-48 unità), rimanendovi sostanzialmente fino alla caduta della Repubblica.
Ancora una volta, la congiuntura marittima veneziana si dimostrò sensibile alle vicende internazionali, in particolare alla guerra d’indipendenza americana che coinvolse via via le maggiori potenze europee tra il 1776 e il 1781 e premiò la neutralità della bandiera di San Marco.
Ma, al di là degli eventi occasionali, si può notare una certa tenuta della marina mercantile della Serenissima su livelli tutto sommato non disprezzabili, che lasciano intuire un suo consolidamento su scala regionale (adriatico-levantina, con qualche propaggine ponentina che raramente andava oltre Gibilterra) nell’ultimo trentennio della sua esistenza.
Una stima della flotta mercantile europea a fine Settecento – della cui riproposizione critica siamo debitori a Ruggiero Romano – vede Venezia seconda soltanto a Napoli in ambito mediterraneo, a parte ovviamente la Francia, che navigava su livelli prossimi a quelli inglesi e apparteneva quindi a un’altra dimensione. Su questo piano, teatro della competizione globale, Venezia scendeva al decimo posto, con 418 imbarcazioni di complessive 60.332 tonnellate, pari all’1,78 per cento del totale (130).
La portata media (144 tonnellate 5 180 botti) era simile a quella francese, a metà strada tra quella più elevata delle marine oceaniche e quella più bassa delle altre flotte italiana, russa e imperiale (131).
Questa stima (180 botti nel 1786-1787) è più alta di quanto risulta dall’interpolazione dei dati raccolti da Ugo Tucci (142 botti nel 1779-1794) (Tab. 9). La differenza – circa il 20 per cento è però meno netta se consideriamo la distanza dei punti di osservazione (Parigi e Venezia) e, soprattutto, la notazione di Tucci secondo cui i valori registrati «devono ritenersi piuttosto inferiori a quelli effettivi» per motivi fiscali (132).
Impressiona di più il divario nelle portate complessive (la stima francese è circa il doppio del dato ufficiale), riconducibile sia ai motivi indicati da Tucci (false dichiarazioni dei proprietari), che al maggior numero di imbarcazioni censite dalla fonte parigina (418 unità contro 250-300).
La questione dei tonnellaggi è importante per capire l’evoluzione della flotta mercantile veneziana nel tardo Settecento. L’aspetto principale è la tendenza verso una riduzione delle portate unitarie. Questa caratteristica ridimensiona il significato dell’opposta tendenza all’aumento del numero di imbarcazioni (Tab. 8), che tuttavia prevale e si riflette nel non trascurabile aumento della portata complessiva tra il 1766 e il 1794.
«tenuta» veneziana. Si potrà allora parlare, più propriamente, di declino relativo, riprendendo il discorso negli stessi termini in cui lo si è impostato sin dall’inizio.
Alla vigilia della fine della sua storia millenaria, Venezia non era più il grande emporio internazionale di un tempo e il lento slittamento della sua economia marittima verso un ruolo regionale poteva dirsi ormai concluso. Il suo porto funzionava ormai più come infrastruttura di servizio dell’immediato entroterra, che come centro di mediazione degli scambi commerciali tra Oriente e Occidente.
Il movimento commerciale della Serenissima nell’ultimo quarto del secolo XVIII, così come ci viene presentato dai registri dei dazi (139), evidenzia il peso crescente dei traffici con la Terraferma suddita (quasi la metà del movimento complessivo) e la corrispondente flessione delle riesportazioni. Dallo scalo realtino venivano inoltrate verso il mercato regionale materie prime (metalli, lana, lino e cotone grezzi, pelli, materie coloranti e concianti), beni di consumo (olio, zucchero, caffè, cacao, droghe e spezie varie) e prodotti lavorati (sapone, cera, vetri e tessuti). In senso inverso, giungevano alla Dominante derrate agricole (grano e riso) e prodotti tessili delle nuove manifatture regionali.
Il traffico di Venezia, alla fine del Settecento, si presentava nettamente rivolto al mercato interno sia quello proprio, di città capitale ancora ricca di risorse umane e patrimoniali e affluente nel suo tenore di vita, sia quello nazionale, di città e territori del Dominio di terraferma in sensibile crescita economica e demografica. Ai mercati esterni si dirigevano flussi commerciali ormai minoritari. L’antica funzione internazionale appariva decisamente incanalata, senza ulteriori sviluppi e quasi in posizione difensiva, su alcune direttrici tradizionali (Levante, Ponente alto e Germania). Nella nuova configurazione del commercio marittimo mondiale, dominato dalle grandi potenze coloniali, lo spazio veneziano era chiaramente e definitivamente periferico.
Questo esito si profilò fin dagli anni Ottanta del Seicento, con la caduta di ogni illusione di facile ripresa dopo la guerra di Candia, e ancor più dopo la pace di Passarowitz, che delimitò ulteriormente il raggio d’azione della marina di San Marco.
A questa prospettiva Venezia non volle arrendersi, se non altro per il mai perduto senso della passata grandezza, cui si sentiva tenuta a corrispondere almeno nelle intenzioni. Ma il conservatorismo, da un lato, e la mancanza di determinazione, dall’altro, resero meno incisive le risposte alla crisi che l’antica Repubblica marinara seppe pur elaborare nel corso di tutto il secolo XVIII, dal sostegno alla cantieristica all’aggiornamento tecnico-professionale di piloti e capitani, alla formazione di architetti e ingegneri navali, al Codice della marina mercantile; dall’organizzazione dei convogli alla riforma delle navi atte, alla pace con i Barbareschi; dalla politica mercantilistica alle riforme doganali, ai tentativi di semiliberalizzazione e al «portofranco»; dai trattati commerciali alle compagnie di commercio, al tentativo di istituire una camera di commercio.
Tuttavia, i margini di manovra di una potenza mediterranea erano oggettivamente assai ristretti all’epoca del nuovo imperialismo marittimo su scala planetaria, con le sue elevatissime esigenze di dotazione di capitale sociale e la sua attitudine ad esercitare traffici molto lontani, grazie ai nuovi strumenti tecnici e scientifici messi a disposizione dalla nautica oceanica e alla delega di sovranità concessa alle varie compagnie da stati coscienti della propria inadeguatezza e disponibili a transigere sulle forme di espressione del potere pur di mettere i gruppi capitalistici nazionali in condizione di accedere agli enormi profitti del commercio coloniale nella durissima lotta per l’egemonia.
Pur non potendo e non riuscendo a contrastare con la necessaria incisività la corrente profonda che, a partire dall’età delle grandi scoperte geografiche, aveva progressivamente spostato il baricentro dell’economia mondiale sulle rive dell’Atlantico, non è privo di significato il tentativo del vecchio ceto dominante veneziano di adattare la propria organizzazione marittima a tutte le novità emergenti a livello internazionale, senza indulgere alla facile riproposizione di modelli stranieri non filtrati attraverso la memoria del proprio passato. Fintantoché questo senso della storia, che fu anche senso dello stato, non scivolò nel tradizionalismo fine a se stesso, Venezia non rinunciò a lottare per il mantenimento di una propria autonoma presenza sul mare, nello spazio limitato che la nuova gerarchia del potere rnarittimo poteva ormai concederle.
1. Christopher Hill, La formazione della potenza inglese. Dal 1530 al 1780, Torino 1977, pp. 174-182, e Fernand Braudel, civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), III, I tempi del mondo, Torino 1982, p. 360.
2. È proprio in questa fase (fine XVII-inizio XVIII secolo) che Gino Luzzatto colse i segni di una «profonda e insanabile decadenza» dell’economia cittadina e il «trionfo completo e definitivo» dell’economia nazionale: Gino Luzzatto, Storia economica dell’età moderna e contemporanea, I, L’età moderna, Padova 1955, pp. 348-353.
3. F. Braudel, Civiltà materiale, III, p. 388, e Immanuel Wallerstein, Il sistema mondiale dell’economia moderna, III, L’era della seconda grande espansione dell’economia-mondo capitalistica. 1730-1840, Bologna 1995, p. 115.
4. G. Luzzatto, Storia economica dell’età moderna e contemporanea, I, p. 346.
5. L’impulso all’ulteriore evoluzione dell’espansione europea (dal commercio al dominio su scala mondiale) venne proprio dal tipo di rapporto instaurato in Asia e in America nel periodo del mercantilismo. Lo stesso processo di industrializzazione, con lo sviluppo della cantieristica e, soprattutto, con la meccanizzazione della filatura e della tessitura del cotone, fu notevolmente stimolato dai traffici con le Indie orientali e occidentali: Wolfgang Reinhard, Storia dell’espansione europea, Napoli 1987, pp. 271-274.
6. Charles Wilson, The British Isles, in An Introduction to the Sources of European Economic History. 1500-1800, I, Western Europe, a cura di Id. - Geoffrey Parker, London 1977, p. 125 (pp. 115-154).
7. Gino Luzzatto, La decadenza di Venezia dopo le scoperte geografiche nella tradizione e nella realtà, «Archivio Veneto», ser. V, 54-55, 1954, pp. 180-181 (pp. 162-181), e Ugo Tucci, Un ciclo d’affari commerciali in Siria (1579-81), in Studi in memoria di Federigo Melis, IV, Napoli 1978, p. 217 (pp. 187-223).
8. Gigliola Pagano de Divitiis, Mercanti inglesi nell’Italia del Seicento. Navi, traffici, egemonie, Venezia 1991, pp. 51-91.
9. Quanto contasse un risparmio su queste voci di spesa si può agevolmente comprendere dall’affermazione di Ugo Tucci, secondo cui «le spese per l’equipaggio [...] superavano il 60 per cento del totale» dei costi di gestione: Ugo Tuccl, Traffici e navi nel Mediterraneo in età moderna, in La penisola italiana e il mare. Costruzioni navali, trasporti e commerci tra XV e XX secolo, a cura di Tommaso Fanfani, Napoli 1993, p. 61 (pp. 57-70).
10. Sulle galere da mercato: Roberto Cessi, Le relazioni commerciali tra Venezia e le Fiandre nel secolo XIV, «Nuovo Archivio Veneto», n. ser., 27, 1914, pp. 5-116; Frederic C. Lane, Venetian Ships and Shipbuilders of the Renaissance, Baltimore 1934, pp. 1-34; Gino Luzzatto, Navigazione di linea e navigazione libera nelle grandi città marinare del Medio Evo, in Id., Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, pp. 53-57; Adolfo Sacerdoti, Note sulle galere da mercato veneziane nel XV secolo, «Studi Veneziani», 4, 1962, pp. 80-105; Alberto Tenenti - Corrado Vivanti, Le film d’un grand système de navigation: les galères marchandes vénitiennes (XIV-XVI siècles), «Annales E.S.C.», 16, 1961, pp. 83-86; Freddy Thiriet, Quelques observations sur le trafic des galères vénitiennes d’après les chiffres des incanti (XIV-XV siècles), in AA.VV., Studi in onore di Amintore Fanfani, III, Milano 1962, pp. 493-522; Ugo Tucci, Costi e ricavi di una galera veneziana ai primi del Cinquecento, «Studi Veneziani», 16, 1974, pp. 109-175, e Id., Le colonie mercantili italiane e il commercio internazionale nel Medio Evo, «Ateneo Veneto», n. ser., 31, 1993, pp. 22-27 (pp. 7-28).
11. Frederic C. Lane, Venice. A Maritime Republic, Baltimore 1973 (trad. it. Storia di Venezia, Torino 1978), pp. 384-385.
12. U. Tuccl, Traffici e navi nel Mediterraneo, p. 58.
13. Ibid.
14. Massimo Costantini, La regolazione dei dazi marittimi e l’esperienza del «portofranco» a Venezia tra il 1662 e il 1684, in La finanza pubblica in età di crisi, a cura di Antonio Di Vittorio, Bari 1993, p. 87 (pp. 77-88), e Ugo Tucci, La marina mercantile veneziana nel Settecento, «Bollettino dell’Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano», 2, 1960, p. 157 (pp. 155-200).
15. Sull’intera vicenda del «portofranco» di Venezia: M. Costantini, La regolazione dei dazi marittimi.
16. U. Tucci, La marina mercantile veneziana, p. 183, e Daniele Beiltrami, La crisi della marina mercantile veneziana e i provvedimenti del 1736 per fronteggiarla, «Rivista Internazionale di Scienze Sociali», 50, 1942, nr. 5, pp. 304-318.
17. L’episodio è riferito da Pier Giovanni Capello, Principii ovvero massime regolatrici di commercio raccolte dalle leggi e documenti della Repubblica di Venezia, ms. s.d. (ma 1733-1737), cc. 292-293.
18. Roberto Cessi, La Repubblica di Venezia e il problema adriatico, Milano 1943, pp. 339-341.
19. Mario Caravale - Alberto Caracciolo, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, Torino 1978, p. 472. Per una visione complessiva del porto franco di Ancona: Alberto Caracciolo, Le port-franc de Arcône, Paris 1965, e Id., Il dibattito sui «porti franchi» nel Settecento: genesi della franchigia di Ancona, «Rivista Storica Italiana», 75, 1963, nr. 3, pp. 538-558.
20. Lo vede bene Gino Luzzatto, che non è certo tenero verso le politiche protezionistiche in generale e quella veneziana in particolare: Gino Luzzatto, La funzione del porto di Venezia nel passato e nel presente, Venezia 1923, p. 13.
21. Roberto Cessi, Storia della Repubblica di Venezia, II, Milano-Messina 1946, p. 158.
22. F.C. Lane, Venice, pp. 386-387.
23. Alberto Tenenti, Venezia e i corsari. 1580-1615, Bari 1961, pp. 136-144.
24. U. Tucci, La marina mercantile veneziana, pp. 179-180.
25. R. Cessi, Storia della Repubblica di Venezia, II, pp. 243-245; F.C. Lane, Venice, p. 419; U. Tucci, La marina mercantile veneziana, p. 190.
26. U. Tucci, La marina mercantile veneziana, p. 157.
27. Ibid., p. 187.
28. F.C. Lane, Venice, pp. 414-415, e Ugo Tucci, La storiografia marittima sulla Repubblica di Venezia, in Tendenze e orientamenti nella storiografia marittima contemporanea: gli Stati italiani e la Repubblica di Ragusa, a cura di Antonio Di Vittorio, Napoli 1986, p. 159 (pp. 151-173).
29. L’espressione è di Ruggiero Romano.
30. Daniele Beltrami, La penetrazione economica dei Veneziani in Terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 1961.
31. James S. Ackersian, Palladio, Torino 1972, pp. 17-18. Che le ville dei nobili veneziani non fossero concepite «solo come luogo di svago, ma come centri di amministrazione fondiaria» l’aveva già segnalato Gino Luzzatto, Introduzione, in Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII, Atti del Convegno 27 giugno - 2 luglio 1957, Venezia-Roma 1961, p. XXI (pp. III-XXIII).
32. Gino Luzzatto, Per la storia delle costruzioni navali a Venezia nei secoli XV e XVI, in Id., Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, pp. 48-49.
33. Gino Luzzatto osservò acutamente, nel saggio appena citato, come il sistema degli imprestiti fosse lo strumento indispensabile a conciliare i contrastanti interessi degli armatori (disponibilità di navi a buon mercato) e dello stato (mantenimento di una base produttiva sempre pronta per ogni esigenza della flotta militare): ibid., p. 44. Da parte sua, Jean-Claude Hocquet attribuisce al sovrapprezzo dei noli del sale, classica forma di estrinsecazione della politica veneziana dei premi, un ruolo decisivo nel rendere redditizio il trasporto a lunga distanza di quel prodotto, povero e voluminoso, su navi utilizzabili anche a scopo militare: Jean -Claude Hocquet, Il sale e la fortuna di Venezia, Roma 1990.
34. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, b. 97, fasc. 25/1, 1644.
35. Per quanto riguarda il controverso problema del valore della botte, sul quale si sono cimentati i maggiori esperti di metrologia navale e di storia marittima della Serenissima, rinviamo ai fondamentali contributi di G. Luzzatto, Per la storia delle costruzioni navali, pp. 42-43 n. 18; Frederic C. Lane, Tonnages, Medieval and Modern, «Economic History Review», ser. II, 17, 1964, nr. 2, pp. 213-233, e Ugo Tucci, Un problema di metrologia navale: la bolle veneziana, «Studi Veneziani», 9, 1967, pp. 201-246. In un successivo intervento, il grande storico americano convenne con Tucci sull’opportunità di adottare, almeno per il Sei-Settecento, il rapporto di 0,8 come valore di conversione della botte in tonnellate: F.C. Lane, Venice, pp. 479-480. Fa invece un po’ troppo il difficile Hocquet, il quale finisce per rinunciare a qualsiasi parità metrica, limitandosi a indicare l’originaria unità di misura in botti: J.-C. Hocquet, Il sale, pp. 17-19. Se è vero che non esiste alcuna soluzione univocamente determinata al problema – che, ricordiamolo, riguarda la conversione di un’unità di volume, quale la botte, in una di peso, quale la tonnellata –, è tuttavia innegabile che una sua conveniente stima può essere proficuamente utilizzata a scopi storico-comparativi, in particolare «per esaminare la consistenza e le variazioni del tonnellaggio veneziano nei periodi lunghi» (Tucci).
36. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, b. 97, fasc. 25/1, Decreto 9 luglio 1644.
37. I relativi provvedimenti vennero presi, rispettivamente, con decreto 31 agosto 1602 e 9 luglio 1644: ibid., fasc. 25/2, Scrittura dei Deputati alla mercanzia, giugno 1671.
38. Durante l’ultimo conflitto con il Turco, il governo della Serenissima cercò di acquistare o noleggiare navi «ad uso di guerra» attraverso i residenti veneti nelle principali piazze marittime (Olanda, Inghilterra e Danimarca): ibid., b. 106, 1715 e b. 107, Scrittura dei Cinque savi, 7 novembre 1714. Da segnalare, nel secondo documento citato, un elenco di navi noleggiate dal governo veneziano, con i relativi prezzi.
39. Ibid., b. 97, fasc. 25/3, Scrittura dei Capi di piazza e dei Capi dei parcenevoli, 8 aprile 1729.
40. Ibid., fasc. 25/4, Scrittura dei Deputati al commercio, 17 dicembre 1725.
41. Ivi, Senato, Mar, filza 792, Decreto 16 luglio 1707.
42. Si parla di «tre decreti non eseguiti, cioè 27 marzo 1694, 2 giugno 1708 e 12 luglio 1708, per le opposizioni dei segadori»: ivi, Cinque Savi alla Mercanzia, b. 97, fasc. 25/4, Agevolezze e facilità concesse per la fabbrica de’ bastimenti.
43. Trattandosi non di marangoni o di calafati, cioè di maestranze qualificate da trattenere in Arsenale, bensì di «facchini di montagna, l’impiego de’ quali s’apprende il secondo giorno che pigliano la sega per mano», ci si poteva permettere di scagliarsi contro «il venalissimo riguardo privato di 50 bifolchi, che hanno più titolo che essenza d’arte», dichiarandosi «attoniti [...] che questi possino impedire il ben pubblico»: ibid., fasc. 25/2, Scrittura dei Cinque savi, s.d. (ma 1709).
44. Ibid., fase. 25/4, Scrittura dei Deputati al commercio, 17 dicembre 1725. Tuttavia, ancora nel 1729, ci si lamentava di persistenti difficoltà: ibid., fasc. 25/3, Scrittura dei Capi di piazza e dei Capi dei parcenevoli, 8 aprile 1729.
45. Ibid., Decreto 12 settembre 1720.
46. U. Tucci, La marina mercantile veneziana, p. 161.
47. Ibid., p. 159.
48. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, b. 97, fasc. 25/3, s.d. (ma marzo-aprile 1722).
49. Ibid., Scrittura dei Capi di piazza e dei Capi dei parcenevoli, 8 aprile 1729.
50. Ibid., fasc. 25/4, 22 settembre 1725.
51. Citato da R. Cessi, Storia della Repubblica di Venezia, II, pp. 211-212.
52. D. Beltrami, La crisi della marina mercantile veneziana e i provvedimenti del 1736, pp. 308-309.
53. Così suddivise: 10 navi atte e 27 non: A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, b. 97, fasc. 25/4, Nota dei bastimenti fabbricati e comprati dal 1736 al 1744, 11 marzo 1744. Per giungere alle 23 navi atte del 1744, nessuna delle quali poteva preesistere in quanto tale alla riforma, bisogna pensare che oltre alla fabbricazione e all’acquisto ci sia stato un adattamento/conversione di 13 navi genericamente da punta in navi atte. D’altra parte, soltanto così i conti tornano anche per le navi non atte, che altrimenti eccederebbero proprio di 13 unità il numero indicato (57 invece di 44): ibid., Nota dei bastimenti veneti, 31 marzo 1744..
54. Da una Nota dei bastimenti che esistevano avanti l’anno 1736, nella citata b. 97 dei Cinque savi alla mercanzia, si ricava il dato di 53 navi che ho inserito nella tabella in corrispondenza del 1735/1736 (luglio 1735-giugno 1736). In altri fogli della stessa busta vengono segnalate, per il 1735 e il 1736, rispettivamente 44 e 37 navi, ma sempre e soltanto con bandiera nazionale. Come sappiamo, la pratica di alzare altri vessilli, purché rispettati dai pirati, era alquanto diffusa tra gli armatori veneziani, almeno prima della riforma, e variava continuamente a seconda delle occasioni. Ne risultava una divaricazione anche notevole tra proprietà e bandiera nazionali, in questo caso tra 53 e 44 e tra 53 e 37, e una sua elevata variabilità temporale: ibid.
55. Ibid., Scritture 13 maggio 1737, 28 luglio e 3 agosto 1740.
56. U. Tucci, La marina mercantile veneziana, pp. 179-180.
57. Il 14 settembre 1752: ibid., p. 183 n. 82.
58. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, b. 840, Scrittura 9 dicembre 1779.
59. V. Tab. 2.
60. U. Tucci, La marina mercantile veneziana, Tabella fuori testo: Bandiere dei bastimenti grossi mercantili in partenza da Venezia dal 1735 al 1759.
61. V. Tab. 1.
62. Con l’unica eccezione del 1773-1774.
63. Nel triennio 1756-1759 il gettito del nuovo stallaggio cadde mediamente a circa 75 mila ducati annui. V. Tab. 2.
64. Giordano Campos ha azzardato una stima dell’intero movimento commerciale (estesa, grazie ad ulteriori accorgimenti, fino all’ultima decade del Settecento). Ovviamente, il risultato corrisponde ai dati ufficiali soltanto per il decennio 1772-1781. Giordano Campos, Il commercio esterno veneziano della seconda metà del ’700 secondo le statistiche ufficiali, «Archivio Veneto», ser. V, 37-38, 1936, pp. 153-155 (pp. 145-183).
65. Giorgio Cappovin, Tripoli e Venezia nel secolo XVIII, Verbania 1942, p. 479; R. Cessi, Storia della Repubblica di Venezia, II, p. 243, e U. Tucci, La marina mercantile veneziana, p. 190 n. 105.
66. R. Cessi, Storia della Repubblica di Venezia, II, p. 252.
67. La navigazione mediterranea non ammetteva, infatti, le larghe approssimazioni tollerabili in quella oceanica (U. Tucci, Traffici e navi nel Mediterraneo, p. 61). Questa resistenza ambientale all’adozione delle nuove tecniche contribuiva ad alimentare la «rendita di posizione» della nautica tradizionale rispetto a quella atlantica.
68. John H. Parry, Le grandi scoperte geografiche. 1450-1650, Milano 1963, pp. 128-137.
69. Sugli aspetti tecnici della cartografia marittima: C. Singer - Dj. Price - E.G.R. Taylor, La cartografia, il rilevamento e la navigazione fino al 1doo, in AA.VV., Storia della tecnologia, III, Torino 1963, pp. 512-540 e E.G.R. Taylor, La cartografìa, il rilevamento e la navigazione. 1400-1750, ibid., pp. 541-568.
70. Ugo Tucci, La carta nautica, in Carte da navigar. Portolani e carte nautiche del Museo Correr. 1318-1732, a cura di Susanna Biadene, Venezia 1990, p. 15.
71. Ibid., p. 19.
72. A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, b. 526, Scritture sull’Accademia dei nobili, s.d.
73. Ibid., Scrittura di Girolamo Balbi, 10 settembre 1749 e Scrittura del Rettore dell’Accademia dei nobili, s.d. (ma 1750).
74. Ibid., Scrittura di Girolamo Balbi.
75. Luigi Zenoni, Per la storia della cultura in Venezia dal 1500 al 1797. L’Accademia dei Nobili alla Giudecca (1619-1797), «Monumenti Storici Pubblici della R. Deputazione Veneta», ser. III, 9, 1916, e Gaspare Gozzi, Sopra il corso di studi che più convenga all’Accademia della Giudecca in Venezia, ibid., pp. 186-200.
76. Franco Venturi, Settecento riformatore, V/2, L’Italia dei lumi. La Repubblica di Venezia (1761-1797), Torino 1990, p. 217.
77. A.S.V., Senato, Rettori, reg. 46, 1671, cc. 269v-270.
78. Ivi, Riformatori dello Studio di Padova, b. 526, Atti relativi alla Scuola di nautica in Venezia.
79. Ibid.
80. Sulla struttura finanziaria della Serenissima: Bilanci generali della Repubblica di Venezia, ser. I, vol. I, a cura di Fabio Besta, Venezia 1912.
81. A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, b. 527, Scrittura di Alvise Foscari e Antonio Nani, 2 novembre 1710.
82. Ibid.
83. Ibid., Decreto del Senato, 8 novembre 1710.
84. Ibid., b. 526, Scrittura del Magistrato all’armar.
85. Massimo Costantini - Luisa Florian, Una Scuola nel Levante, in Levante veneziano. Aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima, a cura di Massimo Costantini - Aliki Nikiforou, Roma 1996, pp. 149-175.
86. A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, b. 527, Scrittura dei Capi di piazza, s.d. (ma agosto/settembre 1739).
87. Ibid.
88. Ibid., b. 526, Scrittura di Giovanni Poleni, – maggio 1733.
89. Ibid., b. 527, Statuto della Scuola nautica, settembre 1739.
90. Ibid., b. 526, Scrittura dei Riformatori al Senato, 29 novembre 1766.
91. Ibid., b. 527, Relazioni del profitto degli scolari, 1739-1742.
92. Ibid., b. 526, Scrittura dei Riformatori al Senato, 29 novembre 1766.
93. Ibid., Carta del maestro di nautica, s.d. (ma 7 gennaio 1767).
94. Ibid., Scrittura del maestro di nautica ai Riformatori, s.d. (ma settembre 1789).
95. Ivi, Senato Secreta, Rettori, filza 275, decreto 16 marzo 1748. Il decreto è citato in Giorgio Zordan, Il Codice per la veneta mercantile marina, I, Padova 1981, p. 1. Di quest’opera, dedicata alla redazione del Codice, è uscito nel 1987 il secondo volume, che si occupa delle vicende successive alla sua promulgazione.
96. G. Zordan, Il Codice, I, p. 7.
97. Ibid., p. 9.
98. Ibid., p. 23, e Maria Francesca Tiepolo, Archivio di Stato di Venezia, in Guida generale degli Archivi di Stato italiani, IV, Roma 1994, p. 924 (pp. 857-1148).
99. G. Zordan, Il Codice, I, p. 59.
100. Ibid., pp. 63-76.
101. Ibid., p. 83.
102. Ibid., pp. 108-110.
103. Ibid., p. 86.
104. Ibid., p. 111.
105. Ibid., pp. 117-119.
106. Ibid., pp. 159-161.
107. La relativa proposta fu avanzata da Andrea Tron e approvata dal senato il 7 ottobre 1780: ibid., p. 205.
108. Ibid., pp. 222-230.
109. A.S.V., Senato, Mar, filza 1208, decreto 21 settembre 1786.
110. G. Zordan, Il Codice, I, pp. 161-180.
111. Ibid., p. 237.
112. Ennio Concina, L’Arsenale della Repubblica di Venezia. Tecniche e istituzioni dal medioevo all’età moderna, Milano 1984, p. 222.
113. Ibid., p. 228.
114. M.F. Tiepolo, Archivio di Stato di Venezia, p. 981.
115. Ferruccio Zago, Documenti relativi alla istituzione in Venezia della prima Camera di commercio (1713-1768), Venezia 1964, pp. 8-11.
116. Ibid., pp. 11-14.
117. Ibid., pp. 30-31.
118. Ibid., p. 49.
119. Ibid., p. 47.
120. Fernand Braudel, civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), II, Igiochi dello scambio, Torino 1981, pp. 435-456; Emile L J. Coornaert, Le istituzioni economiche europee e il Nuovo Mondo; le compagnie privilegiate, in AA.VV., Storia economica Cambridge, IV, L’espansione economica dell’Europa nel Cinque e Seicento, a cura di Edwin E. Rich - Charles H. Wilson, Torino 1975, pp. 255-315; Holden Furber, Imperi rivali nei mercati d’Oriente. 1600-1800. Bologna 1986, pp. 265-321; Francesco Galgano, Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale, Bologna 1993, pp. 78-83; G. Luzzato, Storia economica dell’età moderna e contemporanea, I, pp. 225-234; W. Reinhard, Storia dell’espansione europea, pp. 249-274.
121. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, b. 50, Capitoli della Compagnia di nuova istituzione, 17 agosto 1720.
122. Ibid., Decreto 21 gennaio 1662 (m.v.).
123. Ibid., Scrittura 12 giugno 1718.
124. Ibid.
125. Ibid., Capitoli stabiliti dai Cinque savi alla mercanzia in esecuzione di parte del Senato 25 settembre
1681 per l’erezione di una Compagnia d’Assicuratori in Venezia, 3 ottobre 1681.
126. Ibid., Scrittura 12 giugno 1718.
127. Ibid.
128. Ibid., Scrittura di Gabriel Soderini ai Deputati al commercio (inserta a decreto 26 giugno 1710).
129. Bruno Caizzi, Industria e commercio della Repubblica veneta nel XVIII secolo, Milano 1965, pp. 220-221.
130. Ruggiero Romano, Per una valutazione della flotta mercantile europea alla fine del secolo XVIII, in AA.VV., Studi in onore di Amintore Fanfani, V, Milano 1962, pp. 575-591. L’autore ritiene che il documento originario, redatto in lingua francese e conservato negli Archives Nationales di Parigi, risalga al 1786-1787.
131. Ibid.
132. U. Tucci, La marina mercantile veneziana, p. 192 n. 112.
133. Il country trade era il traffico di piccolo cabotaggio esercitato dalle compagnie coloniali in area asiatica, tra la costa orientale dell’Africa e il Giappone; il commercio «d’India in India» di cui parla Fernand Braudel. Esso serviva a finanziare il disavanzo commerciale europeo con l’Estremo Oriente.
134. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, b. 98, Scrittura di Angelo Emo, 29 giugno 1736.
135. Ibid., b. 105, nr. 232, Scrittura dei Capi di piazza e dei Capi dei parcenevoli, 29 novembre 1718.
136. G. Campos, Il commercio esterno veneziano, pp. 153-155. Vedi anche la Tab. 6 del presente lavoro.
137. Gino Luzzatto, Le vicende del porto di Venezia dal primo Medio Evo allo scoppio della guerra 1914-1918, in Id, Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, pp. 18-19 (pp. 1-35).
138. Il valore del commercio estero inglese quintuplicò nell’arco del Settecento: Phyllis Deane - William A. Cole, British Economic Growth. 1688-1959, Cambridge 1967, p. 48.
139. Si tratta di una serie di registri, conservati nel fondo archivistico dei cinque savi alla mercanzia, che documentano in modo analitico le entrate e le uscite, con le rispettive provenienze e destinazioni, di tutte le merci transitate per le dogane di Venezia dal 1772-1773 alla fine del secolo.