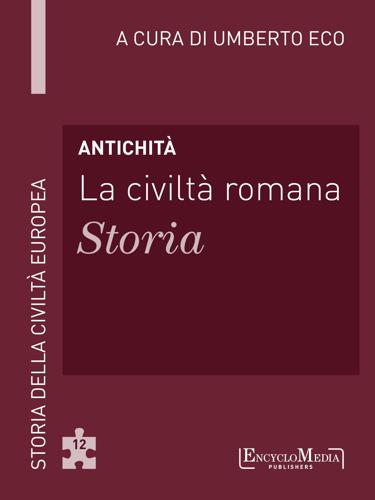Dalla morte di Caio Gracco alla guerra sociale
Dalla morte di Caio Gracco alla guerra sociale
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
La morte di Caio Gracco (121 a.C.) non pone fine ai conflitti interni; apre invece un’ulteriore fase di scontro tra optimates e populares, in cui questi ultimi, grazie alla carismatica figura di Mario, hanno momentaneamente la meglio. La politica estera è segnata da altre sanguinose guerre in Africa e nella stessa Italia settentrionale. Roma deve poi affrontare la ben più insidiosa rivolta degli alleati italici, ai quali si trova infine costretta a concedere la cittadinanza (90-89 a.C.).
Conflitto politico permanente
Da quando Caio Sempronio Gracco, inseguito tra i luoghi sacri dell’Urbe dagli uomini del console Lucio Opimio, sceglie per sé la morte, le cose cambiano profondamente a Roma.
La ferita istituzionale, politica e sociale – aggravata di lì a poco da processi sommari e dall’esecuzione di circa tremila cittadini – sarà accompagnata, nel giro di novant’anni, da innumerevoli altre, ancora più terribili. Tutto, infine, troverà rimedio con l’egemonia di Caio Giulio Cesare Ottaviano (già Caio Ottavio e, di lì a breve, Augusto), vincitore ad Azio e autore del superamento, graduale ma definitivo, dell’ordinamento repubblicano.
Sebbene scavalcati per gravità dai successivi, gli eventi del decennio graccano sono il vero "precedente" che mina la secolare stabilità delle istituzioni di Roma, da allora soggette a frequenti ma poco utili "aggiustamenti": troppe e troppo importanti sono le questioni sollevate dai due tribuni. Divenuti nell’immaginario moderno – si pensi al rivoluzionario francese François-Noël "Gracco" Babeuf – paladini per eccellenza delle masse, già da subito essi divengono modello di molti populares, i politici più sensibili alle esigenze di mutamento.
Sproporzionata sembra invece la reazione di un senato ormai arroccato su posizioni difensive e dominato dagli optimates, i conservatori che, dopo anni di intrighi, per la prima volta usano, contro Caio Gracco, l’arma del senatus consultum ultimum. La dichiarazione dello stato di emergenza sospende – di fatto ma non di diritto – la tradizionale inviolabilità tribunizia e le garanzie del cittadino (in primis la possibilità, in caso di condanna a morte, di appello al popolo, che proprio Caio Gracco aveva recentemente ribadito).
La conseguente repressione, affidata a Opimio, calma momentaneamente le acque, ma non cancella il dato concreto, ovverosia la forza delle tensioni politiche e sociali alimentate da un espansionismo che porta enormi ricchezze ma altrettanto profonde disuguaglianze. L’Urbe era – e sarebbe ancora – cresciuta, sulla scia di quei successi militari e di quelle attività commerciali che l’avevano ormai resa centro del Mediterraneo. Là e solo là si decidono le questioni politiche, mediante le assemblee popolari (che nominano i magistrati e votano le leggi), i magistrati (che, eletti annualmente, governano Roma, l’Italia e le provinciae) e il senato (la suprema assemblea permanente che coopta gli ex magistrati e gestisce aspetti fondamentali, tra cui la politica estera).
La classe dirigente è divisa: tale situazione, già chiara in età graccana, con il tempo si radicalizzerà. La nobilitas – la ristretta cerchia delle famiglie che possono vantare tra gli avi le più alte cariche dello stato –, la componente più autorevole del senato, è ormai in aperta collisione con l’emergente e più aggressiva classe dei cavalieri. Quest’ultima, in continua evoluzione, detiene una parte ancora relativa del potere politico, ma buona fetta di quello economico – agrario e, a differenza della nobilitas, anche commerciale – e la quasi totalità di quello finanziario. Nei decenni successivi, il peso dei cavalieri – tra i quali si affermeranno i publicani, i famigerati appaltatori delle imposte nelle provinciae (le regioni di conquista e, in molti casi, di sfruttamento selvaggio) – aumenterà costantemente.
Anche il resto della cittadinanza è composito. Da una parte la plebe urbana, sempre più numerosa, spesso inattiva e apparentemente priva di ideologie e obiettivi al di là della mera sussistenza. Dall’altra, invece, la popolazione rurale, base dell’esercito e portatrice dei valori dei piccoli possidenti della penisola, non di rado immiseriti da ben più competitive strutture latifondistiche coltivate da schiavi. Di fatto più lontana dal potere (si vota solo a Roma), essa ha, ufficialmente, la maggioranza – 31 su 35 – delle tribù, le unità in cui è diviso, secondo criteri territoriali, l’elettorato. Privi di un ruolo politico attivo, infine, gli italici (i non cittadini che controllavano ancora la maggior parte della penisola), anch’essi divisi in classi, accomunate tutte dal desiderio di equiparazione con l’antico alleato.
Ragionare in termini numerici, anche se impossibile, sarebbe quanto mai utile. Vale infatti la pena ricordare che, nella res publica romana – dove la statura dei protagonisti e la drammaticità degli eventi si sono sempre imposte all’attenzione dell’osservatore –, governanti e leggi, in fondo, sono scelti dalle assemblee dei cittadini: sistemi spesso incoerenti, manipolabili e clientelari, in cui però, a conti fatti, i voti determinano orientamenti e decisioni.
Il voto a Roma: centurie e tribù
Il politologo Giovanni Sartori, sottolineando l’influenza dei sistemi di voto sul comportamento degli elettori, osserva che “all’inizio c’è come un popolo viene fatto votare” (Ingegneria costituzionale comparata, Bologna 1995, 15). Questa verità è valida sempre. Nella Roma repubblicana il cittadino maschio adulto, di qualsiasi estrazione, poteva una volta l’anno eleggere i governanti (consoli, pretori, edili, questori e tribuni della plebe) e più volte l’anno esprimersi sulle leggi: in quest’ultimo caso, mancando la nozione di rappresentanza (propria delle democrazie moderne), vigeva una "democrazia diretta". I tipi di assemblee, che si riunivano solo nell’Urbe e rispondevano a un sistema "maggioritario puro", erano due. Più autorevoli erano i comizi centuriati, organizzati in 193 unità di voto: i cittadini più ricchi erano iscritti nelle prime 98 (poi 89) centurie e gli altri, maggioranza numerica, nelle rimanenti. Seguivano i comizi tributi, suddivisi in 35 unità di voto che raccoglievano, questa volta su base territoriale, l’elettorato: chi aveva origini e proprietà nell’Italia peninsulare era iscritto in una delle 31 tribù rurali; chi invece aveva come unico riferimento la capitale, in una delle 4 urbane, dove confluivano anche i liberti, gli schiavi affrancati. Come i comizi tributi funzionava il concilium plebis, attraverso il quale i tribuni promuovevano gran parte della legislazione romana. Chi aveva la maggioranza? Nei comizi centuriati i più ricchi, mentre nei comizi tributi e nel concilium plebis coloro che, iscritti nelle 31 tribù rurali, vivevano o potevano presentarsi all’occorrenza a Roma. I brogli erano diffusi e bassa era l’affluenza; mancando anche una struttura partitica definita, il personalismo aveva un forte peso; tutto ciò rendeva possibile sia il raggiungimento di un naturale consenso sui temi più popolari sia la manipolazione del voto da parte dei vari potentati. Il carattere più o meno ‘democratico’ delle assemblee romane, questione fondamentale, resta ancora oggetto di vivace dibattito.
Ciò che resta è constatare una situazione complessa, al pari dei conflitti che caratterizzano i decenni successivi. Terreno del contendere è naturalmente il potere, in ogni suo aspetto. Le questioni cruciali già sollevate in età graccana sono la distribuzione delle terre pubbliche, la cittadinanza (e poi l’effettiva integrazione) per gli italici, la composizione delle corti giudicanti (soprattutto nei processi de repetundis, vale a dire per concussione), il controllo della politica estera e delle provinciae, nonché l’uso delle imposte che foraggiano tanto Roma quanto la sua numerosa e spesso inoccupata plebe. A esse se ne aggiungeranno altre.
Mario, la guerra giugurtina e la riforma dell’esercito
Il senato, naturalmente, tenta di riprendere il controllo della situazione, stroncando la fazione graccana ma non affossandone completamente il programma. Le distribuzioni di grano, così come la creazione di colonie, vengono limitate ma non sospese. La liberazione dai vincoli di inalienabilità delle terre già assegnate vanifica invece la riforma agraria, agevolando il ritorno del latifondo.
Proprio in questo clima, sospeso tra restaurazione e accettazione di riforme ormai ineluttabili, trova spazio un personaggio che riuscirà a guidare per un ventennio le sorti della repubblica: Caio Mario esponente di spicco dei populares. Uomo "nuovo" (non appartenente alla nobilitas senatoria) e originario di Arpino, inizia la carriera politica sostenuto dalla potentissima casata dei Metelli. Tribuno della plebe nel 119 a.C., si oppone all’ampliamento delle distribuzioni di grano (che, tra l’altro, attirando gli indigenti nell’Urbe, rischiano di vanificare ancor più la riforma agraria graccana). Pretore nel 115 a.C., si stacca dai Metelli; nel 111 a.C. stabilisce un legame con un’altra famiglia di antichissima nobiltà, sposando Giulia (zia del futuro Caio Giulio Cesare).
Mario si distingue soprattutto nel corso di una nuova guerra africana. Roma, dopo la distruzione di Cartagine (146 a.C.), aveva cercato di garantirsi da resurrezioni dell’antica rivale favorendo la vicina potenza occidentale, la Numidia. Dopo la morte di Massinissa, il figlio Micipsa vi aveva costituito un florido regno, che aveva lasciato poi ai figli naturali Aderbale e Iempsale e all’adottivo Giugurta (118 a.C.). Questi, il più brillante e deciso, il secondo ed esiliato aveva ucciso il primo che si era rivolto a Roma per ottenere aiuto. Causa del successivo conflitto è però Giugurta, il quale nel 112 a.C. fa sterminare la numerosa comunità di commercianti italici della capitale Cirta (l’odierna Costantina), che aveva difeso Aderbale, là assediato. Spingono per la guerra cavalieri e plebe urbana: desiderosi di vendetta, convinti che i senatori siano corrotti da Giugurta, o, più in generale, ben consapevoli degli immediati benefici di un’impresa imperialista. Inizia le operazioni, nel 111 a.C., il console ottimate Lucio Calpurnio Bestia, la cui fanteria viene però sbaragliata dagli agili cavalieri nemici; segue un accordo, che fa scoppiare un vero e proprio scandalo (Giugurta, giunto a Roma per trattare, non si lascia neppure sfuggire l’occasione per farvi assassinare un cugino rivale). Dopo altre spedizioni e altrettanti episodi sfavorevoli alle armate romane, guidate da comandanti poco motivati, nel 109 a.C. il console Quinto Cecilio Metello riesce a risollevare la situazione e, con essa, il buon nome della nobilitas. Quando però Giugurta porta dalla propria parte Bocco, re della più occidentale Mauritania, Mario, che milita in quel momento sotto Metello, chiede e ottiene il permesso di tornare a Roma, per candidarsi al consolato.
Viene così eletto alla suprema magistratura, ma non solo. L’assemblea del popolo, ormai diffidente nei confronti del senato – nel frattempo sottoposto a inchieste –, s’intromette in una questione propria di quel consesso e, con procedura inedita, assegna a Mario il comando delle operazioni. Tornato in Africa nel 107 a.C., il console conclude la guerra nel giro di due anni, anche grazie a un accordo con Bocco, gestito da un questore, giovane ma già abile politico: Lucio Cornelio Silla. Con la cattura di Giugurta – condotto nell’Urbe e gettato in carcere – ha fine un conflitto che mai aveva costituito una minaccia per Roma, ma che ne aveva pesantemente intaccato il prestigio.
Decisiva è la riforma dell’esercito. Un diverso addestramento ed equipaggiamento rendono le legioni più manovrabili e autonome. Nuovo è anche l’arruolamento: per la prima volta vengono impiegati, in maniera sistematica, i nullatenenti, che iniziano così a ricevere una paga. Anche in questo caso i numeri ci sarebbero di grande aiuto; possiamo tuttavia osservare che, in un mondo che sino ad allora ha applicato, per ogni cittadino, proporzionalità tra rilevanza politica e oneri militari (in gran parte a carico del privato), entrano con prepotenza i "professionisti". Essi, fortemente legati – come del resto in molti altri contesti storici – al proprio comandante, guadagnano sempre maggiore peso politico, sia in ambito elettorale sia, addirittura, minacciando dall’esterno la stessa "società civile".
Mario sconfigge Cimbri e Teutoni
La politica non ama i vuoti. Quello aperto, sulla scia dei rovesci subiti in Africa, dalla classe senatoria – e più nello specifico dalla nobilitas dominata dagli optimates –, è molto ampio. Mario può così, dal 104 a.C., essere console per cinque anni consecutivi, divenendo autore di altre decisive vittorie, quali quelle su Cimbri e Teutoni.
Erano, queste, popolazioni di stirpe germanica che, da circa un decennio, stavano dando a Roma seri problemi. Allontanate nel 113 a.C. in uno scontro presso Lubiana, dopo qualche tempo avevano aggirato l’arco alpino e sgominato un’armata romana nella Gallia orientale. Il senato, terminata la guerra giugurtina, aveva ordinato nuovi arruolamenti, che non avevano impedito tuttavia la catastrofe di Arausio (l’odierna Orange), dove nel 105 a.C. erano morti ben 80 mila legionari. Dopo una fase di attesa, i barbari iniziano, nel 102 a.C., a dirigere verso sud un altro ancor più pesante attacco. Ai Romani non resta che sperare in Mario.
La direttrice principale viene portata dai Teutoni contro l’esercito del console, nella valle del Rodano; dopo molte schermaglie, egli si precipita su di loro ad Aquae Sextiae (l’odierna Aix-en-Provence), facendo innumerevoli vittime e altrettanti prigionieri. I Cimbri, invece, erano già entrati in Italia dalla valle dell’Adige, aggirando le armate che avrebbero dovuto presidiarla; ancora una volta è Mario a intercettarli e sconfiggerli presso Vercelli, in un ancor più spaventoso massacro.
Il pericolo proveniente dal sempre minaccioso settentrione svanisce, mentre la gloria del console popularis, se possibile, cresce ancora.
Mario, per anni al centro dell’attenzione pubblica, alla politica interna pare sempre preferire l’impegno militare, sia per indole sia perché così richiesto dalle circostanze.
Lo scontro tra populares e optimates, nonostante la palese affermazione dei primi, sta solo covando sotto la cenere. Protagonista di questa fase è Lucio Appuleio Saturnino, tribuno nel 103 e nel 100 a.C. Egli abbassa il prezzo politico del grano, progetta per i veterani di Mario – ormai legati a doppio filo ai buoni uffici del comandante e alle finanze di Roma – nuove colonie nelle zone appena pacificate di Africa e Gallia, idea infine un tribunale per la maiestas - lesa maestà e tradimento verso il popolo romano. Promuove la propria azione legislativa con la violenza: è questo un errore nell’immediato e un pessimo esempio per i decenni a venire. Un altro errore gli costa ancora più caro: il disegno di aprire le nuove colonie anche agli italici fa infatti esplodere la rabbia della plebe urbana, gelosa dei propri piccoli privilegi e sapientemente istigata dal senato.
Proprio Mario, l’alleato più naturale, abbandona Saturnino, che viene ucciso durante gli scontri di piazza organizzati dagli optimates: con un altro senatus consultum ultimum, il senato aveva chiesto e ottenuto che il console popularis prendesse in mano la situazione. La legislazione di Saturnino viene subito abrogata.
La guerra sociale
Dopo un decennio di relativa calma interna, il problema irrisolto e ormai pressante degli italici finisce per esplodere. Ciò avviene nel 91, quando il tribuno Marco Livio Druso, pur vicino alla nobilitas, vara, attraverso il concilium plebis, una nutrita serie di riforme. Tra queste, l’abbassamento del prezzo politico del grano, la distribuzione di terre, la creazione di colonie e, probabilmente per finanziare tutto ciò, la svalutazione della moneta argentea (introducendo nel conio un ottavo di rame). Propone inoltre, per risolvere il problema della composizione delle giurie de repetundis, l’entrata di ben 300 cavalieri tra i senatori, raddoppiandone pressoché il numero. È, questa, una soluzione in aperto contrasto con la logica che guida il supremo consesso di Roma, che perpetua se stesso cooptando gli ex magistrati. In breve, l’articolato programma di Druso, pensato per conquistare il sostegno di ampi settori della cittadinanza, è sgradito ai più. Al tribuno non resta che proporre ciò cui aveva puntato sin dall’inizio: la cittadinanza romana per gli italici. Il progetto, dirompente – in quanto capace di modificare la società intera e, con essa, i rapporti di forza nel corpo elettorale –, non viene accettato neppure dai suoi più fedeli sostenitori. Senatori, cavalieri e plebe urbana si sollevano; le leggi di Druso vengono abrogate ed egli resta ucciso in circostanze mai chiarite.
Giustizia e politica
A partire da Montesquieu (1689-1755), uno dei concetti alla base del costituzionalismo moderno è la separazione dei poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario. Roma aveva chiara l’idea (già aristotelica e poi polibiana) di ‘costituzione mista’ (con aspetti monarchici, oligarchici e democratici), ma si concentrava più sull’equilibrio tra istituzioni e corpo sociale che sulla differenziazione tra funzioni. Il meccanismo del processo penale, nella sua commistione tra giustizia e politica, ne è prova evidente. Originariamente nelle mani del re, passò poi, con la repubblica, all’assemblea popolare (che in ogni caso aveva l’ultima parola in caso di condanna a morte). Nel II secolo a.C. nacquero apposite commissioni d’inchiesta, le quaestiones extra ordinem, per indagare su reati a sfondo politico; sul loro modello, a partire dal 149, si affermò poi la quaestio perpetua (tribunale permanente) de repetundis, per le tecnicamente difficili e politicamente delicate indagini sulle concussioni dei governatori delle provinciae: il provinciale, non cittadino romano, poteva ottenere giustizia solo appellandosi al senato, che istituiva la commissione. Da allora diverse leggi modificarono la provenienza sociale dei giurati (senatori, cavalieri e a un certo punto anche tribuni aerarii): inutile dire quanto la questione fosse politicamente importante. Allo scadere del mandato dei governanti – sinché in carica non perseguibili – si presentava infatti una finestra temporale durante la quale poter ‘bruciare’ loro, con un’inchiesta o meglio una condanna, il passo successivo nella carriera. Il sistema delle quaestiones perpetuae, presiedute da pretori, si allargò, soprattutto con Silla, ad altri aspetti penali: maiestas, peculato, corruzione elettorale, falso, omicidio e – forse – ingiurie gravi. Di fronte alle quaestiones, che si tenevano nel Foro, si svolse gran parte della carriera oratoria di Cicerone; la folla, che non poteva più giudicare, accorreva ugualmente numerosa, incuriosita e attirata dalla fama dei personaggi coinvolti.
Se Roma pensa di limitarsi a nominare una commissione d’inchiesta, improvvisa e cruenta è la reazione degli italici. Con un massacro di cittadini romani consumatosi ad Ascoli alla fine del 91 a.C., prende infatti il via la guerra sociale, vale a dire la sollevazione in armi dei socii, gli alleati di un tempo. I ribelli, saldamente arroccati nelle zone montuose – centrali e meridionali – della penisola, nonché sulla fascia costiera del medio Adriatico, in una regione più estesa di quella direttamente controllata dall’Urbe, creano in breve tempo uno stato federale con capitale Corfinium (l’odierna Corfinio), rinominata Italia o Italica. 100 mila guerrieri con istituzioni politiche simili a quelle di Roma sfidano così l’antica alleata. Vera e propria guerra civile, essa viene combattuta da ambo le parti tra insidie e difficoltà: i contendenti possiedono infatti le stesse, ormai collaudate tattiche militari.
Cosa vogliono gli italici, scesi in campo così repentinamente? Nonostante numerosi dibattiti – molti di epoca risorgimentale, quando la ribellione contro Roma sembrava "attuale" – non è ancora chiaro, così come intricate sono le fasi del conflitto. Probabilmente alcuni (i Sanniti) aspirano all’autonomia, altri (le popolazioni più a settentrione) alla piena integrazione; anche questa differenza di fondo va considerata fatale alla causa. La secessione ha però messo in luce che esiste un’"altra" Italia. Contro di essa, Roma arruola 150 mila uomini; dopo il vantaggio iniziale dei rivoltosi, cui non è estraneo il fattore sorpresa, le sorti si ribaltano.
Importanti operazioni vengono condotte da Cneo Pompeo Strabone (padre di Cneo Pompeo "Magno", il futuro "triumviro") e da Silla, che di Mario era stato valido aiuto durante la guerra giugurtina. Nel settore settentrionale, Strabone conquista Corfinium e assedia Ascoli; in quello meridionale, Silla riporta una vittoria decisiva in Campania, lanciando poi le truppe in un’invasione sistematica e cruenta del Sannio.
Le armi della diplomazia sono tuttavia, come di frequente, le più affilate: ancora una volta, Roma riesce a dividere il nemico. Mentre i combattimenti imperversano, la maggior parte dei ribelli accetta infatti le concessioni di cittadinanza offerte da un paio di leggi consolari, promosse nel 90 e nell’89 a.C. con il sostegno del senato e rivolte a chi rifiuta di scendere in guerra.
Dopo non molto tempo, l’insidiosa lotta per la sopravvivenza ha fine, mentre aumenta notevolmente – raddoppiando nel giro del ventennio successivo – il numero dei cittadini romani, all’inizio prudenzialmente inseriti in una parte limitata – otto o dieci – delle 35 tribù territoriali. Una più ampia distribuzione avrebbe potuto infatti, in quel sistema "maggioritario puro", creare un forte – anche se coerente – squilibrio in favore dei nuovi arrivati. L’incorporazione diretta di un territorio così vasto e articolato, anch’essa senza precedenti, richiede un ordinamento unitario: le comunità vengono così organizzate secondo lo schema del municipium, nucleo urbano retto da un collegio di quattro magistrati e in stretto dialogo con l’Urbe.