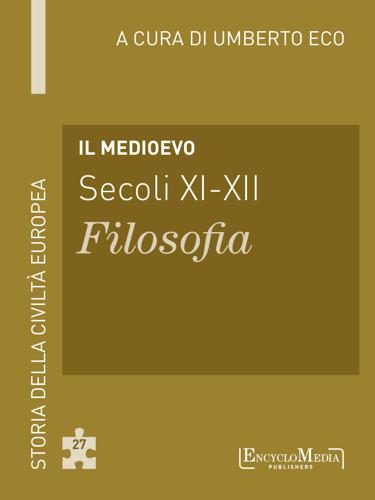Donne intellettuali
Donne intellettuali
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Nonostante l’orientamento misogino di larga parte della società medievale, non è raro incontrare donne che sappiano leggere e scrivere. Non si tratta solo di donne nobili che amministrano le loro terre o di mogli di mercanti che seguono gli affari di famiglia. In vari casi si tratta di vere e proprie intellettuali che mettono su carta, o addirittura predicano, le proprie idee teologiche e filosofiche.
Donne che scrivono
Ildegarda di Bingen
Visioni di Ildegarda
Lettera di Ildegarda di Bingen a Bernardo di Chiaravalle
Padre, questa visione mi sconvolge profondamente: mi appare nello spirito dei misteri e non la vedo con gli occhi del corpo. Io misera, e più che misera nel mio nome di donna, fin dall’infanzia vidi cose meravigliose, che la mia lingua non potrebbe riferire, se lo Spirito Santo non gliele avesse insegnate.
in Corpus Christianorum. Continuatio Medievalis
Christine de Pizan
Uguaglianza fra uomini e donne
La città delle dame
[…] Se Dio ha voluto mostrare espressamente agli uomini che le donne non hanno l’audacia e la forza fisica che gli uomini hanno normalmente, ciò non significa che essi debbano dire e tantomeno credere che al sesso femminile siano precluse tali forze e audacia: molte donne hanno dimostrato grande forza, coraggio e ardimento, tali da intraprendere e realizzare grandi cose […].
C. de Pizan, La città delle dame, a cura di P. Caraffi, Milano-Trento, Luni, 1997
La cultura filosofica e teologica medievale non lascia molto spazio alle donne. Le forme di restrizione di accesso alle attività e agli spazi pubblici si applicano anche allo studio: le donne sono escluse dalle scuole monastiche, dalle scuole cittadine, dalle università, dai collegi e da ogni altra istituzione scolastica. Fin dall’epoca dei Padri viene vietato alle donne di parlare in pubblico (e quindi di insegnare) sulla base delle parole di san Paolo: “le donne devono tacere nelle assemblee. A loro infatti non è permesso parlare”(I Cor. 14), un divieto che verrà ripetuto per secoli. Sulle donne si abbattono molte critiche: sono viziose come Eva, possiedono la ragione in modo inferiore agli uomini, sono incostanti e deboli. Ciononostante sarebbe sbagliato pensare che non vi siano donne intellettuali degne di interesse. I modi in cui compaiono e in cui vengono considerate dalla società sono molto diversi da quelli dei maestri delle università. La loro educazione non è tradizionale, i testi che leggono non sono facilmente rintracciabili, la loro lingua è lontana da quella formalizzata delle università e delle scuole.
Le donne che scrivono opere letterarie, religiose, filosofiche sono più di quante si pensi. Tra queste possiamo individuarne alcune particolarmente importanti per la storia del pensiero filosofico. I temi su cui si concentrano variano da autrice ad autrice: riflessioni etiche, politiche, religiose. In linea di massima si tratta di donne in qualche modo “eccezionali”, che molto spesso riflettono e motivano la loro singolare condizione di donna che scrive. Ciò lascia lo spazio, in alcuni casi, anche a una riflessione sulla donna e sulle possibilità di divulgare le proprie idee in contrapposizione ai divieti vigenti nella società.
Dhuoda: un “manuale” per il figlio lontano
Consideriamo Dhuoda, che vive in età carolingia. È una donna dell’alta nobiltà, andata in sposa a un cugino dell’imperatore Carlo Magno nell’824. La sua particolarità è di aver composto un libro, il Liber manualis. L’opera appartiene al genere degli Specula principum, testi scritti per insegnare ai principi i doveri del loro rango, l’esercizio della virtù, il rispetto della legge divina. Perciò Dhuoda è, a suo modo, una scrittrice politica, in un periodo in cui non esiste una chiara distinzione tra etica e politica. L’elemento particolare di questo speculum è di essere dedicato non a un futuro regnante, ma al proprio figlio, che va ostaggio presso l’imperatore Carlo il Calvo per sancire un accordo di pace. Gli ammonimenti che Dhuoda rivolge al figlio esprimono alcune idee relative al ruolo dei potenti rispetto alla società e al sovrano. Si soffermano sulla fedeltà dovuta ai superiori (Dio, il proprio padre, il proprio signore) e ai compagni d’arme. In alcuni capitoli dell’opera troviamo riferimenti all’importanza della matematica, della preghiera, della lettura. Ai valori del cristianesimo e dell’uomo d’arme se ne aggiungono altri come la gioia e la misura nei comportamenti. Lo scritto di Dhuoda resta per noi tanto una testimonianza degli ideali politici di un’epoca quanto dell’affetto e del desiderio di educare provato da una madre.
Eloisa: un’etica per l’amore
Tutt’altro caso è rappresentato da Eloisa. Fatta istruire dallo zio Fulberto, è allieva, amante e poi moglie di Abelardo, prima di entrare in monastero. Le lettere che l’hanno resa famosa risalgono al periodo in cui è badessa al Paracleto.
Ripercorrendo la vicenda del suo amore con Abelardo, usa la dottrina dell’etica dell’intenzione elaborata da Abelardo stesso per giustificare la scelta di amare fuori dal matrimonio e criticare i suoi comportamenti attuali. Ciò che conta – dice infatti – è l’intenzione e Eloisa ha amato Abelardo per se stesso, non per sposare un uomo importante e per godere dei suoi beni: “Ho compiuto un grande male, ma sai che sono innocente: la colpa infatti non sta negli effetti dell’azione, ma nell’intenzione di chi la compie [...] e quale animo io abbia avuto verso di te, solo tu che lo hai provato, lo puoi giudicare” (Lettera II). E viceversa, le lodi che riceve ora per il suo comportamento di badessa sono immeritate, perché alla correttezza esteriore corrisponde un’intenzione diversa, un animo ancora rivolto ad Abelardo e non a Dio. Eloisa è al femminile una testimonianza degli sviluppi della cultura del suo tempo, in particolare dell’idea dell’amore disinteressato (che deve molto al concetto ciceroniano di amicizia) e dell’etica dell’intenzione.
Ildegarda di Bingen: le visioni e razionalità del mondo
Coeva di Eloisa, è un’altra donna scrittrice: Ildegarda di Bingen. La ragione della sua eccezionalità sta nel dono carismatico che ha ricevuto. Nata in una famiglia della nobiltà renana, fin da piccola vive in un monastero e riceve delle visioni, di cui mette al corrente solo la nutrice. Anni dopo, una malattia la rende consapevole del ruolo scelto per lei: deve rendere pubbliche le sue visioni, riportare la cristianità sulla strada della virtù, combattere le eresie. La fama di Ildegarda si diffonde e la sua prima opera Scivias (Conosci le vie) viene letta e approvata dalle autorità ecclesiastiche. Questo evento costituisce uno spartiacque importante nella vita della visionaria: da quel momento Ildegarda intensifica la sua attività letteraria, intrattiene rapporti epistolari con uomini di Chiesa, con l’imperatore Federico Barbarossa, con l’imperatrice di Bisanzio, con il papa.
Le visioni di Ildegarda sono strutturate in modo preciso. A una visione, a volte accompagnata da parole, segue una spiegazione, anch’essa di origine divina. Ildegarda si presenta perciò come un semplice intermediario e adotta la sua scarsa cultura e la conoscenza limitata del latino quali prove: potrebbe forse una donna fragile e incolta vedere e ascoltare cose tanto importanti e profonde, se non perché scelta da Dio? Alcuni temi delle opere di Ildegarda sono particolarmente interessanti. La prima visione del suo Libro delle opere divine è tutta orientata a mostrare l’unità, l’armonia e la razionalità del cosmo: “Io – dice la voce di Dio nella visione – sono la razionalità col suo vento che è verbo risonante, attraverso il quale ogni creatura è stata fatta [...] Io sono il sostegno di tutto, perché tutte le cose vitali ricevono da me il loro ardore” (I, I, 2, in Ildegarda di Bingen, Il Libro delle opere divine, a cura di Marta Cristiani e Michela Pereira, 2003).
Benché non sia reso esplicito, è verosimile che l’intento fosse criticare la visione dualistica del mondo proposta dai catari. Per confutare l’idea di un mondo disarmonico e devastato dalla lotta tra un principio positivo e uno negativo, Ildegarda sostiene che dalla razionalità divina non poteva discendere che un universo razionale. La razionalità di cui parla si esprime nelle corrispondenze tra i livelli del cosmo, nei richiami interni, nella struttura triadica di tante cose che rievoca la Trinità. Alle opere visionarie (oltre a quelle già citate, ricordiamo il Liber vitae meritorum) si aggiungono quelle medico-fisiche (la Physica e il Causae et curae), nelle quali Ildegarda espone sia una teoria degli umori sia numerosi rimedi alle malattie.
Margherita Porete: l’annullamento della volontà
Ildegarda è la prima di un nutrito gruppo di donne carismatiche. La Chiesa ha un atteggiamento complesso nei loro confronti: cerca di valutare se si tratti di carismatiche autentiche, di impostori o di possedute. Giudica gli scritti. Invia esaminatori e confessori a controllare le mistiche. A seconda dei casi vengono condannate o santificate o più spesso semplicemente accettate con sospetto. Attorno a esse si creano cerchie di seguaci. È un curioso e interessante paradosso: da un lato la società medievale pensa che la donna debba essere confinata negli ambienti privati, fatta tacere perché è condannata alla subalternità, vuoi per la sua debole costituzione fisica, vuoi per il peccato di Eva, vuoi per una supposta inferiorità della sua ragione. Dall’altro però la medesima società è pronta ad accettare e dare ascolto a donne che proclamano di avere visioni e predicano di vivere in umiltà. Una duplicità di ruoli che la cultura medievale esprime attraverso due figure della storia della salvezza: Eva da cui proviene il peccato, Maria da cui proviene la salvezza.
Se Ildegarda appartiene al numero delle mistiche approvate, due secoli dopo invece troviamo una mistica bruciata sul rogo, Margherita Porete. Di questa donna non sappiamo quasi nulla, se non che prima del processo che la condanna a morte aveva già subito un altro processo. La sua opera, lo Specchio delle anime semplici, scritto in volgare francese, conteneva una serie di tesi dubbie e un attacco deciso alla Chiesa istituzionale. L’opera è un dialogo a più voci che descrive la via per ricongiungersi a Dio attraverso il distacco dai beni terreni e l’annullamento della volontà. Di per sé non si tratta di temi estranei all’ortodossia della Chiesa. A colpire di più è probabilmente l’attacco ai teologi, all’uso della ragione che deve retrocedere davanti alla rivelazione della verità di Margherita, l’ostinazione dell’autrice, il circolo di lettori che aveva creato, le critiche alla Chiesa. L’opera conosce grande fortuna, nonostante la condanna, e supererà i confini della Francia.
Christine de Pizan: una donna in lotta per la parità
Tanto Dhuoda quanto Eloisa definivano se stesse “fragili donne”, interiorizzando una concezione della donna dominante nella cultura medievale. Christine de Pizan disse una volta di essere diventata uomo, di fatto accettando il topos della donna fragile, ma in seguito intraprenderà una battaglia culturale per affermare la parità dei sessi. Christine è un personalità eccezionale per molte ragioni.
Istruita dal padre Tommaso di Pizzano (un borgo vicino a Bologna) uomo colto, medico e astrologo al servizio di Carlo V, re di Francia, è costretta dagli eventi a trasformare la propria cultura in professione. Dopo aver perso in rapida successione il padre e il marito, si trova in ristrettezze economiche e con tre figli da mantenere. Intraprende allora una carriera da scrittrice, componendo, su commissione di esponenti dell’alta nobiltà francese, opere storiche e trattati etici. La strana decisione di suo padre di darle un’istruzione a largo raggio, che comprendeva anche testi letterari e filosofici, si trasformerà nella sua fortuna. Ha un grande successo, forse dovuto anche alla singolarità di essere una scrittrice donna. Le sue opere sono numerosissime: poesie come le Cento ballate, la biografia di Carlo V, opere sulla cavalleria, scritti politici come il Libro del corpo dello Stato e il Libro della pace. Alcune delle sue opere hanno un’impronta particolare: prendono posizione sul tema dell’inferiorità della donna, contestando i luoghi comuni misogini dell’epoca. Nella Città delle Dame Christine, che immagina di essere visitata da tre dame, Ragione, Rettitudine e Virtù, mostra con numerosi esempi che le donne sono in grado di comandare, sono intelligenti tanto quanto gli uomini, sono virtuose. A suo avviso sbagliano Aristotele, i chierici e tutti quelli che scambiano il dato sociale dell’inferiorità femminile per un dato di natura. Istruzione e possibilità di agire renderebbero infatti palese la parità di capacità e di doti.
Christine esprime una forma di autoconsapevolezza e una capacità critica uniche. Tra tutte le pensatrici del Medioevo è la sola che all’opera di scrittura unisce la volontà di rovesciare il rapporto di subalternità della donna all’uomo che tutte le altre autrici accettavano come ineluttabile. Christine assume se stessa come modello di quello che le donne potrebbero diventare, se solo fosse consentito loro uno studio degno di questo nome.