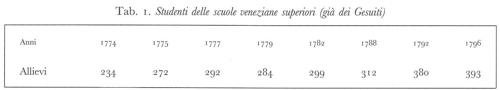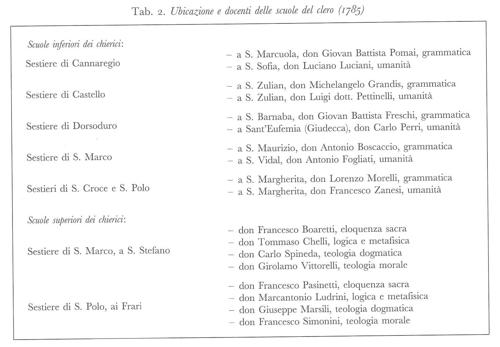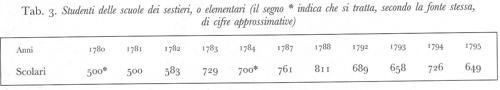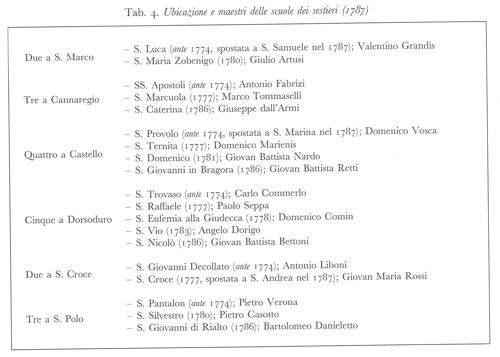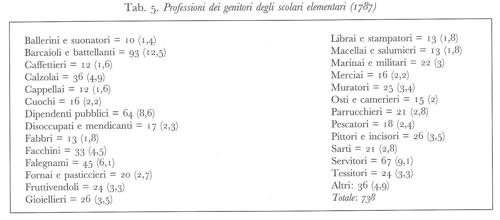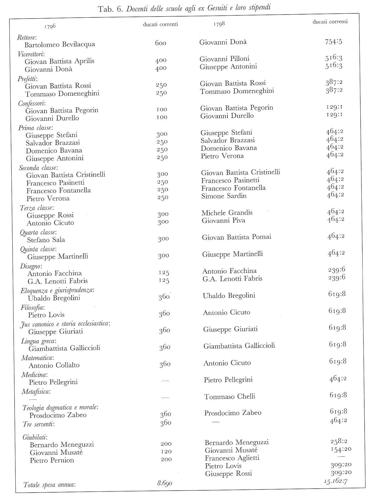Educazione, formazione, istruzione
Educazione, formazione, istruzione
Una gondola misura undici metri e qualcosina: nonostante sia dunque un’imbarcazione piuttosto lunga, il conducente riesce a manovrarla, a girarla anche nello spazio incredibilmente angusto dei canali veneziani.
Magari non ci si affatica più sopra come un tempo, forse non ci è più dato di vederlo curvo sul remo come lo ritraggono le tele del Guardi — intento com’è, oggi, ad imprecare contro i motori e, soprattutto, a non discostarsi troppo dalla barca con l’orchestrina, irrinunciabile orpello degli ubiquitari giapponesi , pure l’abilità è la stessa di un tempo, la tecnica con cui adopera la forcola in otto diversi modi è rimasta immutata nella sua perfezione.
Quel che voglio ricordare, insomma, in questa sorta di preambolo, è racchiuso nell’ovvia constatazione che il loro mestiere i lavoratori e gli artigiani di un tempo per solito sapevano farlo assai bene. La loro capacità ed efficienza erano proverbiali: questo vale per i barcaroli, quanto per gli arsenalotti, i vetrai muranesi... Per tutti costoro la cultura coincideva suppergiù con le conoscenze professionali, e qualche rudimento di religione (per le donne, solo questi ultimi); il popolo veneziano, ancora agli inizi del Settecento, era infatti largamente analfabeta: il leggere e lo scrivere rimanevano traguardi di pochi intelligenti ambiziosi oppure appannaggio dei foresti, campagnoli o montanari che fossero, ossia i lavoratori stagionali (guacortei, conzacareghe, spaccalegna, ombrellai) che in autunno scendevano dalla Carnia, dal Cadore, dal Bergamasco per prestare la loro opera, e che maggiormente avvertivano la necessità di comunicare tra loro e con le famiglie (1). Ma per i locali, ripeto, quale spazio poteva esserci per una diversa, superiore cultura?
Né più di tanto può valere la giusta obiezione che per solito quest’ultima significava allora erudizione classica, poiché val la pena di ricordare che anche nel campo più strettamente connesso alla pratica ed alle scienze esatte, qui tra le lagune, proprio nella città che nel mare aveva fondato la sua potenza e ricchezza, la prima vera scuola di nautica finalizzata all’addestramento dei quadri della marina mercantile sarebbe stata istituita solo nel 1739! Del resto, il paradosso non è maggiore di quello offerto nel corso dei secoli da una Repubblica che sappiamo dedita al commercio in buona parte transalpino, la cui Terraferma però era totalmente sprovvista di una rete viaria degna di talnome (2).
A questo punto, posto che la mancanza d’istruzione dei singoli non aveva costituito ostacolo né per l’efficienza dell’artigianato veneziano organizzato nella struttura corporativa, né per la produzione industriale tradizionalmente rappresentata al meglio dall’Arsenale, e neppure in generale per i bisogni di un complesso sociale che la maggior parte delle testimonianze coeve, italiane e straniere, giudicavano più funzionale, ricco ed alla fin fine «felice» di tanti altri, cerchiamo di vedere cosa successe di nuovo nel corso del Settecento in questa fascia sociale come pure nel settore nobiliare, di cui sinora non si è parlato, ed anche nei ceti della borghesia acculturata, quella degli impieghi statali e delle professioni qualificate: i quali ultimi soggetti — sostanzialmente patrizi e «cittadini» — costituivano categorie urbane certamente provviste d’istruzione e comunque ad essa sensibili, ma che tuttavia rappresentavano, con il clero, solo una minoranza della popolazione veneziana(3).
La situazione agli inizi del secolo nei suoi destinatari sociali:patriziato, borghesia, popolo
Patrizi
Una premessa, anzitutto: sin circa l’ottavo decennio del secolo, sino ai dinamici anni Settanta, nel settore dell’istruzione, tanto pubblica quanto privata, in Italia cambiò poco o nulla rispetto alla situazione seicentesca; pertanto le pagine che seguiranno avranno soprattutto la funzione di richiamare alla memoria una realtà già nota nelle sue linee essenziali.
Poiché la storia l’han sempre fatta, e soprattutto scritta, quelli che detengono il potere e la ricchezza, comincerò ovviamente da costoro, ossia dai patrizi.
A Venezia, secondo i calcoli di Beltrami, costituivano il 3,4% della popolazione e, com’è naturale, al loro interno presentavano una vasta gamma di articolazioni: v’erano anzitutto quelli che disponevano di largo o quantomeno adeguato censo, e che pertanto erano alla guida dello Stato, monopolizzando il senato e la sua zonta, seguiti dagli esponenti dell’ordine giudiziario, i cosiddetti quarantiotti.
In base al noto fenomeno della contrazione demografica che interessò il patriziato veneziano lungo tutto il corso dell’età moderna, e sulla scorta della testimonianza di Giacomo Nani (1756), a questi ceti andavano ricondotti almeno trecentodiciannove nuclei famigliari la cui consistenza possiamo valutare all’incirca sulle duemilacinquecento anime (4): ebbene, i felici rampolli di queste famiglie disponevano di un precettore privato, per solito un abate o un prete, che si recava (o addirittura viveva) nei loro palazzi, non di rado seguendo l’allievo anche nelle villeggiature autunnali. Egli era una sorta di filtro tra la servitù, assieme alla quale il ragazzo trascorreva gran parte della giornata, ed i genitori troppo assorbiti dalle cure della politica, dell’amministrazione patrimoniale e domestica, degli obblighi mondani.
Cosa apprendeva il giovanetto dal suo istitutore? Il leggere e lo scrivere, un poco di matematica e geometria, grammatica, dottrina cristiana, qualche stringata nozione di latino, retorica, filosofia morale, storia veneta, con l’ausilio di un paio di testi che presentavano vecchi centoni di retorica da mandare a mente ed una breve antologia di autori scelti, quali Petrarca e Tasso; assenti la geografia, le scienze naturali, la storia italiana ed europea. Quanto alle femmine, venivano collocate presso uno dei conventi che sorgevano numerosi in città o alla Giudecca, possibilmente dove già dimorava qualche loro zia: lì esse apprendevano il leggere e lo scrivere (quasi sempre stentatamente), i precetti religiosi, il ricamo, il canto e la danza (5).
Questo ciclo educativo aveva termine con l’adolescenza, allorché il fanciullo compiva quindici-sedici anni; dopo di che le ragazze rientravano in famiglia in attesa del matrimonio o si avviavano a prendere i voti, mentre i maschi (ma in sempre minor numero, con il progredire del secolo) proseguivano gli studi in qualche collegio per nobili. Questo normalmente veniva scelto fuori dai Domini della Serenissima, nei territori asburgici o, più facilmente, nei ducati padani o nelle Legazioni pontificie: a Torino, Bologna, Modena, Parma. Qui, nell’arco di un quadriennio, il giovane completava la sua educazione di «cavaliere», in vista soprattutto della funzione sociale a cui la nascita l’aveva destinato: studiava letteratura, latino, eloquenza, filosofia, morale cristiana; imparava a suonare uno strumento, a ballare, a recitare qualche pièce, e poi anche a tirar di scherma e a cavalcare. Una dissertazione, una tesina dal contenuto piuttosto generico concludeva questi studi (6); la laurea dottorale non s’usava: per gli esponenti del patriziato lagunare era diventata un’eccezione a partire dalla metà del Cinquecento, e comunque a Padova i genitori non ce li mandavano, un poco per le incessanti turbolenze di quegli studenti, ma soprattutto per evitare promiscuità e confronti con i «sudditi» (7).
Se dunque gli studi regolari s’interrompevano per il nobile ben prima del conseguimento della maggiore età, il suo processo di acculturazione, inteso come preparazione alla futura carriera politica, veniva sovente integrato con altre opportunità: ad esempio con la frequentazione dei «salotti» che le primarie casate solevano aprire a parenti e amici o agli illustri forestieri che non mancavano di inserire Venezia nel loro Grand Tour, oppure di qualcuna delle numerose accademie private presenti a Venezia, delle quali si dirà più avanti (in particolare, fra esse talune assolvevano alla funzione — destinata ad accentuarsi nel corso del secolo — di vere e proprie palestre finalizzate alla preparazione dei giovani patrizi alla vita politica), o accompagnando il padre o uno zio nelle ambascerie all’estero o più spesso nei rettorati del Dominio; era soprattutto questa la «scuola» che preparava alle future responsabilità, una finestra aperta sul mondo che liberava la mente dai lacci del ristretto recinto delle lagune. Dopo di che al patrizio ormai maggiorenne si aprivano le porte del Palazzo, dove vecchie volpi gli avrebbero tenuto lezione praticamente per tutto il resto della sua vita.
V’erano poi i nobili poveri, i cosiddetti Barnabotti, demograficamente in controtendenza rispetto ai ricchi e quindi per solito gravati da numerosa prole; i loro figli imparavano a leggere e scrivere tra le mura domestiche o presso una delle circa trecento scuole private presenti in città, dove in un’unica stanza un ecclesiastico teneva a bada sette od otto allievi; con qual costrutto — verso la metà del Settecento — c’informa l’abate Gian Antonio de Luca, in un sermone significativamente intitolato Sulla scarsezza de’ buoni maestri, del quale riporto un passo, a dire il vero orrendo per qualità, ma di inequivocabile efficacia (8):
I saggi sghignazzar non di rado io vidi,
che un chiericone e un pretazzuol che legge
sur il breviale, e altro non intende,
appicchi ciondoloni il suo cartello all’uscio tenebroso; e quattro panche
da un marangon piallate, a forza assetta
in un vil bugigattol, nidio a’ sorci, e muffato e puzzoso. Ei compitare
a spizzico saprà, ed i precetti
storpia, mozza e travolge; e queste forme
ribadendo al cervel de’ garzoni freschi,
gli fa secchioni sforacchiati al buono
e tegnenti al peggior.
Dopo di che, se non si faceva chierico, il garzone — presumibilmente già non più freschissimo — passava alle scuole dei Somaschi alla Salute o, ancor meglio, poteva tentare di essere accolto fra i quaranta convittori (saliti a quarantasei nel 1745) dell’Accademia dei nobili alla Giudecca, l’istituzione promossa dallo Stato nel 1619 per ovviare al venir meno delle strutture educative in precedenza assicurate dai Gesuiti, espulsi dai territori della Repubblica in seguito alla crisi dell’Interdetto: qui era seguito dai Somaschi (quantomeno a partire dal 1724, allorché questi Padri assunsero la direzione dell’istituto) per diversi anni — otto ed anche più — durante i quali apprendeva, sulla scorta del loro methodus, i primi rudimenti dell’alfabetizzazione, per giungere poi a seguire i corsi di umanità, retorica, filosofia, diritto, matematica e nautica.
Lì alla Giudecca non era affatto raro il caso di giovanetti che venissero letteralmente abbandonati dalle famiglie alle cure dello Stato fino al compimento dei vent’anni, sino alla vigilia dell’ingresso nella vita pubblica: un’indagine compiuta su un campione di dodici alunni, nel corso del Settecento, ha dimostrato che alcuni di essi mancavano persino del vestiario (9); con tutto ciò, non di rado l’indigenza economica si accompagnava col persistere di grette presunzioni classiste, incentivate dalla vicinanza di genitori e parenti che frequentavano pur sempre la sede del governo: per questo sin dal 1635 s’era pensato di creare a Padova analoga istituzione, in vista forse di un definitivo trasferimento dell’Accademia nella vicina Terraferma, ed il progetto non avrebbe mancato di ripresentarsi periodicamente, ancora nel 1669 e poi sino alle proposte avanzate da Gozzi nel corso degli anni Settanta, come si avrà modo di vedere.
Dati questi presupposti, è verosimile dedurne che i frutti sortiti dalla permanenza nel collegio non fossero dei migliori; tuttavia va detto che la qualità dei docenti doveva essere di buon livello, se dalla loro scuola — per limitarsi agli ultimi tempi dell’istituto — uscirono allievi quali Pier Antonio Zorzi, arcivescovo di Udine e cardinale nel 1803 Daulo Augusto Foscolo, arcivescovo di Corfù; lo scrittore e traduttore Francesco Gritti; infine, last but not least, Carlo Antonio Marin (ancorché la fama di costui sia tuttora riconducibile piuttosto al gran merito di averci portato da Corfù la bella e non mai lodata abbastanza Isabella Teotochi di cui fu il primo infelice marito, in attesa di passar la mano a Giovan Battista Albrizzi, che aveva dalla sua l’attrattiva di un robusto patrimonio con villa sul Terraglio): famoso dunque il Marin, dicevo, in grazia della celebre moglie anziché per i personali — peraltro indubbi e conclamati — talenti di economista e scrittore.
Infine alcuni pochi giovani (non più di venti-trenta unità) potevano essere ospitati, per frequentare l’Università di Padova, presso uno dei collegi colà istituiti a carico di talune specifiche commissarie, come quella fondata nel 1572 dal cardinale Marcantonio da Mula, a beneficio di dodici giovani patrizi (ovviamente poveri), studenti in legge (10).
Cittadini e borghesi
A Venezia, si sa, i cittadini (nell’accezione di cittadini originari, ossia descritti nel Libro d’argento) occupavano il primo posto in quella vasta gamma di umanità che noi oggi comprendiamo sotto la generica definizione di «borghesia». Essi erano per solito più ricchi dei Barnabotti e godevano di maggior prestigio, poiché monopolizzavano la burocrazia statale (a cominciare dalla cancelleria ducale) e la maggior parte delle professioni qualificate (medici, avvocati, notai). Accanto a loro, nobili di Terraferma o d’Oltremare ed esponenti della borghesia medio-alta (i cittadini che godevano dei diritti de intus e de extra, che li rendevano abili al commercio): titolari di qualche ufficio nel complesso apparato amministrativo della capitale, impresari, appaltatori, agenti, commercianti, ecclesiastici...
L’istruzione primaria dei loro figli non si discostava troppo, nel contenuto, da quella del patriziato benestante, in quanto affidata a precettori o scuole private dotate di sufficiente reputazione; le differenze comparivano invece quando si trattava di scegliere l’indirizzo di studi superiori: nella piazza di S. Marco, tra la Libreria marciana e le Procuratie, sussistevano ancora numerose strutture di impianto rinascimentale, volte soprattutto ad assicurare la preparazione dei quadri della burocrazia, la cui origine risaliva al Quattrocento, allorquando la Repubblica aveva dovuto ampliare il proprio apparato amministrativo in seguito alla conquista della Dalmazia e delle province padane. V’erano così le scuole di istituzioni civili e notarili, di filosofia e di logica, di lingua turca, di matematica, di medicina e chirurgia (queste ultime godevano del privilegio di poter conferire sino ad otto lauree all’anno, benché la media settecentesca non superasse ormai le cinque unità (11)); ancora, l’Accademia di pittura e scultura, quindi le scuole dei Conventuali ai Frari e degli Agostiniani a S. Stefano. Solo le famiglie meno abbienti mandavano invece i loro figli all’istituto che i Gesuiti avevano aperto presso il loro convento alle Fondamenta Nuove, sin dal 1657. Secondo un’inchiesta compiuta da Gasparo Gozzi alla fine del 1773 per conto della deputazione ad pias causas, esso era frequentato da un paio di centinaia di giovani «per lo più popolari, alcuni pochi civili, ma di ristrette fortune, o di famiglie aggravate da numerose figliolanze» (12): evidentemente la pregiudiziale antigesuitica durava fatica a spegnersi tra le lagune, nonostante la Ratio studiorum dei Padri rappresentasse pur sempre un impareggiabile strumento didattico che oltretutto consentiva l’accesso all’Università con buone garanzie di successo dopo cinque od otto anni (nel primo caso, oltre al latino, erano previsti studi di grammatica, umanità, retorica, greco, storia, geografia; nel secondo si aggiungevano a queste materie filosofia, astronomia, matematica, fisica, chimica); dopo un tirocinio prevalentemente incentrato su latino e grammatica, insomma, si era in grado di accedere alle facoltà di giurisprudenza, medicina e teologia nel vicino Studio padovano, poiché per molti di questi alunni — diversamente da quanto avveniva per i patrizi — la laurea costituiva un indispensabile requisito professionale.
Come per gli esponenti della classe nobiliare, anche per cittadini e borghesi non mancavano, in una città cosmopolita come Venezia (e dove l’attività editoriale era tradizionalmente fiorente), ulteriori opportunità di promozione intellettuale: a parte i teatri, che prima di Goldoni non rivestirono quasi mai una positiva funzione pedagogica, gli spiriti più avvertiti e sensibili ad istanze culturali avevano la possibilità di iscriversi a qualcuna delle numerose accademie private, dove l’amore per le lettere abbatteva in qualche modo le barriere sociali e garantiva alle migliori emergenze un poco di soddisfazione, grazie al primato dell’ingegno.
Oltre a tre sicuramente arcadiche (la Animosa, fondata sin dal 1698; la Partenia, nel 1714; quella presso i Camaldolesi nell’isola di S. Michele, esistente ancora nel 1727), sulla scorta della vecchia, ma pur sempre utile, compilazione del Maylender (13), ne ho contate almeno nove costituite fra il 1715 ed il 1760: la Albrizziana, fondata dall’editore Almorò Albrizzi nel 1724 con nascosti intenti speculativi ed ingloriosamente chiusa nel 1745, quella dei Concordi, operosa tra il 1760 ed il 1764 nel convento di S. Francesco della Vigna; dei Giocosi, sorta poco prima del 1714 dietro impulso di Alvise Foscari; la Gozziana, aperta dai conti Gozzi nella loro abitazione poco dopo la metà del secolo; quella dei Granelleschi, promossa da Daniele Farsetti tra il 1745 ed il 1761; degli Illesi, o Greca, sorta nel corso della seconda guerra di Morea; dei Planomaci, voluta dall’abate rodigino Medoro Rossi e protetta dal futuro doge Marco Foscarini, attiva tra il 1740 ed il 1772, dei Suscitati, fondata dal gesuita Annibale Lombardelli nel 1657 ed operante sino alla soppressione della Compagnia; degli Unisoni, presso la quale negli anni Trenta si raccoglievano i nobili della parrocchia di S. Gregorio. Il tema predominante era ovviamente rappresentato dalle esercitazioni letterarie, ma i Concordi si occupavano anche di storia ecclesiastica, i Giocosi di scienze, i Suscitati di filosofia, gli Unisoni di musica.
Come si è accennato sopra, taluni «salotti» patrizi si aprivano anche, sotto la superiore egida culturale, ad intellettuali e studiosi di diversa estrazione sociale: nella prima metà del secolo il palazzo di Girolamo Ascanio Giustinian senior, frequentato tra gli altri da Antonio Conti, ospitò nel 1734 Pietro Giannone; lo stesso Conti, assieme a Francesco Algarotti e Gianmaria Ortes, era tra gli habitués degli Emo a S. Simon Piccolo (il procuratore Giovanni e suo figlio Alvise), ed un nutrito campionario di presenti o futuri «spiriti forti», nobili e borghesi, si appassionava alla conversazione del francescano Carlo Lodoli.
Un cenno, infine, richiederebbero le diverse comunità presenti a Venezia, che però la mentalità e la legislazione del tempo consideravano straniere, in primis gli Ebrei (la cui istruzione soprattutto spirituale faceva capo ai centri di studio da essi gestiti (14)), quindi i Greci — che dal 1665 disponevano del Collegio Flangini (15) — e poi i Dalmati, gli Armeni, che davano vita a scuole proprie (anche queste peraltro quasi esclusivamente finalizzate ad intenti assistenziali-religiosi). Tutte queste istituzioni erano in grado di promuovere autonome iniziative editoriali, talora appoggiandosi a stampatori veneziani: «Nicolò Glikis [così Infelise, in un suo esauriente studio] dal 1670 stampava in greco, ed era specializzato in opere liturgiche. Disponeva di ingenti capitali e di un mercato sicuro, data la mancanza di tipografie nel mondo ellenico. I fratelli Cesti [Signorino e Samuele] stampavano in ebraico, mentre nel 1718 Antonio Bortoli ottenne un privilegio esclusivo di stampare in caratteri armeni» (16). Ovviamente, era l’intera società lagunare a beneficiare della positiva ricaduta di quest’attività multietnica.
Popolani
Facevo presente, in apertura di lavoro, l’abilità professionale dei lavoratori veneziani, che in gran parte ne costituiva pure l’appagamento culturale. I frutti di questo binomio li ha sottolineati non molto tempo fa Giorgio Pullini, rifacendosi alla testimonianza di un osservatore qualificato come Goldoni, reduce nella sua città dopo un periodo di assenza: «Che bel piacere [così il commediografo] in tempo di notte trovare le strade illuminate, e le botteghe aperte, e un’affluenza di popolo come di giorno, e un’abbondanza di viveri dappertutto, sino e dopo la mezza notte, come trovarsi in altre città la mattina al mercato! Che allegria, che vivacità in quel minuto Popolo! [...] Cantano i Venditori spacciando le merci o le frutta loro: cantano i Garzoni ritornando dalle botteghe alle loro case: cantano i Gondolieri, aspettando i Padroni: cantasi per terra e per acqua, e cantasi non per vanità, ma per gioia» (17).
Magari analfabeti dunque, ma contenti. E, a quanto pare, anche bravini nel lavoro: per la maggior parte di costoro, infatti, la «scuola» era fornita dalle corporazioni, dal microcosmo delle centinaia di Arti che da sempre formavano il tessuto connettivo degli abitanti delle lagune, producendo il duplice beneficio di assicurare agli iscritti un’autonomia che in taluni casi (ad esempio, l’Arsenale) poteva assumere le sembianze di una sorta di autogoverno, ed ai fruitori del prodotto finito, o del servizio, la garanzia di un’elevata qualità.
Come è noto, questo meccanismo produttivo qui da noi entrò in crisi nel corso del Settecento, che ne segnò la scomparsa; ma in questa sede il fenomeno ci interessa solo per i suoi risvolti pedagogici. Il lungo tirocinio, la lentezza dell’eventuale ascesa individuale nel mondo corporativo non era priva, infatti, di una propria componente educativa e morale, che trovava anzitutto nella rigida subordinazione del prestatore di lavoro verso i detentori del sapere tecnico la premessa ed il riscontro della gerarchia sociale in cui erano incardinate le società d’Ancien Régime. Fu questo, fu la paura del venir meno di tale potente calmieratore sociale, uno dei principali motivi che affossarono la riforma (intesa nel senso di abolizione) delle Arti veneziane che culminò nel tentativo portato avanti da Andrea Memmo nel 1772; ancora nel 1799, cioè dopo la caduta della Serenissima, l’istriano Apollonio del Senno di fronte al governo austriaco ne difendeva in questi termini — a dire il vero un poco tendenziosi — il valore educativo: «Un povero padre di famiglia, il quale non ha modi di far educare la propria prole, e non può, e fors’anche non sa educarla da sé, trova un mezzo sicuro nell’affidar il proprio figlio come garzone a un capomistro, che ne assume l’impegno con la propria responsabilità e col dovere preciso di educarlo per tre o per quattro anni, o per cinque anni continui [...]. Importando sopra tutto a questo capo d’arte che il di lui alunno sia onorato, sia fedele, sia attento, primo suo studio si è di renderlo ben istruito nelle massime di quella sola vera religione senza di cui non si dà, né può darsi vera e soda onestà [...]. Questa educazione dà all’arte il buon individuo, dà alla nazione il buon cittadino e dà al sovrano il suddito vero e cordiale, ben diverso dal suddito per interesse o per forza. La bontà e la docilità del basso popolo veneziano è un effetto di questa educazione» (18).
Facciamo pure la tara a tanto edificanti considerazioni, che certo ne hanno bisogno; un poco di conforto potremmo ricavarlo dal pensiero che non tutto il popolo veneziano risolveva nel tirocinio corporativo l’alfa e l’omega della propria educazione; per i meno sprovveduti v’erano pur sempre le scuole private, v’era qualche vecchio prete disposto ad insegnare i rudimenti del leggere e dello scrivere dietro corresponsione di una tenue somma. Assai meno frequentate erano invece, nonostante fossero gratuite, le sei scuole pubbliche elementari dette dei sestieri; di antica fondazione (erano state istituite con decreto senatorio del 23 marzo 1551), inizialmente prevedevano una duplice articolazione: a sei maestri di grammatica si affiancavano infatti altrettanti di umanità, ma gli uni e gli altri erano stati ben presto limitati a quattro.
Infine, secondo un programma stabilito con terminazione dei riformatori dello Studio di Padova del 4 novembre 1578, ribadito il 17 febbraio 1635 e nuovamente stampato pari pari il 26 agosto 1720, i maestri ormai ridotti a sei (uno per sestiere, senza più distinzioni tra umanità e grammatica) insegnavano in un’unica stanza italiano, latino e dottrina cristiana ad un imprecisato numero di allievi, tutti i giorni feriali, tre ore la mattina ed altrettante al pomeriggio: con qual frutto possiamo ricavarlo dal messaggio che l’8 marzo 1749 i riformatori in carica (Giovanni Emo, Marco Foscarini, Barbon Morosini) rivolgevano ai parroci veneziani, invitandoli a ricordare dal pulpito ai loro fedeli l’esistenza di queste scuole, «affinché per inscienza di così lodevole instituto non resti negletta da’ padri di famiglia la tanto importante educazione de’ figlioli nella religione, nella pietà e nelle belle lettere» (19). Frammezzo a tanto discredito, pure qualcuno trovava la forza di frequentarle e magari anche di continuare gli studi; in tal caso poteva poi approfittare dell’istituto dei Gesuiti alle Fondamenta Nuove, cui si è accennato sopra, o rivolgersi a realtà specificatamente tecniche, come la scuola di architettura navale, attivata presso l’Arsenale.
Quanto poi ad una vera e propria struttura destinata alla scienza ed all’istruzione marinaresca, ebbene scuole di tal natura a Venezia non ce n’erano, o meglio, non c’eran state fino alle soglie del quinto decennio del secolo: ma, data l’importanza dell’argomento e la sua singolarità, dedicherò ad esso il prossimo paragrafo, sperando ovviamente che il lettore non mi abbandoni prima.
Quanti infine allora avvertissero la vocazione ecclesiastica, o comunque avessero in animo di intraprendere quella carriera, potevano rivolgersi ad apposite scuole esistenti in ogni sestiere (in pratica, costituivano l’equivalente di quelle laiche, con le quali avevano in comune la temperie storica e culturale che ne aveva determinato la nascita: la quale risaliva, infatti, al 1525); queste erano affidate alla cura dei parroci, con la saltuaria supervisione di visitatori dipendenti dal patriarca; dopo di che, una volta appresi i primi rudimenti del sapere, il giovanetto entrava in uno dei due seminari, quello ducale tenuto dai Somaschi a S. Nicolò di Castello, e quello patriarcale a S. Cipriano di Murano, nei quali egli completava la sua educazione di futuro sacerdote (20).
Questo quadro, ancorché stringato, manca tuttavia di una componente fondamentale della società, ossia la donna. Il perché è ovvio e la spiegazione rapidissima: le nostre veneziane erano analfabete. Tranne poche mosche bianche, le loro conoscenze si esaurivano infatti nell’ambito della conduzione domestica e dei lavori tipicamente femminili, con qualche elementare ed il più delle volte approssimativa nozione religiosa.
La scuola di nautica
A guardar bene, solo l’apertura della scuola di nautica, nel 1739, venne ad interrompere il pacifico fluire di tanto grigiore nel sistema educativo cittadino: ma va detto subito che si trattò di un evento isolato, riconducibile ad istanze di ordine professionale e tecnico in uno specifico settore, oltretutto gravemente condizionato da una lacuna che mette a dura prova la credibilità del mito del buon governo marciano. Pare inverosimile infatti che una città immersa nell’acqua e che tanta parte della sua fortuna doveva all’opzione marittima, pare incredibile — dicevo — che in una tale città fino al Settecento inoltrato non si avvertisse l’urgenza di organizzare uno specifico istituto che si occupasse della formazione della gente di mare.
S’erano avuti, a dire il vero, alcuni tentativi, sia presso l’Accademia dei nobili alla Giudecca (1619), sia alla Libreria marciana, dove tra il 1634 ed il 1654 il maestro Francesco Natta aveva impartito lezioni sulla «carta da navegar», ma s’era trattato di iniziative effimere o comunque destinate a perire; un nuovo tentativo, nel 1682, rimase addirittura sulla carta. Sicché la vera scuola marinaresca per i Veneziani aveva continuato ad essere la pratica di bordo, dove la formazione avveniva non già attraverso la comunicazione scritta, ma con l’esperienza manuale e l’osservazione replicata infinite volte, e dunque su tempi lunghi: per solito, allora, gli aspiranti marinai risultavano già imbarcati in età adolescenziale, attorno agli undici-dodici anni.
Un qualche interessamento degli organi di governo alla questione comincia finalmente ad avvertirsi con gli inizi del Settecento, allorché la breve illusione della riconquista della Morea fa balenare nuove speranze per una rinnovata presenza della Serenissima nel Levante e, nel contempo, pone con maggior urgenza il problema della concorrenza mercantile dei paesi del Nord, che ora gli operatori realtini sembrano poter fronteggiare meglio, grazie anche al conflitto in atto tra quelle potenze e la coalizione borbonica.
Così, l’8 gennaio 1711 il senato incarica l’ambasciatore a Londra, Pietro Grimani, di reperire alcuni esperti di navigazione e tecnici disposti a trasferirsi a Venezia onde aprire «uno studio di nautica», ma il progetto non trova seguito, forse per il sopravvenire del conflitto contro i Turchi. Silenzio anche dopo, peraltro, quando l’Austria realizza il porto franco a Trieste e poi a Fiume (I 719), imitata di lì a qualche anno da Clemente XII ad Ancona (1732). Fu probabilmente quest’ultima «provocazione» — assieme alla recrudescenza della pirateria — a colmare la misura, così da spingere il senato (decreto del 1° agosto 1733) a promuovere l’istituzione di due maestri di nautica: uno per la Dominante (che doveva prestarsi ad insegnare qualcosina pure agli ospiti dell’Accademia dei nobili), l’altro da inviarsi a Corfù, la principale base navale della flotta del Mediterraneo.
I riformatori dello Studio, incaricati della realizzazione del progetto, si rivolsero al loro massimo esperto, il marchese Giovanni Poleni, che ricopriva presso l’Università padovana la cattedra di matematica: chiamato dunque a fornir parere sui nomi più accreditati ai quali appoggiare il nuovo insegnamento, il 1° maggio 1733 egli indicava Bernardino Zendrini, proto del collegio delle acque, e poi gli abati Suzzi e Crivelli, con la premessa che nessuno di costoro s’era mai occupato di nautica, ma quanto a matematica e geometria — discipline che di tal scienza costituivano il necessario presupposto ed il fondamento — non v’era chi potesse eguagliarli (21).
Carico di impegni com’era, e con l’impresa dei murazzi per la testa, Zendrini declinò l’offerta e così i riformatori decisero di dare intanto la precedenza alla sezione staccata nello Ionio, dove più che uno studioso si richiedeva un esperto di scienza marinaresca, quello che oggi si direbbe un tecnico.
La scelta cadde su un vecchio lupo di mare di Perasto, il capitano Francesco Bronza; a costui il decreto senatorio 24 aprile 1734 affidava nella sede corcirese un corso destinato all’aggiornamento dei quadri della flotta militare (22).
Al Levante, dunque, in qualche modo si riuscì a provvedere, mentre per Venezia si sarebbe dovuto attendere ancora qualche anno, fino cioè alla conclusione della guerra di successione polacca, che sottrasse all’Austria Napoli e la Sicilia, facendo svanire le ultime illusioni dell’ormai vecchio imperatore Carlo circa quell’affermazione in campo marittimo così tenacemente perseguita per tanti anni; ancora, ecco scoppiare imprevista la cosiddetta guerra «dell’orecchio di Jenkins» tra Inghilterra e Spagna.
Sotto la spinta di questa duplice concausa, cioè la crisi dei traffici dei maggiori paesi europei conseguente alla ripresa della conflittualità e la definitiva emarginazione austriaca dal settore mediterraneo, il senato assume delle iniziative, magari di modesta entità, ma non prive di significato: ecco dunque, nel 1739, l’acquisto dei vascelli di linea Kaiser Karl e Trieste, gioielli della smobilitante flotta asburgica, ed ecco finalmente l’istituzione di una regolare e permanente scuola di nautica, come venne chiamata, «da dove uscir dovevano persone atte a diriggere li bastimenti, per togliere con ciò il disordine di affidarli a’ forestieri o non esperti o mal affezionati piloti». A Corfù, dunque, la scuola militare; a Venezia quella «civile» finalizzata al commercio.
Una terminazione dei riformatori dello Studio, datata 17 settembre 1739, appoggiava la conduzione di quest’ultima — dietro suggerimento dei capi di piazza, ossia dei rappresentanti del settore mercantile — al capitano Giovanni Siron, un veneziano di grande esperienza che aveva lungamente soggiornato in Inghilterra e navigato su molti mari, dal Baltico ai Caraibi.
Interessante il piano didattico previsto, che in qualche parte potrebbe dar dei punti a quelli oggi adottati nel nostro felice paese: cinque giorni di lezioni alla settimana (domenica e giovedì liberi), con vacanze che ora suonerebbero alquanto strane, «concessi [...] restandogli quindici giorni di respiro nel mese di ottobre»; numero chiuso: diciotto alunni, scelti dai capi di piazza tra quattordicenni alfabetizzati; un positivo connubio teoria-pratica: dopo due anni di scuola, gli allievi dovevano imbarcarsi per quattro anni, con una piccola paga; al termine d’ogni viaggio erano tenuti a presentare al Siron un diario di bordo, con annotate «le variazioni magnetiche, corse, distanze ed altezze del polo, siccome [...] l’entrata ne’ porti, li rombi delle loro traversie, li segni per riconoscere ogni cosa al caso di avervi a ritornare, la scoperta delle secche se ve ne fossero, e li fondi de’ porti medesimi, dovendo parimente toglierli in pianta supposto di aver l’opportunità per farlo»; un esame conclusivo abilitava al grado di pilota (23).
Non si pensi al Siron come ad un vecchio ufficiale carico d’esperienza, ma ormai stanco e desideroso di tranquillità: infatti pur dopo molti anni, tra il 1760 ed il 1761, dovette affidare la sua scuola ad un supplente, Vincenzo Tommasi, essendogli stato ordinato di imbarcarsi sulle nuove «galere riformate», per collaudarle.
Quanto ai frutti del suo insegnamento, pare fossero confortevoli: ma su questo argomento si tornerà più avanti.
La svolta degli anni Sessanta
Un quadro dunque sostanzialmente statico e deludente, caratterizzato ad ogni livello da mancanza di rigore scientifico e di dottrina, ma puntualmente aperto all’approssimazione alla superficialità al lassismo: proprio come l’odierna scuola italiana.
Si è visto con quanta faticosa lentezza abbia proceduto l’unica innovazione attuata a Venezia, ossia la scuola di nautica; quanto all’altro polo culturale dello Stato — ossia Padova —, ebbene del suo già famoso Studio si sarebbe potuto dire stat magni nominis umbra, poiché i rari tentativi di svecchiarne l’impianto e gli insegnamenti (il piano Maffei del 1715, il progetto — pressoché coevo — di un programma di sviluppo scientifico, recentemente analizzato da Dooley (24)) non avevano trovato spazio per affermarsi, sollevando semmai timori e perplessità anche da parte degli spiriti più avvertiti: abbiamo visto, come, nel corso degli anni Trenta, un patrizio come Giusto Antonio Erizzo stigmatizzasse l’ambiente patavino, «ove nella confusione delle scienze e nella gara de’ bei spiriti, vi alligna una non sana e troppo nuova credenza» (25).
Sicché un vero mutamento complessivo si sarebbe verificato solo nel corso dell’ottavo decennio del secolo, negli anni Settanta, quando il dibattito illuminista e le proposte riformatrici che avevano investito anche la società veneta produssero i frutti più cospicui.
Prima a Padova qualcosa prese a muoversi con il «progetto Stratico» — su cui tornerò più avanti — attorno al 1760-1761 e, tra le lagune, all’indomani della «crisi queriniana» del 1761-1762, che portò alla luce il malessere dei Barnabotti.
Sino a quel momento le prioritarie esigenze della politica estera (le guerre di successione, l’abolizione del patriarcato aquileiese) avevano posto la sordina alle tensioni sociali interne, ma proprio un altro conflitto, quello dei Sette anni (1756-1763), finì per tradursi in un volano propulsivo per il commercio e la navigazione della Repubblica, le cui navi potevano muoversi liberamente nel Mediterraneo, sfruttando la copertura di una bandiera neutrale. L’economia veneziana prese a manifestare segni contraddittori: da un lato l’apparato produttivo si rivelava sempre più condizionato negativamente dalla pesante struttura corporativa, inadeguata a fronteggiare l’agguerrita concorrenza estera (un chiaro esempio è fornito dalla crisi dell’Arte della stampa, incapace di tenere il passo con i successi realizzati nella prima metà del secolo), dall’altro cominciavano ad avvertirsi gli effetti della positiva ricaduta dello sviluppo protoindustriale che ormai interessava vaste zone della fascia prealpina, dall’Alto Vicentino e Trevigiano alla Carnia, mentre qualcosa di nuovo davvero, qualcosa di importante accadeva nel mondo delle campagne, sino ad allora irrimediabilmente refrattario a qualsiasi innovazione: l’esempio partiva nel 1762 da Udine, dove la locale Accademia — già denominata degli Sventati — promuoveva al suo interno una specifica sezione agraria. «Poca favilla gran fiamma seconda», ed ecco il dibattito agronomico venire assunto dal governo: sotto la tutela dei savi alla mercanzia, nel 1764 usciva il «Giornale d’Italia» di Griselini, l’anno dopo si istituiva a Padova la prima cattedra di agricoltura, affidata a Pietro Arduino, nel 1768, infine, un decreto senatorio imponeva a tutte le accademie della Terraferma di trasformarsi in agrarie o, quantomeno, di attivare al loro interno una specifica sezione di tale natura: sappiamo che l’iniziativa fu accompagnata da plebiscitario consenso, che si propagò dalle province lombarde ai centri della Dalmazia; ma chi voglia saperne di più può rivolgersi all’altro mio contributo, dedicato appunto alle campagne, in questo stesso volume.
Forze vive, positivi fermenti non mancavano dunque di manifestarsi anche nel Veneto, sicché divenne sempre più evidente che il punto debole di questa realtà socio-economica consisteva proprio nel suo centro, in un sistema politico incapace di accompagnare, guidare, incrementare le potenzialità locali, creando infrastrutture idonee ed attuando provvedimenti di più moderno ed ampio respiro, finalmente sciolti dalla logica perversa della concessione personale, della grazia elargita in regime di monopolio.
In una parola, era necessario riformare la macchina statale, riorganizzando anzitutto l’apparato burocratico, secondo il modello che l’assolutismo asburgico e prussiano andava proponendo a tutta l’Europa. Occorrevano dunque uomini nuovi, e mezzi. Ma la reperibilità delle risorse finanziarie — e, più in generale, la stessa credibilità dello Stato dovevano anzitutto fare i conti con un pauroso deficit pubblico, che dopo l’ultimo conflitto con il Turco (1715-1718) e le tre costose neutralità armate attivate nel corso delle guerre di successione spagnola, polacca ed austriaca, era giunto a superare (1749) la soglia di 80 milioni di ducati, pari all’incirca alle entrate complessive di un quindicennio.
È ormai assodato che fu Andrea Tron — figlio di quel Nicolò che nel 1719 aveva fondato il complesso laniero di Schio — a tentare di risolvere il problema, coadiuvato da un gruppo di influenti senatori colti, ricchi e soprattutto non troppo sensibili agli scrupoli nei confronti delle prerogative ecclesiastiche.
Sarebbe stata infatti la Chiesa (o meglio, le pingui proprietà del clero secolare e regolare) a pagare i costi del risanamento del debito pubblico della Serenissima, analogamente a quanto andava facendo la corte viennese, dopo il fallito tentativo teresiano di scaricare sulla nobiltà la soluzione dei problemi finanziari che travagliarono l’Impero al termine del conflitto per la successione al trono. La manomorta, in fondo, storicamente assunse anche la funzione di un grosso salvadanaio: per decenni, per secoli si continuò a riempirlo; poi, quando le circostanze lo richiesero, lo si ruppe per far man bassa di quel che c’era dentro, magari con la scusa di reinserire nel circuito economico una quantità di risorse sottoutilizzate; questo avvenne in Italia nel Quattrocento e poi ancora nel Settecento.
Senonché per procedere contro la Chiesa a Venezia era necessario il consenso della maggioranza del patriziato, ossia bisognava fornirgli almeno due cose: motivazione ideologica e tornaconto personale, in omaggio al noto aforisma oraziano per cui «omne tulit punctum, qui miscet utile dulci».
La prima, la motivazione ideologica, nel periodo di cui ci occupiamo non poteva essere facilmente costituita dall’accusa di eventuali prevaricazioni romane nei confronti della Repubblica; c’era stato, sì, lo schiaffo dell’abolizione del patriarcato di Aquileia nel 1748-1751, ma la risposta non s’era fatta attendere (decreto 7 settembre 1754) e poi da allora era passata molta acqua sotto i ponti, e insomma nel Veneto il giurisdizionalismo era un fatto acquisito da lunga pezza. Il che finiva per stemperare non poco il clima anticlericale ed antigesuitico che, nel corso degli anni Sessanta, si respirò ovunque a pieni polmoni in Europa.
Fu il Tron — assieme ad Andrea Querini, Alvise Valaresso ed altri ancora — a far quadrare il cerchio: i beni del clero dovevano servire a migliorare anzitutto la sua condizione materiale e culturale, che ne aveva gran bisogno; questo edificante programma — forse sincero, certo costantemente ribadito in tutti gli atti pubblici che ne sottesero l’applicazione — sarebbe stato accompagnato, anzi, da significativi provvedimenti in favore dei poveri e dei derelitti e — soprattutto — dalla riforma di tutto il complesso educativo dello Stato, a cominciare dalle strutture peculiari del patriziato: fini gli uni e gli altri nobilissimi ed universalmente condivisibili, tali pertanto da tacitare anche le più serie obiezioni.
Quanto al secondo punto, al tornaconto, quello pubblico sarebbe consistito nel ridimensionamento del debito statale; quello personale nella possibilità di impadronirsi a buon prezzo di vaste e fertili proprietà nella vicina Terraferma. Non basta: studiando il caso dei Querini, Renzo Derosas ha dimostrato che l’intera operazione fu accompagnata da una ulteriore formidabile convergenza tra interesse collettivo e privato, dal momento che lo Stato accettò in pagamento per i beni ecclesiastici che furono posti in vendita anche titoli del debito pubblico da lungo tempo inesigibili, e per sopraggiunta valutati, nell’occasione, se non proprio al loro antico valore nominale, quantomeno ad una quotazione superiore a quella fissata dal mercato (26).
Lo strumento di questa vasta operazione fu la deputazione ad pias causas. Cosa fu è noto, e comunque il lettore non mancherà di trovarla adeguatamente spiegata e commentata in questo stesso volume. Ai fini del presente discorso, mi limiterò pertanto a ricordare che essa venne istituita il 12 aprile 1766 ed affidata all’entourage del Tron (i già ricordati Andrea Querini ed Alvise Valaresso, assieme a Gian Antonio da Riva), che in barba alla regola della contumacia poterono operare in essa con continuità, praticamente sciolti da controlli, per almeno sette anni. Compito dei deputati fu di equilibrare il numero degli appartenenti al clero, particolarmente quello regolare, in rapporto alle risorse di cui disponeva, applicando anzitutto il rispetto della «perfetta conventualità» stabilita dal Concilio tridentino, la quale escludeva la sussistenza di monasteri con meno di dodici frati o monache (27). Ne derivò la soppressione di centinaia di conventi, la quale venne seguita dalla vendita all’incanto dei loro patrimoni, sicché tra il 1769 ed il 1793 oltre undicimila ettari di terra passarono di mano, con un beneficio per le casse statali di quasi 6 milioni di ducati, dal momento che il ricavato dalle alienazioni venne fatto confluire nel deposito novissimo al 3% — aperto in Zecca l’anno precedente — formalmente per provvedere appunto alla sussistenza del clero, in realtà per colmare almeno in parte lo sbilancio statale.
Parte di queste entrate non furono devolute tuttavia a vantaggio dell’erario, ma vennero amministrate dalla cassa civanzi (5 resti) della deputazione, al fine di realizzare il programma sociale che le era stato affidato: il fondamentale decreto senatorio del 5 dicembre 1770, infatti, la incaricava di devolvere «ad usi insigni di carità» i beni dei regolari giudicati superflui al loro mantenimento; come si è anticipato, questi caritatevoli fini una successiva deliberazione del 3 settembre 1772 li avrebbe indicati esplicitamente — oltre alle provvidenze per il clero secolare più misero — negli ospedali per i mendicanti e nell’educazione della gioventù specialmente patrizia (28).
Fu quest’ultimo punto, sebbene concernesse un ristretto numero di persone, o forse proprio per questo, ad essere affrontato per primo e con la dovuta attenzione. Quanto ad un ricetto per i mendicanti, se ne parlava da tempo a Venezia, ma non se ne fece nulla: il progetto sarebbe stato periodicamente riproposto al governo dalle denunce dei provveditori alla sanità, soprattutto per motivi di decoro e di ordine pubblico (nel 1760, su una popolazione di 149.476 abitanti, i mendicanti erano ben 17.956, ossia costituivano il 12% delle presenze urbane), ma il triste spettacolo di quella miserabile folla di questuanti e derelitti non sarebbe mai stato eliminato, sicché vigoreggia tuttora.
L’obiettivo primario che i deputati ad pias causas s’erano prefissi consisteva dunque in una serie di riforme nel campo educativo: a riprova del tempismo con cui essi operarono, sin dal giorno stesso delle più gravi deliberazioni contro i regolari (7 settembre 1768) il senato — dietro loro istanza — aveva richiamato l’attenzione dei riformatori dello Studio di Padova su tutto il vasto settore dell’istruzione pubblica, affidando loro il compito di «informare su quale sistema si trattino più comunemente li studi medesimi, quale l’ordine nell’insegnamento e su quali principii e sentenze sieno appoggiate le opinioni, suggerendo quel regolamento che, rispetto alle pubbliche scuole di Venezia e dello Stato, potesse riuscire più proficuo e lodevole alle viste egualmente della religione e del governo» (29).
Anzitutto il patriziato: l’Accademia dei nobili
Da quando gli uomini abbandonarono le caverne e decisero di costruirsi delle case, le realizzarono sempre e dovunque partendo dalle fondamenta per poi giungere al tetto; se poi ora volessimo applicare questo stesso principio all’edificio scolastico — struttura non meno complessa e meritoria — un ovvio rispetto per il buon senso e la logica suggerirebbe l’adozione di analogo criterio in senso crescente: dalla base al vertice.
Senonché, essendo stato teoricamente inserito il problema dell’istruzione fra le primarie pubbliche cure in ogni tempo luogo regime, ma in realtà essendo poi esso risultato quant’altra mai remoto all’attenzione dei vari governi, non appena costoro vi avessero adombrato il più tenue aggravio per la finanza statale (a meno che compensato da immediata vistosa contropartita); non essendo, dicevo, assolutamente presa in seria considerazione la questione educativa neppure nella Venezia settecentesca: ebbene, quando la deputazione ad pias causas esibì con insolita dovizia mezzi non immaginati né richiesti, allora e solo allora si convenne che qualcosa si doveva pur fare, naturalmente in favore di quei settori che potevano garantire — per ricorrere all’odierna terminologia — una significativa ricaduta d’immagine: quali dunque se non l’Università ed il patriziato? Come dire: si comincia dal tetto.
Il decreto del 7 settembre 1768 era stato giustamente provvisto d’una copertura ideologico-morale, ossia la riforma del sistema educativo statale (del resto, mica si poteva dire: vogliamo i soldi dei preti e basta, non suonava bene); e così, magari non propriamente subitissimo, i riformatori dello Studio (Angelo Contarini, Sebastiano Foscarini, Andrea Tron) incaricarono di predisporre il programma un personaggio — questo sì — di notevole levatura: il conte Gasparo Gozzi.
Costui s’era ormai lasciato alle spalle il precario ruolo del gazzettiere per entrare gioiosamente a far parte dei ranghi della burocrazia veneziana come soprintendente alle stampe; inoltre era in buoni rapporti col Foscarini — nipote ed erede materiale e morale del doge Marco di grata memoria — e soprattutto col Tron o meglio, con l’ormai prossima e finalmente legittima moglie di quest’ultimo: Caterina Dolfin (30).
Benché il Gozzi non avesse alcuna particolare competenza nel campo pedagogico, o forse appunto per questo, i riformatori gli commissionarono una serie di relazioni e progetti abbraccianti l’intero apparato educativo statale, ai quali egli attese senza risparmiarsi fra il 1770 ed il 1775.
E così il 12 agosto del 1770 apparve la prima e fondamentale memoria Sulla riforma degli studi(3’), in cui Gozzi poneva sotto accusa l’intera organizzazione scolastica veneziana, basata su principi pedagogici retrivi, e suggeriva una serie di opzioni per i fruitori della futura scuola, tenuto conto dei vari ceti e classi sociali; con molto buon senso, insomma, egli osservava che il diritto allo studio andava applicato ad una realtà dove il massimo risultato prefigurabile era che «ciascuno sia atto e pronto all’osservanza delle leggi e capace di servire alla patria in quegl’impieghi che gli sono dalla sua condizione destinati»: inutile insomma insistere a propinare il latino ad un barcarolo o erudire nella retorica un vuotacessi (giusto per venire incontro al Baretti, noto fautore di questo benemerito ancorché mal rimeritato protagonista della società urbana (32)).
Esaustiva l’analisi del nostro conte, interessanti le sue proposte, ma quei volponi dei riformatori mica intendevano sovvertire secolari strutture dall’oggi al domani, e neppure creare troppi motivi d’imbarazzo ai poveracci che campavano insegnando quattro acche ai ragazzini; e così circa un mese più tardi, il 18 settembre, a loro volta essi si presentavano al senato con una relazione che sostanzialmente restringeva l’ampio respiro della riforma gozziana al solo ambito dell’educazione patrizia, argomentando che «come il bene di qualunque governo principalmente consiste dall’esser retto da uomini savi e virtuosi, così le speranze della continuazione dello stesso bene consistono nella buona educazione di quelli che hanno poi ad amministrare il governo medesimo».
Dopo di che, tramontata rapidamente l’iniziale idea di un nuovo collegio per ventiquattro ricchi patrizi disposti a versare ognuno la non tenue retta di 700 ducati all’anno, i riformatori pensarono di rivolgere la loro attenzione all’Accademia dei nobili alla Giudecca, essendo a tutti ben noto ch’essa di riforme aveva gran bisogno.
Gozzi ne suggeriva il trasferimento a Padova, un poco per esser quella la sede naturale dell’istruzione superiore dello Stato, in quanto la presenza dello Studio avrebbe potuto fornire docenti migliori e più validi strumenti didattici, un poco per allontanare dalle famiglie giovani spesso mancanti di tutto fuorché di pregiudizi e presunzione, un altro poco infine — ed era forse questo l’aspetto maggiormente interessante del progetto — perché egli ne caldeggiava l’apertura ai nobili di Terraferma ed addirittura agli esponenti delle famiglie «cittadine», le quali tradizionalmente fornivano i quadri della burocrazia veneziana.
Insomma, un collegio nella città euganea ad un tempo abbastanza vicina e sufficientemente lontana dalla Dominante —, destinato ad ospitare i rampolli delle classi che monopolizzavano la politica e l’amministrazione della Repubblica «per esservi ammaestrati sotto un’uguale istituzione diretta interamente dallo spirito e dalle leggi del principato, renderebbe [osservava Gozzi] assai più universali le consuetudini del Serenissimo dominio, legherebbe fra quegli ordini diversi, con più forti vincoli, la stima e l’affezione scambievole che nasce e si nudrisce in quella continua pratica giovanile, e per conseguenza sempre più s’assoderebbe la pubblica autorità».
Gran bel programma, talmente bello (anche a non scomodare Scipione Maffei ed il suo Consiglio politico, volto a cooptare in qualche forma di rappresentanza politica la nobiltà «suddita»); così bello, dicevo, che già si era pensato di attuarlo un paio di volte, nel secolo precedente, anche se in termini alquanto diversi. Pertanto, siccome non c’è due senza tre, pure stavolta non se ne fece nulla, evidentemente per lo spirito troppo innovatore che accompagnava il progetto, per le gravi implicazioni politico-sociali che una siffatta realizzazione avrebbe inevitabilmente suscitato.
Eppure Gozzi aveva trovato un alleato in Sebastiano Foscarini, che nella prima metà degli anni Settanta ricoprì a più riprese la carica di riformatore dello Studio; anch’egli, infatti, riteneva necessaria la traslazione dell’Accademia a Padova (ma — si badi — limitandone per ora l’accesso ai soli patrizi), e ne aveva persino individuata la sede nel vecchio e prestigioso Collegio Amuleo, così chiamato dal suo fondatore, il cardinale Marcantonio da Mula che, essendo stato bandito dalla patria, nel 1566 aveva istituito un lascito a favore di essa onde provvedere al mantenimento di alcuni studenti presso l’Università.
Nessuno a Venezia pensò mai di riabilitare la memoria del da Mula, figuriamoci; tuttavia il legato venne accolto in buona grazia, per cui il Collegio sussisteva ancora, due secoli dopo. Però l’edificio era ridotto in condizioni fatiscenti, tanto che nel 1769 se n’erano sbarrate porte e finestre e trasferiti altrove i convittori; ma allora perché non rivitalizzarlo trasportandovi dalla Giudecca l’Accademia con tutti i nobili?
Come si è anticipato, a questo punto il tentativo fallì, sia perché il Foscarini pensava giustamente di inserirlo in una più vasta riorganizzazione di tutto il complesso dei collegi universitari padovani che gli era stata affidata proprio in quel torno di tempo, e di cui si dirà nel seguente paragrafo; sia per le crescenti tensioni sociali che andavano manifestandosi nel patriziato, a motivo dei contrasti fra ricchi e poveri, e che sarebbero sfociate di lì a poco nella correzione del 1774-1775. In breve, solo il 15 gennaio 1773 il Foscarini presentò ai colleghi un progetto di restauro della vasta costruzione, ma accompagnandolo con una lista di spese così lunga da renderlo «suscettibile di sola idea, non già di reale effetto».
A questo punto le lungaggini presero a sommarsi, a rincorrersi: i riformatori rimisero l’alto affare al senato, che rinnovò all’eccelso magistrato la più completa fiducia, sicché i riformatori richiesero un piano di riforma didattico-pedagogica modernamente concepito ad una commissione di quattro docenti dello Studio padovano: Franzoia, Lavagnoli, Sibiliato e Stratico; infine, dopo ulteriori conferenze, ossia commissioni interministeriali, fra i riformatori ed i deputati ad pias causas, fra costoro ed il cassiere dell’Accademia, fra questi e l’aggiunto sopra monasteri, il 4 giugno 1774 si pervenne alla conclusione ch’era bene lasciar le cose come stavano; ripiegando su un aumento degli stanziamenti a favore della vecchia Accademia giudecchina.
Il numero dei patrizi colà ospitati venne dunque portato a sessanta, e furono accordati 3.000 ducati (beninteso, una tantum) per improcrastinabili restauri, apparendo manifestamente angusti i locali del refettorio e delle camerate, insufficienti i previsti sette serventi, inadeguata la dotazione di vestiario per i convittori.
Qualche ritocchino, una stuccatina qua e là. Perché si ponesse mano una buona volta alla riforma degli studi (puntualmente elaborata da Gozzi nel 1775, e denominata Sopra il corso di studi che più convenga all’Accademia della Giudecca) si sarebbe dovuto attendere il sopraggiungere di un’altra correzione, quella del 1780, che per quanto riguarda la nostra Accademia determinò la cosiddetta Legislazione del 22 maggio 1782. Quest’ultima ordinava dettagliatamente la vita all’interno dell’istituto, la cui direzione risultava sdoppiata in un ramo educativo, sempre affidato ai Somaschi, e in uno finanziario, sottoposto ad un economo laico; in particolare, il piano di studi cercava di accentuare gli aspetti di una preparazione più consona ai futuri compiti politici che attendevano i giovani convittori: diritto, oratoria, matematica, geometria, il cui grado di apprendimento sarebbe stato valutato nel corso di un annuo esame conclusivo.
Purtroppo però, siamo di fronte ad un impianto umanistico che conservava sostanzialmente quello precedente, tralasciando le innovazioni scientifiche presenti nei suggerimenti del Gozzi, che aveva caldeggiato — fra l’altro — una qualificazione marinaresca di questi giovani, nella realistica supposizione che non pochi fra essi sarebbero entrati a far parte della flotta militare (la qual cosa era già stata prevista dal decreto senatorio 1° agosto 1733, che però in questa parte aveva trovato solo tardiva ed effimera attuazione, all’inizio degli anni Cinquanta).
Si pensa anche all’Università
Sulla scorta del decreto del 7 settembre 1768, che si può dire esser stato il volano di tutto il movimento di riforme che interessò il sistema scolastico veneto, i riformatori decisero anche di provvedere un poco pure all’almo Studio, al glorioso Ateneo patavino. L’ultimo tentativo di svecchiarne le strutture s’era avuto all’inizio degli anni Sessanta, con un progetto elaborato da Simone Stratico, allora giovane professore, ma destinato ad una prestigiosa carriera; questo piano prevedeva, tra l’altro, una significativa riduzione del complesso degli insegnamenti a vantaggio del settore scientifico, il ridimensionamento dell’uso della lingua latina, l’apertura di collegi sul modello inglese (33). Grazie all’appoggio dei riformatori Francesco Lorenzo Morosini e Bernardo Nani, il progetto Stratico trovò almeno in parte attuazione, ma l’intempestivo sopraggiungere della crisi queriniana indusse il senato, con decreto 29 settembre 1762, a ripristinare le cose sul piede dell’antico metro.
Qualcosa, però, si salvò e successivi interventi del magistrato, nel 1768 (terminazione del 9 settembre: appena due giorni dopo il decreto contro gli ecclesiastici) e poi ancora nel 1771, fissarono definitivamente l’ordinamento didattico dell’Università, che non sarebbe più mutato sino alla caduta della Repubblica; in sostanza si procedette nella direzione di uno svecchiamento degli insegnamenti, con la soppressione di alcune cattedre di natura giuridica (o quantomeno procedendo ad un loro aggiornamento: ad esempio, gli stantii corsi di diritto feudale venivano mutati in diritto feudale, marittimo e commerciale), mentre si istituivano nuove discipline come medicina pratica, chirurgia ospedaliera, veterinaria, agricoltura. Quest’ultima era stata prevista sin dal 1765 ed affidata alla competenza di Pietro Arduino, che si sarebbe rivelato valente agronomo, onorando così la sua cattedra che — va detto — fu la prima del genere ad essere istituita in Italia. È evidente, tuttavia, che non siamo di fronte ad un’ampia profonda ristrutturazione dell’Ateneo patavino, ma semplicemente a qualche intervento settoriale non più rinviabile, pena decenza.
Forse maggiore importanza sul piano pratico rivestirono taluni provvedimenti scaturiti da una visita collegiale compiuta nello Studio dai riformatori (Sebastiano Foscarini, Sebastiano Giustinian, Andrea Tron) l’8 aprile 1771. Che i riformatori dello Studio di Padova si recassero a Padova era evento non soltanto singolare, ma del tutto eccezionale, talché la cosa diede la stura ad orrenda profluvie di iperboliche celebrazioni, orali e scritte, da parte del corpo docente; ai fini del presente discorso, registriamo però volentieri l’iniziativa dei magistrati, ascrivendone il merito al nuovo clima ch’era venuto a crearsi e che la presenza del Tron non mancava di sottolineare.
L’ispezione — chiamiamola così — si protrasse per dodici giorni, nel corso dei quali Giustinian e Tron visitarono la Specola, dove insegnavano due abati: astronomia il Toaldo, architettura il Cerato; quindi il laboratorio chimico del Carburi e persino assistettero alle lezioni di ostetricia tenute dal Calza; nel frattempo il terzo collega, Foscarini, si occupava di verificare la condizione dei quattordici collegi nei quali una cospicua aliquota della popolazione studentesca veniva ospitata in base a commissarie, fondazioni, legati di molteplice natura e, per lo più, di antica o antichissima data.
Pare fosse stata propria sua, del Foscarini voglio dire, l’iniziativa, non si sa per qual ragione: di economia non capì mai nulla, quanto a morale aveva tutto da imparare, e con lui sua moglie, figlio, fratelli, zii, avi e chi più ne ha più ne metta che troverà da divertirsi. Da oltre un secolo la vita privata dei Foscarini di S. Stae — dal 1748 denominati ai Carmini — era, per ricorrere ad un eufemismo, alquanto chiacchierata (più o meno ogni generazione aveva da piangere un esiliato o un morto ammazzato, sempre per quel vezzo delle liaisons amoureuses).
Non resta dunque, per tornare al nostro Sebastiano, se non pensare che a spingerlo ad un impegno il quale doveva protrarsi per anni sia stato un incoercibile desiderio di gloria, di fama, insomma l’ambizione: in fondo, era o non era nipote di un doge e letterato di gran nome (34)?
Tanto più che — volpe vecchia qual era — sapeva benissimo cosa sarebbe emerso dall’inchiesta: solo due collegi, infatti, furono ritrovati versare in buone condizioni, ma per gli altri hai voglia, pianto greco. Ne derivò, poco più di un mese dopo, formale incarico del senato al Foscarini di stendere una relazione sugli istituti padovani ed all’impresa il patrizio dedicò due anni: né furono — onore al merito — fatiche da poco o inutili, poiché i risultati della solerzia del veneziano rappresentarono una delle più significative acquisizioni di tutta l’attività riformatrice intrapresa dalla Repubblica nel corso del Settecento.
In breve, a forza di tagli e ristrutturazioni, egli ridusse a cinquantatré il numero degli studenti (teoricamente, oltre un centinaio) ospitati presso lo Studio a spese di diverse commissarie italiane, dalmate, greche; fornì loro un’unica sede restaurando il soppresso monastero di S. Antonio di Vienna, cui assegnò la significativa denominazione di Collegio di S. Marco (sussiste ancora nell’attuale via Savonarola, mutato titulo: è il «Don Mazza»); gli diede persino un regolamento, un rettore nella persona dell’abate Giuseppe Finozzi, due precettori, tre serventi, un cuoco ed un sottocuoco. Il senato ne approvò gli statuti il 7 dicembre 1771: a leggerli abbiamo di fronte una normativa che in qualche modo ricorda quella militare (mi sto rivolgendo a quell’esigua minoranza di Italiani che ha espletato servizio nelle caserme), molto precisa, vorrei dire pignola, attenta quasi esclusivamente agli aspetti pratici della vita, parcellizzata in mesi giorni ore puntualmente previsti ordinati registrati (35).
Mica però toccava ad un collegio interferire sulla didattica; esso era una struttura, un servizio, e come tale lo concepì ed attuò il Foscarini, superando una quantità di problemi «minori» che poi in realtà sono fondamentali, così da assicurare ai giovani ospiti un minimo conforto, un poco di qualità della vita. Rara avis nel nostro bel paese, rarissima poi a Venezia. Oggi più che mai: si provi, provi il turista pazzo e strapazzo a trovare una toilette che non richieda penosa coda, nell’arco della mezza giornata che trascorre in piazza S. Marco. Non c’è, non fa fino.
Bene, il Foscarini dunque riuscì, migliorando le erogazioni delle commissarie (furono soppressi quattro priorati ed il ricavato investito nei pubblici depositi della Zecca); pervenne insomma costui a riunire sotto un unico tetto studenti di diversa estrazione lingua nazionalità, e a fornir loro uno stile di vita, un’impronta unitaria, suggellata dal leone marciano che segnava la loro «divisa».
Una ventina d’anni dopo il suo successore Francesco Pesaro avrebbe promosso qualche ulteriore ritocco all’assetto del collegio, ma senza alterarne l’impianto, lo spirito, le finalità; tuttavia nel 1797 il complesso sarebbe stato adibito a caserma, per ospitarvi le truppe francesi.
L’abolizione della Compagnia di Gesù e l’avvio delle riforme scolastiche
Ho già accennato al mutato clima, anche culturale, che si avvertì nel Veneto a partire dagli anni Sessanta: come è noto, il fenomeno era largamente italiano ed europeo, ma qui da noi fece le sue prove migliori nel decennio 1765-1775.
Anche per quanto riguarda il settore scolastico e, più in generale, educativo, il decreto 7 settembre 1768 fu alla base — si è detto — di tutte le iniziative che si verificarono nell’ultimo scorcio della Serenissima; esso pertanto diede occasione all’elaborazione di idee proposte progetti — sollecitati e no — che riempirono i tavoli dei riformatori e dei deputati ad pias causas: quali furon millanta, che tutta la notte canta.
Salviamo fra tanta carta e volentieri ricordiamo, grazie alla vastità di respiro ed elevatezza d’assunto, il suggerimento inoltrato nell’agosto del 1768 da Pietro Arduino ai provveditori alle beccarie, volto a promuovere l’istruzione agraria dei contadini attraverso la creazione di una rete di scuole e seminari: progetto ripreso in termini alquanto diversi da Griselini, nel 1773, poi la relazione presentata ai deputati ad pias causas dal sacerdote noalese e futuro insegnante nelle scuole veneziane, Ubaldo Bregolini, il 5 marzo 1772, che proponeva l’utilizzo di taluni fondi spettanti a tutele amministrative di beni ecclesiastici (commende), al fine di una promozione educativa illuministicamente concepita come problema morale e presupposto indispensabile di ogni progresso (36); quindi le scritture sulla riforma (nel senso di soppressione) delle corporazioni cittadine presentate in senato appena qualche settimana più tardi, il 18 aprile 1772, da Andrea Memmo, che invitava i riformatori ad un più efficace controllo sui maestri privati così diffusi nelle città, ed in particolar modo a Venezia, ed a promuovervi una miglior qualificazione della manodopera artigianale mediante la creazione di scuole di disegno, falegnameria, meccanica, secondo quanto suggeriva l’orientamento pedagogico di tipo pragmatico largamente presente agli illuministi, a cominciare dal lombardo Giuseppe Gorani; ancora ed infine, tra il maggio ed il giugno 1773 Griselini pubblicò a puntate, nel suo «Giornale d’Italia», un vasto saggio del teatino Tommaso Antonio Contin, già docente a Parma, intitolato Quale debba essere la educazione de’ fanciulli del minuto popolo, e come possa meglio promuoversi pel pubblico bene, nel quale l’autore si dichiarava senza mezzi termini a favore di un’istruzione essenzialmente pratica (37).
E Gozzi. Sin dall’indomani della visita collegiale dei riformatori in quel di Padova, sin dal 6 agosto 1771, dicevo, in uno scritto rivolto al magistrato sul punto di come migliorare l’almo Studio eccetera, scriveva chiaro, che più chiaro non si può, essere «persuaso ogni governo, che università non possa darsi, se non appoggiata alle scuole anteriori ben ordinate»; sappiamo che la risposta fu: ci pensi il Foscarini insomma, limitatamente ai collegi preuniversitari.
E il senato. Si è già detto che il decreto 3 settembre 1772 prevedeva che buona parte dei fondi amministrati dalla cassa civanzi avrebbe dovuto esser destinata al settore educativo. Donde mobilitazione di letterati, docenti, anche pedagoghi lì per lì scopertisi tali; quindi i consueti ammiccamenti dei politici auspicanti promuoventi sollecitanti: qualcuno persino in buona fede.
Certo è che ad onta di replicati decreti, di tanto fervore, di sì possente sinergia d’ingegni, non si sarebbe cavato un ragno dal buco, se il 21 aprile 1773 il pontefice Clemente XIV non si fosse deciso a sopprimere la Compagnia di Gesù. A Venezia i Gesuiti furono sempre detestati ed una volta anche duramente colpiti con un cinquantennale esilio. Questo accadeva nel XVII secolo.
Ma nel 1773, quando Sua Santità si decise finalmente a farli fuori, non ci fu uno straccio di applauso: li hanno aboliti? Li hanno aboliti, ti ga visto.
Il fatto è che ormai nella Serenissima i Padri contavano come il due di denari quando la va a bastoni, e la soppressione caricava il governo marciano di un inderogabile problema e mica da poco: quello di provvedere al vicariamento di collegi chiese ospedali sino allora con tanto merito (quantomeno rispetto alle alternative praticabili) gestiti dalla Compagnia.
Fu così che il governo veneziano prese la storica decisione di avocare a sé il problema scolastico, beninteso non un giorno prima del 21 aprile 1773, anzi diversi mesi più tardi.
Gli istituti superiori
Quanto dunque importasse al senato l’educazione dei Veneti, di leggieri s’evince se poniam mente al fatto che l’alto consesso lasciò bellamente trascorrere il rimanente della primavera e, già che c’era, pure tutta l’estate senza far nulla; detto questo, bisogna però aggiungere che poi, quando finalmente i Padri coscritti riuscirono a reperire un poco di respiro frammezzo alle loro profondissime cure, dimostrarono di saper agire con buon senso e prudenza.
L’incarico di provvedere alla sostituzione dei Gesuiti venne affidato ai deputati ad pias causas (decreto 29 settembre 1773), perché la responsabilità giuridica ed economica della soppressione dell’ordine ricadeva nelle loro competenze (a proposito di economia: l’asse gesuitico nello Stato veneto oltrepassava l’annuale rendita di ducati 15.000); naturalmente una tal delega accentuava il risvolto giurisdizionalista che sarebbe stato alla base dei provvedimenti futuri: quanto ai riformatori, essi sarebbero stati chiamati in causa solo il 28 gennaio 1775.
Venezia stava vivendo una fase politica assai delicata (lo si è detto, ma è forse non inutile ricordarlo), sottesa da un’aspra lotta all’interno del patriziato: le tensioni — che presto avrebbero determinato la correzione del 1774-1775 — non contrapponevano solo ricchi e poveri, ma passavano all’interno di questi gruppi con un ulteriore motivo di divisione, tra filocuriali e giurisdizionalisti. Proprio allora questi ultimi avevano riportato un notevole successo (forse l’ultimo) col decreto senatorio del 3 settembre 1773, che in pratica dava via libera alla ripresa delle alienazioni dei beni ecclesiastici.
Questa nuova vittoria del Tron contribuisce a spiegare perché i deputati si siano a loro volta indirizzati a Gasparo Gozzi al fine di elaborare, entro il prescritto termine di due mesi, un progetto per realizzare l’avocazione allo Stato delle scuole che i Gesuiti dirigevano a Venezia, come pure a Belluno, Padova, Vicenza, Verona e Brescia.
Il nostro conte aveva già tutto in mente da un pezzo, e soprattutto idee ben chiare: le scuole superiori — superiori, ripeto — dovevano essere professionalizzanti e meritocratiche. Meritocratiche, ossia premiare i migliori. Nell’Italia attuale una tal pratica risulterebbe sorprendente siccome inaudita, ma qui stiamo occupandoci di cose vecchie di due secoli e passa.
Sicché torniamo alla Serenissima e andiamo con ordine; la sua risposta ai deputati reca la data del 29 dicembre 1773 e fu da costoro presentata in pregali il 14 gennaio 1774, dove con singolare rapidità venne approvata appena sei giorni dopo; la qual cosa dimostra la perfetta corrispondenza d’intenti Gozzi-deputati-senato, che aveva in Andrea Tron il minimo comun denominatore ed il volano dell’iniziativa.
Vediamo un po’ allora cosa scrisse il Gozzi, sulla scorta di quel ch’ebbi un dì ahimè remoto a pubblicare, e degli approfondimenti (con qualche correzione) che per chiare parole e con preciso latin stampò in seguito Bruno Rosada(38).
Egli (Gozzi, voglio dire) partì da un punto di vista opposto a quello adottato dai Padri della Compagnia di Gesù: anziché imporre un modello teoricamente ottimale dello sviluppo della persona umana, procedette in senso inverso, ossia dall’osservazione delle esigenze concrete dei discenti: «Tal esame [scriveva riassumendo le conclusioni di una riflessione sulla composizione sociale e le aspirazioni degli studenti che frequentavano l’istituto (39)] m’offerse al pensiero [...] un aggregato di giovani, per lo più popolari, alcuni pochi civili, ma di ristrette fortune [...]. Congetturai perciò [...l che il maggior numero sia un giorno per essere bisognoso di procacciarsi impieghi con la facilità della penna, con la prontezza nell’operazioni aritmetiche, con qualche piccolo traffico, e molti con qualche professione meccanica. Nella massa generale, previdi che se ne potranno eccettuare alcuni i quali si daranno chi alla vita ecclesiastica, chi alle faccende forensi o alla medicina».
Dunque finalità ben diverse da quelle dei Gesuiti, con obiettivi didattici miranti non già ad un’educazione di stampo umanistico, ma professionale, come si è anticipato: Gozzi non intende incrementare colonie di arcadi (per questo bastava sua moglie), ma formare borghesi in grado di inserirsi attivamente nel mondo del lavoro, quali sollecitava una capitale ch’era altresì centro portuale e sede di un patriziato il quale a sua volta richiedeva impiegati, scritturali, agenti capaci di sbrigare pratiche, di sovraintendere alle mille necessità dell’amministrazione patrimoniale, delle relazioni commerciali sociali forensi che a Venezia costituivano tanta parte del quotidiano dipanarsi della vita civile e politica.
Sono questi fini, assieme alla ribadita importanza del criterio — per l’addietro troppo sommariamente applicato, quando non disatteso — della gradualità del processo di insegnamento/apprendimento, a caratterizzare la novità dell’istituto che in apparenza, almeno per quanto riguarda l’impianto esteriore, non sembrerebbe invece distaccarsi troppo dalla preesistente struttura. Esaminiamolo allora, questo impianto, prendendo come punto fermo gli Statuti delle nuove scuole, che furono stampati per ordine della deputazione il 13 gennaio 1775, ossia diversi mesi dopo la riapertura dell’istituto, e che a mia volta ripubblicai nel libro sulla politica scolastica (40).
Questi Statuti furono evidentemente il frutto non solo delle scritture del Gozzi e delle limature apportatevi dai deputati, ma anche del convergere dei suggerimenti avanzati — proprio sulla scorta dell’esperienza vissuta nel corso della fase iniziale dell’attività di queste scuole — dal loro rettore, l’asolano Bartolomeo Bevilacqua, che col nostro conte collaborò in proficua unità d’intenti (41).
Va detto anzitutto che la sede rimase la stessa, ossia il convento dei soppressi Gesuiti alle Fondamenta Nuove. L’istituto fu però interamente affidato ad ecclesiastici secolari: v’era quindi il rettore Bevilacqua, che godeva (alla data iniziale del 1775) di uno stipendio annuo di ducati 600 v.c. (da lire 6:4): niente male, ove si pensi che a metà Settecento la paga annua di un operaio specializzato dell’Arsenale era di ducati 150; l’assistevano due vicerettori, con ducati 400 cadauno: Giovan Battista Aprilis e Marco Fassadoni; c’erano poi due confessori, entrambi con I oo ducati (evidentemente il loro contratto era a tempo determinato): Domenico Arrigoni e Martino Ortolani; quindi due prefetti, ai quali spettava l’arduo compito di badare alla disciplina degli allievi: Giacomo Rizzardini e Giovan Battista Rossi, con ducati 250 cadauno; tre serventi con ducati 120 a testa; infine il corpo docente vero e proprio, con ducati 300 l’uno, così costituito: per le cosiddette scuole inferiori quattro prime classi con Giacomo Loris, Pietro Pernion, Giuseppe Stefani, Antonio Zuanelli; tre seconde classi con Francesco Bonati, Giacomo Marchetti, Giuseppe Martinelli; due terze classi con Giovan Battista Capobianco e Giuseppe Rossi. Queste classi prevedevano l’insegnamento dei primi rudimenti dell’alfabetizzazione italiana e latina, oltre a quelli della matematica: grosso modo l’equivalente della nostra scuola media. Una quarta classe, destinata all’umanità, era affidata a Gian Antonio Turriani; una quinta (retorica) a Gaetano Orti.
Seguivano le tre classi superiori, dette anche delle scienze: la sesta — numerando abovo — di eloquenza, tenuta da Ubaldo Bregolini, la settima (sdoppiata in filosofia morale e teologia morale), rispettivamente da Valentino Busa e Giacomo Alberti; l’ottava infine (geometria), affidata a Domenico Paccanaro.
V’era inoltre un maestro di disegno, Paolo Martini, cui spettava di istruire dodici alunni scelti tra i più idonei.
Non erano docenti di poco valore, e tanto meno necessariamente reperiti sul posto, ossia i primi sui quali ci si fosse imbattuti: alcuni di essi percorsero una significativa carriera e scrissero libri di testo; il Pernion, ad esempio, era dottore in utroque, Bonati poi veniva da Salò, Busa e Paccanaro da Vicenza, Capobianco era di Verona, Martinelli di Padova, Orti di Este, Rossi di Treviso.
Questa, come si è detto, la situazione iniziale, ma col tempo numerose furono le sostituzioni degli insegnanti e diverse materie furono aggiunte o modificate, specie per quanto riguarda il ciclo superiore nella parte che concerneva la formazione dei chierici, che doveva rivelarsi questione complessa e spinosa.
Ma prima di accennare agli aspetti pedagogico-didattici, soffermiamoci ancora un attimo sull’organizzazione dell’istituto. L’anno scolastico aveva inizio il 13 novembre per le classi inferiori ed il 26 per le superiori, e terminava per tutte l’8 settembre, con orario spezzato: rispettivamente due ore al mattino ed altrettante al pomeriggio, che diventavano per il secondo ciclo due e mezza ed una e mezza; vacanza alla domenica ed al giovedì (se non v’erano festività infrasettimanali), l’ultima settimana di carnevale, quella di Pasqua, le vigilie (pomeridiane) di Natale, Ascensione e Pentecoste, il primo giorno di Quaresima e di agosto.
Come si vede le vacanze erano autunnali, in pratica da metà settembre a metà novembre: evidentemente la calura estiva non destava troppi timori, e neppure l’odioso orrendo scirocco che tanto ci affligge in laguna; tuttavia a questo proposito una parolina di spiegazione potrebbero darcela gli storici del clima.
Vediamo ora quanti erano gli studenti. Inizialmente poco più di duecento, sicché Gozzi ottimisticamente auspicava che nelle classi iniziali, dove si trattava di far apprendere agli scolari i primi rudimenti della grammatica e dell’aritmetica, ogni docente dovesse ammaestrarne una dozzina, ma ben presto sorsero problemi, perché nelle prime classi — e solo in queste, dal momento che poi i giovani disertavano per inserirsi nel mondo del lavoro, non appena ne intravvedessero l’occasione — il loro numero aumentò rapidamente, e di conseguenza gli insegnanti si trovarono a far lezione anche a trenta studenti (42).
Ecco le cifre complessive, relativamente agli anni disponibili (Tab. 1):
Nell’arco di circa un ventennio si registra dunque un incremento del 67%, che anzi «sarebbesi facilmente accresciuto [così il Bevilacqua ai riformatori, quasi in un rendiconto finale nel settembre 1796] se con qualche prudente riserva non si avesse cercato d’impedire un eccesso che avrebbe recato disordine ed imbarazzata l’opera dei maestri»; un po’ di prudenza, insomma, con un rinforzino di tirchieria.
Le scuole, infatti, costavano; agli stipendi dei docenti e del personale si sommavano le spese delle recite e dei premi che concludevano l’anno scolastico (agli allievi che si erano distinti veniva conferita una medaglia d’oro o d’argento, con una cerimonia cui per solito interveniva uno dei riformatori per enfatizzarne l’importanza; questo senso dell’entusiasmo e dell’emulazione, individuale e di gruppo, derivava pari pari dalla pedagogia gesuitica); sicché le scuole alle Fondamenta Nuove richiedevano circa 7.000 ducati all’anno, senza contare le spese di restauro, arredo, cancelleria e tutte queste cose qui: 7.000 ducati, pari al 17,5% dei quasi 40.000 che spettavano allo Studio di Padova, il quale però — si badi bene — era l’unica Università della Serenissima, mentre scuole lasciate dai Gesuiti ve n’erano in tutte le principali città dello Stato.
Quanto ai loro aspetti pedagogico-didattici rinvio alla lettura degli Statuti e dello specifico studio di Rosada, dove sono illustrati i programmi delle varie classi e persino i libri di testo ai quali i maestri avevano l’obbligo di attenersi; ai fini del presente lavoro mi limito ad un cenno in nota (43), ricordando che Gozzi relegò il latino nelle classi destinate alla preparazione degli ecclesiastici, dei medici e dei giuristi, mentre per la gran parte degli studenti la materia base diventava l’italiano; non solo, sulla scorta delle prime esperienze (terminazione del 4 dicembre 1778) venne alleggerito il carico d’apprendimento delle prime quattro classi del ciclo inferiore, ch’erano pure le più frequentate, al fine di renderlo «più semplice e più adattato all’età ed alle diverse condizioni de’ giovanetti che vi concorrono, per la maggior parte diretti all’acquisto di quelle cognizioni soltanto, che bastino loro all’esercizio di varie arti e mestieri cui dovranno applicarsi per il loro sostentamento»; in seguito furono aggiunti speciali (e facoltativi) corsi di disegno, trigonometria, meccanica. Naturalmente questo «servizio» — chiamiamolo così — reso alle categorie sociali più deboli non mancò di evidenziare ulteriormente il dualismo insito nei due cicli, inferiore e superiore, nei quali si articolava l’istituto.
Le classi superiori, infatti (alle quali si accedeva mediante un esame), finirono per essere oggetto di maggiore attenzione da parte dei riformatori, subentrati ai deputati ad pias causas nella gestione di queste scuole — come si ricorderà — il 28 gennaio 1775. Qui una terminazione del 22 agosto 1786 introduceva un sistema di verifiche trimestrali, per selezionare ulteriormente i non moltissimi frequentanti.
Contemporaneamente, a quanti avessero seguito le lezioni di giurisprudenza era consentita l’iscrizione al terzo anno della corrispondente facoltà presso l’Università di Padova e due anni dopo (decreto del 13 dicembre 1788) il senato estendeva in parte il beneficio agli studenti di medicina; a questo riguardo, una terminazione dei riformatori del 4 febbraio 1793 accordava a non più di dodici alunni che avessero seguito i corsi agli ex Gesuiti, integrati dalle lezioni di anatomia che durante la Quaresima si tenevano nella sede del Collegio dei medici-fisici (una vera istituzione, a Venezia, poiché risaliva al 1368), l’esonero dal primo biennio padovano; si realizzava in tal modo — al di là di taluni contingenti risvolti non propriamente disinteressati — un felice connubio scuola-università, suscettibile forse di ulteriori sviluppi, qualora non si fosse abbattuta su quel mondo la bufera che sappiamo (44).
In conclusione, che giudizio dare di queste scuole? Certo, non furono una rivoluzione: l’impianto ricordava parecchio quello precedente dei Gesuiti, né avrebbe potuto essere diverso; le pagine iniziali degli Statuti sono doverosamente dedicate alle pratiche devozionali da osservarsi da docenti e alunni; il rettore Bregolini inaugurava puntualmente l’anno scolastico con una lunga e dotta prolusione in latino; le materie umanistiche trovavano ancora largo spazio.
Pertanto sin dagli inizi non mancarono sulla nuova realizzazione riserve e perplessità, anche se provenienti da personaggi non del tutto esenti da sospetti di parte.
Ecco il primo, Francesco Corradini, rappresentante imperiale a Venezia, rivolgersi in questi termini al Kaunitz: «Vederà [...] l’A.V. che li compilatori di detto piano hanno dimenticate le scienze più analoghe e le arti più vantaggiose alla costituzione della Repubblica, quali sarebbero le istruzioni e dimostrazioni relative alla nautica ed alla astronomia, non meno che l’ammaestramento degli artisti massimamente nella meccanica, costituendo chi loro spieghi e dimostri le leggi della gravità dei corpi, le regole applicabili alli differenti usi de’ vari maestri, l’uso delle macchine e delli disegni proporzionati alli vantaggi ed alla perfezione delle arti. Hanno eziandio dimenticato la parte interessante delle belle lettere che via facendo incammina all’atticismo, in queste contrade sconosciuto [...]».
Corradini scriveva nel gennaio 1774, e siccome nel dicembre di quello stesso anno veniva emanato il regolamento scolastico austriaco che doveva già essergli noto nei suoi indirizzi generali, non si può escludere che calcasse un poco la mano per compiacere il padrone.
Altra voce non propriamente entusiasta è quella del misoneista abate Angelo Maria Labia, testimone oculare dell’inaugurazione delle nuove scuole, avvenuta il 26 aprile 1774, a suo giudizio viziata dall’impronta anticlericale che ne era alla base. Tanto che finiva con l’auspicare che tutto finisse in bruo, in brodo (45):
Che bela cossa nel quondam Gesù
dove che ancuo s’a fato l’apertura
dei studi da la gran magistratura
de le man-morte per la zoventù!
A le porte soldai per far star su,
Deputazion in publica figura,
professori che ‚in pondere et mensura’
i poi esser oto onte o poco più.
Messa a capela con pontifical,
prolusion che no s’a capìo un starnùo,
un rinfresco cussì, né ben né mal.
Ghe xe chi vol che tuto vaga in bruo,
e che sta aspettativa universal
e la scomenza e la finissa ancuo.
Certo, tutto vero. Eppure quanta differenza di contenuto, di finalità tra le prolusioni — pur latine — del Bregolini e quelle dei suoi predecessori Gesuiti (46)! C’è di mezzo lo Heinecke, ci sono Mirabeau, Felbiger ed i nostri Maffei, Genovesi, Filangieri, Carli, Pilati, Bianchi... C’è la ventata di questi incredibili anni Settanta. Sicché, per procedere con l’eloquenza dei dati, si pensi che i nuovi regolamenti per le Università di Pavia, Torino e Padova furono emanati rispettivamente il 31 ottobre, 9 novembre e 7 dicembre 1771, seguiti di lì a poco da quelli scolastici: il fenomeno era generale e sincronico.
Le scuole del clero
Sappiamo che fu il clero a pagare il conto delle riforme scolastiche, sicché per decenza i deputati dovettero anche pensare a risollevarne le condizioni spesso penose, cominciando da quelle culturali: la qual cosa, del resto, era espressamente prevista dal decreto 3 settembre 1772.
Inizialmente la soluzione fu di incardinare l’istruzione dei chierici nell’ambito dell’istituto agli ex Gesuiti, dove fu appunto attivato l’insegnamento teologico, che avrebbe dovuto affiancare le tradizionali strutture dei due seminari, patriarcale e ducale (47), Naturalmente questi non vennero soppressi, tuttavia la nuova realtà costituiva un’alternativa laica all’autogestione della formazione del clero e, come tale, non poteva essere accettata a cuor leggero dal vescovo patriarca, il cui operato veniva, oltretutto, implicitamente posto sotto accusa.
E così, non appena l’inetto Bragadin venne sostituito dal più responsabile Federico Maria Giovanelli, uno dei primi atti del nuovo titolare fu di ordinare il ripristino dei dodici visitatori delle parrocchie, allo scopo di vigilare sulle «scuole de’ chierici nostri in ciascun sestiere istituite, [che] abbisogna[no] di qualche peculiare regolamento, attesa la notabile varietà de’ tempi», senza peraltro intendere con ciò «allontanare li chierici nostri dalle scuole pubbliche erette per provvida paterna cura dal Ser.mo Principe nel luogo della soppressa Compagnia di Gesù, ed aperte del pari alla istruzione di tutto l’ordine clericale a noi soggetto» (48).
Quest’ultima precisazione non suonava complimento rituale, perché va detto che i giovani chierici verso l’istituzione laica s’erano subito dimostrati assai tiepidi. Ossia non frequentavano. Accusavano i parroci di caricarli d’incombenze nelle chiese e nelle sacrestie, e costoro ribattevano che mica era colpa loro se il lavoro era tanto.
I riformatori eran corsi per tempo ai ripari, e sin dal 12 settembre 1775 avevano provveduto ad istituire tre nuovi insegnamenti ad hoc: teologia dogmatica, che si affiancava alla morale; storia ecclesiastica; lingua greca ed ebraica, che dal 1782 sarebbe stata affidata al celebre Giambattista Galliccioli.
Disposti dunque a seguire le congiunte esortazioni del loro principe e del loro pastore, quei bravi chierici? Sensibili finalmente all’esercizio di una feconda elevazione dottrinale che consentisse loro di divenire un giorno ministri esemplari, qualificati strumenti atti a diffondere nel popolo le massime redentrici del messaggio cristiano? Macché, tutti sordi come campane.
A smuovere le acque provvide in parte la correzione del 1780, che segnò sì, ancora una volta, il predominio dell’aristocrazia senatoria, ma all’interno di essa — ed è questo il punto interessante — un rovesciamento della tendenza giurisdizionalista a vantaggio dell’ala filoclericale: Pesaro e Barbarigo, insomma, al posto di Tron e Querini.
Il processo di transizione fu lento però, ed il decreto 30 aprile 1781 soltanto una tappa del processo evolutivo. Esso stabiliva provvedimenti a favore dell’istruzione del clero veneziano, consistenti in un aumento dei chierici ospitati presso il seminario patriarcale di Murano, che da quaranta passavano a sessanta, dopo di che le soluzioni divergevano: i filoclericali sostenevano l’opportunità di istituire ex novo una struttura scolastica riservata al clero e separata da quella laica, mentre il partito giurisdizionalista propugnava la validità dell’istituto agli ex Gesuiti (49).
Nelle lagune gli anni Ottanta assistettero al tramonto della stagione riformatrice, in parallelo col declinare dell’astro del Tron, ma la contesa fu aspra e lungo il braccio di ferro tra i due partiti; la seconda (e decisiva) tappa della vittoria della soluzione filoclericale arrivò pertanto solo ile 2 settembre 1784, allorquando venne decisa l’istituzione di una «Cassa educazione e soccorsi al veneto clero secolare», che in sostanza assegnava 9.000 ducati annui all’istruzione degli ecclesiastici: assai più di quanto non toccasse all’istituto agli ex Gesuiti.
Nel maggio 1785 con gran clamore fu chiusa la loggia massonica di rio Marin, il 26 giugno moriva Andrea Tron: in mezzo troviamo il decreto senatorio dell’8 giugno, che sanciva la soluzione propugnata da Pietro Barbarigo.
In breve, i chierici potevano apprendere le nozioni fondamentali di latino, grammatica, umanità presso specifiche scuole ubicate in ogni sestiere (ma S. Polo e S. Croce ne avevano una sola in comune); per gli studi superiori di logica, metafisica, eloquenza sacra, teologia dogmatica e morale dovevano invece rivolgersi ad altri due istituti, l’uno aperto a S. Marco e l’altro a S. Polo, oltre ovviamente a quello «laico» presso le Fondamenta Nuove.
Quanto poi ai programmi, orari, esami, calendario delle lezioni e delle vacanze, stipendi del personale, tutto ciò in fondo non si scostava molto da quanto posto in essere agli ex Gesuiti (50); con in più un regalino, consistente nella consegna gratuita dei libri di testo (ad esempio, il 24 novembre 1785 i riformatori commissionavano al libraio Bettinelli la fornitura di centoventi copie del Dizionario latino ed italiano, già in uso presso le scuole agli ex Gesuiti).
Per l’ubicazione delle scuole, con il quadro degli insegnamenti e dei docenti stabilito il 16 ottobre 1785, congiuntamente dai riformatori (Pietro Barbarigo, Girolamo Ascanio Giustinian, Francesco Lorenzo Morosini) e dai deputati ad pias causas con l’aggiunto sopra monasteri (Ludovico Manin, Giovanni Molin, Alvise Zusto, Marino Garzoni) vedi la Tab. 2.
Completavano il corpo due presidenti, o presidi che dir si voglia: il sacerdote Giovan Battista Schioppalalba ed il canonico Bartolomeo Zender, scelti dal patriarca, ma sottoposti direttamente all’autorità del Barbarigo, che il 4 ottobre 1786 riuscì a farsi nominare soprintendente alle scuole dei chierici.
Alla sua creatura egli dedicò molte cure, senza risparmio di tempo afflizioni fatiche; sappiamo che visitava spesso questi istituti, che assisteva agli esami elogiando esortando ammonendo: sceglieva i docenti da sostituire, provvedeva ai molteplici imprevisti, soprattutto garantiva la copertura economica anche nei non infrequenti casi nei quali il «tetto» dei 9.000 ducati veniva oltrepassato; a suo conforto, il numero dei chierici frequentanti andò costantemente crescendo (ma non presso gli ex Gesuiti), così da giungere a centoventinove nel 1795.
In conclusione, vorrei ricordare quanto ebbi a scrivere nel mio datato lavoro sulla politica scolastica veneziana, a proposito di questi istituti: «Il giurisdizionalismo veneto, dopo le ultime vivaci esperienze realizzate tra il 1768 ed il 1774, Si era così risolto in una sorta di compromesso che, se da un lato salvava i diritti della sovranità statale, dall’altro giungeva a presentare la Repubblica come la più sollecita e rispettosa garante del rinnovato prestigio del suo clero. Al Barbarigo si deve quindi riconoscere l’abilità di aver saputo attendere e sfruttare il momento più idoneo per operare questa inversione di tendenza politica, di cui la ristrutturazione del sistema educativo ecclesiastico non rappresenta che uno degli aspetti [...]» (51).
Se però ora ci chiediamo quali furono i risultati conseguiti da tanto zelo, ricordando che la municipalità del 1797 avrebbe soppresso tali scuole, dietro l’accusa che in esse dominavano «l’ignoranza, la frivolezza, la superstizione», rifacciamoci ad una fonte non sospetta; si tratta di un funzionario austriaco, che in una relazione consegnata a Vienna il 1 ° febbraio 1802 sullo stato delle finanze venete — in un contesto dominato dalla necessità di effettuare risparmi generali e talora impietosi — inaspettatamente suggeriva di aumentare gli investimenti proprio nel settore educativo, «de façon d’en assurer le fruit, si nécessaire dans un pays où [...], quant à Venise surtout, le sacerdoce est abandonné à des gens qui, à l’égard du savoir» apparivano gravemente deficitarie, in quanto per ottenere la veste sacerdotale «il leur suffit, par un bref de Rome, d’avoir servi dans quelque eglise en qualité de clerc pendant un certain nombre d’années, sans besoin d’autre séminaire [...]. C’est à ce système qu’on doit de n’avoir, dans la majeure partie des curés de Venise, que des fils de gondoliers ou autres domestiques, protegés par leurs maîtres; et c’est à ce même système qu’on doit par conséquent en général le manque de vraie religion dans le peuple, ainsi que le manque des moeurs» (52).
Le scuole elementari
Ho già avuto modo di intrattenere il lettore sulla mia, peraltro ovvia, convinzione che una riforma complessiva del sistema d’istruzione pubblica — quale fu quella varata dal governo marciano nel corso dell’ottavo decennio del secolo — avrebbe dovuto a ragion di logica partire dal livello primario per poi giungere a quello superiore; mentre avvenne giusto il contrario, per motivi di opportunità e prestigio, oltre che per l’inorganico raccordo tra i diversi ordini d’istruzione.
Gozzi, a dire il vero, aveva onestamente segnalato sin dall’agosto 1770 (53) che le cinquecentesche scuole dei sestieri (così chiamate perché appunto ve n’era una per regione urbana (54)) erano ormai vistosamente inadatte ai giovani del popolo, dal momento che prevedevano ancora l’insegnamento del latino; ma abbiam pure detto che la loro riforma avrebbe dovuto attendere ancora qualche anno.
Ad assumere l’iniziativa stavolta furono i riformatori e non i deputati ad pias causar (questo perché i docenti di queste scuole appartenevano già al clero secolare ed il loro costo — peraltro assai tenue — era supplito dalla cosiddetta cassa grammatici, antica imposizione gravante sulle compravendite immobiliari urbane); furono dunque i riformatori Sebastiano Foscarini, Girolamo Grimani ed Andrea Querini che il 27 agosto 1774 Si presentarono al senato con una scrittura che descriveva con crudo realismo un quadro di abusi inefficienze disordini: essendo a carico del maestro la sede, «si fa la scuola in qualche peggior sito della casa propria [...], quindi non solo indecenza ed incomodità, ma ancora mutazione di luogo ad ogni mutazione di maestro». I quali poi non offrivano troppe garanzie di efficienza professionale, se non altro per ragioni anagrafiche: quattro su sei, infatti, «s’attrovano in età robusta, uno già antico supplisce coll’opera d’un sostituto, ma uno eletto fino dall’anno 1729 in età d’anni ottantatre, è assolutamente incapace» (55). La pensione, infatti, non s’usava, quale ennesimo omaggio all’oraziano precetto per cui carmina non dant panem, con la cultura non si campa.
Scontata la rapida approvazione del senato, in realtà del tutto indifferente al problema dell’istruzione del basso popolo, considerata niente più che una dimostrazione della pietà e generosità del principe verso i sudditi, nelle cui menti andavano ben inculcati i doveri verso Dio e soprattutto i suoi rappresentanti in questo mondo.
E così, già il 7 settembre 1774 si stampavano e divulgavano per la città gli Statuti delle scuole dei sestieri (56); questi i punti essenziali della riforma: ogni sestiere ospitava una scuola in una sede fissa (in pratica, due stanze a pianterreno, meglio se affittate in qualche immobile di proprietà dei riformatori in carica); i docenti avevano 100 ducati annui (da lire 6:4) di stipendio, peraltro presto portati a 120 — in concomitanza con l’attivazione di un sistema di pensionamento e l’istituzione di supplenti in caso di malattia dei titolari —, mentre contemporaneamente (1778) si stabiliva di fornire gratis il libro di testo agli allievi; l’orario delle lezioni comprendeva mattina e pomeriggio (il giovedì era tutto dedicato all’insegnamento della dottrina cristiana), con vacanze nei giorni festivi più quelli compresi fra il 15 giugno ed il 4 luglio e fra il 4 ottobre ed il 12 novembre; si partiva dal copiare alfabeto e numeri per giungere alla grammatica italiana (il latino era del tutto bandito), stendere lettere, calcolare le operazioni aritmetiche (anche qualche nozione geometrica, a partire dal 1792); due ispettori avrebbero vigilato sul buon andamento di questi istituti.
Naturalmente, nessuna traccia di obbligo scolastico (l’educazione rimaneva un optional), e nessuna suddivisione in classi distinte; gli allievi stavano tutti assieme nella stessa aula, avessero cinque o dodici anni: era tuttavia prevista una sommaria ripartizione, ad arbitrio del maestro, in distinti gradi di apprendimento, per gruppi all’interno dei quali, a fine anno, si effettuava la premiazione dei migliori.
Il provvedimento avallato dal senato politicamente si colloca all’interno della correzione del 1774-1775, presto seguita da quella del 1780; eppure, a proposito di queste scuole, nessuna traccia di contrasti fra i diversi titolari del magistrato dei riformatori, nessuna disparità di pareri, nessun piano concorrenziale o alternativo: questo perché il progetto — diversamente da quanto era successo per l’istituto agli ex Gesuiti e per l’Ateneo patavino — non rivestiva valenze politico-sociali, essendo da tutti considerato — come s’è detto sopra — niente più che una esibizione di carità offerta ai Veneziani, in attesa di estendere il beneficio alle città suddite, onde adeguare il sistema educativo della Repubblica ai coevi provvedimenti che andavano attuandosi altrove, a cominciare dalla vicina Lombardia.
Ecco perché la riforma delle scuole elementari non è riconducibile ad un preciso personaggio politico; il ruolo espletato da Foscarini per i collegi padovani, da Tron per le scuole superiori della Dominante, da Barbarigo per quelle del clero non trova il suo corrispettivo quando si tratta del basso popolo; al solito, dietro queste iniziative troviamo la mente e l’impegno di Gozzi (che a sua volta si rifà, come principale ispiratore, ad Antonio Genovesi) sul piano organizzativo, e — più generalmente — l’ovvia necessità di portare a compimento un processo ormai avviato: nulla di più e nulla di meno.
O meglio: nonostante i riformatori non pubblicizzassero più di tanto questa nuova creatura, nonostante i loro scritti in proposito fossero costantemente improntati a soddisfatto compiacimento per quanto già realizzato, senza adombrare la possibilità di ulteriori provvedimenti migliorativi; nonostante il debole impegno delle autorità, dicevo, le scuole dei sestieri conobbero un rigoglioso sviluppo, di gran lunga superiore a quello degli ex Gesuiti e dei chierici.
In altri termini, i Veneziani accorsero così numerosi da superare ogni previsione; mentre registriamo volentieri questo positivo fenomeno, dobbiamo tuttavia riflettere s’esso non sia nel contempo un ulteriore indice di crisi del mondo del lavoro, dei tradizionali sbocchi occupazionali proprio allora evidenziati dal dibattito sulle corporazioni: ma questo è un altro discorso.
Possediamo dati saltuari di questo incremento, a partire dal 178o (Tab. 3).
Per far fronte all’aumento della popolazione scolastica, i riformatori si videro costretti a reperire nuove sedi e nuovi docenti, perlomeno fino al 1787, quando la situazione giunse alla normalizzazione, senza cioè subire poi ulteriori modifiche.
Riproduco il quadro definitivo di queste strutture, fissato con terminazione del magistrato 22 gennaio 1786 more veneto, cioè 1787, con la data d’istituzione ed il nome dei maestri, tutti ecclesiastici secolari (Tab. 4).
Diciannove scuole elementari a Venezia, nonostante non mancassero di molti e gravi difetti, costituiscono indubbiamente un dato apprezzabile, tale da collocare il sistema d’istruzione preuniversitaria della città tra i più sviluppati nell’Italia dell’Ancien Régime. Tuttavia, è evidente che diciannove maestri erano ancora pochini, tenuto conto che nel corso dell’ultimo decennio della Serenissima ognuno di loro ebbe mediamente da istruire trentotto ragazzi: in fondo, Venezia contava ancora quasi 140.000 anime.
Ma vediamo di conoscerla un po’ più da vicino questa utenza scolastica; abbiamo infatti la fortuna di possedere l’elenco completo dei settecentosessantuno studenti iscritti in data 31 agosto 1787, tutti ovviamente di sesso maschile (57). Donde ricaviamo che il loro numero oscilla fra le ventisei unità della scuola a S. Caterina e le quarantotto di S. Giovanni di Rialto e che la loro età media è di otto anni e dieci mesi, con le punte eccezionali di Bortolo Spregadi del cerer Giovanni, che a soli quattro anni frequenta la scuola a S. Andrea, e di Vincenzo Maggiorin del servitor Giovanni, diciottenne, a SS. Apostoli.
Quanto all’estrazione sociale, v’è tutta la gamma, la straordinaria varietà del mondo del lavoro di una metropoli di quel tempo, con la veneziana peculiarità del primato dei barcaioli: novantatré studenti (sui settecentotrentotto dei quali conosciamo il dato) dichiarano infatti che il loro genitore esercita tale professione (o altra simile, come battellante); seguono i servitori, quindi i dipendenti pubblici, con in testa gli arsenalotti.
Ecco lo specchietto riassuntivo, con le percentuali tra parentesi e l’avvertenza che ho accorpato i mestieri affini, onde evitare un troppo minuzioso elenco (Tab. 5):
Qualche precisazione, a titolo di curiosità: tra gli altri abbastanza numerosi sono gli orologiai e occhialai (sei unità), seguiti dagli ortolani, sacrestani e corrieri, ognuno con cinque nominativi; da rilevare, inoltre, la presenza di un ingegnere, Valentino Bortoli, padre di Giovanni, frequentante la scuola a S. Andrea. A S. Raffaele, inoltre, troviamo i fratelli Giovanni e Michele Traversi del cittadino Cristoforo, e a S. Trovaso Alvise e Francesco Pasqualigo, figli del capitano delle ordinanze Lorenzo.
Veniamo al corpo docente. Qui non troviamo nomi di spicco, ché non doveva restare molto tempo per l’approfondimento culturale a quei poveri preti-maestri che possiamo facilmente immaginare oberati di lavoro, dovendo badare a scolaresche troppo numerose, per di più esposte all’indisciplina di non pochi demotivati turbolenti ed al continuo mutare della loro composizione, a causa di frequenti ritiri o nuovi arrivi (58). L’eccezione è fornita dall’ispettore Carlo Savoldello (1748-1815), autore di diversi libri di testo pubblicati sin dalla fine degli anni Settanta, ossia alquanto tempo prima dell’adozione, nella vicina Lombardia asburgica, dei manuali — peraltro di ben altra levatura e destinati a maggior fortuna — di padre Francesco Soave, i quali costituirono lo strumento di base per gli alunni delle scuole «normali» teresiane (59).
La fortuna delle scuole dei sestieri non fu effimera, ché in qualche modo esse rappresentarono un punto di «non ritorno»; sul loro esempio infatti altre rapidamente sorsero un po’ dappertutto, a Murano, Burano, Chioggia, Cavarzere, Caorle, Capodistria, Muggia e in quasi tutti i centri e grossi paesi della Terraferma. A Venezia i circa settecento scolari registrati alla caduta della Serenissima non diminuirono, nonostante la contrazione demografica della città, anzi salirono a 1.673 nel 1821 (la qual cosa può rivestire diversi significati: anzitutto una maturazione sociale, poi una maggior efficienza dell’amministrazione austriaca, infine un più marcato processo di immiserimento, che rendeva difficoltoso il ricorso alle strutture private).
Le scuole private
Fin che durò la Repubblica, infatti, la maggior parte della domanda d’istruzione continuò a trovar risposta nelle numerose scuole private disseminate un po’ ovunque nella città (tutte, a quanto mi risulta, riservate ai maschi: l’unica eccezione in proposito è costituita dall’iniziativa avviata nel 1787 dalla fraterna dei poveri di S. Nicolò, a Dorsoduro, che stanziava 94 ducati per dotare di una maestra le fanciulle della contrada, ma nell’ambito delle competenze dei provveditori alla sanità, non dei riformatori dello Studio).
Bisognava dunque provvedere in qualche modo alla regolamentazione di queste strutture (o alla loro soppressione, come s’era fatto nei domini asburgici); e così, dopo aver proceduto ad un’indagine riconoscitiva, il decreto senatorio del 7 settembre 1787, prendendo atto che, dietro tali iniziative «senza soggezione di legge, o di sovraintendenza, viene da persone tanto nazionali che estere educato un numero copioso di giovani di tutte le classi con metodi tra loro affatto diversi, e che potrebbero non essere conformi al nazionale sistema», ed in considerazione poi del fatto ch’esse non si potevano facilmente eliminare, «per tutti supplir non potendo le pubbliche istituite»; in base a ciò, dicevo, il senato incaricava i riformatori di «avere sopra di esse un’attenta continua pubblica sopraveglianza, [onde] possibilmente si conformi questa privata educazione a quanto è stato per la pubblica stabilito» (60).
Il decreto — evidentemente sollecitato dal magistrato stesso, di cui erano titolari Giacomo Nani, Francesco Pesaro e Zaccaria Valaresso — trovò immediata esecuzione ed il sistema applicato alle scuole dei sestieri venne esteso ai duecentonovantuno maestri delle scuole private ed ai loro duemilacinquecentotrentasei alunni. Inoltre veniva fatto obbligo ai docenti di munirsi di specifica autorizzazione, articolata su cinque diversi gradi, o classi d’insegnamento, e di sottoporsi ad un controllo trimestrale dei rispettivi parroci.
Queste ultime disposizioni furono tuttavia applicate con italica elasticità: uno Stato delli maestri et alunni delle scuole private sparse per la Dominante, del dicembre 1794, fornisce anzitutto il dato certo di una contrazione del fenomeno: duecentoventisette maestri con duemilacentotré studenti, ma ci informa pure del fatto che quasi la metà dei docenti (centoquattro per l’esattezza) erano ancora sprovvisti di licenza abilitante alla professione.
La gran parte di costoro erano sacerdoti veneziani e si limitavano a far apprendere agli allievi i primi rudimenti del leggere, scrivere e far di conto, ma non mancavano né maestri laici, né insegnamenti di livello superiore.
Il 26 settembre 1788 don Alvise Zanardini informava i riformatori che, tra le cinque scuole private esistenti nella sua parrocchia di S. Baseggio, si distingueva quella «del benemerito e dotto don Antonio Venier. Ritrovai insegnarsi dallo stesso a’ suoi scolari (una gran parte figli de’ patrizi veneti) logica, retorica, belle lettere, giurisprudenza, metafisica [...]. Ammirai il profitto e la compostezza di quella nobile gioventù brillante [...]».
Oltre al Venier — che godette di lunga meritata fama — altri tre docenti privati (due dei quali in possesso di titolo dottorale) erano allora provvisti di mandato per impartire lezioni di diritto; una loro dichiarazione scritta, attestante che lo studente aveva seguito per un biennio il corso di giurisprudenza civile, consentiva all’interessato di iscriversi all’albo degli intervenienti o sollecitadori, procuratori in giudizio per i quali non era richiesto il titolo dottorale. In qualche modo, questo rappresentava un aggancio con quanto s’era fatto nell’istituto agli ex Gesuiti due anni prima, nel 1786, dove — come si ricorderà (61) — a quanti avessero frequentato le lezioni di istituzioni legali era stata permessa l’ammissione al terzo anno della corrispondente facoltà padovana.
L’accentuazione professionale-scientifica di fine secolo
La scuola di nautica
Abbiamo seguito sin qui le linee fondamentali lungo le quali si svolse l’impianto di una sorta di sistema d’istruzione pubblica (e semipubblica) lungo l’asse Venezia-Padova, nella seconda metà del secolo. Questi provvedimenti furono fiancheggiati da altri, in modo non organico, ma significativamente rispondente ad esigenze di natura soprattutto professionale tipiche della città, o frutto dei nuovi tempi.
Vediamo anzitutto quale fu l’evoluzione della scuola di nautica, che abbiamo lasciata più sopra nelle mani del capitano Siron (62); quando costui passò nel mondo dei più, nel 1765, venne sostituito alla grande. Correvano infatti anni davvero felici per la marina veneta: la guerra dei Sette anni aveva favorito le navi battenti la neutrale bandiera del leone, e proprio allora la Repubblica stava concludendo una serie di trattati commerciali con i Barbareschi; donde l’aspirazione ad assicurare validi quadri alla flotta mercantile.
Sicché i riformatori interessarono della cosa gli ambasciatori della Serenissima; toccò al residente a Londra, Cesare Vignola, procurare la persona adatta. In una lettera al magistrato, datata 12 settembre 1766, informava di aver contattato un certo Arthur Edgcombe, ex ufficiale di marina che a Portsmouth dirigeva un collegio di nautica di grande reputazione; inoltre costui appariva «modesto, sobrio e rispettoso; caratteri molto opportuni e non facili a rinvenirsi in persona inglese»: pazienza se poi non sapeva l’italiano, in fondo nessuno è perfetto.
E così l’inglese arrivò a Venezia con i libri, gli strumenti, moglie, figli, tanto entusiasmo e 550 ducati effettivi di paga, il che lo poneva alla stregua di un docente universitario; il suo piano di studi (algebra, nautica, inglese, francese) venne approvato — con la minima solerzia possibile — dalla terminazione del 23 marzo 1770.
Aprì la sua scuola in calle S. Biagio, all’inizio di quello ch’era allora il rio di Castello (pressappoco vicino all’attuale Museo navale), e quando morì, nel 1776, gli subentrò il figlio Thomas, che da alcuni anni gli faceva da assistente col beneplacito dei riformatori, vista l’alta affluenza di giovani alla scuola (definitivamente fissata ad un massimo di 16 nel 1781).
Tommasino era un caratteraccio; o meglio, da buon inglese d’inverno s’adattava bene al freddo ed alle nebbie, ma d’estate smaniava, non sopportava lo scirocco. Donde liti e processi con studenti e vicini di casa, sfociati in una sorta di sollevamento generale del vicinato contro il docente e la sua famiglia, il 30 agosto 1787, talché dovettero intervenire i riformatori con tutto il peso della loro autorità (63). L’Edgcombe comunque la sua materia doveva conoscerla bene (collaborò pure alla compilazione del Codice per la veneta mercantile marina, emanato il 21 settembre 1786, che — tra l’altro — gli addossava il compito di esaminare gli aspiranti al rilascio della patente nautica); si trovava ancora in servizio alla caduta della Repubblica e fu confermato nell’impiego sia dalla municipalità democratica nel 1797 (che con tocco squisito gli aumentò lo stipendio a 600 ducati), sia poi dal governo austriaco, alle cui dipendenze operò sino all’ultimo respiro, fin quando cioè (23 luglio 1803) un attacco di paralisi fulminante si portò al cielo quell’anima eletta; la sua scuola disparve con lui (64).
La scuola di lingua turca
Come è noto, per vari secoli i rapporti veneto-turchi furono intensi, ancorché non sempre cordialissimi né facilissimi. Mentre poi i mercanti riuscirono sempre agevolmente ad intendersi, i contatti diplomatici tra Venezia e la Porta conobbero tutte le difficoltà, le incertezze, i fraintendimenti propri di lingue e mentalità così diverse. Donde il necessario ricorso agli interpreti, i cosiddetti giovani di lingua, o dragomanni.
Durante il Settecento si ebbero replicati tentativi di aprire una scuola di lingue orientali a Venezia: nel 1702, nel 1747 e poi ancora nel 1788, ma tutti fallirono (65).
Quest’ultimo progetto merita un cenno. Può apparire strano che si sia cercato proprio nello scorcio di vita della Repubblica di realizzare quello che in tanti secoli non c’era stato verso di portare a termine; tuttavia la giustificazione non risulta poi tanto improbabile ove si ponga mente alla ripresa che la marina mercantile veneta conobbe in Levante nella seconda metà del secolo (grazie soprattutto alla crisi delle bandiere inglese, spagnola e francese causata dalla guerra dei Sette anni e da quella della rivoluzione americana); all’aumento dei traffici col mar Nero, particolarmente vivace sotto i bailati Memmo e Zulian; all’allacciamento infine di regolari rapporti diplomatici tra la Serenissima e la Russia.
Si venne così al decreto senatorio del 21 agosto 1788, che istituiva una scuola di lingua turca presso l’istituto agli ex Gesuiti sotto la direzione del dragomanno Calavrò Imberti; senonché la pratica si arenò per l’ennesima volta, a causa delle disparità di pareri sorte tra gli ex baili Memmo e Garzoni, fautori della sede veneziana, ed il loro collega Zulian, che invece sosteneva l’opportunità di spostarla nella stessa Costantinopoli; né mancò allora chi pensò di fondare a Padova, presso il seminario vescovile, un centro per l’insegnamento delle lingue araba, turca e persiana, appoggiandolo al noto orientalista Simone Assemani.
Alla fine, dopo anni di inconcludenti diatribe, prevalse la soluzione Zulian ed il decreto del 5 maggio 1792 abolì la precedente deliberazione del 1788 a favore di una scuola presso la sede del bailo, a Pera di Costantinopoli. E così fu, quando non mancava più che una manciata d’anni alla caduta della Repubblica.
Le nuove istituzioni scientifiche urbane
A fine Settecento il peso specifico, ed il ruolo, assunti da Padova all’interno dello Stato veneto presero ad aumentare; e non solo dal punto di vista culturale. Magari è forzatura parlare del formarsi di una diarchia Venezia-Padova lungo l’arteria del Brenta, pure non mancano significativi indizi in proposito, la qual cosa — sia detto per inciso — aiuterebbe in qualche modo a spiegare il successivo, e tuttora perdurante, più generale sviluppo a «pelle di leopardo» della tipologia mentale, sociale ed economica della nostra regione.
Con questa premessa non è difficile dar conto della fondazione, avvenuta nel 1779, dell’Accademia patavina di scienze, lettere ed arti, sorta sulle ceneri di due precedenti organismi: l’antica Accademia dei Ricovrati, ormai ridotta ad esangue attività arcadica, e la recente istituzione agraria varata sulla scia del decreto senatorio del 1768 (66), anch’essa peraltro di grama vita, quantomeno a Padova.
L’operazione fu promossa dal governo marciano, che a sua volta si ispirò ad un modello d’istituto già presente in Italia ed all’estero: si volle cioè dar vita ad un centro prevalentemente scientifico (quello artistico — nell’odierna accezione del termine — trovava la sua sede naturale nella Dominante, dove nel 1756 si erano accresciuti gli spazi e le dotazioni dell’Accademia di pittura e scultura — più tardi divenuta anche di architettura —, ospitata nel «Fonteghetto» presso la piazza di S. Marco; prestigiosa istituzione, di cui nel 1774 facevano parte, per limitarsi a qualche nome, Giacomo Guarana, Michelangelo Morlaiter, Pietro Longhi, Giandomenico Tiepolo); a Padova insomma, dicevo, i riformatori dello Studio intesero creare una sorta di polo scientifico «nazionale», indipendente dal controllo locale ed in grado di collaborare concretamente con l’amministrazione dello Stato, fornendo consulenze di elevato livello in tempi ragionevoli, così da evitare le lungaggini e le farraginosità proprie delle strutture universitarie (altra cosa sarebbe stata, invece, la nuova e non meno illustre Accademia dei XL del Lorgna, fondata a Verona nel 1781).
Dell’organismo padovano — che raggiunse subito un alto grado di prestigio e notorietà — entrarono infatti a far parte non solo cattedratici, ma uomini di cultura e di governo; da esso uscirono, fra i tanti contributi forniti, il piano per la rete viaria della provincia euganea ed un nuovo tipo di mortaio che fu subito impiegato dalle artiglierie di Angelo Emo contro i Tunisini, nel corso della campagna iniziata nel 1784 (67).
Ma anche Venezia non poté sottrarsi, in questo scorcio di secolo, alla suggestione della ventata di razionalità scientifico-tecnologica che percorreva i centri della Terraferma, dell’Istria e financo della Dalmazia al seguito del dibattito agronomico: e così tra le lagune accanto al riproporsi delle tradizionali organizzazioni volte ad assicurare la preparazione dei giovani patrizi all’agone politico ed a vagliarne capacità ed attitudini (come l’Accademia presso i Contarini di S. Trovaso, fondata nel 1754, la Giustiniana nel 1766, la Farsetti-Erizzo nel 1778) — assistiamo al sorgere della Società di medicina (nel novembre del 1780 fu negato invece, su parere dell’accoppiata Gozzi-Tron, il permesso di erigere l’israelita istituto dei Cronicomi (68)); ancora, sul piano delle strutture pubbliche, il 3 ottobre 1777 si era aperto, all’interno dell’Arsenale, un corso quinquennale di «Studi fisico-matematici relativi alla navale architettura», diretto dall’abate Gianmaria Maffioletti, e lo stesso istituto agli ex Gesuiti aveva attivato (terminazione del 27 settembre 1792) un laboratorio di meccanica, affidandolo all’abate Bartolomeo Toffoli (Calalzo 1755 — ivi 1834); purtroppo quest’uomo d’alto ingegno era rapidamente impazzito, sicché, con provvida sensibilità, fin dal gennaio 1794 i riformatori stabilirono di devolvere parte del suo stipendio all’ospedale di S. Servolo per il mantenimento dell’infelice, stante la «compassionevole situazione di mente sconcertata in cui si attrova».
L’iniziativa di maggior significato resta comunque quella che un recente studio ha definito il nuovo «polo medico, farmaceutico e chimico-fisico» che si cercò di realizzare, sempre nella scuola alle Fondamenta Nuove, nel corso dell’ultimo decennio del secolo (69).
Si è visto (70) come il Collegio dei medici fisici della città fosse stato gravemente danneggiato dal decreto senatorio del 26 maggio 1775, che imponeva ai suoi otto dottorandi la preliminare frequenza quadriennale ai corsi dello Studio padovano: danno appena temperato dalla riserva — prontamente accordata agli stessi — di sei posti nel Collegio di S. Marco; in pratica, l’antico privilegio degli otto dottorati veniva di fatto annullato col venir meno dell’incentivo economico, ossia con le minori spese ch’esso comportava rispetto ai corsi padovani.
Donde lamenti suppliche pressioni finalmente sfociati nella terminazione del 4 febbraio 1793 (71), che, sulla scorta di un progetto didattico elaborato dal dottor Pietro Pellegrini, consentiva l’iscrizione direttamente al terzo anno di medicina a Padova a non più di dodici studenti che avessero compiuto gli studi agli ex Gesuiti (dov’era stata attivata la cattedra di istituzioni mediche), integrati da un ciclo di sessanta lezioni di anatomia, nella sede del Collegio medico veneziano.
Sotto l’attenta, intelligente guida dell’abate Bartolomeo Bevilacqua, l’istituto alle Fondamenta Nuove andava così sempre più caratterizzandosi come una scuola di studi superiori avanzati non solo propedeutici all’Università, ma ad essa addirittura integrati, visto ch’erano in grado di surrogare il primo biennio padovano per giurisprudenza e medicina.
Logico quindi che a tale istituto, ed alle sue potenzialità, guardassero quanti, a Venezia, nutrivano interessi professionali di natura scientifica: ecco allora una nuova significativa terminazione dei riformatori, datata 28 febbraio 1794, con cui si concedevano alcune stanze dell’ex convento per ospitarvi la neonata Società veneta di medicina ed un laboratorio chimico-fisico progettato e diretto da Vincenzo Dandolo, ancor giovane allora, ma già ricco e famoso.
Vediamo in breve di che si tratta, rinviando al già ricordato saggio di Giormani quanti desiderano più ampie informazioni.
La Società di medicina era sorta il 4 luglio 1789 su iniziativa dei dottori Andrea Valatelli, Pietro Pezzi e Francesco Aglietti, che intendevano dar vita ad un organismo più efficiente dell’ormai obsoleto Collegio medico-fisico, ispirandosi a modelli già esistenti a Londra, Parigi e Madrid; il nuovo organismo, di cui facevano parte i più bei nomi della farmacia, della medicina e della fisica nell’area lagunare (da ricordare, oltre al Dandolo, i futuri municipalisti Filippo Armano, Antonio Collalto, Rocco Melancini e Stefano Andrea Renier), ricevette dai provveditori alla sanità l’incarico di esaminare il nuovo Codice farmaceutico della Repubblica, uscito dopo lunga attesa nell’aprile 1790: il parere espresso fu così poco lusinghiero che i provveditori fecero ritirare le copie già vendute del Codice, proibendone ogni ulteriore smercio. Dopo di che i membri della Società preferirono dedicare i loro sforzi all’elaborazione di un piano di regolari osservazioni meteorologiche, da attuarsi mediante i nuovi apparecchi del Volta (72).
Quanto al progetto di Dandolo, esso consisteva nell’impiantare un laboratorio fisico-chimico-farmaceutico, al fine di promuovere le conoscenze e le tecniche della chimica farmaceutica, pressoché sconosciute in un ambiente dominato ancora dalla farmacia galenica.
In sostanza, le richieste avanzate dalla Società di medicina e dal Dandolo erano state evidentemente concertate assieme, al fine di riunire in un unico edificio — l’istituto agli ex Gesuiti — una sorta di cittadella del sapere scientifico.
Solo in parte, tuttavia, il progetto trovò attuazione, a causa del pericolo d’incendi che l’impianto del laboratorio avrebbe necessariamente comportato: rimangono comunque intatti il valore dell’iniziativa e la positiva risposta dei riformatori, che rappresentano un tassello veramente importante nel processo di trasformazione della cultura veneta, la quale di lì a poco sarebbe stata chiamata a confrontarsi con l’accelerazione impressa al settore dalla nuova trionfante sensibilità scientifico-tecnologica, che fu propria dell’età napoleonica.
Dopo la caduta
Non tedierò ulteriormente il lettore col racconto di quel che avvenne tra il 1797 e la fine del secolo, perché non farei che fornire l’elenco di relazioni e progetti puntualmente naufragati o disattesi (73), e tutti — democratici o monarchici che fossero — portati a privilegiare il momento educativo su quello culturale, essendo caratterizzato il referente governativo da un’accentuata matrice ideologica.
Aggiungo inoltre che le turbinose vicende politiche, gli sconvolgimenti costituzionali ed amministrativi, la crisi finanziaria resero di fatto impossibile l’attuazione non già di riforme migliorative, ma neppure di una normale gestione della realtà esistente: se il concetto appare ovvio in generale, risulta tanto più evidente in un settore per sua natura richiedente tempi lunghi e continuità istituzionale, come quello della pubblica istruzione.
Di fatto, la municipalità del 1797, attraverso il suo comitato di istruzione pubblica (Pietro Antonio Bembo, Antonio Collalto, Francesco Gritti, Nicolò Rota, Agostino Signoretti), soppresse le scuole dei chierici e l’Accademia dei nobili, inoltre ridusse il numero dei frequentanti il seminario di S. Cipriano; quanto poi all’istituto agli ex Gesuiti, il rettore Bevilacqua ed il suo vice Aprilis rassegnarono spontaneamente le dimissioni, sicché a fine anno la scuola venne affidata all’altro vicerettore, Giovanni Donà. Su di essa abbiamo una relazione, indirizzata al governo austriaco in data 14 settembre 1799, da don Pietro Pernion, che abbiamo già trovato docente presso queste scuole e divenuto, dal 1790, parroco di S. Polo (74). Commissario agli esami di fine anno, il Pernion ci informa che il Donà — compromesso col passato regime — è stato a sua volta sostituito dal vicerettore don Giovanni Pilloni, che per la stessa ragione è stato rimosso il sacerdote Simone Sardin e che inoltre l’insegnamento di matematica e fisica è passato ad Antonio Cicuto, in luogo del dimissionario Collalto (75); ancora, parla di un istituto frequentato da più di quattrocento studenti. Non risulterebbe pertanto alcuna contrazione rispetto al numero di trecentonovantatré registrato nel 1796, nonostante il calo della popolazione; senonché occorre tener presente che la municipalità aveva abolito le specifiche scuole dei chierici e l’Austria aveva confermato tale scelta, per cui molti ecclesiastici erano confluiti nell’istituto agli ex Gesuiti: ben cinquantuno (all’incirca il 20% del totale), se ho contato come si deve tra le liste del Pernion. Ma per tornare ai docenti delle scuole agli ex Gesuiti, se ne veda l’elenco nella Tab. 6 ove, accanto ai nomi alla data del 1796 e all’arrivo degli Austriaci nel 1798, si riportano le variazioni anche in termine di emolumenti stabilite dalla municipalità(76).
Passata la tempesta del 1797 s’era cercato di tornare in qualche modo alla normalità: così il 6 luglio 1799 Pilloni era riuscito ad ottenere dal commissario Pellegrini che avesse luogo la consueta assegnazione dei premi agli studenti, benché per ragioni d’economia si fosse dovuto rinunciare all’altrettanto tradizionale «accademia» di componimenti che accompagnava la cerimonia di chiusura dell’anno scolastico; ancora, Pellegrini aveva dato disposizioni per far pulire e riaprire la biblioteca dell’istituto, chiusa ormai da un biennio.
Insomma, le scuole agli ex Gesuiti avrebbero continuato ad esistere praticamente sul solco del vecchio impianto sino alla decisiva riforma napoleonica del 1807, che finalmente avrebbe dotato il sistema scolastico preuniversitario veneziano di quella efficace, prestigiosa struttura quale fu il liceo S. Caterina, oggi Marco Foscarini, a poche centinaia di metri dal precedente istituto, trasformato in caserma.
Quanto alle scuole dei sestieri, l’Austria confermò al Savoldello l’incarico di ispettore, che gli era stato sottratto dalla municipalità (ma tardi: il 28 novembre 1797); anche per queste strutture i rapporti ufficiali sono improntati ad ottimismo, tuttavia la realtà doveva essere ben diversa, come testimonia il moltiplicarsi incontrollato dell’attività dei maestri privati, pur nel «drastico ridimensionamento dell’istruzione» che emerge da una rilevazione del 1801, utilizzata da Michele Gottardi nel suo bel libro.
A questo proposito vorrei terminare ricordando un’iniziativa proprio nell’ambito delle scuole private, destinata a grande successo e che fu sempre molto cara ai Veneziani: quella dei padri Cavanis, i fratelli Anton Angelo e Marc’Antonio, che a partire dal 1798 presero a raccogliere allievi — dapprima una decina, poi sempre più numerosi — in una loro casa alle Zattere (Dorsoduro). L’istituto era gratuito e si proponeva come fine il recupero culturale e sociale di giovani altrimenti destinati a crescere nella strada.
Ma questa storia appartiene ad un’altra epoca.
1. Il caso dei Bergamaschi è stato recentemente documentato da Andrea Zannini, Flussi d’immigrazione e strutture sociali urbane. Il caso dei bergamaschi a Venezia, «Bollettino di Demografia Storica», 19, 1993, p. 211 (pp. 207-215).
2. Il compito di ovviare alla lacuna venne assunto dai governi successivi a quello marciano, in particolare da quello asburgico: cf. in proposito Giorgio Scarpa, Strade e agricoltura nel Veneto della Restaurazione, «Atti e Memorie della Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona», 169, 1987-1988, pp. 1-88.
3. Secondo i calcoli di Beltrami, nel 1760 il patriziato rappresentava il 3,4% dei residenti nella Dominante, mentre l’alta borghesia l’8,3% (Daniele Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Padova 1954, p. 72).
4. Padova, Biblioteca Universitaria, ms. 914: Jacopo Nani, Saggio politico del corpo aristocratico della Repubblica di Venezia per l’anno 1756, cc. n.n.
5. Per l’educazione dell’unica figlia, Chiara, il ricchissimo procuratore di S. Marco, Piero Pisani Moretta, versò al monastero della Croce una retta di 100 ducati annui tra il 1716 ed il 1717, ossia fin quando la giovanetta ebbe compiuto i sedici anni; attorno alla metà del secolo quest’ultima, rimasta vedova, operò nello stesso modo con le tre figlie, mentre per altrettanti maschi si rivolse a precettori privati; i suoi quaderni di cassa documentano l’acquisto di un solo libro, la Gerusalemme liberata del Tasso nell’edizione albrizziana del 1745, col moderato esborso di ducati 17:18 (Giuseppe Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta. Storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro vicende patrimoniali tra 1705 e 1836, Roma 1984, pp. 146 e 268).
6. Per citare un illustre esempio, Nicolò Tron (1685-1772), fondatore del lanificio di Schio e padre del celebre Andrea, studiò nel Collegio di Parma dal 1702 al 1704. Le sue stringate — stringate eccome, ad onta dell’ambizioso assunto — Theses ex universa philosophia [...] sono consultabili tra le miscellanee della Marciana. Nel Collegio ducale la presenza di Veneziani e nobili di Terraferma fu di tutto rispetto: negli anni compresi fra il 1700 ed il 1750, su un totale di 1.121 convittori i sudditi della Serenissima furono 223, ossia il 20% (Gian Paolo Brizzi, La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento. I seminaria nobilium nell’Italia centro-settentrionale, Bologna 1976, pp. 38 e 179-180).
7. In una antiretorica Istruzione al figlio quindicenne, stesa attorno alla metà degli anni Trenta del secolo da Giusto Antonio Erizzo — un patrizio di medie fortune e notevole intelligenza —, si esclude la validità dei collegi e soprattutto dell’ambiente padovano, come strumento educativo, sostenendo invece la bontà del controllo domestico col prevalere della moralità sulla dottrina. Così l’Erizzo al destinatario dello scritto, sul punto dell’istruzione ch’egli dovrà a sua volta riservare ai futuri figli: «Nell’educazione de’ medesimi, avverti poi la più diligente attenzione [...]. Provedili d’un savio, dotto, ma, più assai, che sia accostumato direttore, o sia religioso d’età avanzata e d’acclamate virtù, e se puoi di meno, tienli lontani da’ collegi, meno poi da farli educar in Padova, ove nella confusione delle scienze e nella gara de’ bei spiriti, vi alligna una non sana e troppo nuova credenza. Allontanati dal cenno del padre, non apprendono la vera suggezione a’ genitori né le massime del nostro governo, meno poi gl’interessi domestici. S’allevano colà con massime oltramontane e con troppo bizzarri spiriti, ed allo ritornare alle loro case niente hanno appreso né di disciplina paterna, né di patria, né di domestico modo di vivere. Sinché son teneri, non pensar neppur di correggerli indiscretamente né con la mano, osservando sempre che la sola tua autorità et assoluta li ponga a freno». Quando poi si tratterà «o di maritarli o di mandarli ne’ pubblici impieghi [destini] il più capace all’economia et al matrimonio, e quello che sarà più dotato di talento ed applicato allo studio per i pubblici impieghi [...]». Diversamente da altri consimili documenti, l’importanza di questo scritto è data dalla sua originalità, ossia dal non essere destinato alla divulgazione, ma ad uso strettamente privato, come testimonia il tono (sincero al punto da sfiorare talora la rudezza) con cui l’Erizzo si rivolge al figlio, che pure — si badi — era il suo unico erede: «Tu per verità, a parlarti da sincero ed affettuoso padre, non sei nato per essere grande. Non te lo accorda né la tua nascita né le tue fortune né il tuo talento, né io certamente ravviso in te quei spiriti che ti potessero far elevare a’ più cospicui posti e gradi della Repubblica». Battista (era questo il nome del fruitore dell’opera) non rivestì effettivamente un ruolo degno di segnalazione nel gran mondo lagunare (rimasto vedovo, non trovò di meglio che farsi abate, ch’era il modo più spiccio per defilarsi dalla politica), ma suo figlio Paolo Antonio (1750-1824) sì, talché Marino Berengo ebbe a definirlo «una delle menti più acute dell’aristocrazia veneziana» (Giuseppe Gullino, «Una eredità di consigli e di salutari avvertimenti»: l’istruzione morale, politica ed economica di un patrizio veneziano al figlio (1734-1738?), in I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea. Atti del Convegno. Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983, a cura di Amelio Tagliaferri, Udine 1984, rispettivamente pp. 361 e 356 [pp. 339-363]).
8. Antonio Zardo, Gasparo Gozzi e le venete scuole nella seconda metà del Settecento, Firenze 1918, pp. 16-17.
9. Si tratta dell’ottima tesi di laurea di Antonio Fabris, Aspetti di assistenza al patriziato povero nella Venezia del XVIII secolo: l’Accademia dei nobili alla Giudecca, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Venezia, a.a. 1982-1983. In generale, sull’Accademia, è ancor valido il vecchio Luigi Zenoni, Per la storia della cultura in Venezia dal 1500 al 1797. L’Accademia dei nobili alla Giudecca (1619-1797), Venezia 1916.
10. Sul Collegio Amuleo, come pure su altre consimili istituzioni esistenti a Padova ed interessate dal riformismo settecentesco, rinvio ad un mio saggio: Una riforma settecentesca della Serenissima: il collegio di S. Marco, «Studi Veneziani», 13, 1971, p. 554 (pp. 515-586). Sulle precedenti strutture, oltre a quanto riportato nel volume di questa Storia relativo appunto al Seicento, cf. Maurizio Sangalli, Università, scuole private, collegi ed educazione, accademie a Padova tra ’500 e ’600: alcuni spunti per una storia «integrata» delle istituzioni scolastiche, «Annali di Storia dell’Educazione e delle Istituzioni Scolastiche», 3, 1996, pp. 93-118.
11. Richard Palmer, The Studio of Venice and Its Graduates in the Sixteenth Century, Trieste 1983, p. I. Sui non facili rapporti tra Padova e Venezia, concernenti appunto la facoltà di addottorare, cf. il denso studio di Virgilio Giormani, Contrasti fra l’Università di Padova e il Collegio dei medici di Venezia nel ’700, «Quaderni per la Storia dell’Università di Padova», 28, 1995, pp. 23-87.
12. Scritti di Gasparo Gozzi con giunta d’inediti e rari, scelti e ordinati da Niccolò Tommaseo, II, Firenze 1849, p. 335.
13. Michele Maylender, Storia delle Accademie d’ltalia, I-V, Bologna 1926-1930, ad voces; cf. inoltre Antonio Zanon, Della utilità morale, economica e politica delle Accademie d’agricoltura, arti e commercio, Udine 1771, pp. 280-302 Michele Battagia, Delle accademie veneziane. Dissertazione storica, Venezia 1826, passim; per una puntualizzazione critica della questione, Brendan Dooley, Le accademie, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 5/I, Il Settecento, Vicenza 1985, pp. 77-90.
14. Le norme sulle quali si fondavano le scuole del Ghetto veneziano, alla data del 1714, sono state studiate da Pier Cesare Ioly Zorattini, Fervore di educazione ebraica nelle Comunità venete del ’700, «La Rassegna Mensile d’Israel», 34, 1968, nr. 10, pp. 582-587 (pp. 582-591).
15. Istituito con un lascito dell’avvocato corfiota Tommaso Flangini, poteva ospitare 14 studenti, non necessariamente sudditi della Serenissima. Era (anzi è, poiché sussiste tuttora) situato presso la chiesa di S. Giorgio dei Greci e dipendeva dall’arcivescovo di Filadelfia; al termine del corso di studi, questi giovani potevano passare in uno dei due collegi universitari disponibili a Padova per la «nazione» greca: il Cottunio e quello denominato di S. Giovanni (A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 547, passim; Manoussos Manoussacas, The Histoy of the Greek Confraternity (1498-1953) and the Activity of the Greek Institute of Venice (1966-1982), «Modern Greek Studies Yearbook», 5, 1989, p. 329 [pp. 321-394]).
16. Mario Infelise, L’editoria veneziana nel ’700, Milano 1989, pp. 38-39.
17. Giorgio Pullini, Il teatro fra polemica e costume, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 5/I, Il Settecento, Vicenza 1985, p. 280 (pp. 277-307).
18. A.S.V., Inquisitorato alle Arti, b. 2, fasc. Arti di Venezia. 1797, cc. 10-11. Sulle presunte «bontà e docilità» dei popolani veneziani avrei tuttavia delle perplessità: in età napoleonica ed austriaca autorevoli testimonianze ne parlano come di purissima feccia. La realtà odierna conferma appieno la validità del secondo giudizio.
19. Su queste vicende, un breve quadro in Giuseppe Gullino, La politica scolastica veneziana nell’età delle riforme, Venezia 1973, pp. 69-78; gli obblighi ed il programma dei maestri, stabiliti nel 1578, a pp. 151-153.
20. Sulle vicende che accompagnarono la nascita di questi istituti, si veda Silvio Tramontin, Gli inizi dei due Seminari di Venezia, «Studi Veneziani», 7, 1965, pp. 363-377.
21. Tutto ciò, in A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 526, cc. n.n.
22. Per le scuole di nautica veneziana e corcirese, oltre al vecchio Giuseppe Bettanini, Documenti per servire alla storia della Scuola Nautica in Venezia, Venezia 1894, cf. ora Massimo Costantini - Luisa Florian, Una scuola nel Levante, in Levante veneziano. Aspetti di storia delle Isole Ionie al tempo della Serenissima, a cura di Massimo Costantini - Aliki Nikiforou, Roma 1996, pp. 149-175. A Corfù il Bronza poté disporre di un vascello di primo rango (ancorché di non recentissimo varo) per le esercitazioni pratiche, e sappiamo ch’era ancora attivo nel febbraio del 1740; alquanto modesto — secondo il condivisibile parere di Tucci — il programma da lui adottato, consistente in «una parte introduttiva sulla geometria pratica, sulla sfera armillare e sulla cosmografia; una seconda parte dedicata alla declinazione magnetica, al metodo per computare il cammino di una nave e alle maree; infine la pratica degli strumenti per rilevare la latitudine [...]» (Ugo Tucci, La pratica della navigazione, in Storia di Venezia, Temi, Il Mare, a cura di Alberto Tenenti - Ugo Tucci, Roma 1991, p. 548 [pp. 527-559]).
23. Un buon numero di queste relazioni, concernenti il periodo 1742- 1754, in A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filze 522-525: Diarii dei viaggi della Scuola di nautica. Gli scritti alternano pagine di calcoli e schizzi geometrici con brevi descrizioni delle esperienze di bordo, a dire il vero largamente colpevoli nei confronti di grammatica, sintassi e tutte queste cose qua; ecco uno scampolo della non proprio felicissima prosa del cadetto Francesco Tarabocchia, che il 31 maggio 1742 partì da Venezia alla volta di Malta sulla nave Protezion celeste e San Antonio di Padova: « [...] la mattina del medemo giorno [25 luglio] a horre 5 al levar del sole salpassimo del suddetto porto [Cefalonia] con la conserva per pochissimo vento da Levante, con la barca e caicchio da prova, che ne remurchiò fuori, seguitando la pocca bava di Levante fino le horre 11 [...]. Seguitando il nostro bordeggiare tra la Ceffalonia piccola e l’isola di Santa Maura, la sera del medemo giorno arrivassimo l’ontani di Cappo Ducato miglia 15 in circa. [Qui] ritrovassimo una tartana francese, noi ponessimo fuori la bandiera et essa seguitando il suo camino alla volta nostra tagliandone il camino senza por fuori la bandiera, alora li tirassimo un tiro di canon di coperta con la balla; subitamente spiegò fuori la bandiera bianca francese, e prese il suo camino da pupa di noi. Venendo a parlamento con il capitanio [Pietro Bozzato] ne diede relazione delli venti Nauti fuori; la sudetta veniva da Tripoli di Barbaria [...]. Seguitando la bonaccia, la mattina del 30 gietassimo il caichio in aqua per andar a remurchiar la nave [...]».
24. Brendan Dooley, Giornalismo, università e organizzazione della scienza: tentativi di formare una accademia scientifica veneta all’inizio del Settecento, «Archivio Veneto», ser. V, 155, 1983, pp. 5-39.
25. Cf. n. 7.
26. Renzo Derosas, I Querini Stampalia. Vicende patrimoniali dal Cinque all’Ottocento, in I Querini Stampalia. Un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, a cura di Giorgio Busetto - Madile Gambier, Venezia 1987, p. 58 (pp. 43-87). Nel 1714, a causa della guerra di Morea, gli interessi dei capitali in Zecca erano stati drasticamente ridotti al 2%; nel 1746, poi, si era giunti all’1 1/3%, eliminando anche formalmente la rata in resto, ossia una delle tre soluzioni mediante le quali venivano corrisposti gli interessi sui capitali a beneficio dei depositanti, e che era stata congelata appunto a partire dal 1714: in altri termini delle tre rate previste, da allora la Zecca decise di pagarne solo due, mentre la rimanente venne virtualmente accreditata al portatore del titolo. Di conseguenza ebbe a verificarsi una sorta di bancarotta, con due ovvi corollari: discredito del credito pubblico, con svelta disaffezione degli operatori realtini e stranieri — in primis, i Genovesi —; penalizzazione dei capitalisti veneziani, cioè dei patrizi il cui portafoglio era costituito in buona misura da titoli del debito statale. Alla luce di questa realtà, la vendita dei beni ecclesiastici promossa dalla deputazione ad pias causas assume un ulteriore significato, nel contesto della società lagunare.
27. Renata Targhetta, Secolari e regolari nel Veneto prima e dopo la legislazione antiecclesiastica (1765-84), «Studi Veneziani», n. ser., 19, 1990, pp. 176-177 (pp. 171-188). In base ai calcoli dell’A., nel giro di alcuni anni, fra il 1766 ed il 1790, il clero secolare veneto subì una contrazione di circa 2.000 unità, passando da 22.307 a 20.274 individui, mentre quello regolare quasi dimezzò, riducendosi da 7.770 a 4.265; ai superstiti tuttavia venne garantito un adeguato assegnamento, che variava da ordine a ordine, ma non fu mai inferiore a mezzo ducato al giorno: in altri termini, si ovviava — almeno sotto l’aspetto materiale — a talune indecorose e non più tollerabili situazioni di avvilimento del ceto ecclesiastico.
28. Il decreto 3 settembre 1772 (che recepiva integralmente una scrittura dei deputati ad pias causas di due settimane prima) così giustificava queste tre priorità: « [...] preferenza giustamente meritano gli ospitali, il clero secolare veneto e la educazione della gioventù, specialmente patrizia; nei primi racchiudendosi il benefizio a considerabile numero di popolo che senza tali istituzioni provide perirebbe nell’abbandono, nelle infermità e nella miseria; nel clero veneto contemplandosi il fine di suplire a quei difetti che [...] lo rendono in gran parte incapace a sostenere li più importanti doveri del sacro ministero; e nella educazione della gioventù, specialmente patrizia, accoppiandosi [...] le doti e le qualità de’ cittadini che devono succedere nel Governo ed operare la felicità della Repubblica nostra». La conclusione del documento indicava tuttavia chiaramente quale fosse il reale intendimento del legislatore: «[...] poiché li mezzi attuali somministrano migliori opportunità [...], usando appunto di quelle rendite che continuar devono in uso pio, la maturità del Senato quello reputa della educazione della gioventù il migliore tra tutti, comecché dal regolato costume e dalla soda disciplina nei studii dipende la formazione dell’uomo e del cittadino» (Bartolomeo Cecchetti, La Repubblica di Venezia e la corte di Roma nei rapporti della religione, II, Venezia 1874, pp. 167 s.).
29. A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 36, c. 542. Per quanto concerne il decreto 7 settembre 1768 e le sue implicazioni, rinvio a G. Gullino, La politica scolastica, pp. 25-27 e bibliografia ivi citata, al quale mi rifarò ampiamente nella presente trattazione, risparmiando al lettore l’afflizione di ulteriori citazioni.
30. Sul Gozzi rinvio ai risultati di una recente puntualizzazione: Gasparo Gozzi. Il lavoro di un intellettuale nel Settecento veneziano. Atti del Convegno (Venezia-Pordenone 4-6 dicembre 1986), a cura di Ilaria Crotti - Ricciarda Ricorda, Padova i 989; in partic., ai fini del presente discorso, si vedano i contributi di Piero Del Negro (Gaspare Gozzi e la politica veneziana, pp. 45-63) e Bruno Rosada (Gaspare Gozzi tra morale e pedagogia, pp. 79-93).
31. Scritti di Gasparo Gozzi con giunta d’inediti e rari, pp. 297-333.
32. Ebbe a scrivere il Baretti, senza che alcuno osasse contraddirlo, esser più utile ad una città una squadra di vuotacessi che una colonia di arcadi.
33. V. in proposito Piero Del Negro, I «Pensieri di Simone Stratico sull’Università di Padova» (1760), «Quaderni per la Storia dell’Università di Padova», 17, 1984, pp. 191-229; Id., L’università, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 5/I, Il Settecento, Vicenza 1985, pp. 66-72 (pp. 47-76)
34. Sui provvedimenti promossi dal Foscarini in seguito alla visita del 1771 rinvio ad un mio saggio, già citato alla n. 10, Una riforma settecentesca della Serenissima. Per quanto attuato nella Lombardia austriaca, in questo stesso torno di anni, Marina Roggero, Insegnar lettere. Ricerche di storia dell’istruzione in età moderna, Alessandria 1992, pp. 109-112.
35. Riporto, a titolo di esempio, uno stralcio del regolamento del Collegio, da me pubblicato in appendice del saggio di cui alla nota precedente: «Art. V: Rapporto alla disciplina cristiana, ch’è il principio d’ogni virtù, è preciso comando nostro [cioè dei riformatori] che ciascheduno degli alunni alle festività ed a Pasqua [...] s’abbia da accostare ai santissimi sacramenti della Chiesa, della confessione e comunione, ed abbia da esibire nelle mani del rev. rettore attestato che comprovi d’aver egli esercitati questi atti [...]. Art. XIII: Sarà permesso agli alunni d’entrare in qualche onesta bottega da caffè per reficiarsi con qualche onesta bevanda o per conversare con persone pulite. Ma vien loro proibito rigorosamente d’intrattenervisi per giocare a carte ed altri giochi, e molto più d’entrare nelle osterie e nelle bettole, sotto pena della pubblica indignazione». I convittori vestivano un’uniforme color marrone, con ricamato l’emblema marciano.
36. Bregolini non pensava alle città né alle campagne, ma soprattutto ai paesi come la sua Noale, che evidentemente già allora caratterizzavano la realtà veneta: «[...] terre ancora [scriveva] e grosse popolazioni vi sono, o per incuria o per impotenza, o per isfortuna degli abitanti, affatto prive di persone capaci d’erudire ed ammaestrare i giovanetti [...]. Qual tratto di generosa beneficenza non sarebbe quello d’un principe ch’estendesse le paterne sue cure a somministrare a questa porzione di sudditi i mezzi opportuni di qualche maestro [...]. Molti ingegni che per difetto della prima necessaria cultura infelicemente s’isteriliscono od infecondi periscono, si vedrebbero germogliare [...]. Molte oneste, ma povere famiglie, e prive del modo d’allevare allo studio i figlioli ne’ collegi e ne’ seminari, avrebbero la giusta consolazione di vederli iniziati nelle arti liberali e nelle prime scienze, e si troverebbero [...] in istato di mandarli poi a’ pubblici studi nell’università [...]. Il ritratto de’ fondi delle commende potrebbe il protettore della Chiesa convertirlo per qualche parte in quest’uso?» (G. Gullino, La politica scolastica, pp. 40-42). Sul Bregolini (1722-1807), cf. la voce di Ne-Reo Vianello in Dizionario Biografico degli Italiani, XIV, Roma 1972, pp. 116-118.
37. Sugli scritti dei vari Arduino, Bregolini, Memmo, Contin, rinvio a G. Gullino, La politica scolastica, ad indicem. Sull’opera di Contin, si veda inoltre Francesca Meneghetti Casarin, «Diseducazione» patrizia, «diseducazione» plebea: un dibattito nella Venezia del Settecento, «Studi Veneziani», n. ser., 17, 1989, pp. 148-150 (pp. 117-156); sulla figura dell’uomo e la sua carriera, Federico Seneca, Tommaso Antonio Contin e la cattedra di storia ecclesiastica nell’Ateneo patavino, «Quaderni per la Storia dell’Università di Padova», 25, 1992, pp. 445-457. Quanto al dibattutissimo tema della questione educativa nell’Italia dei lumi ed all’ingente produzione storiografica che lo ha accompagnato nell’ultimo trentennio, mi limito a ricordare alcuni dei più recenti lavori maggiormente attinenti all’area geografica in esame: per i termini generali della questione, oltre al già citato lavoro della Roggero, particolarmente attento al Piemonte (Insegnar lettere, pp. 113-135), Si veda Xenio Toscani, Scuole e alfabetismo nello Stato di Milano da Carlo Borromeo alla Rivoluzione, Brescia 1993 (cf. soprattutto pp. 157-228), che lascia spazio pure all’analisi della distribuzione territoriale degli istituti educativi. Circa poi l’istruzione primaria o elementare, Piero Del Negro, I letterati e la plebe: il problema dell’acculturazione delle classi popolari negli anni 1770, in Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa: convegni per il secondo centenario di Maria Teresa d’Austria, a cura di Aldo De Maddalena - Ettore Rotelli - Gennaro Barbarisi, II, Bologna 1982, pp. 1043-1058; Id., Alfabetizzazione, apparato educativo e questione linguistica in Lombardia e nel Veneto, in Teorie e pratiche linguistiche nell’Italia del Settecento, a cura di Lia Formigari, Bologna 1984, pp. 253-268; su quella superiore, o preuniversitaria: Elena Brambilla, Le professioni scientifico-tecniche a Milano e la riforma dei collegi privilegiati (sec. XVII-1770), in Ideologia e scienza nell’opera di Paolo Frisi (1728-1784), a cura di Gennaro Barbarisi, Milano 1987, pp. 383-446 (pp. 345-446); e ancora di Marina Roggero, per un periodo un poco più avanzato, Il sapere e la virtù. Stato, università e professioni nel Piemonte tra Settecento ed Ottocento, Torino 1987.
38. G. Gullino, La politica scolastica, pp. 46-66; Bruno Rosada, Un capitolo di storia dell’istruzione secondaria. Le «Pubbliche Scuole» a Venezia (1774-1807), «Istruzione Tecnica e Professionale», 19, 1982, pp. 185-193.
39. Cf. sopra, testo relativo alla n. 12.
40. G. Gullino, La politica scolastica, pp. 133-151.
41. Dottore in teologia, il Bevilacqua (1740-1815) studiò nel seminario di Treviso, dove ebbe come maestro di eloquenza Ubaldo Bregolini, che sarebbe stato un suo sottoposto nelle scuole degli ex Gesuiti. Fu Gozzi a preferire Bevilacqua, che prediligeva la matematica e la geometria rispetto alle materie umanistiche; e così l’asolano divenne rettore del nuovo istituto, conservando l’incarico sino alla caduta della Repubblica; quindi si dimise, nonostante la municipalità gli avesse aumentato gli emolumenti. Avrebbe ripreso il suo posto il 10 settembre 1801 per poi presentare nuovamente — e questa volta definitivamente — e dimissioni quando infine l’istituto venne chiuso, nel 1807, per far posto al nuovo liceo-convitto di S. Caterina. Nella circostanza il Moscati aveva offerto al Bevilacqua la cattedra di matematica, ma non il rettorato, che venne affidato al più giovane Antonio Traversi, a sua volta matematico e fisico. Sul Bevilacqua, si veda l’Elogio steso da Antonio Meneghelli, professore all’Università di Padova e già suo allievo, in Opere scelte dell’abate Bartolomeo Bevilacqua, Padova 1816, pp. VII-XLIII.
42. Ecco l’organico dell’istituto nell’a.s. 1781-1782, donde emerge diffuso il fenomeno della ripetenza nel ciclo inferiore, mentre in quello superiore — i cui insegnamenti appaiono già alquanto diversi da quelli inizialmente previsti, poiché non mancarono sostituzioni di materie e spostamenti di docenti — è riscontrabile la contemporanea frequenza a più corsi specializzanti: Prima classe: don Antonio Magrini, con 16 studenti (3 del I anno, 11 del II, 1 del III, 1 del IV); don Giuseppe Stefani, con 24 allievi (12 del I, 6 del II, 6 del III); don Giacomo Loris, con 27 allievi (15 del I, 6 del II, 5 del III, 1 del IV); don Pietro Pernion, con 30 allievi (23 del I, 6 del II, 1 del III). Totale: 97 allievi. Seconda classe: don Giacomo Marchetti, con 25 allievi (4 del I, 5 del II, 9 del III, 7 del IV); don Giovanni Maria Selva, con 27 allievi (5 del I, 8 del II, 6 del III, 8 del IV); don Antonio Donà, con 31 allievi (2 del I, 9 del II, 16 del III, 2 del IV, 1 del VI, 1 del VII). Totale: 83 allievi. Terza classe: don Giuseppe Rossi, con 14 allievi (2 del II, 3 del III, 3 del V, 5 del VI, 1 del VII); don Bernardo Meneguzzi, con 19 allievi (2 del I, 4 del II, 6 del III, I del IV, 1 del V, 3 del VI, 2 del VII). Totale: 33 allievi. Quarta classe: don Stefano Sala, con 26 allievi (7 del I, 1 del II, 3 del III, 2 del IV, 3 del V, 5 del VI, 3 del VII, 2 dell’VIII). Quinta classe: don Giuseppe Martinelli, con 10 allievi (2 del I, 1 del II, 1 del III, I del VI, 3 del VII, 2 del IX). Scuola di geometria: don Domenico Paccanaro, con 11 allievi (5 del II, 3 del III, 1 del IV, 1 del V, 1 del VII). Scuola di filosofia: don Pietro Lovis, con 9 allievi (di cui 2 del II, 5 del III, 1 del IV, 1 del IX; 5 frequentano anche la scuola di geometria). Scuola di eloquenza e giurisprudenza: dott. Ubaldo Bregolini, con 15 allievi (6 del I, 2 del II, 3 del III, 2 del V, 1 del VII, 1 del IX; anche qui, 5 frequentano altre scuole). Scuola di lingua greca: don Cirillo Martini, con 4 allievi, tutti frequentanti pure altre scuole (2 del III, 1 del VII, I del IX). Scuola di jus canonico e storia ecclesiastica: don Giuseppe Giuriati, con 3 allievi (2 del VI, 1 del VII). Scuola di teologia: don Giacomo Alberti, con 8 allievi (1 del I, 2 del II, 4 del III, 1 del VII). Totale: 299 iscritti ai diversi insegnamenti; in realtà 285 presenze fisiche di studenti secondo i nostri calcoli, benché il documento ne fissi il totale a 286. Come si è accennato, infatti, alcuni allievi (ad esempio nelle scuole di filosofia, di eloquenza e giurisprudenza, di lingua greca) seguivano più corsi, e quindi figuravano contemporaneamente in classi diverse (A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 533, fasc. 2: Elenchi studenti). In una relazione al principe, datata 22 novembre 1778, i riformatori (Girolamo Ascanio Giustinian, Francesco Pesaro, Zaccaria Valaresso) scrivevano che la maggior parte degli scolari che frequentavano l’istituto agli ex Gesuiti, «arrivati ad una età sufficiente, et acquistate le prime istruzioni, passano nelle arti e nelle professioni proprie della lor condizione». Questa disaffezione dei Veneziani verso l’istruzione era risultata ancor più marcata prima del «nuovo corso» riformatore: nell’agosto 1768 il magistrato aveva denunciato come, di fronte a dodici posti disponibili, solo tre patrizi si fossero iscritti all’Accademia della Giudecca; ancora, una terminazione del 6 giugno 1769 stabiliva che le lezioni di diritto civile ad uso degli allievi della cancelleria ducale, che solevano tenersi presso la Libreria marciana, dovessero esser svolte in lingua italiana anziché latina; che il sabato fosse di vacanza; che tre anni di corso fossero valutati come cinque ai fini della carriera: il tutto, «onde allettare i giovani della Cancelleria ducale ad intervenire nelle [sic] lezioni» (A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 36, cc. 282, 286r-v).
43. Questa la struttura iniziale del programma secondo la terminazione esecutiva, che riproduco: «Notizia generale d’ordine degl’illustrissimi ed eccellentissimi signori Deputati estraordinari ad pias causas ed Aggiunto sopra monasteri. In esecuzione del decreto dell’ecc.mo Senato 20 gennaro 1773 [...]. Le scuole si apriranno il 26/4/1774, con 8 classi di studio e materie così ripartite: Prima classe: maestri due. Leggere con buona pronunzia - Scrivere con buon carattere e correttamente - Principii della grammatica italiana congiunti a quelli della latina - Principii di aritmetica pratica - Alcuni scolari negli elementi del disegno. Seconda classe: maestri due. Grammatica latina unita alla lingua italiana - Aritmetica numerale sotto il maestro particolare nell’ora assegnata - Elementi della cronologia - Continuazione del disegno. Terza classe: maestro uno. Grammatica latina detta superiore, unita alla prosodia - Geometria sotto lo stesso maestro di aritmetica della classe precedente nell’altra ora assegnata - Principii di geografia - Continuazione del disegno. Quarta classe: maestro uno. - Umanità - Mitologia, o sia storia favolosa - Istoria veneta, romana e di altre nazioni - Logica sotto il maestro particolare nell’ora assegnata - Continuazione del disegno, come sopra. Quinta classe: maestro uno. Figure retoriche, o sian buone lettere - Continuazione della storia - Elementi della morale civile e dell’economia famigliare. Sesta classe: maestro uno. L’arte oratoria sopra i migliori esemplari sacri e profani. Settima classe: maestro uno. Filosofia, cioè elementi di metafisica nella seconda ora, poiché questo maestro deve nella prima ora insegnar la logica a quelli della quarta classe. Ottava classe: maestro uno. Teologia dogmatica e morale, sopra gli autori approvati» (A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 533, fasc. 3: Decreti).
44. Con decreto senatorio del 19 agosto 1773 s’era istituita a Venezia una scuola di ostetricia appoggiata al Collegio medico, al quale tuttavia, due anni dopo, era stato sottratto l’antico privilegio di conferire la laurea dottorale ad un massimo di otto studenti all’anno. Su tutta la materia, A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 521.
45. Per le testimonianze di Corradini e Labia, rinvio a G. Gullino, La politica scolastica, pp. 58-59.
46. Per esempio: Michelangelo Balzi s.j., Ars novitatis oratori, Venetiis ut placeat, necessaria. Prolusio in inauguratione studiorum, Venetiis 1703.
47. Su di essi, cf. il testo relativo alla n. 20.
48. Il decreto patriarcale, del 7 gennaio 1776, in A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 541, ad diem. Giovanelli era stato eletto due giorni prima.
49. E intanto i chierici continuavano a bigiare; in una relazione ai riformatori, del 15 settembre 1782, il Bevilacqua ripeteva ancora una volta che il loro numero risultava «sommamente scarso [nelle scuole] di Jus canonico e di Teologia, che sono destinate all’ammaestramento de’ soli chierici. [...] L’alienazione di questo clero non solo dalle scuole pubbliche, ma da tutte le altre ancora, l’abitudine di allevarsi nell’ozio e nell’ignoranza, il falso pretesto della bolla Sistina, che li tiene occupati in un servigio materiale ed inutile, furono cose altre volte assoggettate alla maturità di questo ecc.mo magistrato. Ora non farò che soggiungere come non fu mai così ristretto il numero de’ chierici in queste scuole, come lo fu nell’anno corrente; perché tra quelli che si trovavano ascritti alle scuole, vari ne furono scelti sul principio dell’anno pel seminario patriarcale, e pochissimi furono quelli che vi si ascrissero nell’anno presente. Convien credere che non abbia bastato a superare la fermezza de’ parrochi il zelo di mons. Patriarca, ricercato dall’ecc.mo Senato recentemente su questo articolo; perché dalli 20 dicembre passato, in cui fu decretata la ricerca, fino al giorno presente un solo chierico non si presentò per essere ascritto alle scuole» (A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 533, fasc. 2: Relazioni, ad diem).
50. Ristampai gli Statuti delle scuole dei chierici, editi il 21 luglio 1785, in G. Gullino, La politica scolastica, pp. 163-173.
51. Ibid., p. 114.
52. A.S.V., Governo austriaco. Atti Bissingen, b. 50/35. La relazione non è firmata.
53. Cf. il testo relativo alla n. 31.
54. Cf. il testo relativo alla n. 19.
55. La scrittura in A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 39, cc. 77-79.
56. Ripubblicati in G. Gullino, La politica scolastica, pp. 155-158.
57. A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 529, fasc. 7.
58. A scorrere le carte dei riformatori si ricava infatti che su questi arrivi e partenze non c’erano regole fisse, e chi voglia conoscere un po’ meglio i motivi che spingevano gli scolari a disertare avrà anche modo di imbattersi in qualche genuino frammento della società veneziana del tempo; ecco un esempio, stilato da don Marienis, maestro a S. Ternita, il 28 agosto 1787: «Giovanni Cilia, 9 anni, figlio di un facchino, stette due mesi in scuola sempre con poca voglia di far bene e solo di giocare; poi mancò addì 5 luglio e ho saputo esser andato in una bottega da caregheta» (A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 529, ad diem; le filze concernenti le scuole dei sestieri vanno dalla 529 alla 532).
59. Il 28 gennaio i 794 i riformatori (Paolo Bembo, Francesco Vendramin, Pietro Zen) accordavano il non proprio ingentissimo premio di 80 ducati una tantum al Savoldello, in risposta ad una sua supplica ove ricordava i servizi ulteriormente espletati «quantunque non alligati al dovere di un ispettore. Tali furono la formazione di un Salterio, di un Abbaco, la duplice edizione di un formulario di lettere sì mercantili che familiari, la triplice edizione dell’Aritmetica numerica, degli esemplari a regola del carattere da me inventati, le recenti figure geometriche dall’autorità Loro addottate, l’annual diario dimostrante li giorni di scuola e vacanza, lo stato degli alunni premiati con la distinzione a parte di quelli trasfusi alle scuole degli ex gesuiti»; ricordava infine che queste «estranee cure» erano state da lui «incontrate dietro le prescrizioni dell’EE.VV.» (A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 61, cc. 831-832v). Se 80 ducati possono non sembrare granché, va detto però che in quello stesso 1794 al Savoldello toccò il bene d’esser nominato parroco di S. Margherita; dopo di che gli fu prontamente concesso di mantenere la duplice incombenza, cui anzi venne a sommarsi pure l’insegnamento «ne’ principi] geometrici», previsto con terminazione del 21 novembre 1792 per quegli studenti che intendevano inserirsi proficuamente nel mondo delle corporazioni di mestiere. Sul Savoldello e la sua produzione didattica, si veda Claudia Salmini, Il libro scolastico tra Settecento e Ottocento: due autori, in L’editoria del ’700 e i Remondini, a cura di Mario Infelise - Paola Marini, Bassano 1992, pp. 97-103 (pp. 97-121).
60. A.S.V., Deputazione ad pias causas, b. 50, ad diem. Su tutta la questione si veda inoltre ivi, Riformatori dello Studio di Padova, filza 535: Scuole private; cf. inoltre G. Gullino, La politica scolastica, pp. i 15-116.
61. Cf. testo relativo alla n. 44.
62. Cf. testo relativo alla n. 23.
63. Così l’Edgcombe relazionava ai riformatori circa il comportamento dei propri vicini: «Il titolo di ladro, bullo e ruffiano è il più famigliare col quale pubblicamente mi contrassegnino, dicono sulle finestre a voce aperta e in presenza delle mie istesse sorelle che esse vanno fuori di casa a procurarsi sollazzo e guadagno [...], e che la mia scuola non è già scuola di nautica, ma [...] casa di vituperio, a tutto questo aggiungendo bestemmie, imprecazioni e tali improperi, che crederei contaminare le pudiche orecchie di VV.EE. col proferirle» (A.S.V., Riformatori dello Studio di Padova, filza 526, cc. n.n.). Posso assicurare che tutt’oggi, in alcune zone del sestiere di Castello, il tratto dei residenti non sempre s’ispira allo stile oxoniense.
64. Dell’Edgcombe ci restano tre edizioni veneziane (1777, 1789, 1802) di un manuale intitolato Pratica giornaliera del piloto in altura [...] con le tavole necessarie alla [...] navigazione, che veniva distribuito gratuitamente agli allievi.
65. Genesi e svolgimento della defatigante questione sono stati ricostruiti da Francesca Lucchetta, L’ultimo progetto di una scuola orientalistica a Venezia nel Settecento, «Quaderni di Studi Arabi», 3, 1985, pp. 1-42, e bibliografia ivi riportata.
66. Cf. testo successivo alla n. 24.
67. Sulla nascita ed i primi tempi dell’Accademia patavina di scienze, lettere ed arti, Piero Del Negro, Appunti sul patriziato veneziano, la cultura e la politica della ricerca scientifica nel secondo Settecento, in Giampiero Bozzolato - Piero Del Negro - Cecilia Ghetti, La Specola dell’Università di Padova, Brugine 1986, pp. 264-294 (pp. 249-294).
68. Questa la motivazione addotta da Gozzi: «Se fosse con tal metodo fondato un piano per un corpo cattolico, ardirei d’affermare ch’esso è interamente regolato e proficuo: ma essendo ordinato per un’adunanza di genti, forse le più di tutte osservabili per la loro accortezza e misteriosa dissimulazione, non posso fare a meno di toccare alcuni sospetti [...]» (G. Gullino, La politica scolastica, pp. 91-92). A Venezia, in quegli anni, particolarmente pesanti furono le sanzioni antisemite promosse dal Tron; in direzione opposta muoveva invece la politica asburgica: si vedano per tutti Chiara Lesizza Budin, La scuola ebraica goriziana dalle origini all’anno 1800, in AA.VV., Ha-Tikvà. La speranza attraverso l’ebraismo goriziano, Gorizia 1991, pp. 17-27, e la bibliografia ivi riportata; Diana De Rosa, Le scuole pie e normali della nazione ebraica di Trieste (XVIII e XIX secolo), «Quaderni Giuliani di Storia», 17, 1996, nr. 1, pp. 7-20 (pp. 7-37). Tuttavia, alla caduta della Repubblica, operavano nel Ghetto otto maestri di scuola e sei maestre, su un complesso di 1.626 anime (Marino Berengo, Gli ebrei veneziani a fine ’700, in AA.VV., Italia judaica. Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima emancipazione, Roma 1989, p. 12 [pp. 9-30]).
69. Virgilio Giormani, La scuola pubblica agli ex gesuiti: un polo medico, farmaceutico e chimico-fisico nel 1794 a Venezia, «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, 152, 1993-1994, pp. 33-61. Un quadro d’insieme dell’organizzazione scientifica nel Veneto tra Sette ed Ottocento in Maria Laura Soppelsa, Scienze e storia della scienza, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 6, Dall’età napoleonica alla prima guerra mondiale, Vicenza 1986, pp. 493-517 (pp. 493-551).
70. Cf. n. 44.
71. Cf. testo relativo alla n. 44.
72. Alessandro Volta, Epistolario, III, Bologna 1952, pp. 49-50: lettera di Francesco Aglietti, segretario della Società di medicina, del 21 novembre 1789.
73. Basti per tutti il progetto di un Teatro Civico volto a sviluppare gli inespressi ed oscuri — ma indubitabilmente presenti — «talenti» popolari, inoltrato alla municipalità sin dai primi giorni della sua azione politica, a firma di otto cittadini: in testa Niccolò Ugo Foscolo (Raccolta di carte pubbliche, istruzioni, legislazioni [...] del nuovo Veneto Governo democratico, I, Venezia 1797, pp. 239-240). Per il periodo successivo, larga messe in A.S.V., Governo generale austriaco, b. 1: Atti inespediti del commissario Pellegrini, passim.
73. A.S.V., Governo generale austriaco, b. 288, 1799/IV, fasc. 4. Sul sistema scolastico veneziano negli anni immediatamente successivi alla caduta della Repubblica, Michele Gottardi, L’Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806, Milano 1993, pp. 280-287.
74. L’ex municipalista Antonio Collalto (Venezia 1765-Padova 1820) riparò dapprima in Olanda, quindi a Parigi ed a Milano, per riprendere poi l’insegnamento a Padova in età napoleonica. Amico di Vincenzo Dandolo e di Joseph Louis Lagrange, fu matematico di notevole levatura, ancorché non geniale (cf. su di lui la «voce» di Ugo Baldini in Dizionario Biografico degli Italiani, XXVI, Roma 1982, pp. 774-777).
75. Pertanto l’accrescimento risulta di ducati 6.472:7, pari al 74,5% della spesa registrata nel 1796 (A.S.V., Governo generale austriaco, b. 1: Atti inespediti del commissario Pellegrini, cc. n.n. Si tratta di un «piano», non firmato né datato, per risollevare l’istruzione pubblica veneziana colpita dal «totale rovescio di metodi» attuato dalla municipalità).