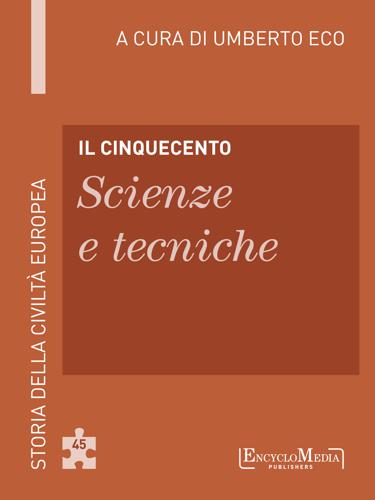I luoghi della scienza: corti e mecenatismo
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Nel corso del Cinquecento le corti si affermano come veri centri di produzione culturale e attraverso il mecenatismo dei principi sono il luogo di attività di medici, scienziati e ingegneri. L’interesse dei principi per la cartografia e la navigazione, così come per medicina e alchimia costituisce uno dei principali impulsi alla pratica scientifica.
Il mecenatismo delle scienze
Tra Quattro e Cinquecento le corti assumono sempre più il ruolo di centri di produzione culturale, divengono luoghi in cui si raccolgono non solo artisti e letterati, ma anche filosofi, medici e scienziati. Il mecenatismo è parte integrante dell’esercizio del potere del principe e, nello stesso tempo, uno dei principali fattori che contribuiscono alla diffusione delle scienze. Le corti divengono così le sedi privilegiate per la diffusione di nuove idee e pratiche scientifiche, spesso bandite dalle università. In particolare gli Asburgo e soprattutto Rodolfo II accordano la loro protezione a naturalisti, medici e astronomi. In Italia il mecenatismo delle scienze si verifica in primo luogo in Toscana, dove i Medici si mostrano personalmente interessati alle scienze esatte e alle scienze occulte. Il mecenatismo si estende dalle arti alle scienze anche a Roma e nei centri minori dell’Italia centrale e settentrionale (come Urbino e Ferrara). In Spagna e Portogallo il mecenatismo si sviluppa in stretta relazione ai viaggi e alle esplorazioni, che richiedono qualificati cartografi e navigatori. In Inghilterra i sovrani Tudor – in particolare Elisabetta I – proteggono matematici e geografi, la cui opera è finalizzata ad accrescere la potenza inglese nei mari. In Francia, con l’appoggio di Enrico III, fiorisce l’Accademia del poeta Jean-Antoine de Baïf, dove vengono discussi temi filosofici e scientifici, tra cui la cosmologia copernicana.
In Europa centrale e in Danimarca
I principi tedeschi si distinguono soprattutto per la protezione che accordano ai sostenitori della medicina di Paracelso, che invece le maggiori università europee condannano duramente. La prima diffusione del movimento paracelsiano sarebbe stata impossibile senza l’attivo sostegno delle corti: i paracelsiani (e in numerose corti anche gli alchimisti) trovano nei principi un attivo supporto finanziario che consente la pubblicazione delle loro opere, e spesso permette loro di creare un laboratorio. Alla corte di Otto Heinrich, duca di Neuberg, poi elettore palatino, trova ospitalità Adam von Bodenstein (1528-1577), uno dei primi a diffondere il pensiero di Paracelso, e Alexander von Suchten, autore di un famoso trattato sull’antimonio. Un altro patrono dei paracelsiani è Augusto I di Sassonia, alla cui corte opera Michael Toxites, curatore dell’edizione di numerose opere di Paracelso.
Una delle figure più attive e più originali nell’ambito del mecenatismo delle arti e delle scienze in Europa è Rodolfo II, figlio di Massimiliano II (anch’egli mecenate delle arti e delle scienze). Nella sua corte a Praga, Rodolfo II raccoglie medici, paracelsiani e alchimisti – Ercker (1530?1594), Croll, Ruland, Maier) –, naturalisti – Mattioli e Dodoens –, nonché astronomi e astrologi. Tra questi, vi è l’astronomo danese Tycho Brahe, che nel 1599 diviene matematico di corte, posizione poi occupata da Keplero. Rodolfo II non è solo un mecenate, ma è un accanito collezionista di opere d’arte e di minerali, e si interessa direttamente alle scienze, sia alle scienze occulte sia alle applicazioni pratiche, in particolare alla metallurgia e alla mineralogia.
In Danimarca, il re Federico II, il cui medico personale è il paracelsiano Petrus Severinus, dà in feudo (nel 1576) a Tycho Brahe l’isola di Hveen, nel Sund, dove l’astronomo costruisce il castello di Uraniborg che diventa la sede di un osservatorio e di vari laboratori. Qui Brahe compie osservazioni per un ventennio, e costruisce strumenti astronomici molto più precisi di quelli allora in uso.
In Italia
In Toscana – nell’ambito del consolidamento politico dello Stato – Cosimo I de’ Medici dà un contributo significativo allo sviluppo delle scienze, riorganizzando l’ateneo pisano e chiamando professori di prestigio. Egli stesso si dedica a studi di botanica e lavora nella Fonderia, un vero e proprio laboratorio costruito all’interno di Palazzo Vecchio. Tra gli interessi di Cosimo I vi è l’alchimia, coltivata anche dal suo erede Francesco I, che si dedica soprattutto allo studio delle scienze della natura, in particolare di fenomeni straordinari, nonché alla preparazione di farmaci dai poteri eccezionali e di meccanismi meravigliosi, come quelli per realizzare il moto perpetuo. La corte medicea diviene uno dei centri della penisola più attivi nel campo della ricerca naturalistica; vi confluiscono materiali e conoscenze da varie località europee e dal Nuovo Mondo. Ferdinando de’Medici, mentre è ancora cardinale a Roma, e prima di succedere al fratello Francesco I, utilizza i canali della diplomazia pontificia, per fare arrivare a Firenze numerosi reperti naturalistici dall’America.
A Urbino i Montefeltro sono i mecenati di scienziati e tecnici, come Luca Pacioli, Federico Commandino, Francesco di Giorgio Martini e Guidobaldo Del Monte. Importante la protezione accordata a eminenti medici che operano come medici di corte, ricevendo vantaggi economici, aiuti per la pubblicazione delle loro opere e spesso cattedre nelle università. È il caso di Nicolò Leoniceno, professore di medicina a Ferrara e medico dei duchi, che per circa cinquant’anni si dedica a studi di botanica e farmacologia.
In Inghilterra e in Francia
Il mecenatismo dei sovrani inglesi, da Enrico VIII a Giacomo I, si orienta in primo luogo verso i costruttori di macchine, di strumenti musicali e di orologi, di strumenti scientifici e verso i cartografi, le cui opere e competenze favoriscono l’accrescimento della potenza economica inglese. A beneficiare del mecenatismo della corte inglese, nella seconda metà del secolo, vi sono medici, astronomi e matematici, alcuni dei quali sostenitori del sistema copernicano, come Thomas Digges Thomas Harriot e William Gilbert.
John Dee, matematico, astrologo, alchimista e mago, riceve una pensione da Edoardo VI e successivamente è al servizio della regina Elisabetta I come consulente per la navigazione, con il compito di costruire strumenti e produrre carte geografiche. Ma l’attività a corte di John Dee si estende anche all’astrologia e alla magia: nel 1577 egli è invitato dalla regina a interpretare il significato dell’apparizione delle comete e subito dopo deve mettere a frutto le sue arti magiche per liberare Elisabetta da un maleficio.
In Francia il mecenatismo delle scienze e tecniche ha inizio con Francesco I, al cui servizio opera (dal 1517 alla morte nel 1519) Leonardo Da Vinci. Ad Amboise Leonardo prosegue i propri studi di geometria, meccanica e idraulica, progetta e costruisce macchine. Ai due anni in cui è al servizio di Francesco I risale il progetto di Leonardo di costruzione di una residenza reale a Remorantin (presso Amboise), nonché di un’ambiziosa rete di canali navigabili che avrebbero dovuto collegare il Mediterraneo all’Atlantico.
Sotto Carlo IX, Jean-Antoine de Baïf organizza incontri di musicisti e di poeti che nel 1570 ricevono un riconoscimento ufficiale da parte del sovrano. Si tratta della prima accademia francese che, alla morte del sovrano, ottiene la protezione di Enrico III, personalmente interessato alla filosofia, e diventa l’Académie du Palais, sotto la direzione di Guy de Pibrac. Le attività dell’accademia, di cui fanno parte Ronsard, Dorat, Jodelle, Tyard, Aubigné e Jacques Davy du Perron, si estendono alla filosofia e alle scienze.
Nuove concezioni scientifiche, tra cui il copernicanesimo, sono dibattute dagli accademici e dal sovrano che esprime vivo interesse per il pensiero di Giordano Bruno, a Parigi tra il 1581 e il 1583. Le guerre di religione provocano poi un rapido declino delle attività dell’Académie du Palais.
Nel vivo delle guerre di religione, grazie all’appoggio del duca Anne de Montmorency, l’ugonotto Bernard Palissy, dopo essere stato incarcerato a Bordeaux nel 1559, ottiene la protezione della regina madre Caterina de’ Medici che, oltre a salvargli la vita, lo impiega come ceramista nella decorazione delle Tuileries. Nel 1575, a Parigi, Palissy tiene una serie di lezioni di storia naturale e crea una collezione di “oggetti straordinari e mostruosità della natura”. Le sue attività scientifiche e tecniche terminano nel 1588, anno in cui viene arrestato, perché protestante, e incarcerato alla Bastiglia.
In Spagna e in Portogallo
I sovrani spagnoli, impegnati nella colonizzazione del Nuovo Mondo, mostrano particolare interesse per gli studi astronomici e cartografici. Sono legate alla navigazione anche le ricerche in campo naturalistico che Filippo II commissiona nel Nuovo Mondo. Nel 1503, la Corona crea a Siviglia la Casa de Contratación che, da ufficio per il controllo della navigazione e dei commerci con il Nuovo Mondo, diviene in seguito centro d’insegnamento e di diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche legate alla navigazione. La necessità di accumulare ricchezze e conoscenze (sia geografiche sia naturalistiche) provenienti dall’America spinge Filippo II ad associare al Consiglio delle Indie il cosmografo Juan Lopez Velasco che raccoglie osservazioni astronomiche condotte nelle Indie Occidentali.
Nel 1570 Filippo II, personalmente interessato alla botanica, promuove una spedizione scientifica nel Nuovo Mondo sotto la guida del geografo portoghese Francisco Dominguez, e affida al medico Francisco Hernandez il compito di effettuare uno studio della fauna e della flora del Messico. Ai viceré viene richiesto di mettere a disposizione alcuni artisti, perché realizzino illustrazioni delle piante locali. Il risultato della spedizione è una monumentale raccolta di dati, all’interno della quale sono descritti e accuratamente raffigurati piante e animali. A causa dell’enorme mole di materiale, Filippo II non si impegna a far pubblicare la raccolta di Hernandez; di essa il medico italiano Nardo Antonio Recchi, allora presente alla corte di Madrid, compone un compendio (non pubblicato) e, in seguito, l’Accademia dei Lincei ne prepara una parziale edizione a stampa, il Tesoro messicano , che compare solo nel 1651.
A Madrid, nel 1582, Filippo II inaugura l’Accademia delle scienze, dove scienziati di vari Paesi tengono periodicamente lezioni, soprattutto su argomenti di matematica e ingegneria. Oltre alle conferenze, i membri dell’accademia preparano traduzioni in castigliano di opere scientifiche e costruiscono strumenti scientifici. All’Escorial è costruito un laboratorio nel quale operano distillatori, medici e alchimisti, provenienti da varie parti d’Europa.
I sovrani portoghesi del XV e del XVI secolo hanno piena consapevolezza dell’importanza degli studi di astronomia per la navigazione. L’astronomo ebreo Abraham Zacut, cacciato dalla Spagna per non essersi convertito al cattolicesimo, si rifugia in Portogallo, dove lavora per pochi anni – in quanto espulso anche dal Portogallo – come astronomo di corte e contribuisce all’organizzazione della spedizione di Vasco de Gama.
Successivamente l’astronomo Pedro Nuñez, un conversos (Ebreo convertito al cattolicesimo), lavora per il re portoghese Giovanni III (1502-1557) come astronomo e medico di corte e poi riceve la cattedra di astronomia all’università di Coimbra. Nuñez insegna astronomia ai membri della corte e a esponenti della nobiltà, ed è quindi nominato supervisore della marina portoghese, con la funzione – tra le altre – di controllare la produzione di carte per la navigazione.