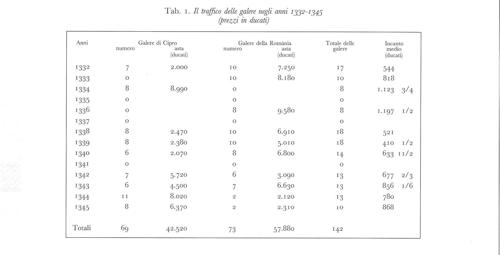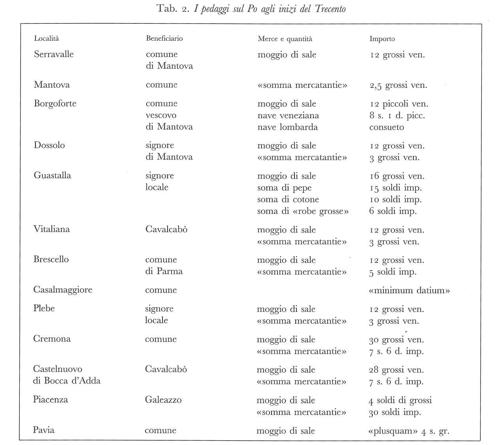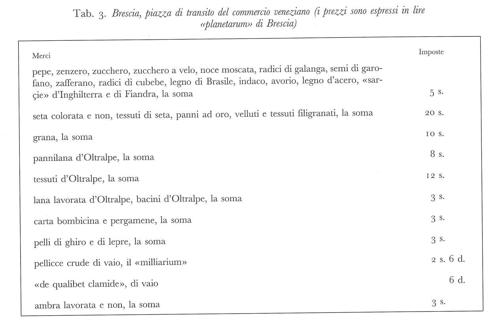I meccanismi dei traffici
I meccanismi dei traffici
Uomini e merci
Appartiene alla logica di un'economia essenzialmente marittima la creazione o l'accaparramento degli scambi via mare fra i diversi settori di una costa divisa in zone di influenza e in mercati: e proprio questo realizzò Venezia nell'arco del secolo XIII, con la conquista della Romània, costituendo un impero coloniale e un vasto mercato nel Mediterraneo orientale e nell'Adriatico, assoggettati al controllo della sua flotta. Città marinara dominante, dalla fine del Duecento Venezia venne evolvendosi come organismo economico e sociale dotato di istituzioni tese alla protezione dei mercanti e allo sviluppo commerciale: uomini delle più varie estrazioni sociali - aristocratici o popolani, cittadini a pieno titolo o immigrati - parteciparono a questo processo. Anche se l'incontestabile potenza economica di Venezia alla fine del Medioevo ne ha favorito l'identificazione con un sistema capitalistico a dominanza mercantile, si trattava di un sistema ibrido, nel quale l'investimento di capitali andava di pari passo con ogni sorta di privilegi volti a mantenere la guida degli affari, economici, commerciali o politici che fossero, in mano a una ristretta frangia della società.
Agli albori del secolo XIV il sistema economico veneziano era già pervenuto alla piena maturità. Perfettamente strutturato, esso ruotava intorno a un gruppo di operatori specializzati che fungevano da intermediari negli scambi fra produttori e consumatori stranieri: mercanti capitalisti che traevano i propri profitti dall'investimento e dalle successive vendite, operazioni reiterate all'infinito così da amplificare i guadagni. I produttori rimanevano al di fuori del processo di circolazione delle merci, appannaggio esclusivo dei mercanti. Tanto i profitti commerciali quanto l'esistenza stessa del capitale mercantile e della mercatura avevano origine nello scambio di prodotti fra comunità differenti e lontane le une dalle altre, vale a dire nel commercio "di transito". I cespiti principali non venivano dall'esportazione dei prodotti della terra - nell'accezione veneziana medievale di "patria" - bensì dalla mediazione degli scambi fra comunità commercialmente ed economicamente meno sviluppate e dallo sfruttamento di bacini di produzione specializzati. Da intermediario, nettamente separato dalle diverse sfere produttive, fungeva quel capitale mercantile che proprio su tale base si era costituito.
Il mercante acquistava a basso prezzo per rivendere ad alto; ma il saggio di profitto tendeva a diminuire con l'espansione stessa dei traffici, che contestualmente produceva l'innalzamento della domanda sui mercati di approvvigionamento e dell'offerta su quelli di smercio. A questa caduta i mercanti cercavano di ovviare puntando sulla diversificazione dei beni circolanti e sull'allargamento dei mercati esistenti o sull'apertura di quelli nuovi. Come le altre città marinare, anche Venezia assecondò lo sviluppo di questo commercio articolato, sostenendo lo sforzo dei propri operatori nella ricerca di nuovi oggetti di scambio e nell'esplorazione di vie commerciali vergini, come pure nell'ottenimento di privilegi e di facilitazioni in terre sempre più lontane. La Serenissima aprì dunque la via a forme originali di investimento a elevato tasso di profitto, variabile in funzione dei tempi di circolazione delle merci e della più o meno celere rotazione del capitale monetario. Ma si poteva altresì riservare quella frazione di capitale che non aveva trovato impiego nei traffici e destinarla a operazioni creditizie; il capitale mercantile si configurava insomma secondo due specie a loro volta dipendenti dalla destinazione dell'investimento, nel commercio di beni, ma anche in quello del denaro. Sull'uno e sull'altro fronte gli investitori erano sempre gli stessi, al punto che la storiografia non isola la figura del mercante da quella del mercante-banchiere.
Lo Stato procedette al consolidamento del capitalismo mercantile attraverso dispositivi e istituzioni giuridiche intese alla salvaguardia della proprietà mobiliare e dei contratti nonché elaborando strutture affatto nuove destinate a favorire gli interessi dei mercanti soprattutto nei settori protezionistico, coloniale e finanziario.
Ciò fece mettendo questi ultimi al riparo dalla concorrenza dei vicini, il che significò per Venezia l'imposizione del monopolio marciano sui piccoli centri costieri e su di un entroterra sempre più vasto.
Per favorire il commercio internazionale e l'economia marinara, a partire dal secolo XIII fu invece creata - con l'impiego talora della forza, talaltra della diplomazia dei trattati - una rete di punti d'appoggio in territorio straniero, cui si accompagnò l'apertura di sbocchi commerciali e l'insediamento di colonie mercantili. Tali punti d'appoggio, mercati e colonie non erano scelti certo a caso, ma là dove il flusso dei traffici aveva concentrato gli scambi, sì da garantire la continuità del commercio e, insieme, la sicurezza delle persone. Essi andavano difesi ad ogni costo dalle rivolte indigene e dalle ambizioni dei rivali, anche al prezzo degli oneri di guerra e dell'indebitamento pubblico.
Infine, per provvedere al finanziamento dei prestiti contratti - pagamento degli interessi e ammortamento del capitale - vennero assegnate entrate ordinarie dello Stato, provenienti dalle imposte indirette sul consumo e sul commercio di transito. Una politica fiscale e finanziaria a tutto vantaggio dell'aristocrazia mercantile, giacché i prestatori erano quasi esclusivamente dei mercanti capitalisti cui veniva offerta la possibilità di investire parte dei propri capitali in titoli del debito pubblico negoziabili sul mercato e realizzabili in qualsiasi momento. Nel quadro di una sapiente diversificazione, i profitti finanziari andavano così ad aggiungersi a quelli commerciali e a quelli del prestito a interesse, non conoscendo il capitale accumulato pause o tesaurizzazioni improduttive. Come dire che, nel secolo XIV, il debito pubblico trasformava il denaro inerte in capitale, senza i rischi connessi all'investimento mercantile o all'usura. Materialmente i creditori nei confronti dello Stato non davano nulla: la somma prestata veniva trasformata in obbligazioni trasferibili che funzionavano in mano loro come moneta contante. Il sistema poggiava sulle tasse pagate dai consumatori e dai mercanti stranieri attivi nell'import-export con i Veneziani. Se guerre o iniziative statali di altra natura a sostegno del commercio marittimo - invio di ambascerie, prebende volte ad assicurarsi la fedeltà di principi-clienti, dimostrazioni di forza - obbligavano a ricorrere al debito pubblico, erano sì i mercanti a fornire il sostegno economico ma in definitiva erano altri a pagare.
Le "mude", i "fondachi", l'associazione dei mercanti in comunità su base nazionale, strumenti introdotti per organizzare il commercio e migliorarne l'efficienza, come pure la ricerca di nuovi prodotti e di nuovi mercati, la concentrazione degli scambi, il progresso delle tecniche mercantili e bancarie, la fondazione di colonie, il rafforzamento del controllo sul retroterra veneziano, tutto questo concorreva a garantire profitti elevati, a far lievitare i tassi e ad accrescere il reddito da capitale. Profitti che aumentavano ogni qual volta le condizioni generali consentivano di rafforzare il monopolio sul commercio di transito, destinato tuttavia a tramontare a misura dello sviluppo economico di quelle stesse popolazioni la cui debolezza aveva contribuito a instaurarlo (1). In questo caso, il declino del sistema del commercio di transito non provocava semplicemente la crisi di questo o di quel settore dello scambio, ma anzi, corrodendone il fondamento della ricchezza, metteva in discussione la supremazia medesima dei popoli a spiccata vocazione mercantile. Tale inversione di tendenza si traduceva nel calo dei rendimenti dell'investimento e nel decremento del saggio di profitto. I mercanti constatando un'evoluzione dei prezzi a loro sfavorevole, quando tentavano d'incrementare il volume degli affari, cercavano allora per i propri capitali destinazioni differenti dal commercio, volgendosi a comparti economici quali l'industriale, il bancario e il fondiario.
D'altronde i mercanti-banchieri non ignoravano certo l'investimento industriale, specie nei rami di attività più direttamente connessi con lo scambio come, ad esempio, la cantieristica; e quanto fosse stretto tale legame lo dimostra il fatto che gli armatori appartenessero sovente allo strato superiore del ceto mercantile. Le economie marittime fondavano la prosperità di tale ceto sulla maggiorazione praticata sui prezzi dei beni occidentali distribuiti in Oriente e di quelli orientali importati in Occidente. Poiché le merci che meglio si scambiavano contro i ricchi prodotti dell'Oriente erano i panni di lana, l'industria tessile di lusso era un settore privilegiato dell'investimento mercantile; da quando le botteghe artigiane cominciarono a produrre per l'esportazione e non più per il mercato locale, i mercanti importatori di lana grezza ed esportatori di tessuto lavorato finirono per ridurre la figura dell'artigiano a quella di mero dipendente, incaricato di dar corso alle commesse.
Da lungo tempo a Venezia un limitato investimento fondiario si accompagnava a quello mercantile e industriale. Se in città l'acquisto di case, fondachi o botteghe era senz'altro remunerativo, in campagna campi e tenute non erano sempre visti, almeno inizialmente, come un investimento redditizio. Si compravano bensì le terre, ma per farne luogo di soggiorno e di riposo nei pressi della città, al contempo villeggiatura e fonte di rispettabilità sociale come pure rifugio durante le epidemie che devastavano gli agglomerati urbani. Fu questa la prima tappa della penetrazione fondiaria dei Veneziani in terraferma, che si sarebbe prolungata fino alla metà del secolo XV (2).
Il patriziato e lo sviluppo economico
Il Trecento appartiene ormai a una fase caratterizzata dall'aumento degli investimenti nel commercio, dal lievitare delle rendite e dall'investimento dei profitti, dall'aumento del numero e dell'importanza delle imprese marittime, dal perfezionamento dei trasporti via nave e dall'immigrazione di mano d'opera qualificata come anche dalla specializzazione e dalla divisione sociale del lavoro. Tutti elementi, questi, che contribuivano alla riduzione dei costi e all'accelerazione del ritmo di circolazione delle merci e del capitale.
Per favorire l'espansione, la diversificazione e la razionalizzazione del commercio, il ceto mercantile ottenne il concorso attivo dello Stato, tangibile nelle istituzioni giuridiche, protezionistiche, monetarie, finanziarie e coloniali, tutte orientate a garantire i guadagni e ad aumentare i profitti (3).
Il concentrarsi di questi ultimi stimolò lo sviluppo, e condizionò il consumo, il risparmio e il reinvestimento. Il risparmio, che poteva essere spontaneo o forzato, era decisamente forzato per le classi subalterne chiamate a pagare il costo degli interventi esterni operati dallo Stato a favore dei mercanti, attraverso l'istituzione del debito pubblico, delle imposte sul consumo, della svalutazione della moneta di biglione riservata ai pagamenti interni. Ancora più sfruttate dal monopolio dei traffici erano tuttavia le comunità straniere.
La popolazione veneziana viveva sulle risorse del mare essendo le isole troppo piccole per fornire una produzione agricola sufficiente. Perché Venezia divenne una grande potenza marinara? Perché acquistò una funzione di intermediaria negli scambi via mare fra produttori di merci differenti? Per poter assumere tale ruolo era necessario poter disporre di eccedenze barattabili contro i beni prodotti in terraferma, e il sale fornì questa prima e indispensabile merce di scambio. Gli scambi sale-grano probabilmente contrassegnarono la fase iniziale dell'economia lagunare determinando inoltre l'origine della navigazione fluviale, in Laguna e nell'alto Adriatico. Ben presto anche questi scambi si rivelarono insufficienti; la vita e il benessere della popolazione esigevano ben di più: carne, vino, olio, spezie. La città si impegnò ulteriormente nell'attività marinara, nei traffici, nell'attività armatoriale e cantieristica (4).
Fernando Fagiani non esita a parlare di "una larghissima e capillare mobilitazione di capitali - attraverso i tipici contratti di colleganza e di prestito marittimo - al servizio del commercio oltremare [che] dava ad esso la possibilità di sfruttare le sempre nuove occasioni che si offrivano a uomini di ogni estrazione sociale dotati di inventiva, intraprendenza, capacità, coraggio. [...] La via alla mercatura [era] aperta a tutti i capaci e gli intraprendenti; tutti costoro [potevano] trovare l'appoggio finanziario necessario per ampliare il loro volume di affari, per far circolare ricchezza, non vi [erano] discriminazioni a livello sociale fra i finanziatori e i finanziati" (5). Si tratta però di una visione poco realistica, parziale e incompleta della società veneziana e del suo funzionamento, in quanto assimila gli strati sociali più abbienti a tutta la popolazione. A Venezia, nel Medioevo, c'erano i ricchi e c'erano i poveri e non occorre essere degli esperti per avanzare l'ipotesi che i poveri fossero più numerosi dei ricchi e che la gente di modesta estrazione sopravanzasse numericamente i patrizi.
Come tante altre città medievali, Venezia avrebbe potuto accontentarsi di creare una fiera stagionale ove attirare mercanti e denaro; essa preferì invece sfuggire a questa logica costituendo un centro ove si trovassero permanentemente (lungo tutto il corso dell'anno) i prodotti del Levante, dell'Asia e dell'Occidente. Per creare l'"emporio ", si dovette vietare l'uso di Venezia come porto di transito: gli stranieri che avessero voluto inviare merci verso Levante attraverso la città lagunare, dovevano necessariamente, una volta pagati i diritti di ingresso, venderle ai Veneziani, anzi a coloro tra essi che avessero i requisiti giuridici necessari all'esercizio del commercio. Quando, viceversa, acquistavano a Venezia prodotti levantini o orientali, non potevano farlo se non tramite cittadini veneziani. A questi ultimi (mercanti e armatori) era riservato tutto il commercio proveniente dal Mediterraneo e ad esso diretto, attraverso la piazza di Rialto. Agli stranieri erano interdetti sia l'imbarco di merci dalla Signoria al Levante sia l'acquisto diretto nel Levante di merci destinate a transitare per il porto della città (6).
Affinché l'emporio raggiungesse la massima produttività, il flusso dei prodotti dall'Oriente verso Rialto e da Rialto verso l'Occidente doveva mantenersi continuo, ampio e il più veloce possibile. Qualsiasi calo in uno di questi fattori avrebbe determinato una perdita di ricchezza, mentre un ingorgo dell'afflusso avrebbe riempito oltremisura i magazzini con la conseguente immobilizzazione dei capitali. Occorreva dunque regolamentare la domanda e l'offerta, cosa che non fu mai facile. La domanda dipendeva dagli abituali fattori congiunturali cui tuttavia si aggiungevano ostacoli imprevisti: chiusura delle vie di transito, nuove tasse imposte dai signori che le controllavano, scarsa sicurezza delle strade, mancanza di denaro o di merci da scambiare. Quando ci si rendeva conto della contrazione della domanda era spesso troppo tardi - complice la lentezza delle comunicazioni - per tentare di adattare l'offerta e di ridurre gli acquisti sui mercati orientali. Così pure per quanto riguardava l'offerta dall'India, dalla Persia o dall'Estremo Oriente di prodotti che si muovevano al lento ritmo delle carovane fino ai porti del Levante, ove li attendeva un numero più o meno elevato di imbarcazioni. A seconda della consistenza delle carovane e delle navi i mercanti orientali potevano sperare in prezzi migliori o temere di non rientrare nemmeno nelle spese sopportate nel lungo viaggio attraverso i deserti asiatici. Se l'invenduto si fosse accumulato nei depositi orientali, l'anno successivo il numero delle carovane si sarebbe ridotto (7).
Gli stessi Veneziani contribuivano a indebolire le funzioni dell'emporio. Quando infatti navigavano nei mari occidentali ove praticavano il tramping, cadevano nella tentazione di cedervi direttamente i prodotti orientali o di acquistare merci occidentali da portare nel Levante senza passare attraverso l'emporio realtino, traffici questi che il senato aveva proibito in quanto avrebbero indebolito le funzioni di Rialto. Le merci acquistate nel Levante dovevano venir sbarcate a Venezia prima di poter ripartire verso Ponente, anche via mare, e nel passaggio pagavano una duplice tassa d'ingresso e di uscita. Sulle principali strade del Levante lo Stato creò linee commerciali regolari cui concesse il monopolio assoluto del trasporto dei prodotti più preziosi al fine di mantenere in vita l'emporio realtino, circondandolo con una barriera di protezione. La regolarità delle linee garantiva un'organizzazione rigorosa che agevolava le decisioni degli operatori, mentre il calendario prestabilito induceva da un lato i Veneziani a mobilitare capitali e merci alla vigilia delle partenze, dall'altro i mercanti stranieri operanti in città a riunire i capitali necessari agli acquisti in previsione dei rientri. I viaggi regolari favorivano le previsioni e gli operatori, già a conoscenza dell'offerta all'arrivo della muda, programmavano gli investimenti per la muda successiva. Parimenti, la regolarità degli arrivi delle galere nei porti levantini determinava l'organizzazione degli stessi mercati del Levante (8).
Eccellente esempio di collaborazione fra Stato e privati, le galere, di proprietà statale, venivano costruite in cantieri statali su ordinazione di un patrizio nominato dal senato mentre l'armamento e la gestione erano affidati a privati i quali, a scadenze annuali, li acquistavano all'asta. Il senato metteva all'incanto sulle tre linee di Cipro, della Romània e di Alessandria, il numero di navi che, sulla base delle stime dei traffici, riteneva necessarie. Solo i patrizi potevano prendere parte alle aste e dunque armare e gestire le galere, conservando così il monopolio assoluto del trasporto delle merci più preziose.
Il patriziato aveva comunque ceduto parte delle attività mercantili a un'altra categoria, il cui profilo giuridico si identificava con la sua sola capacità di condurre gli affari. Il ceto dei "cittadini", numericamente paragonabile a quello dei patrizi, formava il 5% della popolazione veneziana e godeva di particolari privilegi. Ne facevano parte tre gruppi: i cittadini "originarii", di antica ascendenza veneziana, e i cittadini "de intus" o "de intus et de extra", originariamente stranieri ma residenti cui era stata conferita la cittadinanza e che in città pagavano le tasse. Molti di loro erano mercanti che in tal modo fruivano della protezione delle leggi e dello statuto giuridico di Veneziano negli affari. Solamente chi apparteneva a queste categorie sociali e giuridiche poteva praticare la mercatura (9).
Il mercante di Venezia
L'estimo del 1379, stabilito per l'imponibile dei prestiti durante la guerra di Chioggia, censiva coloro la cui ricchezza immobiliare superasse le 300 "lire a grossi": 38 istituti religiosi e 2.128 persone, tra cui 1.211 nobili e 917 "popolani". Tra questi ultimi, il più ricco era Bandino Garzoni, un mercante lucchese (10) che nel 1381 ottenne un titolo nobiliare per il suo contributo finanziario alla guerra. Disponevano di oltre 10.000 lire 26 popolani che avevano fatto fortuna con il commercio del grano, come Pietro Regla di San Giacomo dall'Orio e il mercante "de biave" Lunardo dall'Agnella, oppure con le spezie come lo "spicier" Nicolò Sturion di Santa Maria Nova. All'interno delle professioni dei popolani erano rappresentate tutte le corporazioni artigiane: macellai, lattai, fruttivendoli, saponai, calzolai, bottai, fabbri, orefici, muratori, carpentieri, sarti, barbieri, tintori, cordai, tavernieri, conciatori, ecc. Fra i più ricchi, 15 droghieri e 13 pellicciai, esponenti di quella borghesia mercantile operante entro i limiti della città e non al di fuori di essa.
a) Il mercante e i mestieri
Alcune manifatture, come quelle del vetro, delle pelli o della lana, che abbisognavano di maggiori capitali per l'acquisto della materia prima e delle attrezzature e nelle quali erano previste fasi successive di lavorazione del materiale ad opera di diversi specialisti, richiedevano una stretta collaborazione di mastri e mercanti. Per il vetro, ad esempio, si dovevano utilizzare diversi tipi di forno, tutti di proprietà di nobili mercanti che li affittavano ai mastri vetrai. Tale collaborazione andava dall'importazione delle materie prime all'esportazione del prodotto finito. "Come spesso succedeva, i Veneziani si trovarono in un'inconsueta posizione di favore all'intersezione delle vie del commercio delle pellicce", quelle che dalla Russia raggiungevano l'Oriente e quelle - soprattutto le pelli di agnello - che dalle regioni meridionali salivano verso il Nord. Le pellicce venivano trasformate a Venezia da corporazioni specializzate: i "varotarii", i "peliparii" e i "glirarii". Gli importatori si accordavano con gli artigiani pellicciai, sia cedendo loro le pelli da rivendere sul mercato locale dopo la lavorazione, sia rimanendone proprietari, nel qual caso i mastri fungevano da loro agenti ("compari") (11).
L'industria tessile era controllata dai fabbricanti di tessuti di lana, mercanti imprenditori che acquistavano la lana, e la davano poi da cardare, filare, tessere e follare all'industria domestica, formata spesso da artigiani assai qualificati, pagati a cottimo.
Così pure facevano i "fustagnarii" del cotone. Le industrie dipendevano in larga misura dal capitale investito da mercanti nobili, che fornivano la materia prima, il denaro e l'organizzazione necessari a piazzare il prodotto in mercati lontani. Nel settore della lana, assai marcato era il predominio della gilda dei mercanti di tessuti che formavano una corporazione imprenditoriale, mentre cardatori, follatori e filatori non erano autorizzati ad associarsi in gilde: nella Venezia medievale non esisteva infatti una generale Arte della lana (12) e tuttavia le Arti erano numerose, tanto che il catalogo di Monticolo ne elenca 54: "il pesce, l'olio e il frumento erano generi alimentari che possedevano ciascuno la sua arte" (13). Le Arti veneziane erano ripartite in innumerevoli microspecialità attente ciascuna a salvaguardare la propria particolarità gestendo direttamente gli acquisti così da evitare il rischio che i mercanti potessero assicurarsene il monopolio. Secondo Frederic C. Lane ne facevano parte artigiani-gestori più che mercanti-padroni (14). Le amministrava la magistratura della giustizia vecchia, che rappresentava anche un'istanza d'appello contro le decisioni della "banca dell'arte" e una protezione contro i capricci dei mercanti e del mercato.
Lo Stato esercitava un severo controllo sulla qualità del prodotto. Nel 1355 una filatrice vendette a un mercante tedesco 10 libbre d'oro filato avvolto in gomitolo secondo l'uso di Tana, al prezzo di 10 ducati la libbra. Poiché era impossibile fornire un materiale così bello a un prezzo inferiore, il mercante le suggerì di tenere il filo migliore all'esterno del gomitolo; lui si sarebbe occupato di spedire la merce a Tana. La donna fece un primo esperimento con 10 libbre e il mercante, soddisfatto del lavoro, le fornì oro per 40 lire di grossi, passandole un ordine per un totale di 400 ducati. Successivamente però cambiò idea e rifiutò di acquistare un quarto dell'ordinazione. Il marito della donna e il mercante portarono la questione davanti ai consoli dei mercanti che eseguirono una perizia; il metallo, fuso da due uomini dell'Arte, risultò contenere 2 libbre e 3 once di oro non puro (" turpis "). La coppia di artigiani fu condannata a una multa in quanto, come ricordarono i consoli nella loro relazione, "pro honore terre et comodo mercatorum, quilibet faciens artem auri filati tenetur facere quod aurum quod vendit sequatur de subtus de medio et de super", ossia tutta la matassa doveva essere di pari qualità e il filo esterno non doveva nasconderne di qualità inferiore: erano in gioco l'onore di tutto il ceto mercantile e la reputazione di Venezia (15).
b) L'apprendistato del mercante: i consigli di un padre
Nel suo testamento Giovanni Stornado (morto nel 1348) aveva raccomandato ai procuratori di speculare con il denaro dell'eredità dei suoi figli ancora minori: avrebbero dovuto effettuare i loro acquisti entro i due mesi successivi alla partenza da Venezia delle "galere da mercado" e rivendere l'anno successivo, in coincidenza con l'aumento dei prezzi, un mese prima che gli ultimi mercantili abbandonassero Venezia. L'operazione avrebbe dovuto ripetersi per tre anni: nel caso il profitto avesse raggiunto il 6% annuo si sarebbe andati avanti diversamente, il capitale avrebbe dovuto essere trasferito in buoni. Quando il figlio maggiore avesse raggiunto i diciotto anni, avrebbe iniziato l'apprendistato mercantile nel Levante; si sarebbe dovuta vendere allora la metà dei buoni o addirittura la totalità in caso di ottimi affari. È un esempio lampante di come i capitali finanziari potessero essere trasformati alternativamente in prestiti o in investimenti commerciali. All'età di diciotto anni, il secondo figlio avrebbe raggiunto il fratello in Levante ma i due, su consiglio del genitore, non avrebbero dovuto avere partecipazioni comuni alla stessa muda di galere; avrebbero potuto comunque viaggiare con le navi. La società sarebbe dovuta durare fino a che il più giovane avesse compiuto i venticinque anni: un bell'esempio di pianificazione economica (16). I procuratori agirono secondo le istruzioni ma, avendo perduto l'1,6% nella speculazione, si rifugiarono nei buoni al 6%.
c) Il mercante allo scrittoio
Pignol Zucchello, "originario di Pisa, nobile e savio mercante sotto la stazon dei panni a Rialto", divenuto cittadino "de intus et de extra", aveva per molto tempo dovuto tacere le malversazioni subite da parte di taluni dei consoci cui aveva dovuto rivolgersi, in quanto straniero, per i traffici "de extra". Un pellicciaio di Tana, Nicoletto Gata, gli scriveva che un viaggio fino a Tana, appunto, "elo non è miga 'l viagio da Rialto a San Marcho"; ma le disavventure del disgraziato non si limitarono a questo, dato che poi a Saraj fu ridotto in schiavitù per debiti. Ecco poi un saggio delle comunicazioni che Pignol, mercante non specializzato, riceveva dai suoi corrispondenti: gli erano state inviate da Candia 16 botti di vino, 3.415 forme di formaggio ripartite in due carichi a bordo di altrettanti "legni", e poi taffetà, candele di cera, due "fardelini" di zafferano, sei "pondi" di mandorle e una giara di olio (20 ottobre 1336); una missiva successiva, del gennaio 1337, precisava che i 3.048 formaggi imbarcati sul "legno grande" pesavano 27.076 libbre, pari a 4,250 chili cadauno. A Tana egli faceva acquistare pelli di martora, di faina e di vaio a centinaia. Poiché prestava molta attenzione alla qualità delle merci, Francesco Bartolomei, a Candia, gli dava avviso così di aver ricevuto la lettera: "sicome la detta malvagia sì non era così buona chome voi voreste" (18 marzo 1344). Da parte sua, il suo agente lo pregava di inviargli una scatola di stagno, 14.000 cerchi ("cierchi") da botte di lunghezze comprese tra gli 8, i 9 e i 10 piedi e 500-1.000 mazzi di vimini ben secchi in uno o due barili nuovi da 42 "mistati".
Non occorre insistere ulteriormente; abbiamo citato queste lettere commerciali solo per mettere in evidenza il carattere talvolta umile degli affari del mercante veneziano, tutt'altro che specializzato unicamente negli scambi di prodotti di lusso, come le lontane e preziose spezie da barattare con i superbi tessuti dell'artigianato fiammingo, poi tinti nelle botteghe fiorentine. Le lettere indirizzate al mercante di Rialto, che qui assumiamo come figura emblematica, ci ricordano giustamente che nel Medioevo si mangiava formaggio, si cucinava con l'olio e si beveva del vino che non sempre era della migliore qualità, ma che si poteva migliorare con un pizzico di spezie, che ci si faceva luce con le candele e, soprattutto, che a Venezia tutti questi prodotti dovevano essere importati, dando luogo a un commercio consistente, in volume d'affari come in valore. Zucchello non era un piccolo commerciante obbligato ad accontentarsi di vendere vimini; era informato degli arrivi e dei prezzi a Candia di spezie quali la "chanafistola", il pepe, l'incenso o l'indaco e di piante medicinali o purgative come lo "zaffiore", il falso zafferano di Alessandria, ma chiedeva che gli fossero spediti anche cotone turco e frumento. Tramite lettera veniva avvertito dei movimenti delle navi e delle galere nelle acque di Candia, degli ultimi porti toccati e delle future destinazioni (17).
d) Uno speculatore avveduto
La speculazione era legata a tutte le attività mercantili e finanziarie del comune. Il patrizio Tommaso Zane, nella primavera del 1363, lasciava in eredità 18 titoli di credito non ancora liquidati, acquistati a un prezzo assai inferiore al loro valore nominale da alcuni importatori che avevano posto in deposito il sale nei magazzini dell'ufficio del sale. Possedeva inoltre 2.000 "moggia" di sale, pari a oltre 2.000 tonnellate. I trasporti rientrarono a Venezia fra l'autunno del 1360 e l'estate del 1362; parte dei crediti venne rimborsata a Donato, figlio di Tommaso, fra il 1363 e il 1365 e i procuratori di San Marco, che amministravano la tutela di Donato, cedettero i titoli non pagati ad altri privati. Si trattava di crediti che l'ufficio rimborsava al loro valore nominale mentre gli aggiotatori li pagavano solamente al 70% qualora la scadenza non sembrasse loro troppo lontana. Tomà Zane, fiducioso nell'effettivo rendimento della speculazione sui crediti del sale, raccomandava all'erede di tenerne sempre per 7.000 ducati alla camera del sale; lui stesso, mentre era in vita, ne possedeva il doppio, 15.230. Ci è stato possibile calcolare su un esempio preciso, un'operazione avviata nel 1361 e terminata nell'aprile del 1364, che in tre anni il guadagno era stato del 132%. Era probabile che il collegio promettesse noli elevati che lo Stato sarebbe stato nell'impossibilità di pagare prima di diversi anni in quanto teneva conto di queste pratiche. Sapeva che mercanti e armatori, nella necessità di accelerare la rotazione dei capitali, cedevano crediti agli speculatori a un tasso medio del 45% - in altre parole gli importatori non ricavavano molto di più che anteriormente al 1345. Il resto, il 55%, andava ad arricchire ulteriormente i patrizi più benestanti come Zane, il quale interveniva talvolta in seconda istanza nella speculazione, riacquistando da altri membri del patriziato le "fedi" non ancora cedute ad altri privati dai procuratori. Nel circuito dei crediti del sale troviamo i nomi di membri delle famiglie Michiel, Marcello, Morosini, Soranzo, Dolfin... I ricchi patrizi beneficiavano del sistema senza partecipare direttamente al commercio del sale. I crediti, una volta pagati, venivano spesso affidati alla banca di Pietro Zancani. In un certo senso il patriziato aveva edificato un vero e proprio monopolio del sale, intermedio fra il monopolio statale ed i tanti importatori che non erano disposti ad attendere lunghi anni prima che la camera del sale liquidasse loro i certificati (18).
Il mercante fuori di Venezia. a) Il mercante sulle grandi rotte commerciali
Nell'estate del 1338 sei patrizi delle famiglie Loredan, Contarini, Querini e Soranzo fondarono una "societas" e lasciarono Venezia alla volta di Delhi lungo la via continentale del Nord su cui si trovavano i grandi scali di Costantinopoli, Tana, Astrakhan e i caravanserragli di Organzi, Tirmidh e Ghazni. Portavano con loro tessuti, tele fini e ambra da vendere lungo il cammino, un orologio e una fontana per Muhammad ibn Tughluk, sultano di Delhi, che li ebbe per 200.000 bisanti. Con il guadagno realizzato acquistarono perle da rivendere a partite in Francia (19). Giovanni Loredan, il protagonista del processo che, per una oscura questione di eredità, fu portato davanti ai giudici di petizion - il tribunale del commercio -, era di ritorno da un precedente, lungo viaggio nel Catai, da dove aveva portato spezie che aveva rivenduto, prima di ripartire per l'India, per procurarsi stoffe di Malines, tessuti di Firenze, stamigne e ambra. Delle pezze furono commerciate fino a Saraj, la capitale del khān di Qipciāq, a nord di Astrakhan. Lungo il tragitto, la carovana, che seguiva i passi dei fratelli Polo nel loro viaggio del 1261-1262 e di Marco Polo un cinquantennio prima, incontrò altri Veneziani a Costantinopoli e a Tana - cosa nient'affatto sorprendente - ma anche ad Astrakhan e a Organzi, la città dove si tesseva l'organza. Un simile viaggio necessitava di una vera e propria preparazione fisica e intellettuale: i Veneziani seguivano scrupolosamente i consigli di Francesco Balducci Pegolotti, l'agente dei Bardi il quale, nel Libro de Divisamenti, più noto sotto il nome di Pratica della mercatura, aveva descritto l'itinerario, le merci da importare, i mercati su cui piazzarle, l'inutilità di conservare tessuti per i territori al di là di Organzi in quanto forse solo le più raffinate tra le stoffe europee avrebbero ammortizzato i costi eccessivi del trasporto attraverso le alte montagne afgane.
Non si è prestata sufficiente attenzione alla natura e al disequilibrio degli scambi in cui si erano impegnati i mercanti veneziani. Costoro rientravano dall'Asia con spezie o perle, merci di grande valore e di poco ingombro ma comunque prodotti di raccolta, mentre avevano lasciato l'Europa con le merci più ricche dell'industria europea, con i tessuti delle Fiandre o di Brabante, della Toscana, l'orologio e la fontana meccanica - due automi probabilmente, di certo testimonianze dell'ingegno tecnico europeo. Né meno notevole era stata l'organizzazione commerciale della spedizione; i mercanti infatti erano sì legati da un contratto di "societas", ma ciascuno concludeva comunque i propri affari personali, integrando il proprio capitale strada facendo e stringendo rapporti con persone con cui diveniva facile stabilire nuove "colleganze". Giovanni Loredan, che aveva lasciato Venezia munito di molte colleganze, a Costantinopoli aveva ricavato una certa liquidità dalla vendita dei tessuti e aveva concluso con un mercante cremonese un contratto di cambio pagabile a Delhi dove questi aveva dei creditori; in Asia centrale, aveva chiesto un ulteriore prestito a un arabo che aveva preteso un interesse superiore al 40%.
b) Il mercante in terra straniera
Nell'estate del 1350, a Costantinopoli, il notaio veneziano Antonio Bresciano stipulò 58 atti in cui si nominavano 189 persone fra mercanti e testimoni (20). Di 116 ci è nota la provenienza: il 42 % era veneziano, il 15% era costituito da Veneziani residenti a Costantinopoli e il 9% risiedeva a Creta. I due terzi delle pratiche del nostro riguardavano dunque Veneziani, e tra questi dominavano i nobili: Celsi, Contarini, Corner, Dolfin, Giustiniani e Soranzo. I Veneziani, come altre colonie mercantili, eccetto i Genovesi che possedevano un proprio quartiere a Pera, si erano per lo più stabiliti sulla riva meridionale del Corno d'Oro, dove beneficiavano del diritto di totale extraterritorialità e dunque di larga autonomia. Il maggiore dei loro privilegi, successivamente alla Bolla d'oro del 1082 confermata nel 1265, consisteva nell'esenzione da tutte le tasse doganali, ivi compreso il kommerkion sulle transazioni, mentre ad un kommerkion del 10% su tutti gli affari erano sottomessi i Greci e gli Orientali sudditi dell'Impero. Tale imposta, pagata in pari misura dal venditore e dall'acquirente, fu causa di contestazioni in quanto la corte imperiale ne pretendeva l'applicazione anche ai Greci che acquistassero dai mercanti della Repubblica. Per porre fine alla disparità di trattamento fra Veneziani o Occidentali in genere (con il trattato di Ninfea i Genovesi avevano ottenuto un analogo privilegio) e i loro concorrenti bizantini, Giovanni VI Cantacuzeno aveva tentato di ricostituire una marina bizantina onde evitare il ricorso ai mercantili italiani. Per ovviare alle necessità del proprio commercio marittimo, la Serenissima aveva addirittura contribuito a restaurare i vecchi arsenali bizantini.
Tutti gli approvvigionamenti della capitale in derrate di prima necessità - grano, sale, vino, olio - passavano attraverso le mani e le navi degli Occidentali che controllavano anche il commercio al dettaglio, la vendita dei vini di Creta nelle taverne, le carni macellate e il pescato. Tutto ciò era perfettamente normale. La grande città era più un mercato di consumo immediato che un centro di esportazione; il porto era animato dal commercio di transito, di scalo e di deposito sulle vie marittime che da Tana, da Caffa o da Trebisonda raggiungevano i grandi emporia occidentali. È probabilmente per questo motivo che troviamo tante vendite di schiavi tatari - 15 negli atti del notaio Bresciano, 12 maschi e 3 femmine - il che faceva di Costantinopoli "un fiorente mercato della tratta" (21). Il prezzo medio delle donne era assai più elevato, 50 iperperi contro i 30 di uno schiavo. I più venivano acquistati dai mercanti veneziani appena prima del rientro in patria (22).
L'altra derrata importante a Costantinopoli era, assieme al grano, il vino importato dai paesi greci non veneziani e da Creta. Il 15 marzo del 1344 il senato esaminò il progetto imperiale di vietare ai mercanti stranieri la vendita al dettaglio, un documento che testimonia della singolare estensione dei trattati: dalla libera importazione e dalla vendita franca all'ingrosso Venezia era passata al controllo di un gran numero di taverne e alla vendita al dettaglio a prezzi competitivi. I tavernieri veneziani attiravano la clientela a detrimento dei concorrenti greci e del fisco, e se molti erano in realtà dei Greci che avevano illegalmente ottenuto la cittadinanza veneziana per sfuggire alle tasse, è anche vero che i Veneziani non disdegnavano i benefici della vendita al dettaglio: non tutti erano grandi uomini d'affari che attendevano notizie solo da Bruges o da Alessandria.
c) Una grande impresa mercantile nelle colonie
Nell'aprile del 1358 il senato volle avviare un'inchiesta su una società formata da quattro o cinque mercanti che, a Cipro, si erano accordati per diminuire la quantità di cotone destinata a Venezia, in modo da mantenere i prezzi artificiosamente alti. Il senato si proponeva di estendere le indagini anche allo zucchero in polvere, al sale e ad altre derrate, come pure agli armatori che per analoghe motivazioni decidevano di diminuire il numero di navi da trasporto e, infine, a tutti i porti di transito dei mercanti veneziani. Alla base del provvedimento vi erano il proposito di evitare il calo delle riscossioni doganali, la contrazione dei noli, preludio a una crisi della marina e delle costruzioni navali, e il timore della concorrenza degli altri porti - Ancona in primo luogo - qualora i mercati occidentali non fossero più stati approvvigionati da Venezia. In realtà nessuna di tali proposte ottenne il numero di assensi necessario e l'iniziativa si arenò. Coloro che reggevano i monopoli non furono più inquisiti e il senato dovette rimettersi al loro buon volere per "dare de dictis sale et pulvere [zuchari] aliis ad sufficientiam iuxta peticionem mercatorum et patronorum qui volunt caricare navigia" (23).
"Se il commercio è sempre lo scopo e lo stimolo più forte della attività coloniale delle grandi città marittime del Mediterraneo occidentale, esso si accompagna talvolta a manifestazioni notevoli di attività agricola ed industriale, dirette ad alimentare appunto una più intensa e proficua corrente di scambi", scriveva Gino Luzzatto (24). A Cipro, indipendente sotto la dinastia dei Lusignano, i fratelli Corner avevano orientato la loro attività verso due richiestissimi prodotti agroindustriali, il cotone e la canna da zucchero. Nel 1365, la compagnia da loro fondata con Vito Lion e dotata di un capitale di 83.000 ducati aveva sviluppato un'economia di piantagioni, con le colture specializzate più richieste dal mercato internazionale e più adatte ad accrescere i traffici.
Gli stretti rapporti con i principi di Cipro avevano garantito ai Corner facilitazioni commerciali e fiscali: privilegi costosi e che bisognava pagare. Nel 1366, per finanziare la campagna contro i Turchi, Pietro I di Lusignano si fece prestare 60.000 ducati da Federico Corner che ottenne il casale di Piscopi sulla costa meridionale dell'isola e incentivò la coltivazione e la trasformazione della canna. Alla fine del secolo i tre nipoti di Federico erano stati invitati dal padre a rimanere in "fraterna società" per 25 anni e a investire 5-6.000 ducati l'anno nelle piantagioni di Piscopi. I Corner si interessavano attivamente al commercio marittimo, all'appalto delle galere e alle spedizioni commerciali (le sole mude dell'autunno del 1365 dirette a Venezia e a Genova fruttarono a Fantin Corner 67.800 ducati), alla vendita del pepe e della noce moscata, all'esportazione del sale di Cipro, avendo ricevuto in pegno dai principi dell'isola, a quel che pare, la grande salina di Larnaca (25).
d) Il commercio veneziano via terra
I Veneziani non rifuggivano le fatiche e i pericoli del commercio terrestre. Non esitavano a valicare le Alpi per condurre i loro affari in tutte le città del Nord e i mercanti stranieri, specialmente tedeschi, non monopolizzavano né l'importazione a Venezia dei prodotti delle loro terre né l'esportazione di prodotti levantini che venivano trasportati dalle navi veneziane. C'è da aggiungere poi che i Veneziani non se ne stavano passivi al loro banco, sotto le volte di Rialto, ad attendere i soci. Nel 1306, Giovanni d'Avanzo, che aveva un credito di 133 lire di grossi sui beni dell'imperatore e dei mercanti tedeschi (26), ebbe a subire un furto in Germania; l'anno successivo, nel maggio 1307, Alberto, re dei Romani e imperatore di Germania, informava il consiglio urbano di Costanza, sul lago omonimo, che doveva ritrovare e perseguire i briganti che avevano rubato 67 marchi d'argento a quattro mercanti veneziani: Marco Romano, Ermolao Bianco, Savarino de Jacobo e Romano Diedo (27). Nel 1384 o nel 1385, alcuni nobili di ca' Donà spedivano della seta a Monaco, nella Germania del Sud (28). Non tutti seguivano personalmente le vie di terra; talvolta preferivano affidare i loro beni a uno straniero che conoscesse l'itinerario, come quel Petrachino di Boemia che, alla fine dell'inverno del 1341, rientrava da Bruges con 19 balle di merci. Le strade tuttavia erano spesso interrotte dalle intemperie e Petrachino scomparve con una balla di 366 libbre di zafferano e i 187 ducati con cui doveva pagare gli addetti ai trasporti. Quando questi si recarono a Venezia a raccontare l'accaduto, il senato inviò alla ricerca del colpevole un ambasciatore che conosceva il tedesco.
La Germania era anche la via d'accesso per i due grandi mercati del Nord-Ovest europeo: le fiere della Champagne, in declino già dalla fine del secolo XIII, e Bruges nelle Fiandre, per la quale proprio allora si apriva un'epoca di prosperità. Mentre è appena menzionabile la presenza di Venezia nella Champagne, l'attrazione esercitata da Bruges non venne mai meno per tutto il Trecento; i Veneziani infatti trovarono nuovi itinerari per stringere legami commerciali con il grande emporio fiammingo. Il balivo ("gastaldio") che reggeva per conto del duca Ottone di Carinzia il castello di Matsch nel Tirolo, aveva preso la disdicevole iniziativa di confiscare 20 balle di tessuti a Tomà Balduin malgrado il salvacondotto di cui era in possesso, e per motivi "frivoli e sospetti" rifiutava di restituire la merce benché si andasse deteriorando. Erano di conseguenza logiche le esitazioni che trattenevano le spedizioni attraverso il Brennero fino alle fiere francesi della Champagne, come ebbe a scrivere al duca il doge Pietro Gradenigo, concedendogli un termine di quindici giorni per risolvere l'affare (29).
Le vie di terra erano spesso dominio di incomprensibili vessazioni che si aggiungevano alle chiusure orografiche, alla difficoltà di superare fiumi e torrenti, di scalare rilievi e di comprendere i dialetti degli abitanti. In mare e nei quartieri mercantili dei porti orientali, tutti parlavano la "lingua franca" - una sorta di italiano -, ma lungo le vie di terra le lingue erano sempre diverse e sebbene le valli che solcano i primi pendii delle Alpi meridionali già costituissero in qualche modo - nella sommaria geografia del tempo - un'avvisaglia di Germania, il mosaico degli idiomi, dallo sloveno del sud-est fino al fiammingo del nord-ovest, esigeva sforzi e pazienza. Si capisce perché i mercanti italiani all'estero tendessero a ritrovarsi negli stessi quartieri, se non proprio per respirare l'aria di casa, almeno per ritrovarvi lingua e abitudini proprie. A Bruges i Veneziani, i Genovesi e i Fiorentini avevano ciascuno un proprio consolato sulla stessa piccola piazza attraversata dalla Vlamingstraat. Nelle vicinanze si trovava il palazzo della famiglia van de Beurs, che diventerà, nel secolo successivo, la prima "borsa". Il commercio si concentrava in questo piccolo spazio ove i Veneziani, che sopraggiungevano sempre più numerosi via mare, incontravano i mercanti di altre nazioni lungo l'asse Markt-Kranplatz-Grosser Zoll. Era questo il luogo dei grandi appuntamenti internazionali dei mercanti accorsi da tutta Europa; era qui che contrattavano Italiani, Inglesi, Anseatici e Castigliani; era qui che si annodavano i rapporti d'affari tra le più operose città europee. E qui bisognava dunque venire per concludere affari con i mercanti di Brema, di Amburgo, di Lubecca, persino con quelli di Riga e di Bergen. Nel secolo XIV (nel 1347, prima della Peste Nera e in maniera più stabile nel 1357) i Veneziani, stanchi dei pericoli e delle imboscate sulle vie di terra, attivarono la linea marittima Venezia-Bruges. Fu ancora nel 1347 che gli Anseatici si diedero un quartier generale a Bruges e presero l'abitudine di riunirsi nel convento dei Carmelitani, prima di edificare - nel secolo successivo - la Casa degli Anseatici (Oosterlingenhuis). Bruges offriva un altro motivo di interesse, emblematico della situazione del commercio alla fine del Medioevo: ogni nazione aveva qui i propri pesi e le proprie bilance - le bilance della grande dogana e della gru, quella degli Spagnoli per pesare i metalli a Sint Jansplein, quella degli Inglesi per pesare la lana nella Engelsestraat... (30). A partire dalla seconda metà del Trecento, la Germania non figura più, secondo la documentazione pazientemente raccolta da Henry Simonsfeld, come via d'accesso a Bruges: da intermediaria era ormai diventata cliente (31).
L'impatto della crisi demografica
Nel secolo XIV, dopo l'espansione e la relativa prosperità dei precedenti due secoli, l'Europa conobbe una serie di catastrofi senza precedenti che non risparmiarono Venezia e Genova, le porte attraverso cui, alla fine del 1347, con i vascelli e le merci giunse dall'Asia quell'epidemia che ogni sette-dieci anni avrebbe rinnovato con terrificante regolarità le sue devastazioni. La peste non colpiva a caso, ma si abbatteva su popolazioni già indebolite dalla fame, inserendosi nella macabra trilogia carestia-guerra-mortalità, i cui termini, se pure potevano essere invertiti, costituivano il segno evidente della più generale crisi in cui versava l'economia europea alla fine del Medioevo. Purtroppo, per quanto riguarda Venezia non si sono ancora condotti studi esaurienti sull'impatto della crisi sull'economia e la società. Si è scritto, giustamente, che un grande porto viene risparmiato dalla carestia più facilmente di una regione agricola per la sua possibilità di approvvigionarsi in mercati lontani grazie ai mercanti e alle navi. Quando però, nel 1348, scoppiò la peste, Venezia subì l'afflusso delle popolazioni cacciate dalla terraferma dalla grave crisi alimentare del 1347, in cerca di pane ed elemosina davanti alle porte delle chiese.
Nel 1338 la popolazione veneziana ammontava probabilmente a 110-120.000 abitanti; la peste, secondo i cronisti, ne falcidiò probabilmente la metà, sì che nel 1349 essa non superava le 50-60.000 unità. Una catastrofe di tali dimensioni produce necessariamente le conseguenze più disastrose sul livello delle attività economiche, poiché riduce della metà i produttori e i consumatori. La peste non era ancora terminata che già, il 22 giugno, il maggior consiglio, sensibile al problema, discuteva su come rimediare alle perdite. Coloro che erano stati banditi furono richiamati, i prigionieri per debiti liberati, la tassa di ingresso nelle Arti soppressa. Parimenti venne assai ridotto il periodo di residenza necessario agli immigrati per ottenere i privilegi "de intus et de foris", come l'accesso al commercio interno ed esterno via mare. Si tentò anche di attirare gli artigiani conferendo loro il diritto di esportare prodotti oltremare. La Repubblica, dunque, per colmare i vuoti scavati nella popolazione richiamava manodopera qualificata, esperta, dotata di conoscenze tecniche e forse anche di capitali, accompagnata dalla famiglia, da servi e da operai.
L'afflusso di stranieri fu consistente ma non bastò a riempire i vuoti lasciati dall'epidemia e l'immigrazione divenne elemento costante della politica di mantenimento degli equilibri demografici. Venezia tentò anche di rinvigorire le proprie forze favorendo l'immigrazione di contadini poveri, o di ricchi stranieri attratti dalle possibilità di guadagno del mercato di Rialto, o ancora di mercanti e artigiani provvisti di capitali; alla fine del Trecento, fra i gruppi più numerosi figuravano i Tedeschi, molti dei quali fecero i fornai (32), i Fiorentini e gli Ebrei ashkenaziti. Nel 1383, ad esempio, il senato autorizzò un mercante del fondaco, Filippo Grandis di Norimberga, specializzato nella spedizione di lane in Lombardia da dove importava tele, ad aprire un commercio a Rialto e vendervi i tessuti marchiati col sigillo dei "visdomini"; liberale autorizzazione limitata però a un anno ed eventualmente rinnovabile (33).
Le conseguenze della peste perdurarono a lungo sotto diverse forme: la penuria di manodopera determinò il rialzo dei salari nell'artigianato e dei prezzi alimentari; ma soprattutto la ricchezza si trovò concentrata nelle mani di un gruppo ristretto di sopravvissuti i quali, dopo i momenti di paura e di dolore, avrebbero potuto cedere alla tentazione di dilapidare i patrimoni ereditati in acquisti voluttuari o donazioni a favore delle istituzioni religiose. Il senato dunque dovette suo malgrado riconoscere che quasi tutto il capitale della città rischiava di cadere nelle mani della Chiesa, "in extremam desolationem civium nostrorum" (34).
C'è poi, passato a lungo sotto silenzio, un altro aspetto della politica demografica, strettamente legato al commercio: la tratta degli esseri umani. Solamente negli atti del notaio Marco dei Raffanelli, attivo a Venezia alla fine del secolo, tra il 1388 e il 1398, Krekić ha rinvenuto non meno di 292 atti di vendita di schiavi, in maggioranza donne tatare (221) nel solo mercato veneziano. In particolare, le donne erano per lo più di età compresa tra gli undici e i trent'anni e venivano valutate in media fino a 45 ducati, mentre un uomo della stessa età ne valeva solo 37 e mezzo. Era un commercio di considerevole portata con un traffico che raggiungeva un totale di 12.250 ducati. Certamente si ricorreva agli schiavi come manodopera, ma ci doveva essere dell'altro, altrimenti i giovani maschi avrebbero avuto un valore pari a quello delle femmine: occorrevano sì domestici, ma ancor più giovani concubine. La lettura dei testamenti è rivelatrice dei rapporti che univano le giovani al de cuius defunto, che non mancava infatti di mettere da parte dei piccoli gruzzoli per l'amante e i suoi figli. L'abbondanza di schiavi originari della Russia meridionale e del Caucaso dimostra come il mercante veneziano esercitasse anche la tratta (35).
Il commercio dei prodotti di prima necessità. a) Il commercio dei grani
Quali erano le esigenze di cereali, farina, pane e biscotto? Si pensi che alla popolazione residente si aggiungevano i non residenti, le ciurme, gli equipaggi della flotta, i viaggiatori e i mercanti, i pellegrini e tutti coloro che si imbarcavano per molti mesi, con le loro provviste di biscotto, su navi approvvigionate proprio a Venezia. La domanda di grano sul mercato veneziano era consistente: nel 1342 i granai della città ne custodivano 365.559 staia e, di queste, 97.320 erano di frumento di ottima qualità. Freddy Thiriet, pubblicando le cifre citate (36), non esitava a ridurle a una trentina di migliaia di ettolitri, ma ciò perché aveva confuso le misure cretesi con i pesi veneziani. Di fatto si trattava di una massa pari a 229.936 quintali, ma quello che ci interessa qui è segnalare come l'amministrazione veneziana valutasse il fabbisogno quotidiano in 1.000 staia, ovvero 62.900 chili di cereali, equivalenti a una razione giornaliera, per persona, di una libbra (37).
Nei rifornimenti di granaglie occupavano un posto particolare le competenze delle rendite che i proprietari di terre situate nei comuni vicini o lontani che fossero, da Verona alla Marca, trasportavano in Laguna: tra essi un patriziato che aveva cominciato ad acquistare beni fondiari in terraferma ben prima del Quattrocento (38), e in ciò tuttavia preceduto da un'altra categoria di illustri proprietari: i piccoli e grandi monasteri lagunari, con estesi possedimenti che percepivano rendite in natura a lungo sfruttate come riserva demaniale (39). Il convento di San Giorgio in Alga, non certo fra i più ricchi, ricavava dai fondi di Campolongo Maggiore e di Mestre 415 moggi (padovani) di frumento, grano ("biade"), miglio, segale e farro ("spelta"), oltre a ortaggi, vino, pollame e uova (40).
Il possesso di beni nei vicini terreni agricoli della terraferma stava molto a cuore ai Veneziani, non tanto perché vedessero nella terra un valore-rifugio di contro ai rischi inerenti il commercio marittimo, quanto per la possibilità di spedire in franchigia a Venezia i raccolti destinati a una popolazione urbana numerosa e costretta ad importare i generi di prima necessità. Fra gli altri citeremo le famiglie Morosini, Corner, Trevisan, da Molin, Contarini, Querini, proprietarie di terre nel Ferrarese (41). I Veneziani avevano ottenuto il diritto di importare i loro raccolti senza tasse, ma le autorità estensi avevano scoperto che alcuni esercitavano anche il contrabbando: un Querini, per esempio, acquistava grani sulla piazza di Ferrara e li spediva a Venezia frodando i diritti doganali. Non sempre però i proprietari di beni in terraferma godevano del diritto di portare in città i loro raccolti: nel 1307 il governo di Treviso aveva istituito il sistema della licenza per evitare le esportazioni clandestine, ma talvolta capitava che cadesse nella propria stessa trappola, come quando, avendo saputo che Venezia attendeva un convoglio di grano dalle Puglie, dovette aprire improvvisamente le frontiere (42).
Per tutti i rifornimenti che giungevano dall'Italia padana attraverso i fiumi e dalle altre regioni per mare, la Repubblica dipendeva dalle vie d'acqua. Il ciclo del grano si conciliava perfettamente con il calendario del raccolto e della navigazione: nei paesi mediterranei veniva mietuto all'inizio dell'estate e arrivava a Venezia con la muda d'autunno (stagione della navigazione), ma in caso di penuria le navi ripartivano in inverno e rientravano all'inizio della primavera quando minacciava la carestia; era quello il carico principale delle navi disarmate di medio tonnellaggio. Nei periodi bellici il comune preferiva organizzare dei convogli: fu così che nel 1380, durante la guerra di Chioggia, i Genovesi si impadronirono di 4 galere e 24 velieri carichi di cereali (43).
Per assicurarsi un regolare approvvigionamento, il comune acquistava i raccolti a termine, già in primavera se non addirittura, specialmente nelle colonie, con un anticipo di anni. A Creta, fornitrice importante delle isole della Romània veneziana, il traffico era controllato dai grandi proprietari veneziani che preferivano vendere il raccolto a prezzi elevati sul libero mercato egeo piuttosto che cederlo a basso prezzo all'ufficio del grano (44). Nel 1333 un ambasciatore dei feudatari veneziani dell'isola aveva offerto al comune 80.000 misure di grano l'anno, per un periodo di cinque anni al prezzo di 18 iperperi ogni 100 misure, ma gli ufficiali fecero notare che i feudatari erano tenuti a non superare i 16 iperperi e il senato si rifiutò di far lievitare i prezzi (45). Di regola, tuttavia, tutte le esportazioni dell'isola dovevano essere dirette a Venezia sia per le necessità del consumo della città sia per la ridistribuzione all'estero con il puntiglioso controllo delle autorità. L'ufficio del grano anticipava ai feudatari il pagamento delle future forniture tanto che questi vi si rivolgevano per chiedere prestiti per i noli dei cereali spediti e, in caso di necessità, per comperare da terzi quanto occorreva per completare il loro raccolto e la fornitura. Alessio Kalergi ottenne dall'ufficio un prestito di 6.000 iperperi da rimborsare con consegne di grani nei quattro anni a venire, nelle fiere che nell'isola si tenevano in agosto. I crediti accordati come anticipo sulle consegne introducevano il capitale commerciale nei circuiti della distribuzione cerealicola, stimolavano la produzione subordinandola al mercato, stabilizzavano i prezzi dei cereali - prodotti particolarmente sensibili a tutti gli aspetti congiunturali - e garantivano una certa liquidità ai produttori nonché un regolare approvvigionamento al cliente creditore.
Con le Puglie, la Sicilia era uno dei migliori fornitori dei grandi porti italiani. Per potervi realizzare i propri affari conveniva poter contare su una clientela sul posto, cui rendere servizi con appoggi diplomatici o finanziari, costituire un apparato commerciale ben saldo nei porti, centri economici e finanziari. "Non ci si improvvisa mercante di grano", osservava Fernand Braudel (46). Occorrevano anche capitali, e conoscenza dei luoghi di produzione, nonché una rete di corrispondenti e di informatori. Essendo i meccanismi commerciali controllati dalla Corona, era prudente allacciare rapporti con la corte e con l'amministrazione; i mercanti e i diplomatici veneziani di passaggio nell'isola vi tessevano saldi rapporti con le potenti casate feudali. Così avevano fatto i Chiaramonte, ad esempio, con mercanti siciliani che, come Pino Campolo (47), avevano a lungo soggiornato a Venezia o con ufficiali, "maestri secreti" come Giacomo Campolo, parente di Pino, oppure anche con "mastri portolani" come quel Bartolomeo Rosso, procuratore del mercante Luca Bembo, definito di volta in volta "mercante di Venezia" o "cittadino di Siracusa". Costoro concludevano trattati per l'esportazione del frumento di Modica nel cuore dei feudi dei Chiaromonte o della Val di Noto dove un funzionario legato in affari con il Rosso, Pietro di Forlì, vendeva le licenze di esportazione ("tratte"). Gli acquisti veneziani in Val di Noto erano consistenti: durante l'autunno del 1399 vi furono negoziate 5.300 salme, circa 11.000 ettolitri, il 70% delle quali dal cardinale Pietro Serra, ex segretario del re e vescovo di Catania, influente personaggio impegnato in complessi affari di crediti con la corte e con privati cittadini. I Veneziani avevano rapporti privilegiati con certi porti: Ludovico Contarini e i Bragadin concentravano le proprie attività su Siracusa e Vindicari o sulla Val di Noto, mentre Ognibene d'Agostino e Giovannuccio Giliolo preferivano esportare formaggi e frumento da Sciacca e da Mazara (48).
Grande porto al riparo da carestie più di molte regioni agricole - al minimo allarme le flotte salpavano verso tutti i "caricatori" mediterranei - Venezia riforniva talvolta le basi d'Oltremare la cui funzione sarebbe stata invece quella di garantire il servizio di approvvigionamento della metropoli. La Serenissima non mancava di allargare i propri rapporti commerciali marittimi con il Levante a terre straniere cui inviava prodotti alimentari. Nel 1317, alla fine della grande crisi frumentaria che si era abbattuta sull'Europa, dovette inviare grani a Negroponte, a Corone, a Modone e a Cipro. Nel 1320 le autorità dei porti armeni che ricevevano cereali da Cipro e da Creta, toccate dalla penuria di grani, obbligarono i legni veneziani a scaricare sul luogo. Il commercio e la fornitura di viveri favorivano inoltre la penetrazione nel bacino mediterraneo orientale e il dominio di quelle vie marittime da parte delle marine occidentali. Per ottenere l'estensione dei privilegi commerciali la Repubblica distribuiva frumento anche ai musulmani di Tripoli di Siria e grano siciliano alla Tunisia(49) che, fino al secolo precedente, era stata uno dei suoi grandi fornitori.
b) Il commercio della carne
Marin Sanudo stimava il fabbisogno annuo di carne, alla fine del Quattrocento, sui 14.000 buoi, 13.000 vitelli e 70.000 capi di bestiame minore (50) di provenienza estera. L'approvvigionamento occupava macellai di Venezia e di Padova e fu a costoro che, nel 1324, in Cadore furono confiscati 2.400 montoni e agnelli (51). A Venezia le famiglie patrizie facevano largo uso di carne fresca o salata, di cacciagione e di pollame (52). I "ternieri", che commerciavano in olio, grassi, formaggio e miele, vendevano anche carne salata, mentre quella fresca era smerciata dai macellai. In tempo di guerra, la speculazione contribuiva al lievitare dei prezzi. Un modesto macellaio, Vielmo de Zane, intentò davanti ai consoli dei mercanti un processo contro un grosso importatore che aveva in magazzino 100 "miera" (sulle 50 tonnellate) di carni salate, vendute in contanti a 115 lire per "mier". Nel luglio del 1378, mentre le truppe coalizzate assediavano Mestre, Vielmo, che non aveva la possibilità di immagazzinare, acquistò a termine 10 miera di carne a 120 lire, cifra contrattabile. Alla fine del mese, quando già il costo era salito a 125 lire, l'importatore riacquistò allo stesso prezzo la merce. Sei mesi più tardi, quando a causa della guerra la carestia faceva sentire i suoi effetti in città, si erano raggiunte le 190 lire. La pratica delle vendite a termine contribuì a far sì che il prodotto scarseggiasse e che l'insieme dei prezzi lievitasse fino al 300% durante la crisi della guerra di Chioggia (53).
c) Le differenti forme di approvvigionamento della città
Le vie d'acqua erano determinanti nel commercio veneziano ma a monte, come per i territori arciducali situati al di là delle Alpi, taluni segmenti del tragitto non lasciavano alternativa se non il percorso via terra.
Al tempo del blocco attuato alla fine della guerra di Chioggia, dal 22 febbraio al 14 settembre del 1381, al fine di controllare tutti i movimenti di generi alimentari e di interdirne il trasporto verso Venezia, i doganieri di Chiusa annotarono giorno dopo giorno il passaggio delle bestie da soma, del bestiame di piccola e grossa taglia, dei carri di vettovaglie con grano, frumento, segale, avena, ortaggi, carne salata, strutto, sego e salumi scesi dal Nord verso le città della regione del Friuli. La curva dei passaggi diminuiva regolarmente dalla fine del mese di febbraio a metà settembre, mentre la circolazione più intensa era quella che si verificava nella stagione invernale. In pieno inverno infatti cavalli e buoi erano disponibili per il basto e per tirare la carretta o la slitta, poiché da dicembre a marzo lo spessore della neve trasformava i cammini più impervi in piste sdrucciolevoli. Ma il calendario dei lavori agricoli era ancora più rigido di quello meteorologico e la struttura contadina del trasporto imponeva ferree condizioni alla circolazione alpina. Diversa era la situazione dei trasportatori: alcuni, gli agenti che lavoravano per conto di mercanti, non possedevano che uno o due cavalli, altri, piccoli imprenditori che univano commercio e trasporto, lungo il cammino ne affittavano dieci o venti volte tanti, aggiogati o imbastati e accompagnati da garzoni/servi. Molti erano contadini che per integrare le magre risorse facevano lavorare il cavallo, loro unico capitale. Per lo più i trasportatori non perdevano tempo alla ricerca di un cliente, ma depositavano le merci presso il locandiere. La loro attività era caratterizzata dal viaggio in gruppo: si radunavano carri e bestie da soma in carovane e ci si aiutava l'un l'altro a superare i pendii (54). Lo stesso meccanismo funzionava per il "corso", come erano chiamate le carovane che trasportavano i generi di prima necessità - grano, legna da riscaldamento, pelli, bestiame, carni seccate - nei piccoli porti istriani, soprattutto in quello di Capodistria, dov'era l'imbarco per Venezia.
d) Il sale e le spezie
L'"ordo salis". Nel Trecento Venezia si avvalse di due politiche assolutamente diverse per conseguire un unico risultato: il monopolio degli approvvigionamenti di sale nell'Italia padana e lungo l'arco alpino fino alla linea dei grandi valichi. Nell'economia veneziana il sale è il prodotto che meglio può illustrare i meccanismi del mercato: la città lo importava in modo massiccio e lo riesportava integralmente, poiché per la popolazione urbana quello di Chioggia era più che sufficiente. Nell'Adriatico la Repubblica tese, se pur con successo limitato, a imporre il proprio monopolio sulle forniture di sale dei produttori e delle autorità delle signorie sotto la cui giurisdizione erano poste le saline, mentre il trasporto del prodotto fino ai depositi veneziani era lasciato all'iniziativa dei privati che lavoravano con i loro legni di piccolo tonnellaggio per l'ufficio del sale. Essendo il sale un genere di monopolio, i mercanti non intervenivano nell'acquisto, nella vendita o nel trasporto, benché quest'ultimo fosse libero a condizione che il proprietario della barca potesse esibire i certificati rilasciati dalle autorità, le "bullette". Venezia poteva ricorrere a una tale monopolizzazione della produzione grazie al suo peso determinante nell'Adriatico, che le consentiva di imporre la sua volontà egemone con le armi o con le alleanze. Non tutte le saline del Mediterraneo erano alla sua portata: le più vaste erano controllate infatti dal potente principe di Aragona, mentre altre si trovavano sotto la giurisdizione di sovrani musulmani, arabi, mamelucchi o tatari e quella di Cipro apparteneva ai Lusignano. Nell'impero coloniale, Corfù e Candia disponevano solo di una piccola produzione destinata al fabbisogno locale: non sarebbe stato possibile esigere che i produttori cedessero gratuitamente il loro sale. In tali condizioni Venezia spostò il monopolio dalla produzione al trasporto e approntò una serie di dispositivi assai restrittivi dando vita all'"ordo salis", l'ordine del sale.
La storia del sale ben descrive i mutamenti operati nel commercio dal patriziato veneziano alla fine del Trecento. Nel secolo precedente, dopo una serie di operazioni militari o un brutale blocco commerciale, Venezia era riuscita a imporre per trattato il suo monopolio su molte città come Padova e Treviso, le più vicine, Ravenna e Ferrara, le meglio servite via mare, Verona e Mantova che controllavano l'Adige e il Po, le due grandi vie della navigazione fluviale, e Bologna che avrebbe potuto servirsi delle saline romagnole (55). Ma si trattava di una forma di monopolio che aveva in sé i germi della guerra, e la Serenissima, ben prima della fine del secolo XIII, aveva capito come fosse preferibile controllare il commercio del sale all'origine, debellare il contrabbando, chiudere le vie all'approvvigionamento autonomo, orientarsi insomma verso un monopolio della produzione ottenuto a spese di signori più deboli dei grandi comuni italiani, o comunque più lontani, e grazie al suo incontestato predominio sull'Adriatico. Così, senza far ricorso alle armi, avrebbe imposto il monopolio sul sale alle popolazioni dell'Italia del Nord.
Nel Mediterraneo gli acquisti di sale grosso fatti dai Veneziani obbedivano alle leggi del mercato, ma il comune non poteva basarsi sulla sola iniziativa privata, ciò che sarebbe stato contrario a ogni uso invalso, tanto estraneo gli era lo stesso concetto di libera iniziativa. Doveva dunque avere sempre disponibili massicci quantitativi di sale per far fronte alla domanda di un vasto entroterra, densamente popolato e, soprattutto, costretto a ricorrere a Venezia. Lo Stato, per conciliare la libera produzione e il monopolio sulle forniture, non trovò mezzo migliore che istituire un complesso di costrizioni e di incentivi, conosciuto sotto il nome di "ordo salis", per favorire un flusso regolare nelle importazioni. L'"ordo salis" fissava il prezzo, la quantità, la qualità e l'origine del prodotto che i mercanti dovevano portare al ritorno da ogni loro viaggio e che il comune era disponibile ad acquistare (56).
L'"ordo salis" fu applicato durante tutto il secolo XIV. Si trattava di una procedura rigida che imponeva di importare a Venezia quantità fissate di sale in proporzione alle merci di pregio caricate sui vascelli tondi e armati. Nel 1303 i mercanti che si recavano ad Alessandria furono invitati ad adeguarvisi. Successivamente, in una convenzione stipulata tra gli stessi mercanti e la signoria, venne adottato un calcolo differente che autorizzava un quantitativo di sale pari ai due terzi del carico totale, proporzione nient'affatto sorprendente dato che nelle navi tonde la stiva costituiva quasi il 60% dello spazio disponibile per le merci. Nel 1353 però, quando le navi rientrarono in porto a pieno carico, il maggior consiglio, ritenendo l'eccedente "venuto senza nessun ordine", decise di acquistarlo "per la metà del prezzo del sale importato secondo l'ordine": certo, si trattava di un prodotto utile e proficuo ma che non avrebbe dovuto sostituirsi agli altri traffici né minare le funzioni del porto di Venezia. Il maggior consiglio tuttavia mutò presto d'avviso in quanto, dopo due anni di guerra con Genova e le conseguenti difficoltà nel commercio marittimo, il sale giunto per il maggior profitto del comune fu dichiarato "non arrivato contro l'ordine" e i trasportatori ne ottennero il prezzo pieno.
L'"ordo" imponeva anche un calendario: le navi dovevano lasciare i posti di carico prima del giorno di sant'Andrea (il 30 novembre), in ossequio sì alle prescrizioni del rilascio invernale ma in realtà per garantirsi un prodotto ben secco, prima delle piogge dell'inizio dell'inverno. Se in certe annate l'ordine non era stato rinnovato ma i mercanti rientravano con le stive colme di sale, gli ufficiali rifiutavano di prenderlo in carico dato che "non avevano ricevuto alcun ordine in proposito". Esisteva infine un'altra disposizione: i mercanti dovevano conformarsi strettamente alle norme d'origine; non dovevano cioè imbarcare a Tripoli in Libia un sale che avrebbero poi spacciato come proveniente da Rās el-Makhbez. Il controllo veniva operato da addetti che riconoscevano le differenze in peso delle diverse qualità mediterranee confrontandole con i campioni esposti nell'ufficio (sale della "mostra") e grazie alle lettere rilasciate dai consoli veneziani o dalle autorità locali (57).
La camera del sale, che regolava gli acquisti, ricopriva un ruolo di primaria importanza nell'economia della città. Sale e grano infatti alimentavano, in terraferma, due correnti di traffico che si svolgevano in senso contrario: Venezia consegnava il sale alle province padane dalle quali importava buona parte del suo approvvigionamento in grano. Nei libri dei due uffici del sale e del grano taluni mercanti o, più spesso, dei signori, erano creditori presso la camera del grano per le consegne e debitori alla camera del sale per gli acquisti. L'una era sempre in debito, l'altra sempre in credito, in un sistema di compensazione per cui la seconda trasferiva parte degli introiti alla prima, oppure operava consegne gratuite a favore di quei fornitori che lo Stato si trovava nell'impossibilità di liquidare con le normali forme di pagamento.
Le spezie. È singolare che, a dispetto della sua estrema importanza, dopo l'opera ormai datata di Wilhelm von Heyd (58), il traffico delle spezie, almeno per il secolo XIV, non sia mai più stato oggetto di monografie né di articoli. La storiografia veneziana preferisce affrontare il soggetto solo dal punto di vista della storia dei viaggi delle galere, tuttavia l'uso così diffuso delle spezie nella cucina medievale e il ruolo propulsivo che ricoprirono nel commercio ne fanno uno dei prodotti più importanti per l'uomo del Medioevo. Per convincersene basta percorrere il Libro di cucina veneziano, compilato appunto nel secolo XIV (59): niente vi è di più variegato del genere delle spezie, ciascuna delle quali aveva un uso specifico, culinario, farmaceutico, cosmetico (in profumeria), religioso (l'incenso e la mirra) o semplicemente sociale. Tutte le classi ne facevano uso, ma una netta distinzione di ceto si faceva strada attraverso le differenze di prezzo, tanto che si potrebbero distinguere le spezie dell'aristocrazia da quelle per la gente comune. E poco probabile che siano stati gli Arabi a farle conoscere all'Occidente, tanto il loro uso era diffuso già nell'antichità greca e romana (60).
Il pepe, una delle spezie più diffuse, è la semente di un rampicante che si attorciglia agli alberi come le liane e produce dei fiori a spiga i cui frutti carnosi, appassendo, assumono una tinta grigia o nerastra. Con adeguati trattamenti se ne ottiene pepe nero, bianco o rosso. La pianta del pepe cresce nelle regioni calde e umide del Sud-Est dell'Asia, dall'India all'Indonesia, mentre in Africa se ne trova una varietà meno pregiata, nota sotto il nome di cardamomo o pepe di Guinea. Assai apprezzata era anche la cannella, la scorza aromatica del cinnamomo che si sviluppa in cedui nelle Indie Orientali, a Ceylon e in Cina, dove è conosciuta come cassia. Dalle Molucche proveniva l'eugenia, la spezia più orientale del commercio veneziano. Essa cresce su alberi alti 10-15 metri, da cui si colgono i boccioli che, una volta essiccati, si vendono come chiodi di garofano. La noce moscata è la mandorla della semente della miristica, un albero frondoso delle isole indonesiane Banda; il tegumento della semente è il macis. Lo zenzero è prodotto dai rizomi sotterranei di una pianta perenne simile alla canna che prospera dal Ssu chuan alla Malesia. Infine la meno apprezzata curcuma, estratta da un tubero presente in Cina, nel Bengala e a Giava, entrava nella composizione di polveri come il curry, e il cardamomo del Malabar in quella di oli e unguenti (61).
Le crisi che sconvolgevano gli interminabili itinerari lungo i quali questi prodotti dell'Estremo Oriente venivano avviati fino ai confini del mondo mediterraneo perturbavano le vie delle spezie. Alessandria e il Cairo, teste di ponte delle strade del mar Rosso, furono a lungo depositi di spezie ma la pace mongola, garantendo la sicurezza degli itinerari dell'Asia centrale, diede nuova vita alle vie della seta e delle spezie che portavano a Tana, a Tabriz e a Trebisonda. Dagli ultimi decenni del secolo XIII alla metà del XIV gli emporia del Ponto, dominati dal mercato occidentale, divennero i magazzini del mondo intero, ma poi la disorganizzazione dei khānati mongoli fece perdere ogni interesse per i lunghi percorsi continentali dell'Asia. I mercanti indiani e arabi ritrovarono le vie marittime dell'oceano, del golfo Persico e del mar Rosso; la seconda metà del Trecento vide nuovamente affermarsi la superiorità dei depositi di Alessandria e di Beirut.
I trasporti marittimi degli Occidentali si adattarono a tali mutamenti secolari. Le interdizioni pontificie al commercio con i Saraceni si erano fatte assai rigide dopo la caduta di Acri e per una quarantina d'anni, periodo identificato da Eliyahu Ashtor con la crisi del commercio levantino, si diradarono le navigazioni occidentali verso Alessandria, privilegiando le vie per Tana e Trebisonda. Benché non sia facile ricostruire i movimenti delle navi durante la prima metà del secolo XIV, sappiamo che nel 1343, quando i Tatari attaccarono i mercanti occidentali a Tana, le perdite veneziane ammontarono a 300.000 fiorini e quelle dei Genovesi a 350.000: verosimilmente, il totale degli investimenti mercantili dell'anno. Il disastro provocò in Italia un rialzo dei prezzi dal 50 al 100% a seconda del tipo di spezia (62).
Dal 1344 gli Occidentali presero a tornare in Egitto e in Siria. L'archivio Datini fa luce sul commercio delle spezie in Occidente dopo il 1380. Dal 1372 Beirut divenne l'approdo di testa della muda per Cipro: ogni anno vi giungevano dalle tre alle sei galere, mentre Alessandria ne accoglieva in media tre. Verso il 1400, gli investimenti in Egitto e in Siria, per le sole spezie, ammontavano a più di 300.000 dinari. Venezia si scontrava con la concorrenza locale dei Genovesi che in tale commercio piazzavano somme dell'ordine dei 200.000 dinari e dei Catalani che compravano per un valore di 150.000 dinari. Le altre nazioni occidentali partecipavano in misura minore ai trasporti: Marsiglia con un legno quasi ogni anno, Ancona, Ragusa o l'Italia meridionale in modo ancora più sporadico. I Veneziani esportavano da Alessandria tutte le spezie ma soprattutto pepe; dalla Siria invece lo zenzero, lo zucchero e i chiodi di garofano rivaleggiavano con il pepe (63).
e) Il commercio dei metalli
Per equilibrare in valore e in massa i carichi delle navi dirette al Levante e per soddisfare i bisogni della popolazione della città e delle colonie - tenendo conto anche delle necessità della difesa -, la Repubblica doveva setacciare un vasto retroterra al fine di reperire i prodotti indispensabili. Da tal punto di vista e grazie al controllo politico esercitato sulle rive dell'Adriatico, la città godeva di una posizione privilegiata, essendo insieme il più accessibile dei porti mediterranei e lo sbocco naturale sui mari del Sud di vaste regioni tedesche, dal Tirolo (Schwaz) ai monti della Boemia (Kutna Hora), dagli antichi massicci metalliferi che vanno dalla Renania alla Stiria e alla Sassonia (Freiberg) (64), all'Ungheria fino alla Bosnia (65) - regioni che, alla fine del Medioevo, conobbero un notevole impulso nel settore minerario. Per la maggior parte del secolo la stessa Ragusa rimase sotto il controllo veneziano, così come Zara.
I più ricercati erano i metalli non ferrosi, il rame e lo stagno, i metalli preziosi, oro e argento, e per ultimo il ferro. Il 6 settembre 1301 due mercanti tedeschi di Vienna avviarono da Aquileia a Venezia rame e stagno tramite un "barcarol" che, volendo trasportare dei buoi a Chioggia, aveva scelto di fare una deviazione, ma i capitani di posta sequestrarono il metallo e lo depositarono a San Clemente (66). Nel 1375 fu consegnato un carico di stagno per un valore di 5.717 lire di grossi (67). La qualità doveva essere garantita: quando, nel novembre del 1318, molti dei lingotti ("pecie") importati da un mercante di Friesach furono riconosciuti non all'altezza o addirittura "falsi", il rame fu sequestrato e il commerciante dovette pagare un'ammenda di 30 lire e 12 soldi. Nel dicembre del 1368 un viennese giunse al fondaco con 18 "milliaria" di rame di prima fusione ("fuxine nove") che i mastri dei forni ("domini a geto ") rifiutarono di acquistare perché di qualità scadente, a meno che l'importatore non avesse proceduto a una seconda affinazione a proprie spese (68). Un altro metallo esportato dai Tedeschi in grandi quantità era il ferro; nella primavera del 1345, ad esempio, due mercanti di Villach condussero 31.000 libbre di ferro locale di diverso valore (69) e nel 1375 un carico per un totale di 120 lire di grossi fu autorizzato a venire via terra da Belluno a Venezia, dove sarebbe stato affidato per le stime agli imprenditori dell'Arsenale (70).
I mercanti di Norimberga e Ratisbona erano specializzati nel commercio dell'argento: nel 1332 quattro commercianti di Ratisbona, sorpresi mentre portavano a Venezia oro e argento, furono condannati a versare un'ammenda per non aver depositato il metallo prezioso al fondaco il giorno stesso del loro arrivo (71); alla fine del 1369, un mercante di Norimberga inviò a Symon Speier a Venezia 101 marchi e 2 once d'argento per acquistare spezie e altre merci (72).
La politica commerciale e i finanziamenti
Nel Trecento Venezia era già una repubblica mercantile, nonostante le sue istituzioni continuassero a essere rette secondo le concezioni dell'antico comune dei secoli XII e XIII. "Repubblica mercantile" va qui inteso nei due sensi strettamente interdipendenti di uno Stato la cui politica, interna ed estera, navale, militare e diplomatica, sia orientata all'espansione, alla difesa dei mercati e alla protezione delle vie commerciali, mantenendo nel contempo come uno dei principali obiettivi la spinta agli investimenti grazie a una politica sociale, monetaria e fiscale volta a orientare il capitale verso gli affari commerciali e i mercati esteri. In questo senso risultano indicativi da un lato la negoziazione dei trattati commerciali con i comuni distribuiti lungo le vie marittime e continentali, dall'altro l'orientamento impartito agli investimenti mercantili. Il doppio meccanismo contribuiva a rafforzare la posizione egemonica della Repubblica nei confronti dei suoi clienti grazie alla potenza politica e alle funzioni finanziarie di piazza internazionale dei capitali.
Una libertà unilaterale. a) Libertà commerciale ed egemonia: i patti
I Veneziani gestivano per lo più gli affari in una cornice feudale poco favorevole al libero commercio e più attenta a proteggere i particolarismi locali. In realtà "euntes", "transeuntes", "redeuntes" che fossero, essi consideravano come essenziale la libera circolazione per se stessi, per le merci, per i capitali. La Serenissima era stata da sempre attenta a garantire la libertà di movimento concludendo accordi commerciali con i signori e i comuni vicini: Treviso, Padova, Ravenna, il Patriarcato, Verona, Mantova, Bologna, Ancona, Brescia, Milano... I trattati, che rispondevano a obiettivi analoghi e spesso comportavano le medesime clausole giuridiche, erano stati conclusi per lo più nel secolo XII e nella prima metà del XIII (73), ma dovevano essere rinnovati sia quando comportavano una clausola di durata, sia quando le circostanze ne imponevano delle modifiche.
Nel secolo XIV, Venezia era ancora fedele a quella politica dei patti commerciali di cui Trevor Dean ha recentemente proposto una nuova lettura (74).
La storiografia tradizionale vede infatti in quei trattati un vero e proprio assoggettamento alla Repubblica dei comuni caduti sotto la dominazione economica della città lagunare, che si sarebbe appropriata delle loro risorse, ne avrebbe smantellato le barriere doganali e annullato qualsiasi possibilità di sviluppo economico (75). A cosa acconsentiva dunque il comune che accettava un accordo commerciale? Rinunciava a ricevere direttamente merci dal mare e si rassegnava a rivolgersi a Venezia che disponeva in teoria del monopolio del commercio marittimo nell'Adriatico; rinunciava a percepire molti dei diritti commerciali a favore dei Veneziani; aboliva le gilde e dunque riduceva le proprie attività industriali. Accettava insomma di essere ridotta al rango di città a prevalente interesse agrario e feudale. La città lagunare otteneva il rispetto dei trattati con pattuglie navali armate, edificando barriere e fortificazioni o anche, come fece a Ferrara, con un "visdominus", una sorta di proconsole veneziano incaricato della salvaguardia degli interessi della Repubblica. In realtà, tuttavia, i trattati non impedivano affatto la corruzione delle guardie, l'inefficienza dei sistemi di controllo né il contrabbando verso la Lombardia di merci importate via mare. Agli occhi dei Veneziani, per esempio, Ferrara presentava un triplice interesse: non solo era situata alla testa della navigazione padana ma anche al centro di una regione produttrice di grano e in prossimità delle pescose valli di Comacchio.
Con quali meccanismi e con quali istituzioni commerciali interstatuali Venezia aveva potuto imporre il suo potere e proteggere i propri interessi? I trattati erano divenuti necessari per mettere ordine in questioni complesse come le rappresaglie, l'estradizione dei debitori in fuga (76), l'ammontare dei diritti doganali, le esenzioni, la sicurezza delle strade, i tribunali commerciali e i rifornimenti di viveri. Si trattava in questi casi di clausole arbitrali e di reciprocità, ma i Veneziani introdussero ben presto due nuovi elementi che fecero pendere la bilancia in favore dell'egemonia veneziana (77): il monopolio del sale e i privilegi ai propri mercanti. Venezia, tuttavia, cedeva talvolta a qualche concessione; nel 1313, per esempio, dopo la guerra di Ferrara, dovette impegnarsi con il papa, che aspirava al controllo della città padana, a mantenere aperta la via di navigazione del Po, rinunciando alla costruzione di un canale che era stato progettato per facilitare le comunicazioni con la Lombardia (78) senza passare per Ferrara. Ai Veneziani fu inoltre fatto divieto di acquistare proprietà senza licenza pontificia.
Nel 1366, per ridurre il contrabbando da Venezia a Ferrara, fu nuovamente instaurato l'antico sistema dei "certificati d'origine", documenti che i mercanti presentavano alle autorità consolari ricevendone una controlettera da presentare al rientro in patria. Ma gli Este, signori di Ferrara, eludevano facilmente tali obblighi in quanto il trattato era stato firmato con Ferrara e non con città o zone come il Polesine, Adria, Argenta o Comacchio, ugualmente in loro possesso. In definitiva le risorse del diritto feudale consentivano di salvaguardare la giurisdizione estense dagli sconfinamenti veneziani e si opponevano alla costruzione di un vasto mercato dominato da Venezia. La Repubblica tuttavia compiva sforzi notevoli per mantenere a proprio vantaggio la libera circolazione dei mercanti e dei loro beni, pattugliando il Po e facendo scortare i convogli da guardie. Nel secolo XIV essa non ricorreva più volentieri ai blocchi, alla "strictura", come per il passato: altro era decretare un blocco, altro ottenerne l'applicazione quando si disponeva del sale quale unica arma veramente efficace da opporre a vicini recalcitranti e sempre pronti a rispondere: niente sale, niente grano. Il blocco era un'arma a doppio taglio da maneggiare con la massima precauzione.
Di fatto la politica di esenzione dalle tasse reclamata e messa in opera dai Veneziani conduceva a un paradosso così descritto da Trevor Dean: "i Veneziani residenti a Ferrara beneficiavano di immunità maggiori rispetto a quelli che abitavano a Venezia" in quanto, nel secolo XIII, le franchigie erano state accordate a marinai, a piccoli commercianti giunti a Ferrara con le loro derrate, mentre nel secolo XIV si trattava di nobili veneziani, di "signori" che chiedevano l'esonero per tutte le merci in transito attraverso il distretto ferrarese (79). La politica di Venezia mirava ad assicurare ai propri mercanti il libero transito attraverso tutta l'Italia padana e i patti erano il mezzo migliore per assicurarsi il trionfo di quest'aspirazione.
b) Il monopolio coloniale
In materia di commercio e di approvvigionamenti, alle colonie veniva imposta una rigorosa subordinazione agli interessi economici della metropoli (80). In linea di principio tutte le esportazioni dall'isola di Creta dovevano essere dirette a Venezia, sia per il consumo interno della città che per la distribuzione all'estero. Lo stesso principio monopolistico vigeva per le importazioni cretesi, sempre obbligate a passare per la capitale. Regole così rigide di esclusivismo coloniale erano talvolta di difficile applicazione: vano era sperare di deviare verso la città lagunare il commercio di Creta con Rodi, Cipro o Costantinopoli.
La Repubblica, accanto alle colonie fondate dopo la conquista del 1204, pose in essere un tipo differente di colonizzazione per meglio rafforzare il proprio peso commerciale. Nel 1319 e nel 1364 ottenne dall'amministrazione greca di Trebisonda l'autonomia e lo statuto di extraterritorialità della propria agenzia commerciale, un regime favorevole al commercio, il libero accesso per i mercanti a tutto il territorio dell'Impero, la riduzione delle tasse, la possibilità di usare i propri pesi e misure, la libertà di accesso per i velieri nel porto di Trebisonda e negli altri scali. Nel 1367 Veneziani furono autorizzati a fortificare il loro banco e nel 1376 i kommerkioi furono ridotti della metà. Trebisonda costituiva anche l'accesso al mare della Persia e di Tabriz, e i Veneziani, che mancavano di soci con cui concludere affari, invitarono l'imperatore ad attirare i mercanti persiani nella capitale con la promessa di agevolazioni fiscali. Parimenti avevano bisogno dei servizi di intermediari nel commercio al minuto e nella ricerca di mercati per le forniture dall'interno. Nel commercio dei prodotti locali dell'Impero con gli Italiani, tale ruolo era stato monopolizzato dai Greci o dagli Armeni che trafficavano in quasi tutti i porti del mar Nero e che si erano rivelati particolarmente abili nel tessere una rete di mercati locali dominata dai Latini. I Greci, consoci degli Italiani, assumevano allora la nazionalità veneziana per poter alleviare la pressione fiscale che gravava sui sudditi dell'imperatore e per usufruire di ulteriori vantaggi.
c) Una posizione egemonica
Nella stessa Venezia gli artigiani, i dettaglianti e i servizi si trovavano sotto la tutela del capitale mercantile che esercitava il proprio controllo su tutte le attività economiche: commercio all'ingrosso e al minuto, trasporti, banche, crediti e laboratori industriali. Il commercio restava "base e baluardo della finanza, della ricchezza, della potenza veneziana" (81); il debito pubblico veniva finanziato con le imposte sul consumo e sugli affari e con le tasse doganali. "La politica di Venezia è tutta e costantemente indirizzata a promuovere e favorire con ogni mezzo il commercio internazionale, fonte massima delle entrate fiscali e della ricchezza di tutta la popolazione" (82). Non era nelle intenzioni dei mercanti e delle autorità trasformare Venezia in un porto di transito: lo sforzo maggiore consisteva nell'attirare in città mercanti stranieri di ogni provenienza con merci condotte per via di terra, nel mettere a loro disposizione alloggi, magazzini e sensali che favorissero i contatti, dal momento che i prodotti in arrivo dovevano essere venduti ai Veneziani prima di venir riesportati oltremare su trasporti di proprietà della Repubblica. Un postulato, questo, valido anche nell'altro senso: le merci giunte via mare e destinate all'entroterra dovevano affluire a Venezia, che a sua volta le avrebbe riesportate. Ecco dunque realizzata la politica del monopolio della navigazione nel Golfo, elaborata assai presto e applicata con forza nel secolo XIII, pur se con molte deroghe: ancora nel Trecento, per esempio, ben vive erano le attività marinare di Ancona (al di fuori del controllo di Venezia) e di Ragusa (sotto la sua egemonia).
d) Il fondaco dei Tedeschi
Se all'estero i Veneziani si appellavano alla libertà degli scambi commerciali, che mal si adattavano alle costrizioni di tipo feudale, comunale o corporativo, in casa si mostravano estremamente puntigliosi nella difesa dei privilegi, che concedevano solo minimi margini alle iniziative dei mercanti stranieri (83). Venezia poteva prosperare nella sua funzione di intermediario fra i paesi oltremontani e il Levante, a condizione che ogni scambio avvenisse nella sua sfera d'azione. Dal 1177 aveva vietato ai sudditi dell'Impero qualsiasi commercio con il Levante, limitando gli scambi al solo territorio cittadino e vietando l'acquisto di merci straniere in terraferma italiana. Durante il Medioevo, tuttavia, nei rapporti d'affari che univano Venezia e la Germania, i Tedeschi coprivano un ruolo rilevante trattando con gli Italiani sulle diverse piazze commerciali e finanziarie ai confini del mondo germanico. A Venezia essi erano assoggettati all'alloggio, alla disciplina e agli obblighi del fondaco dei Tedeschi, la cui creazione aveva coinciso con un inasprimento dell'organizzazione del controllo commerciale estero veneziano. A testimonianza di un simile irrigidimento si pensi alla disavventura capitata a Luca Silvestro che, a Treviso, aveva conosciuto un mercante tedesco che gli proponeva delle pellicce; prima però avrebbe dovuto presentarle al fondaco dove si recò con Silvestro. La vendita fu conclusa davanti al "messeta" e i diritti versati; gli ufficiali del fondaco però li citarono in giudizio poiché l'affare era stato concluso a Treviso mentre il capitolare vietava ai Veneziani di recarsi a Padova o a Treviso per trattare con i Tedeschi e Luca Silvestro fu multato per un quarto del prezzo: 20 lire di grossi (84). I Tedeschi portavano al fondaco anche tela comune, ma il 24 febbraio 1348 il senato venne a sapere che da nove giorni taluni ne acquistavano al fondaco grossi quantitativi da inviare in Oriente a bordo di navi non armate, il cui costo di navigazione era di molto inferiore a quello delle galere: si trattava dunque di una concorrenza temibile per i commercianti che utilizzavano le galere. I provveditori di comun furono incaricati di svolgere un'inchiesta in tutta la città per porre fine a tali attività (85).
L'ambito in cui era più sensibile la discriminazione commerciale fra Veneziani e stranieri era quello delle tasse doganali. A Venezia esistevano tre antichi dazi: il "quarantesimo" (2,5%) pagato dagli stranieri per i prodotti importati o esportati via terra o dal nord del Golfo; il "quinto" (20%), applicato sulle importazioni di lusso giunte via mare dal Levante e infine l'"octuagesimo" - l'unico che i Veneziani dovessero versare su tutte le merci -, pari solamente all' 1,25%. Il tornaconto era considerevole: chi avrebbe potuto far loro concorrenza? Per il controllo del commercio estero e per l'esazione dei dazi, il comune aveva presto istituito le tasse delle "tre tavole", cui si erano successivamente aggiunte altre gabelle, per esempio la "messettaria". Gli affari venivano conclusi sotto il controllo del messeta, un ufficiale o un funzionario del comune, che fungeva da intermediario e da interprete (doveva saper parlare e leggere il tedesco) e prelevava un diritto pari allo 0,50% del valore dell'affare pagato dalle due parti.
Il fondaco dei Tedeschi, ripreso da analoghe istituzioni esistenti a Bisanzio e nei paesi musulmani, passò ben presto (1268) sotto la diretta amministrazione veneziana e divenne un "officium" controllato da tre visdomini e retto da un vero e proprio regolamento: residenza obbligatoria per i mercanti tedeschi, mediazione e controllo veneziano su ogni affare trattato, registrazione e sdoganamento delle merci importate o destinate all'esportazione. Il volume d'affari trattato annualmente al fondaco era considerevole, così come gli introiti fiscali per lo Stato.
Chiamati nel secolo XIV "sanseri" o "sensali", i messeti presenti al fondaco nel 1226 erano una ventina (86), ma l'espansione del volume d'affari con la Germania ne fece salire il numero, dal 1314, a 30, subordinati all'autorità dei consoli dei mercanti e al servizio dei mercanti tedeschi "qui continue veniunt ad fonticum". Questi ultimi, condotti al fondaco in barca e per la via più breve, venivano presentati al funzionario più alto in grado il quale sceglieva un sensale che poteva, lui solo, accompagnarli per le calli o consigliarli negli affari. I sensali poi, oltre a presentare ai visdomini un resoconto scritto sulla natura e sul prezzo delle merci scambiate e ad annotare il nome delle parti interessate, dovevano prestare particolare attenzione a che non si trattassero vendite clandestine d'oro e d'argento.
Nel secolo XIV, dopo il 1363, un tariffario doganale elenca le merci scambiate al fondaco: l'argento pagava un dazio dello 0,3%, il piombo e lo stagno dell'1%, il ferro e la lana dello 0,8%.
I sensali non sfuggivano alle debolezze proprie dei funzionari veneziani: frode e corruzione. Una delibera del maggior consiglio (30 gennaio 1390) ne denunciava l'intervento per conto terzi in affari commissionati, la formazione di società commerciali segrete con mercanti stranieri o veneziani, le dichiarazioni di contratti a valori inferiori rispetto al reale ammontare al fine di frodare i diritti nonché i pagamenti occulti così ottenuti.
Di fatto frode e contrabbando, stante l'estrema complessità dei regolamenti e la speranza di maggiori guadagni per i mercanti, continuavano a persistere. Così un tedesco, il giorno di Natale, aveva voluto esportare da Venezia 8 libbre di zafferano e altre spezie acquistate la vigilia di cui, non essendo stato designato nessun messeta, ancora non era stata effettuata la stima; lo "specialis" incorse in una pesante ammenda di 30 lire e 2 soldi (87). Vi erano dei beni proibiti, le armi per esempio: un viennese aveva comprato a Venezia due corazze, delle mantellette e degli usberghi da offrire al suo signore, contravvenendo così alle disposizioni che vietavano l'esportazione delle armi e inoltre aveva agito "sine messetaria" (88). La Repubblica prestava la massima cura a non lasciar partire questo tipo di prodotto; nell'agosto del 1378, quando era pesantemente impegnata nell'ultima grande guerra contro Genova, la quarantia criminale condannò a pesanti ammende due droghieri e i loro complici per aver venduto dei barili di salnitro a Nicola di Spira, che aveva dichiarato al messeta trattarsi di zucchero in polvere (89). Vi era chi trovava degli espedienti per aggirare la difficoltà, come quel Rodolfo di Neustadt che sperava di poter recuperare il pepe e i fustagni lasciati a Venezia, proponendo in cambio un carico di stagno e di rame (90), metalli che erano allora classificati come strategici.
Un altro aveva tentato di esportare 14 libbre di seta e 5 di filo d'oro benché i documenti ne dichiarassero quantità minori. Il maggior consiglio accettò di rendergli la merce e di sollevarlo dalle sanzioni penali - tra cui la messa al bando - se avesse pagato un'ammenda raddoppiata. Le autorità perseguivano più volentieri il mercante straniero che avesse commesso qualche infrazione se il socio veneziano non poteva invocare a sua discolpa l'ignoranza della lingua e delle leggi. Tale disavventura toccò a tre Tedeschi i quali, nel loro primo viaggio a Venezia (erano "novi", giovani) incontrarono un interprete tedesco che li condusse in Ca'Bragadin a vedere e acquistare seta senza la presenza di un ufficiale; non conoscendo le usanze, effettuarono l'acquisto dopo aver pagato tutti i diritti, comprese la mediazione e la pesatura. L'intermediario venne imprigionato mentre i giovani inesperti, "consideratis puritate et innocentia eorum" furono rilasciati.
Non conosciamo con precisione l'entità del commercio tedesco a Venezia. Il fondaco era spesso intasato di merci che per giorni o addirittura per settimane restavano all'aria aperta prima di poter essere stipate nei magazzini. Un mercante, tanto per fare un esempio, aveva importato dalla Germania sei rotoli e due balle di tela ma dovette attendere una decina di giorni prima di poterli riporre al coperto, ormai zuppi a causa dell'umidità, poiché al suo arrivo non vi erano locali disponibili nel fondaco (91). In tali scambi c'era un settore in cui i Tedeschi avevano un ruolo insostituibile: l'importazione di metalli preziosi. Fu questa attività che fece della Repubblica uno fra i più importanti mercati europei d'oro e d'argento. La ridistribuzione dei prodotti tedeschi permise a Venezia di rispondere alle richieste di metalli preziosi dei paesi del Levante e di mantenere attiva la bilancia dei pagamenti. L'afflusso di detti materiali già dal secolo precedente aveva favorito il conio alla Zecca del ducato d'oro e del grosso d'argento, due monete che alla fine del Medioevo fecero di Venezia una delle massime piazze monetarie europee (92).
I puntigliosi regolamenti veneziani creavano notevole disturbo alle attività dei mercanti stranieri in città. Il loro arrivo veniva annunciato dai posti doganali disseminati su tutti i canali e le strade che conducevano in Laguna: nel 1322 quattro mercanti di Ratisbona che erano stati visti trasportare oro e argento furono condannati a pagare un'ammenda per non aver depositato i preziosi al fondaco il giorno stesso del loro arrivo. Lo stesso anno, un viennese, colpevole dello stesso reato ma che aveva invocato a propria discolpa dei violenti mal di testa, fu graziato e il quarto confiscato dei suoi 30 marchi d'argento gli venne reso (93).
Il 14 giugno 1346, benché il doge Andrea Dandolo assicurasse l'imperatore Ludovico che Venezia trattava i mercanti tedeschi "con dolcezza e favore, meglio di quanto trattasse quelli delle altre nazioni e addirittura meglio degli stessi Veneziani" (94), un certo Enrico incorse in un'ammenda di 30 lire e 12 soldi per l'acquisto di una pezza di stoffa ("sciamiti") per la sua famiglia, cioè per uso personale. Lo si perdonò in quanto "ignorans ordinem terre nostre" (95).
A questo tipo di vessazioni seguivano adeguate rappresaglie: i mercanti veneziani - come del resto i loro clienti stranieri - avevano salvacondotti e carte di trasporto in regola, ma l'ignoranza di un qualche punto del regolamento era così frequente che a Venezia multe e confische sembravano legittime, mentre all'estero ai Veneziani suonavano come violazioni dei normali diritti. A titolo di esempio di tali restrizioni, riandiamo al 30 luglio del 1321: gli stranieri ("forenses", i non Veneziani) potevano acquistare, detenere e vendere le merci provenienti dai paesi fuori del Golfo, le derrate cioè avviate a Venezia dai paesi mediterranei, ma non potevano realizzare alcuna transazione commerciale con i Friulani né con i Tedeschi (96) poiché i Veneziani se ne riservavano il monopolio.
e) Venezia e la Germania
Le città più coinvolte nei rapporti commerciali che si intrecciarono a Venezia furono a lungo Vienna (97), Norimberga e Ratisbona, che esportavano metalli - rame, oro o argento - e importavano da Venezia spezie e prodotti d'Oriente. Nel secolo XIV la via di terra che raggiungeva le Fiandre attraverso la Germania assunse grande importanza a livello internazionale e i mercati più attivi divennero quelli di Augsburg, di Ulma e delle città renane, specialmente Colonia. Vi erano compagnie tedesche che importavano spezie per Francoforte, Anversa o Bruges e cotone per le città della Svevia, ed esportavano a Venezia i bei tessuti fiamminghi e renani o le tele di lino delle città della Svevia e del lago di Costanza (98).
I rapporti con la Germania evidenziano le difficoltà con cui dovevano scontrarsi i mercanti alla fine del Medioevo. Al primo, grave limite costituito dalla frammentazione territoriale, si aggiungeva che nelle città tedesche non sempre era facile distinguere i mercanti di Venezia da quelli di altre città italiane. Così avvenne che a Lindau, sul lago di Costanza, in seguito a problemi sorti con Milano, vennero confiscate delle merci veneziane; il doge allora - era il 6 febbraio del 1309 - scrisse ai consoli di Lindau che Milano era una città "per sé" dove i Veneziani non potevano intervenire (90). Esercitare il commercio in quei tempi inquieti esigeva una sicura conoscenza dei rapporti di forza tra le varie città, delle alleanze, delle inimicizie, delle sottili questioni che dividevano i comuni. Nel 1329 il tedesco Hans Basel - vero e proprio mercante itinerante - era riuscito a vendere due cavalli e a comprare otto belle tele di Lucca e cinque pezze di seta a Bologna; prima della partenza da Venezia, gli amici lo avevano gentilmente consigliato, se avesse dovuto passare per Treviso, di tacere sull'origine delle merci (Bologna appunto). Viaggiava dunque "sine bulleta" ma mal gliene incolse: capitò in un posto di dogana veneziano dove gli furono sequestrate le stoffe e dovette pagare una multa di 5 lire (100).
Il frazionamento politico ostacolava il buon andamento degli affari e l'immateriale frontiera fra signorie nemiche ostacolava pesantemente le attività commerciali; il solo fatto di venire dalla città rivale destava sospetti. Il traffico terrestre incontrava difficoltà più gravi di quello marittimo: il marinaio e il mercante temevano certo la tempesta e i pirati, ma il mare almeno era un vasto spazio libero, non attraversato da barriere, da pedaggi o esigenze contraddittorie. Per essere più esatti, Venezia dominava incontrastata il mare e vi dettava legge; la terraferma invece era un regno di incomprensibili vessazioni che andavano ad aggiungersi alle barriere dei rilievi montuosi e alle difficoltà di comprendere la lingua degli abitanti.
Ma è lecito parlare di brigantaggio sulle vie di terra, quando assai spesso erano proprio le autorità pubbliche a prendere l'iniziativa di sequestri e pignoramenti, in base all'applicazione del diritto feudale o comunale e urbano, per cui ogni mercato poteva esigere un diritto di tappa e le merci in transito dovevano essere proposte ai mercanti locali prima di poter proseguire - e solo nel caso nessuno le avesse acquistate - per la loro strada? Nell'ottobre del 1308 il doge dovette intervenire presso le autorità di Augsburg affinché restituissero ai Veneziani le merci sequestrate a Füssen. In dicembre, ancora, fu costretto a chiedere che le merci poste sotto sequestro dai duchi di Montfort e Bregenz e messe in vendita sul mercato di Merano fossero restituite ai proprietari veneziani (101).
Il diritto di prelazione, legato a quello di tappa, aveva come conseguenza un altro inconveniente contro cui la Serenissima protestò nel 1358: le balle dei mercanti veneziani dirette in Fiandra venivano aperte dalle autorità renane per l'ispezione e in tale stato rimanevano immobilizzate per tre o quattro giorni (102).
Ogni volta che si poneva la necessità di un tale intervento presso una città, un signore o l'imperatore stesso, bisognava inviare un messaggero e deliberare i crediti per le spese del viaggio, l'acquisto del cavallo e la piccola scorta appiedata; se la missione era coronata da successo, il mercante recuperava i suoi beni e rendeva, oltre ai cavalli, quanto non era stato speso (103). Ancora nel 1385, i mercanti in favore dei quali lo Stato era intervenuto per sbloccare le merci ferme a Monaco pagarono i costi dell'ambasciata nella proporzione del 25% del valore globale e altrettanto fu prelevato su tutte le merci in movimento via terra fino al completamento della somma. Non sempre era facile, per coloro ai quali i beni venivano sequestrati, procurarsi gli anticipi necessari e il senato consigliava loro di cercare personalmente un prestito in quanto il comune non era in grado di sopportare nuove uscite. Fra le vittime del sequestro di Monaco figurano i Donà che avevano spedito della seta (104). Le spese degli ambasciatori venivano calcolate forfettariamente e la loro missione era limitata nel tempo a quaranta giorni: 3 ducati al giorno per l'ambasciatore, due uomini di scorta ("famuli"), un interprete e quattro cavalli. Il mantenimento di una tale carovana, costretta a scendere nelle locande, è un chiaro indice dell'altissimo potere d'acquisto della moneta d'oro alla fine del Trecento. A dispetto delle difficoltà e della modestia della somma accordata, la scelta dell'ambasciata non mancò di suscitare intrighi: il 16 marzo era stato eletto Giovanni de' Garzoni, il 25 la scelta cadeva invece su Roberto Morosini e il 7 settembre il senato scrisse a un terzo uomo, Michele Contarini, "ambaxatori nostro in partibus Bavarie" di negoziare l'affare.
È difficile comprendere appieno il ruolo svolto dai mercanti veneziani nel commercio con la Germania ma basti dire che, negli anni 1345-1346, il consiglio della città di Norimberga scriveva al borgomastro di Ratisbona avvertendolo del pericolo che essi rappresentavano per i commerci in entrambe le città e pregandolo di avviare una trattativa comune presso l'imperatore. Fu in quell'occasione che le autorità di Norimberga sequestrarono la merce di alcuni Veneziani, i quali, a loro volta, risposero con l'espulsione di tutti i mercanti della città tedesca (105). Alcuni mercanti veneziani allora non esitarono a scrivere ai clienti di Norimberga di inviare la lana e le altre merci per le vie di Cividale e Padova, ma il senato reagì con prontezza vietando qualsiasi corrispondenza con la città interdetta. Nemmeno le altre vie, purtroppo, erano sicure e il 7 gennaio 1348 il senato cominciò a inquietarsi perché i beni dei Veneziani di ritorno dalle Fiandre per la strada di Basilea erano stati bloccati e sequestrati. Un notaio del palazzo vi fu inviato per studiare la possibilità di nuovi collegamenti con le Fiandre (106), ma il 25 agosto 1348 si venne a sapere che anche Albertus di Werdenberg, conte dell'alta Svevia, si era impadronito, due anni prima, di merci che rientravano dalle Fiandre; né da meno era il conte Ludwig von Öttingen, vassallo del duca d'Austria, il quale non si esimeva dal prendere analoghi provvedimenti (107). In definitiva, passassero per Norimberga a est, per Basilea a ovest, per il Giura svevo al centro, le strade per le Fiandre non offrivano più alcuna sicurezza. Per rimediare alla situazione venne interpellato il signore di Padova affinché riannodasse buoni rapporti con Norimberga (108); il contenzioso commerciale fra le due città richiese tempi lunghi, ma se ne venne a capo nel novembre 1348 quando le autorità di Norimberga promisero di restituire le merci veneziane sequestrate a Francoforte e a Monaco.
Il lungo conflitto commerciale con Norimberga, durato oltre due anni, diede a pensare: il 2 luglio 1349 il senato richiamò all'ordine il podestà e il comune di Conegliano dove alcuni mercanti tedeschi erano stati spogliati di tutti i loro beni malgrado avessero pagato i diritti che avrebbero dovuto garantire loro la sicurezza del passaggio. Il senato faceva giustamente notare agli interlocutori che "propter istud damnum posset nostratibus utentibus in partibus Alemanie non modicum prejudicium iminere". Si cominciavano a intravvedere i molteplici inconvenienti e pericoli di quella politica di rappresaglie che aveva fino ad allora regolato i rapporti internazionali. Due anni più tardi, analoghe considerazioni prevalsero nuovamente quando si dovette risarcire un mercante tedesco, vittima di un furto nel territorio trevigiano: la salvaguardia degli interessi dei Veneziani che prendevano la via delle Fiandre ispirava le opere di buona volontà e lo spirito di concordia (109).
Gli investimenti
Per concludere un affare occorre del denaro, un capitale; o più spesso - giacché gli affari si fanno con i soldi degli altri - è necessario trovare crediti o prestiti presso chi - privato cittadino o Stato - disponga di capitale. La città è una piazza finanziaria in cui differenti categorie di mutuatari si fanno concorrenza di fronte ai potenziali creditori, e dove la situazione del momento impone l'abbondanza o la scarsezza del denaro, soprattutto se lo Stato deve affrontare gravose spese belliche e, di conseguenza, mobilizzare la ricchezza dei privati. Privati e Stato si fanno allora una temibile concorrenza e, per disporre di liquidità, si affrontano in una guerra di tassi di interesse. La piazza finanziaria reagisce come un mercato unico dove gli investimenti si fanno preferibilmente nei settori che offrono la maggiore sicurezza e gli introiti più elevati. Un portafoglio ben gestito contiene quasi sempre svariati tipi di titoli: non solo buoni di Stato e crediti commerciali ma anche polizze di debiti. E dunque disagevole affrontare questo argomento senza far interferire credito pubblico con credito privato, tanto più che l'onnipotenza e l'interventismo dello Stato influivano non poco. Venezia, nel Medioevo, costituiva una vera e propria piazza mondiale, la principale forse, reattiva a tutti gli avvenimenti esterni che sconvolgevano, per fare un esempio, il mercato monetario.
Il mercato dei capitali. a) Il commercio dei metalli preziosi e la moneta
L'Oriente come metallo monetario usava soprattutto l'argento, che nei suoi mercati aveva tradizionalmente un valore superiore a quello attribuitogli dall'Europa, più legata all'oro. Di conseguenza Venezia, sua partner commerciale, non poteva, considerata la sua politica monetaria, contribuire ad abbassarne il valore: era suo interesse infatti mantenere elevato il valore dell'argento con cui effettuava la maggior parte dei pagamenti. A Venezia aveva largo seguito la teoria della moneta-merce e i movimenti dell'oro e dell'argento costituivano "una parte del commercio di beni". Le monete veneziane assumevano un ruolo monetario quali mezzi di pagamento sostitutivi nel Levante, ma il commercio dei metalli preziosi - equilibrando il deficit commerciale permanente dell'Europa (110) - era considerato la porta d'accesso privilegiata ai mercati orientali. Nel 1284, quando decise il conio del ducato d'oro al titolo di 24 carati (3,559 grammi), il maggior consiglio stabilì anche che gli ufficiali della Zecca acquistassero il metallo a un prezzo che permettesse di scambiare il ducato per 18 grossi d'argento e poi, alcuni mesi più tardi, per 18 grossi e mezzo. Questo cambio legale rimasto stabile fino al 1328 istituiva, con un rapporto pari a 1/10,9, un corso dell'argento elevato rispetto all'oro, sebbene non molto realistico in un momento in cui la produzione d'argento nelle miniere boeme abbassava il tasso a 13/1 o addirittura a 14/1. Nel 1311 ancora, pur essendo l'oro quotato a 1/13 sulle piazze europee, Venezia persisteva nella sua fedeltà alla parità ufficiale e non aveva alcuna intenzione di ritornare sulle decisioni prese. Accadde quel che doveva accadere: la gente era restia a vendere l'oro a una Zecca che pagava con argento fermo al tasso del 1284-1285 (111). Fortunatamente la legge permetteva allo Stato di pagare i lingotti d'oro con le monete ottenute dalla loro fusione - una sorta di ricorso al credito al fine di procurare alla Zecca il metallo indispensabile al conio del ducato. Il successo del grosso era basato tanto sull'afflusso a Venezia della produzione delle miniere d'argento dell'Europa centrale (112) quanto sulla sua rapida esportazione, dovuta alla forte domanda dall'Oriente di una buona e stabile moneta d'argento e alle esigenze europee di oggetti di lusso orientali. In questo senso Venezia reagiva con maggior sensibilità al monometallismo dell'Oriente che alle leggi su cui, in Occidente, si reggeva il bimetallismo con le sue rationes variabili tra oro e argento. Di conseguenza, c'era sempre un notevole scarto tra il mercato e la legge.
Ma poteva succedere qualcosa di ancora più grave: il deprezzamento dell'argento su un mercato dove, dal 1305, il ducato veniva scambiato contro 24 grossi. Fortunatamente, nel periodo successivo al 1320, l'oro cominciò ad affluire dal Sudan attraverso l'Egitto e la Barbaria o dall'Ungheria in quantità tale che la ratio ritornò al di sotto del limite di 11/1 (113). Il valore relativo dei metalli preziosi subiva oscillazioni legate alla quantità degli arrivi. Nel 1328 fu il deprezzamento dell'argento a causare una significativa riforma: il titolo e il peso del grosso rimasero invariati, mentre il valore legale fu fatto scendere a 1/24 del ducato (114). Secondo Lane tuttavia non si sarebbe trattato di una rivalutazione del ducato che veniva già da tempo cambiato contro 24 o più grossi, ma della stabilizzazione del suo corso a 24 grossi per frenare un ulteriore crollo della moneta d'oro. Gli effetti dell'operazione si sarebbero fatti sentire fino alla caduta della Repubblica, poiché da allora pagamenti e riscossioni furono registrati in lire di 240 grossi, pari a 10 ducati.
La riforma era stata adottata da poco quando l'argento cominciò a rivalutarsi con tale rapidità che nel 1332 si dovette imporre agli importatori la cessione diretta alla Zecca del 20% del metallo, con un calo del 20% rispetto al prezzo di mercato. Le conseguenze si fecero immediatamente sentire a Venezia, dove si assisté a un forte afflusso d'oro, importato dai mercanti, e alla fuga del grosso cui si andavano sostituendo imitazioni straniere di minor titolo e monete tosate. Il governo non volle svalutare il grosso adattandolo al nuovo valore dell'argento, ma ne rallentò e poi sospese il conio - che per la Zecca rappresentava ormai una perdita - e al suo posto fece battere due nuove monete, il "mezzanino" e il "soldino", frazioni del grosso - che avrebbero dovuto sostituire - con una percentuale di prezioso inferiore del 10% rispetto alla buona moneta d'argento; si era così ripristinata la parità oro/argento. Di fatto, tale riduzione si sarebbe rivelata insufficiente di fronte al continuo rialzo del valore del metallo bianco e nel 1353 la disparità tra i valori legale e reale dell'argento portò nuovamente a una situazione difficile: dal 1202, anno della creazione del grosso, da un marco d'argento si ricavavano effettivamente 109 grossi e mezzo, ma se si fosse valutato il marco rapportandolo al ducato e al corso legale del grosso (1/24 del ducato), da un marco si sarebbero dovuti fondere 156 grossi.
La riforma andò di pari passo con un profondo rinnovamento delle istituzioni che si facevano carico della politica monetaria e della gestione del commercio dei metalli preziosi. Dal secolo XIII, la competenza in materia monetaria era passata dal maggior consiglio alla quarantia, più qualificata in un settore così tecnico. Tre membri del consiglio dei quaranta ispezionavano settimanalmente i laboratori per verificare la qualità del conio. Era difficile però scalzare completamente il maggior consiglio, chiave di volta dell'edificio costituzionale veneziano, cui venne lasciato il commercio dell'argento (115). L'8 luglio 1331 il maggior consiglio subordinava le questioni attinenti alla moneta all'autorità del senato, in virtù della sua competenza sul commercio e sulla navigazione, settori cui la circolazione del denaro era particolarmente legata (116). Le funzioni del senato si estesero dal controllo sul commercio dell'oro e dell'argento e sul fondaco dei Tedeschi - principale centro della compravendita di metalli preziosi - alla regolamentazione dell'attività della Zecca in materia di conio e di circolazione. L'importanza del senato andò via via aumentando: vietò la circolazione di valuta straniera, fissò le norme del cambio sulla base di pezzi usciti dalla Zecca, definì le strategie utili ad assicurare un approvvigionamento d'argento sufficiente per i periodi di guerra, definì i tassi di interesse da versare ai privati, le caratteristiche delle monete, le modalità del conio dei metalli depositati alla Zecca e infine si applicò alla salvaguardia della qualità delle monete in circolazione (118). La quarantia fu particolarmente attiva nel decennio successivo al 1340, in una difficile congiuntura economica (118), quando si dovettero prendere misure contro l'eccessivo afflusso d'oro alla Zecca, scorporare la "Zecca dell'argento" dalla "Zecca dell'oro" e, il 15 ottobre 1349, riorganizzare completamente l'ufficio. L'attività legislativa del consiglio veniva preceduta da puntuali analisi della situazione monetaria generale condotte da commissioni di saggi istituite dalla quarantia.
Fu solamente nel 1379, negli anni più difficili della guerra con i Genovesi, tra le più gravi difficoltà finanziarie ed economiche, che Venezia uscì dal sistema cui era stata fedele per centottanta anni, con la decisione di mantenere il rapporto 1/24 e lasciando fluttuare il valore intrinseco del grosso in modo che non si allontanasse troppo da quello reale. Finiva così il predominio del grosso d'argento e trionfava il ducato d'oro (119). In realtà, nel 1379, dopo un'interruzione di ventiquattro anni, venne coniata una nuova moneta d'argento cui si diede il riverito nome di "grosso"; il paradosso consiste nel fatto che da allora si ebbero un grosso antico, di conto, che valeva 1/240 della lira di grosso, pari a 1/24 del ducato, e il nuovo grosso d'argento di valore variabile.
b) Il mercato stagionale dei cambi (120)
Un manoscritto fiorentino anonimo, lo Zibaldone di notizie utilli a merchadanti (121), insiste sulla estrema regolarità stagionale del commercio veneziano che innescava i meccanismi dell'offerta e della domanda sul mercato monetario. La città era di fatto una fiera permanente ritmata dalla partenza e dai rientri delle galere, delle cocche e delle navi: tutta la vita cittadina vi si concatenava, dato che i convogli esportavano a Ponente ciò che altri avevano importato da Levante e viceversa. La navigazione dipendeva anche dai mercanti tedeschi scesi da nord con prodotti minerari, oro e argento. Da ultimo, la regolamentazione dei traffici equivaleva a un'affermazione della politica volontaristica del senato e dei consigli del comune. Tali fattori, tradotti nella esemplare costanza del calendario, facilitavano il compito degli agenti di cambio, invitati ad anticipare la domanda senza attendere gli effetti della scarsità di contanti, dato che costi elevati comportavano un afflusso di liquidità che determinava il ribasso dei cambi (122).
I periodi di rialzo e di calo si succedevano così nel corso dell'anno: in febbraio - a Venezia l'ultimo mese dell'anno, nel cuore dell'inverno - il movimento degli affari era debole e il mercato depresso; in marzo e aprile si verificava un leggero incremento in coincidenza con la partenza delle galere delle Fiandre che importavano poco denaro e molte merci acquistate a credito e pagate con moneta di banca. In maggio e giugno i mercanti mobilizzavano i loro averi rimpatriando le rimesse dalle grandi piazze occidentali, Bruges, Londra e Parigi, in previsione della partenza delle galere di Romània, le cui aste si tenevano a fine maggio-inizio giugno e i cui termini scadevano alla fine della prima quindicina di luglio; in quel periodo i corsi salivano alle stelle e il credito rincarava con l'esportazione verso Oriente di valuta e lingotti. Dopo la partenza delle navi di Romània, fra il 15 e il 20 luglio ("al tempo usato"), la febbre diminuiva, ma per poco, dato che la partenza per Beirut di convogli carichi di metallo prezioso in quantità maggiori rispetto ai precedenti prosciugava completamente il mercato. Veniva infine, agli inizi di settembre, il turno delle galere provenienti da Alessandria; si apriva allora un periodo di totale apatia, i corsi precipitavano e la domanda di moneta rimaneva stazionaria per i due mesi successivi. A partire dalla metà di novembre Venezia attendeva il ritorno delle flotte, ma la ripresa dell'attività commerciale aveva solo deboli ripercussioni sul corso dei cambi giacché i Tedeschi affluivano con monete e lingotti per acquistare spezie e altri prodotti orientali; il mercato monetario conosceva allora una certa "larghezza" di liquidità. Il periodo natalizio, tempo di fiere, reintroduceva la "strettezza", la contrazione del mercato e l'argento a caro prezzo; gli importatori pagavano i diritti e i noli allo Stato mentre le cocche della "muda del cotone" salpavano per Cipro e per la Siria portando con sé "buona summa de danari"; l'arrivo di febbraio dava fiato al mercato che tornava a una situazione di abbondanza monetaria.
c) Venezia, piazza internazionale di scambi (123)
Per i pagamenti Venezia aveva adottato il sistema per compensazione già in uso, nei secoli precedenti, nelle fiere della Champagne (124). Giulio Mandich ne fornisce una chiara descrizione: "Con l'accordo, un debitore (assegnante) dà al creditore (assegnatario) un terzo, come nuovo debitore (assegnato); ma anche accade che l'assegnante sia creditore del terzo assegnato, e l'assegnato sia creditore dell'assegnatario. Si realizza allora, fra le diverse parti, il cosiddetto scontro" (125). Ma l'operazione può procedere ulteriormente e coinvolgere altre persone: "Non di rado un assegnato diventa a sua volta assegnante, ordinando ad un altro soggetto (un secondo assegnato) di adempiere all'originario assegnatario; oppure un assegnatario diventa poi assegnante [...], e così anche più volte, sino a quando, specialmente nelle fiere, l'itinerante assegnato [...] si imbatte in una controparte, con la quale gli riesce possibile una compensazione". La suddetta pratica era facilitata a Venezia, come in tutte le grandi piazze commerciali del Medioevo, dai frequenti incontri dei commercianti in luoghi determinati della città, a Rialto, "a pie' del campanile di San Iacomo" in particolare, in certe ore del giorno, quando cambia-valute e banchieri aprivano le loro tavole. Qui interveniva il secondo elemento del meccanismo degli "scontri": la banca "de scritta" che liquidava in conti correnti i suoi rapporti "tanto con l'assegnante quanto con l'assegnatario". Quando debitore e creditore si presentavano insieme alla banca e il primo ordinava di "scrivere" una somma a credito del secondo con un trasferimento da conto a conto, la banca, se accettava, veniva assegnata dal debitore al creditore e si impegnava a tenere la somma a disposizione dell'assegnatario per un ulteriore trasferimento nel credito di altri conti. La banca interveniva nel pagamento delle merci sulla piazza o anche, di frequente, fuori piazza. In quest'ultimo caso le parti interessate non potevano più essere presenti per dare l'ordine verbalmente; occorreva dunque un ordine scritto perché i pagamenti potessero essere effettuati o ne fosse materializzata la promessa. "La differentia loci è differentia pecuniae", porta cioè a fissare un rapporto di cambio fra la moneta presente a Venezia e quella assente. "La differentia loci è differentia temporis", ovvero costringe a stabilire un termine all'obbligazione che scadeva altrove (126).
Un'operazione, ripetuta di frequente, metteva in gioco le due condizioni della differenza di luogo e dello scarto nel tempo: il cambio o, più esattamente, il contratto di cambio per cui un acquirente che riceveva denaro si impegnava a rimborsarlo al venditore altrove e in un'altra moneta, ed emetteva una lettera a garanzia dell'esecuzione. Tramite il meccanismo delle assegnazioni, la lettera coinvolgeva quattro persone: "Il prenditore della valuta, in veste di traente, indirizza la lettera ad un terzo soggetto (trassato), perché la paghi; il datore della valuta, in veste di remittente, manda la lettera ad un quarto soggetto (remissario), perché la riscuota" (127). La lettera di cambio non aveva per oggetto principale il pagamento delle merci; essa era semplicemente "un ordine di pagare una certa somma, in un certo luogo, quale corrispettivo di un'altra somma ricevuta in un altro luogo": in quanto tale, veniva utilizzata come strumento di credito per ottenere capitali a condizioni vantaggiose o per investire con una certa sicurezza. Il compratore trovava infatti denaro presente sulla piazza e il venditore otteneva valuta assente, presente cioè in un'altra piazza. Il meccanismo, con i suoi tempi lunghi - dieci giorni all'andata, venti al ritorno, per un totale di un mese - e la sua prassi - effetto pagabile in un mese - funzionava perfettamente fra Firenze e Venezia; Venezia era la piazza creditrice che dava il "certo" - "Venezia dà a Firenze [...] lire [veneziane] 1, per lire a fiorini tot" - mentre Firenze dava l'"incerto" - "lire a fiorini tot per lire [veneziane] 1". Nei cambi si deve considerare di fatto la moneta presente (sulla piazza), che costituiva il valore ("valuta") del cambio ma, per definirne il prezzo, va considerata quella scelta come oggetto del contratto. La speculazione giocava allora, più che sui rapporti di parità delle lire di Venezia e di Firenze, sul dislivello tra i corsi di cambio della moneta veneziana su ciascuna delle piazze. Così, in un accordo firmato dal veneziano Nero Cocco con la filiale della società fiorentina "Duccio di Banchello e compagni" cui il mercante aveva venduto della lana - il trassato era un certo "Piero Gradenigo e compagni" - figura un corso giornaliero del cambio: "valsono i grossi questo dì [9 ottobre 1338] lire 14 s. 15 e 1/2 a fior la lira di grossi manchi" (128).
È il caso di dire che, trattandosi dei libri della filiale veneziana della casa fiorentina, vediamo operare soprattutto i banchieri fiorentini e in particolare la casa madre che, per procurarsi denaro a Firenze, ricorreva spesso alla lettera di cambio. Vendeva dunque la lira di grossi (più esattamente la "lira di grossi mancha", l'unità in vigore nel decennio del 1330) a un determinato prezzo, emettendo tratte sulla filiale veneziana che, a sua volta, per procurarsi valuta, utilizzava i contratti di cambio con Firenze, acquistava la "lira di grossi mancha" a un determinato prezzo ed emetteva tratte sulla casa madre. Non va dimenticato che, se l'operazione era condotta dai mercanti-banchieri fiorentini, era sempre Venezia a "dare il certo" - ben lo sapeva Raymond A. de Roover nelle sue pionieristiche ricerche (129) - e la casa madre di Firenze sopportava l'intero costo dell'operazione. La Repubblica, grazie alla sua potenza commerciale e finanziaria nel secolo XIV, riusciva a praticare lo stesso gioco in molte altre piazze del Levante e del Ponente e, da questo punto di vista, costituiva una fiera internazionale permanente, come giustamente aveva intuito Gino Luzzatto (130).
La concorrenza negli investimenti. a) La colleganza
Come avvenivano il finanziamento delle operazioni commerciali e il reperimento dei capitali? A quali condizioni dovevano sottostare i commercianti quando si rivolgevano a chi ne disponeva? Esistevano quattro tipi di contratti: la "commenda" associava due persone, lo "stans", che anticipava integralmente il capitale e restava in sede, e il "procertans" che invece era in perenne viaggio alla ricerca di affari da concludere. Alla fine di ogni viaggio, verificata la contabilità, il finanziatore rientrava in possesso di un capitale aumentato dei tre quarti dei profitti, mentre il mercante conservava il quarto restante. A Venezia si era a lungo preferita una variante detta "colleganza" per cui lo "stans" investiva per i due terzi e il commerciante integrava la cifra preventivata. Alla fine dell'operazione, al mercante spettavano i due quarti (per la parte investita e per la sua attiva partecipazione) mentre al finanziatore spettava l'altra metà. Il contratto di cambio marittimo comportava un'operazione di prestito conclusa per il commercio d'oltremare e un rimborso in un'altra moneta e in un altro luogo, con gli interessi maturati nel cambio. Vi era infine la "compagnia" o "societas" nella quale più soci investivano somme uguali o da remunerarsi in funzione dell'investimento. Nei contratti come la colleganza e la compagnia il mercante partecipava economicamente anche incrementando il capitale via via che gli affari procedevano; inversamente, lo "stans" era il solo a investire e il solo a rischiare eventuali perdite.
b) Evoluzione della colleganza
Già nel corso del Duecento era stata abbandonata quella forma di colleganza bilaterale in cui il mercante investiva un terzo del capitale. Gli atti del notaio Domenico, che esercitò dal 1309 al 1316, indicano che ormai "un solo personaggio portava con sé l'intero capitale". Su 42 contratti, in uno soltanto il "procertans" dichiarava di investire nel contratto se stesso, cioè il proprio lavoro. In due casi, il profitto veniva ripartito sulla base tradizionale della commenda di tre quarti/un quarto; in altri due invece la divisione era due terzi/un terzo e, curiosamente, un terzo/due terzi a favore del "procertans". Tredici contratti presentavano la divisione in parti uguali. In un atto è precisato che l'interesse non può essere superiore all'8%, mentre negli altri 22 la quota, non prefissata, veniva lasciata all'arbitrio del "procertans" che promette una "buona" o "giusta" spartizione (131). Gli accordi in questione si possono ripartire ugualmente in due distinte categorie: 24 riguardavano il commercio a terra o per mare mentre 18 facevano riferimento alle vendite al minuto a Rialto. A seconda del luogo di esercizio dell'attività veniva data la preferenza all'uno o all'altro tipo di ripartizione dei profitti da capitale. Per il primo tipo 14 erano a parte fissa mentre altri 9 venivano lasciati alle stime del "procertans"; per il secondo prevaleva la parte "giusta e buona" (14 contro 3 a retribuzione contrattata) mentre solo 2 erano i casi incerti. Nel secolo XIV si assisté a un radicale mutamento dell'antica colleganza sia per quanto riguardava la natura giuridica che per il contenuto economico, fino a configurarsi come un semplice prestito a interesse concesso a bottegai o artigiani operanti in Venezia. I mercanti, per quanto li riguardava, preferivano costituire delle società, come il maggior consiglio suggeriva già alla fine del secolo XIII.
Giustamente Luzzatto raccomandava di non contrapporre capitalista - "se pure può usarsi questa parola" - a mercante, sfruttatore a sfruttato. Il "procertans" era spesso un giovane che aveva ottenuto un prestito dai familiari, ritiratisi dall'avventura marinara. Il commerciante arricchito che non avesse voluto rinunciare agli affari investiva in numerosi "accomendatari" per diminuire i rischi, come pure il mercante che nelle sue peregrinazioni faceva ricorso a più investitori ("accomendanti") per radunare il capitale necessario all'impresa. La sua parte - un quarto dei profitti - non era affatto esigua come potrebbe sembrare, in quanto comprendeva una quota sui profitti di ognuna delle colleganze negoziate per uno stesso viaggio (132). Scopo di queste ultime era non tanto l'acquisto delle merci prima della partenza quanto un'esportazione di capitali finalizzata a saldare i debiti della bilancia commerciale aperti dall'Occidente con l'Oriente nell'acquisto di derrate preziose.
c) Il ruolo dei procuratori di San Marco nell'economia
I procuratori di San Marco - appena un gradino al disotto del doge nella gerarchia delle cariche e degli onori - erano i magistrati che godevano di maggior prestigio a Venezia. Costituivano infatti una potenza economica che agiva da tesoro pubblico; ricevevano depositi valutari per il comune e fungevano da cassaforte di sicurezza per i privati, da tesoro per i doni devoluti alla chiesa di San Marco, da deposito per i benefici ecclesiastici. Dopo la creazione del debito pubblico, avvenuta nel 1262, gli introiti superiori a una certa somma dovevano essere depositati alle procuratie e usati per pagare gli interessi del debito, per ammortizzare gli investimenti o messi a disposizione di altri enti governativi; in tal modo i procuratori furono in grado, nel 1323, di collaborare alla partenza delle galere con un prestito di 10.000 lire.
Le "commendaciones", i depositi di gioielli, d'oro e di moneta effettuati da privati, interessavano soprattutto i principi stranieri che vedevano in Venezia un forziere sicuro, lontano dalle crisi che ne potevano minacciare il potere. Fra costoro figuravano il conte di Pullendorf, il comune di Forlì, Marsilio da Carrara, il cardinale di Ferrara, Obizzo d'Este e Carlo di Bernabò Visconti (133). Gli Estensi piazzavano dei fondi nei buoni del governo veneziano, non solo per mettersi al riparo da eventuali incidenti dinastici ma anche per beneficiare delle facilitazioni sui conti correnti e per le traslazioni verso la camera apostolica (134). Nel 1355, Cangrande II cercò un luogo sicuro ove depositare parte del suo considerevole capitale liquido; Venezia con la sua rete di banche e di istituti finanziari, e in particolar modo con la camera del grano sempre alla ricerca di crediti per pagare le importazioni, offriva appunto tutte le possibilità di una grande piazza bancaria. La camera accettava depositi a lungo termine dai privati che mettessero i loro capitali a disposizione dello Stato, e rimetteva loro degli interessi. Cangrande depositò 77.500 ducati presso la camera del grano e 110.000 presso i procuratori (135). L'operazione fu condotta dai fratelli Maffei, uomini d'affari veronesi stabilitisi a Venezia nel 1348, subito dopo la Peste Nera. Questi cambiavalute ("campsores") di Rialto divennero gli agenti finanziari dello Scaligero nei trasferimenti dei fondi, parte dei quali venne realizzata direttamente dalla banca Maffei alla camera del grano (136).
I procuratori erano anche gli esecutori e i curatori della classe agiata; amministravano le tutele e con i profitti derivanti dagli investimenti dell'attivo sovvenivano ai bisogni delle dette tutele. Le successioni private, a differenza dei depositi di sicurezza, venivano affidate ai procuratori "ad lucrandum", ossia la liquidità in attivo veniva investita. I profitti andavano a coprire sia il carico delle obbligazioni pie e caritatevoli "ad perpetuum", sia gli aiuti a breve termine per la vedova e gli orfani o per costituire le doti. I procuratori disponevano dei contanti secondo le disposizioni testamentarie, ma in assenza di precise direttive potevano investire "in Venetiis" a loro discrezione e a rischio degli eredi (137). Potevano muoversi in cinque direzioni: merci, proprietà immobiliari, buoni di Stato, colleganze o depositi presso l'ufficio del grano o quello del sale (138). Per le tutele a breve termine i procuratori investivano in prestiti commerciali mentre i buoni erano scelti per il lungo termine.
d) I procuratori e la colleganza locale
Nel 1232 gli Statuti del doge Tiepolo autorizzarono i tutori a utilizzare gli averi dei loro pupilli nelle colleganze purché le operazioni fossero condotte all'interno di Venezia e non nel più rischioso commercio marittimo. I procuratori furono dunque invitati a concedere credito agli imprenditori del commercio e dell'industria locali. La colleganza locale, fino al 1380, garantì un ambito d'azione a un volume di fondi in espansione alla ricerca di impiego e una fonte vitale di crediti a imprenditori in cerca di liquidità. Il capitale investito nelle colleganze variava dai 40 ai 500 ducati dati in prestito a un anno; le somme prestate dai procuratori erano più elevate di quelle dei privati: spesso per una successione importante raggiungevano i 400-600 ducati; per quella di Francesco Querini, ad esempio, si arrivò a investire 55.000 ducati in colleganze.
Non essendo il tasso preliminarmente definito (per evitare che il contratto venisse tacciato d'usura - nel senso veneziano del termine), l'unico rischio consisteva nella determinazione dell'interesse alla scadenza. Tale incertezza era risolta in due possibili modi: o facendo dipendere il guadagno dal successo dell'operazione e dalla buona fede di chi aveva richiesto il prestito, nel qual caso il tasso era compreso tra l'8 e il 12% l'anno, oppure equiparando il tasso a quello che un banchiere vicino, un importante droghiere o un mercante in tessuti avrebbero concesso sui depositi loro affidati, al momento della scadenza della colleganza. Fra le imprese cui si faceva riferimento nel calcolo degli interessi su piazza figuravano, negli anni 1365-1375, la banca dei fratelli Jacobello Zancani, la drogheria di Pietro Longo e il commercio di tessuti di Marino Carlo. L'interesse offerto sui depositi da questi affermati imprenditori determinava il corso del mercato e in tal caso le percentuali erano spesso comprese tra il 15 e il 24%.
I procuratori potevano ottenere almeno l'8% e sperare su percentuali che raggiungessero il 12-15; buoni del tesoro acquistati all'80% fino alla guerra di Chioggia fruttavano il 6,25%. Negli ultimi decenni del Trecento, tuttavia, la popolarità della colleganza andò via via scemando; la crisi bancaria successiva al 1375, alla vigilia della guerra contro Genova, depresse il mercato monetario. La caduta del prezzo dei buoni, pur seguita dal calo del tasso di interesse, favorì gli acquisti a buon prezzo da parte di coloro che si accontentavano del 3 o del 4% del rapporto alla pari, equivalente al 12-15% del valore d'acquisto. La speculazione sugli "imprestiti" ebbe come conseguenza il declino delle colleganze presso gli speculatori. Si potevano ottenere crediti dagli Ebrei, i quali erano stati invitati dallo Stato a concederne a un tasso dell'8% su pegno o del 10 senza. Dopo la guerra di Chioggia la colleganza scomparve rapidamente dagli investimenti praticati dai procuratori.
Nell'immediato dopoguerra le successioni di molti defunti mancavano dei capitali liquidi, assorbiti da un governo che dal 1377 al 1381 aveva prelevato il 107% del patrimonio registrato all'estimo, pari - effettuate tutte le correzioni - al 30% della ricchezza reale, in particolar modo della liquidità. Le tutele, anch'esse soggette a imposte, non disponevano più di contanti e nel 1382 il governo impose ai procuratori l'alternativa di rimborsare i titoli di credito al 60% con una bancarotta del 40% oppure di perdere integralmente il credito. I buoni valevano dal 40 al 42%; l'interesse versato per i titoli del debito pubblico, oltre il 5% al tasso reale, aveva finito con il superare quello delle colleganze.
I rendiconti sulle tutele riportano numerosi esempi di investimenti di doti nelle colleganze locali ma, dai primi anni del secolo XIV, anche l'ufficio del grano divenne un deposito per le doti amministrate dai procuratori. Dal 1316, per rispondere alle lamentele dei fornitori non pagati, il maggior consiglio autorizzò l'ufficio a prelevare un prestito sulle doti depositate alle procuratie (139) e, nel 1329, ne favorì il trasferimento all'ufficio del grano ove maturavano interessi annui del 5%: si trattava di un considerevole investimento nel debito fluttuante amministrato dall'ufficio. Ormai il comune si assumeva il rischio di garantire le doti sulle riserve di metalli preziosi e l'operazione si configurò come parte integrante del sistema del credito, offrendo agli investimenti un interesse modico ma regolare e allo Stato un'arma decisiva. Di fatto i testatori ricordiamo per esempio il testamento di Stefano Manolesso nel 1331 - affidavano indifferentemente le doti per le figlie all'ufficio del grano o a quello del sale (140).
I procuratori di San Marco, tesorieri dello Stato e amministratori delle tutele, rendono ancora una volta evidente lo stretto legame instauratosi tra la cosa pubblica e gli interessi privati, sia riguardo all'investimento delle eredità al servizio della comunità degli affari, sia in quanto rimanevano il massimo acquirente di buoni di Stato. La procuratia forniva allo Stato finanziamenti a buon mercato, investiva nel debito fluttuante secondo le sue necessità e offriva agli imprenditori della piccola borghesia locale - delle botteghe e dei laboratori - crediti commerciali a tassi elevati.
e) Prestiti e vita economica
I buoni di Stato (imprestiti) costituivano l'attivo di maggior convenienza per i procuratori. Ogni testatore infatti ne era in possesso e le stesse successioni, proprio come le persone fisiche, erano tenute all'acquisto di imprestiti per saldare le imposte statali.
Per la maggior parte del Trecento gli interessi rimasero stabilmente sul 5%; il tasso reale tuttavia, se calcolato non sul valore nominale ma sul prezzo d'acquisto (= di mercato) superava largamente il 5%. Questa politica di acquisti massicci e concentrati dei procuratori contribuiva alla stabilità del mercato degli imprestiti, un vantaggio dei quali consisteva nella rendita uniforme, sicura e perpetua. In una città priva di territori, a chi non volesse rischiare tutto nelle imprese marittime e commerciali, non rimaneva che acquistare case, botteghe o imprestiti. Il prezzo dell'acquisto di immobili poteva essere saldato con prestiti stimati al loro valore corrente e il loro passaggio di mano in mano invitava a speculazioni la cui manifestazione più evidente consisteva nelle variazioni del loro corso di mercato; prima del 1376 esso aveva oscillato da 60, nel 1311, a 102 nel 1344, l'unico anno in cui superarono la parità. Le autorità - il maggior consiglio, il senato - avevano adottato una energica politica di difesa del corso dei prestiti il cui commercio diveniva più attivo man mano che aumentavano le tassazioni e che, nella città, andavano accumulandosi le ricchezze con la conseguente concentrazione dei titoli in poche mani. I contribuenti più modesti vendevano di frequente i vecchi titoli per comprarne di nuovi, soprattutto nei periodi in cui il loro corso tendeva al ribasso, circostanza favorevole della quale i più abbienti approfittavano per acquistare e accumulare con poca spesa (141).
Nel luglio del 1316 una commissione di cinque savi avviò la revisione dell'estimo dei nuovi cittadini nominati negli ultimi venticinque anni, al fine di imporre loro una partecipazione agli imprestiti proporzionale ai capitali direttamente o indirettamente impiegati nel commercio. Poiché Venezia evitava sistematicamente, in quegli anni, di ricorrere al prestito di Stato, si trattò di una misura protezionistica volta non tanto a aumentarne i rendimenti quanto a limitare le attività commerciali degli immigrati (142). Nel 1324 le autorità vietavano di investire in colleganze per i commerci d'oltremare somme superiori all'estimo che regolava l'imponibile dei prestiti. Assodato che lo sviluppo economico dipende in larga misura dalla capacità degli uomini d'affari di reperire crediti e dall'abilità nell'investire cifre superiori ai loro capitali, occorre vedere in questi provvedimenti tra il fiscale e il commerciale un tentativo mirato a contenere il volume degli affari così da evitare il surriscaldamento dell'economia con il conseguente crollo dei prezzi e da riservarne i benefici ai più abbienti, iscritti all'estimo.
Nuove tecniche commerciali. a) La contabilità a partita doppia
La colleganza vide l'inizio del suo declino, anche nel commercio col Levante, allorché invalse l'uso di delegare agenti commissionari. I mercanti smisero di viaggiare, partendo con le merci e rientrando con la stessa flotta; erano i loro commessi, residenti da molti anni oltremare, che ricevevano le derrate e il denaro in contanti, vendevano e acquistavano secondo gli ordini ricevuti, trattenevano una percentuale e, infine, diventavano soci permanenti (143). A questa nuova forma di società si adattarono i nuovi meccanismi contabili a meno che, all'inverso, non sia stata l'elaborazione di nuove contabilità a determinare le nuove associazioni. Le innovazioni erano probabilmente anteriori al secolo XIV (144): importatori o esportatori che fossero, i Veneziani dovevano conservare l'elenco delle merci caricate e ricevute e delle somme dovute ai o dai loro agenti commerciali. I conti potevano essere "aperti", per i lotti di mercanzia ricevuta, o "addebitati", all'atto di spedizione dei prodotti caricati. A questi ultimi Lane diede il nome di "quaderni di carichi di navi e di valute di mercanzie" ("venture [viazo] accounting and shipment accounts ") (145). A fianco del conto di viaggio esistevano ormai anche i rendiconti dell'agente d'oltremare e i libri contabili contenevano sempre un indice la cui consultazione permetteva un rapido e completo prospetto dell'andamento dei commerci e delle operazioni degli agenti. L'adozione della partita doppia (" double entry bookkeeping") favorì la trasformazione dei metodi commerciali e dello statuto del mercante che da itinerante accompagnatore delle merci divenne sedentario. La perdita della contabilità trecentesca negli archivi veneziani non ci permette di chiarire come il nuovo sistema abbia determinato lo stretto e diretto legame fra due mercanti lontani (146) e il ruolo dalla stessa avuto nell'evoluzione del commercio.
b) L'assicurazione marittima
I patrizi, mercanti-armatori, effettuavano investimenti sia nelle merci che nelle navi che le trasportavano. A causa dei pericoli del mare, la vita di una nave era necessariamente breve; l'ammortamento andava dunque calcolato su una durata di non oltre dieci anni e bisognava prevedere la sostituzione del mezzo perduto o invecchiato. Nel secolo XIV a Venezia esisteva già una forma di assicurazione marittima, benché gli archivi di Firenze conservassero - così si credeva - "la più antica polizza d'assicurazione che ci sia conservata, del 22 ottobre 1395" (147). In realtà ulteriori ricerche - grazie a una testimonianza del 1336 - ne hanno confermato l'esistenza a Venezia: due proprietari di galere, Damian Nadal e Tomà Falier, si assumevano reciprocamente i rischi in una formula ancora sommaria - ma davvero precoce di assicurazione marittima. Alla fine del secolo, a Candia, il genovese Niccolini de Fieschi assicurò la nave del veneziano Antonio de Barba per 200 ducati, contro un premio di 25 ducati (148). Tre processi del 1393 "dimostrano una naturale dimestichezza delle parti e del tribunale nel trattare il negozio d'assicurazione marittima" (149). Il fatto che Venezia si rivolgesse spesso ad assicuratori genovesi o fiorentini vale a sottolinearne la tipica struttura per cui il ceto mercantile privilegiava le piccole società familiari fondate per obiettivi precisi rispetto alle grandi compagnie bancarie e finanziarie orientate alle operazioni sul mercato internazionale; e appunto in questo quadro rientrava l'assicurazione marittima (150). Ma chi era veramente protetto? La nave o le merci? I beni dell'armatore o quelli del mercante? Per quanto riguardava Creta, indubbiamente la nave.
I nuovi istituti bancari. a) Le banche locali
Le banche locali, di cui a più riprese si è analizzato il ruolo svolto nell'economia veneziana - si pensi, ad esempio al trasferimento dei beni di Cangrande -, appartenevano spesso a mercanti internazionali che agivano per proprio conto o come banchieri alla ricerca di investimenti per il denaro depositato (151). I banchieri locali erano dunque importanti operatori economici che agivano "effettuando i pagamenti con un tratto di penna" (Reinhold C. Mueller) da quando la valuta metallica era stata sostituita con una moneta bancaria. Già i cambiavalute, attraverso i crediti e le compensazioni, avevano creato ex nihilo una moneta bancaria che circolava nei libri contabili sotto forma di versamenti solo parzialmente coperti dalle giacenze metalliche custodite nelle casseforti. L'attività della banca veniva dunque a realizzare la creazione di una moneta scritturale e fiduciaria - già in uso del resto nel 1321, quando ai banchieri era stata riconosciuta la possibilità di liquidare i depositi dei clienti a tre giorni dalla presentazione della domanda (152).
A Rialto, dove si incrociava gente di tutto il mondo e dalle valute più disparate, si rendeva necessaria una rete di abili cambiavalute in grado di stimare ogni singola moneta e, in qualità di banchieri, di accettare depositi accreditando in moneta locale il conto corrente dei clienti. Una volta costituita una rete di conti correnti in corrispondenza - cioè un sistema bancario propriamente detto -, essi creavano denaro per il ben noto principio dell'"espansione multipla". La moneta di banca equivaleva a contante: "denarii de banchis sunt denarii contati", avrebbero sentenziato i giudici di petizion, all'inizio del secolo successivo (153).
Nel Trecento si potevano trovare simultaneamente in campo San Giacomo, a Rialto, dalle otto alle dieci banche "de scritta". Nel decennio successivo al 1350, Andrea Malipiero intratteneva rapporti con cinque banchieri - soprattutto con Armelin da Mosto - trattando però prevalentemente con il "cambiator" Alvise Viaro. Daniele Emo, nel febbraio del 1362, aprì un conto corrente presso Piero Zancani; Tommaso Talenti, un amico di Petrarca, naturalizzato veneziano, ne accese uno presso Gabriele Soranzo nel 1380 (154). Non di rado però si trattava di conti non coperti.
La "moneta di banca", cioè i conti correnti, si utilizzava con ordini dati a voce per il pagamento di fatture nel commercio all'ingrosso, al punto che i conti bancari occupavano un posto preminente nelle contabilità commerciali, per il versamento degli affitti, per la negoziazione delle lettere di cambio - a partire da quella più antica, emessa nel 1360 a beneficio di Bartolomeo Michiel e rinvenuta negli archivi veneziani (155) -, per i prestiti autorizzati dal banchiere (sullo scoperto) o fra clienti di uno stesso istituto (ne è un esempio la colleganza di 300 ducati messa a disposizione di chi aveva chiesto il prestito sul banco di Bartolomeo Michiel, cambiavalute di Rialto), per le transazioni sui metalli preziosi, nonché per i pagamenti alla Zecca o all'"officium extraordinariorum" (le dogane) delegato a percepire le tasse e i noli delle galere statali, ecc.
La banca era controllata dalle autorità; la sede, pubblica, era ottenuta in affitto attraverso una procedura d'asta e il banchiere doveva poter presentare sufficienti garanzie ai consoli dei mercanti. Lo Stato, del resto, incoraggiava attivamente il ricorso ai banchieri e alla moneta di banca. Nell'ottobre del 1321, in piena crisi monetaria di argento raro, gli uffici delle imposte ricevettero l'ordine di accettare solo i grossi d'argento, con grave pregiudizio per i commercianti le cui galere ritornavano cariche di merci e che dovevano pagare i noli e i diritti alle dogane. I mercanti furono autorizzati, per poter scaricare e vendere, a ricorrere a garanti disposti a pagare i diritti entro il 28 dicembre. Di fatto, si presentarono come "pleçii" banchieri disposti a riscuotere man mano che le merci venivano vendute e a pagare in contanti il giorno fissato (156). Verso la fine del secolo, il ceto mercantile esercitò pressioni affinché l'ufficio accettasse versamenti in moneta bancaria e, agli inizi del Quattrocento, il senato intervenne perché le dogane ammettessero i "denarios scriptos" così da facilitare le transazioni.
Successivamente alla guerra di Chioggia, per far fronte alle spese, lo Stato chiese dei prestiti alle banche che acconsentirono nella duplice speranza di accreditare i conti correnti dei fornitori senza sborsare denaro liquido e di incassare in contanti dallo Stato. Un tale sistema poggiava su due piani di fiducia: nel banchiere da un lato e dall'altro nello Stato, cui si riconosceva la capacità di pagare il banchiere.
Che non si trattasse di un'attività di tutto riposo, lo dimostra la disavventura di cui Cristoforo Zancani fu vittima, e che lo portò al fallimento della sua banca. Alcune pratiche erano ancora di livello assai rudimentale e il banchiere dimostrò una sorprendente ingenuità. Nell'ottobre del 1390 il mercante viennese Hans Roch era andato a prendere un testimone a San Giacomo di Luprio; i due, diretti a San Marco incontrarono, nelle vicinanze del fondaco, Nicolò di Bartolomeo e lo invitarono a unirsi a loro poiché il tedesco, che non conosceva una sola parola di latino, voleva esaminare i conti che Cristoforo Zancani aveva con Hans Roch. Il banchiere, che si trovava in piazza San Marco, dovette però andare a casa a prendere il suo quaderno, e ne ritornò con un foglio di carta ("folium bombicinum"). I quattro si recarono assieme al banco che si trovava presso il campanile; i testimoni esaminarono il documento trovandovi diverse anomalie e in una polizza scoprirono che Zancani doveva a Hans Roch parecchio denaro: 64 lire per un vecchio conto, 8 lire e 2 soldi per uno più recente, senza contare le 100 lire di grossi che Cristoforo affermava di aver versato direttamente a un rappresentante di Hans. In realtà Zancani era fallito e con lui molti mercanti tedeschi avevano perso considerevoli somme (157). Zancani dichiarò che la perdita era dovuta a una sfortunata operazione condotta sulle monete "viennesi" portate da Hans Roch. Dalla testimonianza di un tedesco in servizio al fondaco sappiamo che qualche giorno prima Hans aveva ingaggiato un barcaiolo di San Geremia a Cannaregio per il trasporto dei "viennesi" al fondaco. Il denaro era talmente pesante che un uomo non sarebbe riuscito a trasportare da solo le due grosse bisacce; si provvide allora a dividerle e il facchino fece un paio di viaggi fino alla barca. Per una settimana Roch custodì la somma nella sua stanza, poi, in presenza del testimone, la trasferì in due grossi sacchi e i due si recarono insieme alla banca di Zancani che - riponendo il denaro sotto il banco - chiese quanto potesse pesare. Roch rispose laconicamente che "secondo lui pesavano molto" (158).
b) L'appello a nuove forze. La promozione interna
Durante la guerra di Chioggia, nei quattro anni dal 1378 al 1381, le imposte avevano raggiunto il 107% del patrimonio imponibile dei Veneziani iscritti all'estimo, cifra che, in realtà, a causa dell'inestricabile sistema di valutazione dei patrimoni imponibili, corrisponderebbe al 30% della ricchezza effettiva. Il prelievo raggiunse i 2,5 milioni di ducati. Il pagamento degli interessi del debito pubblico fu sospeso, il prezzo di mercato dei titoli crollò e, a guerra finita, i tassi di interesse furono abbassati. Se prima un moderato prelievo forzato avrebbe costituito un investimento, ora, attuato in modo massiccio, trasformava il sistema in una sorta di imposta diretta sul capitale. Ma il titolo di debito, alienabile, generava un attivo mercato libero che fruttava più allo speculatore che al contribuente. Il prelievo esauriva di fatto le riserve liquide dei contribuenti e l'intera città soffriva di "magna denariorum penuria". Il commercio con il Levante languiva ormai dal 1379-1380 sottraendo guadagni ai privati e allo Stato una fonte di entrate. Per rispondere alla pressione fiscale molti cercarono prestiti, anche a tassi elevati, presso altri privati, e vendettero dapprima i beni mobili e infine anche gli immobili.
Lo Stato prese delle contromisure: innanzitutto i contribuenti più deboli (un terzo degli effettivi) potevano scegliere di versare solamente il 40% del prestito, a fondo perduto, senza mantenere alcun diritto sul titolo e sugli interessi - in questo modo il sistema fiscale veneziano conobbe provvisoriamente l'imposta diretta; successivamente sequestrò e mise in vendita i beni mobili e immobili dei morosi. Era però difficile trovare possibili acquirenti e lo Stato autorizzò a partecipare alle aste anche gli stranieri, a patto che versassero le imposte sulla cifra pagata, conquistandosi così il diritto di commerciare a Venezia e fuori della città allo stesso titolo dei cittadini per un ammontare pari alla somma investita nell'acquisto. Essi avrebbero potuto, inoltre, provvedere al saldo integrale o parziale dell'acquisto con titoli del debito pubblico al corso di mercato. In tal modo, anche se il tesoro non veniva a incassare contanti, il governo offriva una possibilità di investimento ai possessori di titoli, riduceva il debito e dunque gli interessi da versare, e trasmetteva la proprietà a chi fosse stato in grado di pagare le imposte. I cittadini più abbienti, poi, erano stati invitati a contribuire, con la promessa che alla fine della guerra avrebbero avuto una possibilità di accesso alla nobiltà, e di fatto 30 popolani (su 60 candidati) furono ammessi al maggior consiglio. Si trattava di quella categoria di nuovi ricchi che avevano accumulato i titoli di Stato acquistati a buon mercato da contribuenti obbligati a vendere e che, non essendo iscritti all'estimo o comparendovi per somme nettamente inferiori al loro patrimonio - i liquidi sfuggivano facilmente alla valutazione dei periti -, disponevano di capitali. Grazie al contributo di nuove forze e di capitali stranieri, Venezia era così giunta a realizzare la ripresa economica del dopoguerra (159).
c) Il prestito degli Ebrei a Venezia
In seguito alla guerra si era instaurato a Venezia un regime di penuria monetaria: il capitale liquido dei ceti abbienti era stato assorbito dalle imposte e dal prestito forzato mentre le casse della Repubblica si erano prosciugate aggravando la povertà degli artigiani e dei lavoratori. La mancanza di moneta faceva lievitare i tassi di interesse, i ricchi erano alle corde e non ottenevano più crediti con cui saldare i debiti verso lo Stato; i mercanti non riuscivano a riavviare gli affari né i poveri a soddisfare le necessità quotidiane. Lo Stato ricorse allora a una fonte di ricchezza esterna alla situazione economica locale e di facile controllo: dopo la guerra di Chioggia, il comune invitò i prestatori ebrei a trasferirsi in città con le loro famiglie, esperimento che si protrasse per un quindicennio, dal 1382 al 1397 (106).
In Italia, i prestatori ebrei avevano cominciato ad affluire, spesso dalla Germania, dopo la Peste Nera e le persecuzioni antisemite che le avevano fatto seguito. Fra il 1350 e il 1370, nel Veneto, le banche cristiane di prestito erano rapidamente scomparse, portate alla rovina dalle vaste reti di rapporti create dai nuovi sopraggiunti i quali erano in grado di concedere più denaro a tassi inferiori. A Venezia la situazione era diversa poiché il prestito su pegno non era permesso né ai Cristiani né agli Ebrei. I Veneziani infatti valutavano la legittimità delle operazioni locali di credito con la mentalità di uomini d'affari: i prestiti commerciali - colleganze locali - erano, come si è visto, perfettamente legittimi, purché il tasso d'interesse fosse fissato in anticipo: esso rimaneva incerto fino alla scadenza del prestito stesso e soltanto allora vi veniva applicato il tasso corrente di mercato. Il prestito era legittimo anche se l'interesse del tasso rappresentava un rischio. Viceversa, non erano autorizzati quei prestiti che fissavano in anticipo, "cum pacto et convencione", il tasso d'interesse.
Nel 1254 il maggior consiglio aveva votato il divieto per ogni forma di usura ma quando, nel 1355, i tassi di interesse raggiunsero il 25, il 30 e addirittura il 40%, volle riesaminare la sua politica del credito, legalizzando il prestito su pegno al 10% e su obbligazione scritta al 12%. Il progetto non ebbe seguito fino al febbraio del 1382 quando finalmente venne accettato. L'usura era ormai divenuta legale in città anche se i Veneziani tenevano a precisare che era stato fissato un tetto massimo di interesse legale ("prode") "pro evitandis maximis usuris".
Gli Ebrei prestavano a patrizi che per poter trattare i loro affari chiedevano somme notevoli, come quei 300 ducati passati con un semplice trasferimento da conto a conto nella banca di Gabriele Soranzo (161). In altre parole, se gli Ebrei non potevano offrire un servizio diretto di conti correnti, ciò non impediva loro di aprirne per uso personale presso i banchieri di Rialto. Di norma evitavano i prestiti ai poveri ma, nel 1389, all'epoca in cui fallirono le banche di Antonio Contarini e di Cristoforo Zancani, il governo impose per qualche mese l'apertura di banchi di pegno "ad minutum" a molte famiglie ebree, arrivando così, durante la crisi bancaria, a imporre il prestito di 13.000 ducati all'8% in quattro mesi.
Quando i cittadini, quand'anche patrizi, non pagavano i debiti agli Ebrei, il comune interveniva in favore di questi ultimi, dando prova di lealtà e riconoscendone i servigi. Tra l'altro, nel 1390, gli Ebrei avevano concesso denaro anche ai padroni delle galere per le Fiandre, e il collegio ci informa che parte delle somme era stata data su pegno. Com'erano mutati i tempi in soli dieci anni! Dal febbraio del 1397, tuttavia, agli Ebrei non fu più consentito il libero accesso in città, benché con i loro 150-200.000 ducati concessi a tassi ragionevoli e regolamentati avessero contribuito a risanare l'economia e a stroncare una speculazione che esigeva tassi esorbitanti sui prestiti, pur acquistando dei buoni di Stato a buon mercato.
Il potere veneziano, tanto era cavilloso non appena si trattava di imporre il rispetto delle regole monopolistiche mirate a contrastare la concorrenza straniera, altrettanto si mostrava tollerante rispetto alle pratiche religiose. Nel maggio del 1329, un venerdì, quattro mercanti ebrei di Zurigo giunsero in città per vendervi dell'argento, pari a 16 lire di grossi. Quel giorno non riuscirono a trovare ufficiali liberi - per assenteismo sul lavoro? - cui presentare la merce; l'indomani poi, era sabato, "festa solenne durante la quale non possono eseguire lavori o servizi, né direttamente né per interposta persona". Gli ufficiali del fondaco li condannarono ugualmente a versare la quarta parte: 5 soldi per lira, ovvero 4 lire di grossi. Il maggior consiglio, "considerata qualitate hominum et negocii", ridusse però l'ammenda alla metà sebbene gli ufficiali, offesi per l'eccessiva indulgenza, protestassero che "dicti Judei maliciose egerunt nec verum dicunt" (162). La politica del consiglio aveva dimostrato dunque una certa comprensione ed elasticità nei confronti dei mercanti ebrei ben prima della grave crisi demografica sopravvenuta alla fine del secolo. Analogo atteggiamento si mostra in un'altra circostanza, nei confronti di giovani figli di mercanti tedeschi. Il maggior consiglio, sapendo che i rapporti commerciali con la Germania dovevano svilupparsi attraverso relazioni culturali che preparassero l'avvenire, incoraggiò sei famiglie veneziane a fornire alloggio ai figli di mercanti tedeschi, "non aliquo pretio sed amore", a mandarli a scuola per apprendervi la grammatica e l'abaco, le nozioni di calcolo necessarie a tenere la contabilità e i libri (163).
d) Le compagnie fiorentine a Venezia
La nuova politica di integrazione degli stranieri cui veniva consentito un accesso agevolato alla cittadinanza tendeva soprattutto ad attirare i mercanti fiorentini, che nel 1382 vennero esentati dal pagamento della "tratta" sull'importazione delle merci a Venezia. Uno dei più noti fra costoro era un tal Zanobi di Taddeo Gatti, corrispondente a Venezia dell'azienda di Francesco di Marco Datini, il quale aveva spedito da Venezia al suo padrone 7.000 lettere commerciali e contribuito a riorganizzare uno dei maggiori mercati bancari europei (164).
Di fatto, dagli inizi del Trecento, nonostante il sistema protezionistico che riservava ai Veneziani il monopolio degli affari trattati nella città lagunare e nei porti o sulle linee di navigazione dove il comune poteva vantare il primato, non mancavano le compagnie straniere che esercitavano attività mercantili e bancarie. Era il caso, negli anni 1336-1340, della "Piero del Buono", divenuta poi "Ambrogio Guidi e compagni", filiale della "Duccio di Banchello e Banco Bencivenni" operante a Firenze e che possedeva altre due filiali a Mantova e a Bruges. L'attività principale consisteva nel cambio su Firenze, ma la compagnia trattava anche con gli artigiani veneziani nelle vendite di lana, pelli di pecora, cotone, "vallonia", tessuti e barre di ferro, usando come intermediario per i pagamenti la banca "de scritta" di ser Gianni Stornato. Tra i clienti, i Fiorentini potevano vantare Maffio Morosini e un Barbarigo, ser Lorenzo, impegnato, nel dicembre del 1336, nel commercio della lana (165).
Le vie commerciali e i traffici
L'attività principale della Repubblica mercantile consisteva nel traffico marittimo, e la sua situazione territoriale nel Trecento le aveva permesso di costituire una talassocrazia, una potenza marinara: uno Stato che, con i suoi punti d'appoggio sulle coste e sulle isole disseminate lungo le vie verso il Levante dominava il mare. E questo era solo l'essenziale; i mercanti poi, lungi dal rimanere in città nella paziente attesa dei clienti, provvedevano in larga misura alla riesportazione dei prodotti così da non lasciare ad altri il monopolio dei profitti derivanti dalle vendite. Incoraggiavano l'importazione delle derrate europee più ricercate nei mercati orientali e chi ne disponeva era sempre il benvenuto a Rialto.
Per favorire i movimenti veneziani e stranieri lungo le vie di terra - il cui primo segmento era costituito dai fiumi dell'Italia padana - Venezia condusse una politica volta a sgombrare tali tratte dai molteplici ostacoli imposti dai diversi poteri urbani o feudali quando questi, ai crocevia, nei porti e sotto ai ponti delle vie di terra e fluviali che traversavano la loro giurisdizione, imponevano i più svariati pedaggi.
"La nostra città, per grazia di Dio, si è fatta grande e si è moltiplicata ad opera dei mercanti, i nostri hanno soggiornato in varie parti del mondo per terra e per mare, valorizzandole" - proclamava il senato nel 1343. E proseguiva: "ecco in cosa consistono la vita nostra e dei nostri figli; poiché vivere di altro che non sia la mercatura né potremmo né sapremmo" (166). Nel 1323-1325 erano stati avviati i lavori di modernizzazione e di ampliamento dell'Arsenale con la costruzione dell'"Arsenal novo" da dove avrebbero dovuto uscire le galere messe all'asta ogni anno per i viaggi. La riva di San Marco, finalmente lastricata nel 1324 dal ponte della Paglia a San Biagio, era la sede delle attività portuali e le imbarcazioni vi si affollavano per scaricare il sale ai "saleri" di San Biagio e poi, quando questi furono trasferiti alla "Punta della Doana", per sbarcarvi il grano. Le magistrature incaricate della sorveglianza del commercio veneziano e dell'esazione dei diritti di ingresso e uscita si concentrarono progressivamente sulle rive dell'isola di Rialto, presso il ponte e il mercato, lì dove era più agevole il controllo degli arrivi e delle partenze. A Rialto si negoziavano i noli e i contratti a termine, si affittavano all'asta le grandi galere da trasporto; lì erano l'ufficio dei pesi e delle misure e la polizia dei mercati che era stata affidata agli ufficiali sopra Rialto, i servizi di ispezione e di esazione delle tasse chiamate delle "tre tavole", i Lombardi che controllavano i movimenti delle merci in terraferma, i visdomini da mar che presiedevano al commercio marittimo, la ternaria che si occupava soprattutto del traffico dei grassi, dell'olio e talvolta del legno. Gli ufficiali del frumento, che sorvegliavano lo scarico dei sacchi di farina al fondaco delle farine (167), esercitavano gomito a gomito con gli ufficiali del sale mentre, dall'altro lato del canale, ai piedi del ponte, il fondaco dei Tedeschi costituiva il luogo di raduno di tutti i mercanti tedeschi della città.
È qui il caso di sottolineare un fatto essenziale nella storia navale del Mediterraneo. Nel Trecento, a parte due tipi di nave regolarmente presenti in tutto il secolo, la galera da trasporto e la nave (a vela) - sopravvissuta questa solo per aver mutuato dalla cocca tutte le innovazioni introdotte nel Mediterraneo (168) -, tutti i mezzi d'alto mare conobbero un'esistenza effimera. Già negli anni 1320-1330 la tarida era solo un ricordo; la fortuna della cocca non durò più di 75 anni, sparendo addirittura prima del decennio 1420-1430; il panfilo non superò i 40 anni e il "ligno" cedette al "navilio", in attesa che nuovi modelli - destinati a una più lunga esistenza - si moltiplicassero dopo la fine del secolo XIV e per tutto il XV; quasi che, dopo le incertezze del periodo compreso fra il secolo XII e il XIV (169), la costruzione navale, la navigazione e l'arte nautica avessero finalmente trovato delle basi più stabili.
a) La fine della tarida
La principale funzione della tarida era il trasporto; essa imbarcava i mercanti - era ancora l'epoca del commercio itinerante - e due scrivani incaricati di controllare che tutte le merci caricate a bordo fossero stipate nella stiva, mentre i viveri per i marinai (un "bigontio" di vino, uno di acqua e un sacco di pane) rimanevano sul ponte. Il compito principale degli scrivani consisteva comunque nell'evitare carichi eccessivi e perciò dovevano pesare le merci con la bilancia romana ("statera") e misurare l'altezza del bordo libero contrassegnato da un listello di legno: a pieno carico lo scafo delle taride doveva emergere di almeno 3 piedi. Un eventuale sovraccarico veniva annotato e, al ritorno a Venezia, denunciato ai consoli dei mercanti che avrebbero condannato l'imprenditore colpevole a un'ammenda del doppio del nolo per ogni "millier" o "cantar" in eccesso. Era beninteso vietato riprendere le operazioni di carico una volta completate le misure. Le taride non avevano limiti di navigazione; potevano andare oltremare "et ad omnes alias partes", ma i padroni dovevano conformarsi agli accordi presi con i marinai a proposito del rilascio invernale. Al termine fissato gli uomini ricevevano la paga, che tuttavia poteva anche raddoppiare in caso di ritardo (170).
La tarida era una nave a un solo ponte protetto da castelli, la cui unica differenza rispetto alla "nave" consisteva nell'altezza delle murate. Attorno al 1300 ebbe a subire consistenti e pronte modifiche e dal marzo del 1300 al luglio del 1304 furono 7 quelle che tornarono ai cantieri per essere dotate di un ponte supplementare (171). Quale poteva essere la resistenza di uno scafo così trasformato? La tarida perdeva infatti uno dei suoi caratteri peculiari per diventare anch'essa un'imbarcazione di alto bordo. I Veneziani, secondo gli ufficiali del re di Aragona che tenevano i registri del sale a Ibiza, nel cuore del bacino occidentale del Mediterraneo, le rimasero fedeli ancora per una cinquantina d'anni: dal 1336 al 1343, su 26 mezzi che caricarono sale sull'isola, gli ufficiali registrarono 20 taride - cioè i tre quarti del grosso tonnellaggio veneziano destinato alla navigazione di lungo corso -, 2 cocche e un natante non meglio identificato. In quegli anni il termine "tarida" non era più in uso a Venezia, dove era ormai solo un ricordo del passato, anche se sarà ancora utilizzato nel 1337 almeno per un trasporto di sale (172). Doveva essere curioso incrociare nel Mediterraneo occidentale delle taride, quasi tutte battenti la bandiera di San Marco, in un periodo in cui perfino il nome era scomparso dal vocabolario veneziano. Probabilmente il termine designava ormai i mezzi da carico a un solo ponte e con attrezzatura e timone latini, in qualche modo la vecchia nave latina del secolo XIII che, lungo tutto il Trecento, non fu mai completamente sostituita. Del resto le discrepanze terminologiche riguardano ben altro che la tarida, e non poche furono le esitazioni degli addetti alla registrazione degli atti della procedura marittima (173).
Fu probabilmente la cocca a detronizzare la tarida. Oggi se ne conoscono le caratteristiche principali ma molte sono ancora le questioni insolute sulla sua apparizione nel Mediterraneo e sugli adattamenti che le furono apportati. Costruita a varea, con un solo albero di maestra armato di una solida vela quadrata, montata su un pennone manovrato dal bompresso con una drizza, costituiva il bastimento da trasporto e da carico dei mari del Nord già nel secolo XII; ben presto fu completata con quel timone assiale fissato al telaio di poppa che compare, dal 1242, sul sigillo della città anseatica di Elbing. I legni del Mediterraneo davano spesso la sensazione di dover essere rinforzati con contrafforti sovrapposti e fissati alle murate: così non era per la cocca la cui naturale robustezza stupiva i contemporanei. Le linee pure, senza aggiunte e ben profilate favorivano la penetrazione nelle onde aperte da una prua ben dritta. La sezione dei bagli era notevole, come pure lo spessore delle travi della bordatura mentre l'architettura era rinforzata da un forte paramezzale posto sulla chiglia e su cui poggiava la scassa dell'albero. Sul ponte trovavano posto alcune rudimentali costruzioni che anticipavano i casseri, rivelatisi in seguito così utili negli scontri navali (174).
Quando il fiorentino Villani ne descrive l'introduzione nel Mediterraneo, ne attribuisce l'invenzione ai Baschi di Baiona, cosa d'altra parte assolutamente verosimile (175). Anche nelle statistiche doganali più recenti, una nave viene sempre dall'ultimo porto in cui ha fatto scalo, e i Baschi, trovandosi sul confine fra l'Oceano settentrionale e il Mezzogiorno, occupavano una posizione ideale per fare da intermediari. I cantieri mediterranei ripresero molte caratteristiche di questa imbarcazione, ma non la bordatura a varea che non riuscì a imporsi. Nel Mediterraneo allora si chiamò "cocca" o "coca" qualsiasi legno ad alto bordo, con un solo albero a vela quadrata su pennone, la cui superficie poteva essere regolata con vele di coltellaccio e matafioni e - aspetto più decisivo - guidata con un timone di poppa. Se ne potevano anche incontrare con tre timoni, uno di poppa e due laterali, di tipo latino (176). Tutti gli elementi sopra elencati ne accentuavano l'originale e inconfondibile profilo. Il numero dei ponti invece non era affatto determinante: uno, due o tre che fossero, l'unico effetto era quello di aumentarne l'altezza sull'acqua e, per quanto riguardava il commercio, accrescerne sensibilmente le capacità di carico e di trasporto.
Chiedersi chi per primo abbia avuto il merito di far navigare questa bella nave è questione priva di senso. I Genovesi precedettero i Veneziani? Non erano stati a loro volta preceduti dai Catalani o dai Marsigliesi (177)? L'eccellente analista Villani aveva osservato: "In questo medesimo tempo [1304] certi di Baiona in Guascogna con loro navi, le quali chiamano cocche, passarono per lo stretto di Sibilia, e vennero in questo nostro mare corseggiando, e feciono danno assai; e d'allora innanzi i Genovesi e' Veneziani e' Catalani usaro di navicare con le cocche, e lasciarono il navicare delle navi grosse per più sicuro navicare, e che sono di meno spesa; e questo fu in queste nostre marine grande mutazione di navilio". Genovesi, Veneziani e Catalani, tutti adottarono le cocche che offrivano maggior sicurezza con minor spesa. È un errore criticarne la "mediocre capienza", poiché fu proprio questo a determinarne la scelta.
Venezia mise in uso le cocche a partire dai primi anni del Trecento (dal 1315 secondo Lane), ma gli atti del notaio Domenico contengono 20 documenti riguardanti la spartizione della somma versata dal conte di Ampurias, resosi colpevole della cattura e del naufragio nelle acque di Barcellona della "nave vocata cocha Santa Maria Caloritissa", dal nome greco ("la più bella"), comandata da Beleto Vido - circostanza in cui, per la prima volta, si trova citata una cocca nella flotta veneziana. Su di essa 20 mercanti avevano caricato dell'"habere grossum" e del sale. Il primo indennizzo fu versato il 23 marzo del 1312, ma il naufragio doveva risalire a una data di molto anteriore, se si pensa a quanto fosse difficile far condannare un corsaro catalano e ottenere un qualche risarcimento: ben prima comunque dell'ottobre del 1311, data in cui fu stabilita la procura con l'autorizzazione a spartire l'indennizzo fra gli aventi diritto (178). Si dovrà tuttavia attendere la metà del secolo prima che Venezia si converta alla cocca, indotta forse anche dalle catastrofi che si abbatterono sulla città intorno alla metà del secolo: la Peste Nera del 1348 che decimò la popolazione adulta, e la perdita della Dalmazia, vero e proprio serbatoio di marinai e di gente di mare, ceduta nel 1356 al re di Ungheria.
La fortuna della cocca fu di breve durata, ma alcuni degli elementi che ne avevano decretato la superiorità passarono ad altri bastimenti più conformi alla tradizione mediterranea. Principale beneficiario ne fu la "nave" che però, fra la fine del secolo XIII e la metà del XIV, subì cambiamenti tanto importanti da abbandonare molte peculiarità: l'attrezzatura e il timone latini fecero posto alla vela quadrata e al timone assiale. Più a lungo durarono la distribuzione della velatura su diversi alberi e la grande capacità di carico (179).
c) Le galere
Accanto alla galera da combattimento, Venezia sviluppò un tipo di vascello mercantile a scafo allargato, dove trovavano posto 3 uomini per banco disposti in due file di 30, separate da una stretta corsia percorsa dai sorveglianti. La biremi portava 120 rematori e la galera mercantile 180. Quando, nella prima metà del Trecento, si svilupparono i viaggi verso le Fiandre e l'Oriente, ogni anno salpavano da Venezia una trentina di navi, con 5.000 vogatori. L'enorme quantità di energia richiesta dalle galere in navigazione era contrassegno di un mondo forte, non ancora indebolito dalle epidemie. Benché fosse la più numerosa, la categoria dei rematori non aveva diritto a organizzarsi in corporazioni; si trattava per lo più di salariati liberi ma spesso, per completare i ranghi, si doveva ricorrere a prigionieri condannati per insolvenza. All'inizio del Trecento, l'arruolamento forzato per i debitori era divenuto una pena sostitutiva alla prigione al punto che molti, pur di non pagare, preferivano arruolarsi nelle galere. Nel 1312 si era reso necessario limitare tale forma di reclutamento ai debiti insoluti inferiori alle 20 lire; nel 1331 invece gli armatori furono autorizzati a reclutare uomini che in questo modo avrebbero estinto i loro debiti (180).
Il totale degli effettivi era composto di 200 uomini comandati dall'appaltatore della nave, il quale a sua volta doveva sottostare alle norme specificate nel "capitolato d'appalto". Le maestranze - "marangon", "calafato", "remaio" erano formate da tecnici assoldati per la manutenzione e, in caso di avaria, per le riparazioni urgenti. Il "comito" regolava la voga, mentre gli scrivani tenevano i ruolini della ciurma e dei passeggeri e i registri di carico e di scarico. Otto nocchieri si occupavano delle manovre "alla timoneria, alla manovra delle vele e ancore, alla stivatura delle mercanzie", il pilota badava alla rotta mentre i balestrieri assicuravano la difesa (181).
Imbarco e carico
Nel Trecento non si poneva ancora, almeno nei termini stabiliti da Fernand Braudel a partire da una rapida analisi della situazione al secolo XVI, il problema della rivalità fra grossi e piccoli tonnellaggi. Si potrebbe piuttosto parlare di complementarità: gli uni erano più adatti ai lunghi viaggi, gli altri ai tragitti brevi. Anche se i documenti veneziani in nostro possesso non permettono un'analisi seriale o quantitativa prima della fine del Cinquecento, Venezia non faceva eccezione alla regola. Lo studio di un prodotto ad elevato peso specifico come il sale getta qualche luce sulla struttura della navigazione nel Mediterraneo nella seconda metà del Trecento. Grazie alla pregevole ricerca condotta da Ciro Manca attraverso la ricca serie del Real patrimonio agli Archivi della Corona di Aragona, sappiamo che, dal 1346 al 1414, 2.699 navi avevano caricato alle saline sarde di Cagliari (182). La galera non era il mezzo più adatto a trasportare un tipo di merce così pesante; le navi invece non la trascuravano - furono 200, quasi 4 all'anno; la tarida era già passata di moda, il panfilo invece stava facendo il suo ingresso trionfale se ben 234 (il 10,3%) panfili stranieri approdarono al porto sardo. Era questo il periodo di gloria della cocca che toccava un quarto delle presenze effettive nelle saline sarde. I mezzi più numerosi rimanevano però i "legni" e, soprattutto, le barche di piccolo cabotaggio che non si allontanavano dalle acque insulari. I trasporti elencati avevano capienza variabile: la "nau" sopportava un carico 11 volte superiore a quello della barca, mentre la cocca soltanto 5, all'incirca come i legni e i panfili (la cocca in generale poteva caricare con un rapporto di 1,40/ 1 rispetto al legno) (183).
I generi alimentari costituivano il principale settore del trasporto marittimo. Si trattava insieme di un traffico di massa per grano, sale, vino, olio e pesce, e di un commercio di merci ricercate e dagli alti profitti, quali le spezie. I prodotti giunti via mare venivano immagazzinati in diverse maniere: gli alimenti più pesanti, l'uno sull'altro nella stiva, i generi liquidi in botti di legno cerchiate, in urne o in giare; le spezie in sacchi messi talvolta in casse; la frutta secca quasi sempre insaccata. Molti paesi erano legati agli imballi tradizionali - Alessandria alla "sporta", la Spagna alla giara - ma tutti facevano uso delle risorse locali: legno, cotone, canapa, terracotta, foglie, palme, ecc. Per ogni merce era in uso un particolare imballaggio, adattato al tipo di nave: la galera, poco comoda data l'angustia degli spazi, stipava lo zucchero in casse, mentre per la nave si preferivano le voluminose botti. Contrariamente all'opinione diffusa, il contenitore non serviva anche da unità di misura, poiché le misure, già agli inizi del Trecento, erano ormai divenute unità astratte e matematiche senza alcun rapporto con pacchi, balle, involucri, barili e botti, destinati unicamente alla conservazione e alla protezione del contenuto (184).
Non ci sono giunte polizze di carico marittimo che ci permettano di conoscere la quantità e la natura del carico di un vascello che fosse salpato dal porto lagunare verso lontane destinazioni; sappiamo però che, dopo il naufragio della cocca Santa Maria Caloritissa, una ventina di mercanti veneziani, "mercatores et participes ipsius habere", furono risarciti in proporzione alle somme investite nella spedizione. Appartenevano tutti al patriziato, con l'eccezione del cristallaio Marco e di un servo di Marin Falier; gli altri erano dei Civran, Zulian, Venier, Pisano, Trevisan, Bondulmier, Soranzo, Giustinian, Loredan, Zane, ecc.
Secondo quali criteri i mercanti si ripartivano gli spazi nelle stive? I "loca navis" designavano frazioni ideali uniformi della proprietà dell'imbarcazione: dove il termine designava la nave come oggetto di proprietà, di impresa di navigazione e di trasporto, o di armamento. Anche "pars" era un vocabolo di uso corrente - nella lingua ordinaria -, ma sprovvisto di una qualsiasi accezione tecnico-giuridica e riferito piuttosto all'idea di relazione a una totalità. Ogni frazione della "pars" era a sua volta una "pars" e non poteva quindi designare una quota fissa; si dovettero perciò inventare i "loca" e le "sortes" già in uso nella Venezia del secolo XI quando a Costantinopoli era stato concluso un contratto commerciale per 237 lire, di cui 158 "per una quarta parte di una buza, questo quarto comprende cinque sortes della portata di dieci milliaria ciascuna". Perfino le ancore erano divise in "sortes". I "carati" invece erano sempre 24, una costante che presupponeva la variazione dell'entità del carato in funzione delle dimensioni dell'imbarcazione. Quando la nave era armata dai "participes" o "socii", il "locus" (o la "pars", o il carato), non indicava più solamente una parte del legno con le attrezzature ma anche una frazione della società di navigazione e dell'impresa con i relativi crediti e debiti. L'utilità della divisione in quote uguali e fisse facilitava la contabilità e la gestione, come pure la spartizione dei benefici o delle perdite. Ogni associato partecipava secondo la propria quota di carati (l'armatore) e di "loca" (il mercante). Nel 1275 il maggior consiglio deliberava che "nessun mercante su una nave del comune possa avere un `locum' se prima non abbia versato quattro cantari al comune, e non possa avere più di un ῾locum'", intendendosi per "locus" lo "spazio" su cui Si basavano il calcolo e il pagamento dei noli "et specialiter locos III dicte navis et cum caricu illorum locorum". Al servizio di ogni "locus" era probabilmente assegnato un marinaio (185),
Uno studio recente (186) ha richiamato l'attenzione su tre aspetti fondamentali della storia marittima del Mediterraneo nel Medioevo: il rapporto tra la geografia - il mare e le rotte - e la risposta tecnologica alle sue insidie - le navi commerciali o da guerra -, e l'influenza di questi due fattori sulla guerra navale e sulla "corsa". I venti con i loro sbalzi d'umore, le correnti o le bocche che riparano i porti, le stagioni, gli anticicloni e le depressioni che - d'inverno come d'estate - determinano il clima del Mediterraneo, l'alternarsi giornaliero delle brezze di terra e di mare, le osservazioni meteorologiche, le isole che offrono riparo alle imbarcazioni in difficoltà e la pressante necessità di rinnovare le provviste d'acqua dolce per gli equipaggi, tanto più decisiva per le galere da combattimento e per quelle mercantili che consumavano quantità enormi di energia muscolare (per tre settimane di crociera il fabbisogno d'acqua arrivava a 8.000 litri): tutti questi elementi esercitavano un'influenza determinante sulla navigazione. Nello stretto di Gibilterra era più agevole passare dall'Atlantico al Mediterraneo che non il contrario; ed era importante tenere la rotta di Tenedo di fronte all'imbocco dei Dardanelli. Le correnti, che non avevano lo stesso senso dei venti, più regolari, aiutavano a correggerne l'impatto e determinavano le grandi vie di navigazione ("trunk routes"). Il sistema delle masse d'aria che dominano il settore nord rendeva pericolose le coste meridionali del Mediterraneo poste sottovento. Le navi e i marinai musulmani, e gli Orientali in genere, erano sfavoriti rispetto ai loro rivali settentrionali e d'Occidente: ciò significa, per esempio, che un veliero che rientrasse da Alessandria o da Beirut impiegava al ritorno il doppio del tempo che all'andata. La guerra navale, che si serviva delle correnti costiere, ricorreva spesso, per tutti questi motivi, a forze anfibie e di conseguenza il controllo delle rotte passava attraverso il dominio delle terre e delle isole limitrofe. L'impero coloniale di Venezia, con i suoi numerosi punti d'appoggio, era concepito anzitutto al servizio delle sue flotte.
La navigazione nel Mediterraneo orientale - area privilegiata da imbarcazioni, mercanti e marinai veneziani - era sottoposta alle insidie meteorologiche: il bacino orientale, in estate, subisce l'influsso dominante delle basse pressioni indopersiane: le masse d'aria, deviando con moto a spirale verso il centro della depressione e le coste occidentali dell'Arabia e dell'Asia minore, generano venti da nord/nord-ovest che dal mar Egeo spirano verso le coste della Libia, dell'Egitto, della Palestina e della Siria, attraversando il Mediterraneo. Si tratta di venti etesii, i "meltemi", che a Creta soffiano con estrema regolarità - in media fino alle 1.400 ore - da maggio a settembre. Navigare contro i meltemi era quasi impossibile; era giocoforza dunque trovare delle rotte sostitutive per congiungere Alessandria all'Ovest, lungo le coste della Palestina, della Siria, della Cilicia e della Licia, utilizzando le correnti e le brezze litoranee. Ai vantaggi si opponevano però numerosi pericoli: le scogliere, i venti avversi e il mare agitato (187). Non è affatto sorprendente che, in tali condizioni, le cocche di ritorno da Alessandria facessero sosta a Beirut, a Famagosta o a Larnaca.
Nella storia della navigazione veneziana la piccola isola di Tenedo, all'ingresso dei Dardanelli, si rivelò uno scalo di primaria importanza. Il Mediterraneo subisce, soprattutto d'estate, durante la stagione secca, una forte evaporazione per cui il livello delle acque tende a scendere, parzialmente compensato dai grandi fiumi russi e dal Danubio, tributari del mar Nero che, attraverso gli stretti, sfocia nel Mediterraneo stesso. Ai Dardanelli le correnti dal mar Nero sono molto forti - fino a 6-7 nodi - e le imbarcazioni dirette a Costantinopoli o verso lo stesso mar Nero non riuscivano a risalirle se non con l'aiuto dei venti di sud-ovest. Talvolta però bisognava attendere anche due o tre settimane, per cui risultava della massima importanza controllare Tenedo, nelle cui baie le barche potevano aspettare il tempo favorevole. La guerra di Chioggia ebbe inizio proprio nelle acque di quest'isola contesa dai Veneziani e dai Genovesi. La sottile dialettica di vento e corrente, l'uno opposto all'altra, getta luce anche sul sistema della navigazione, sul calendario dei traffici e sulla guerra navale.
Nel Trecento, per "muda" si intendeva sia una flotta che navigava di conserva per ragioni di mutua protezione, sia il periodo legale in cui certe merci venivano caricate, in determinate piazze, sulle imbarcazioni in partenza per Venezia. Perché limitare a periodi prestabiliti le operazioni di carico? I Veneziani avevano suddiviso le merci in categorie: l'" havere subtile" (prodotti leggeri, spezie, seta, tinture, ecc.), caricato sulle galere; l'"havere subtile" e il cotone, imbarcato invece nelle cocche e nelle navi in precise circostanze; infine le merci pesanti come sale, grano, olio, vino e legno, che non rientravano nel calendario della muda. La data delle mude rimaneva invariata di anno in anno, salvo che per i viaggi a lungo termine. Nel 1328 nei porti della Romània come nel 1360 a Cipro, per i carichi ci si attenne rigidamente alle seguenti date:
Secondo Lane, l'esistenza della muda trovava giustificazione in sette fattori: evitare la cattiva stagione, accelerare la rotazione dei legni abbreviandone i tempi per il carico in Oriente, vivacizzare i movimenti finanziari, mantenere attive le fiere di Venezia (188), raggruppare in fiere l'attività dei porti del Levante, controllare il volume delle merci in arrivo nel porto lagunare e, facilitando le previsioni, evitare la saturazione del mercato.
A Venezia, che combinava l'impresa privata con una tradizione di supremazia statale, il potere riteneva necessaria l'adozione di una gestione comunale per le attività che l'iniziativa privata non sarebbe stata in grado di sfruttare in modo soddisfacente (189). I monopoli di Stato e la partecipazione diretta del governo agli affari appartenevano a una antica tradizione e i mercanti che governavano la Repubblica vi acquiescevano volentieri. L'esempio più significativo di questa combinazione di interessi è offerto dalla cessione tramite asta di galere da mercato, proprietà statale affittata ai privati secondo una forma di contratto che risale al 1329 o forse addirittura al 1325. In precedenza, la politica della Repubblica fluttuava tra due estremi: dalla proprietà e dallo sfruttamento comunale alla proprietà e allo sfruttamento privato con una sorveglianza statale assai ridotta.
Facendo riferimento al periodo compreso tra il 1300 e il 1500, Lane distingueva cinque tipi di navigazione: 1) i viaggi liberi di imbarcazioni possedute e gestite a titolo privato, che interessavano quasi esclusivamente il piccolo tonnellaggio disarmato; 2) i viaggi regolamentati di mezzi posseduti e gestiti a titolo privato, soprattutto in Adriatico e nella Romània, per galere di proprietà privata all'inizio del secolo XIV (190); 3) i viaggi con licenza di navi possedute e gestite a titolo privato per il trasporto di merci leggere - stoffe, moneta, lingotti, spezie - autorizzate a caricare nel Levante in periodi determinati o, nel Trecento, per cocche e navi, a rientrare a Venezia con carichi di sale; 4) i viaggi delle galere del comune cedute all'asta per operazioni private; 5) l'operazione diretta del comune con imbarcazioni di sua proprietà - soprattutto, agli inizi del secolo XIV, con galere (191). Sarà bene evitare di parlare di intervento diretto dello Stato per ciò che concerne strettamente la politica fiscale o di pubblica sicurezza; tutti i trasporti autorizzati a levare l'ancora dovevano sottostare all'ispezione degli equipaggi e del carico.
Quattro erano le zone commerciali marittime di particolare interesse: l'Adriatico; il mar Nero, Costantinopoli e gli Stretti, la Romània; l'Egitto e l'Oltremare, comprendente la Palestina, le antiche terre di conquista dei Crociati, Cipro e Lajazzo, il porto del regno della piccola Armenia succeduto a Acri riconquistata dai Mamelucchi nel 1291; infine il Ponente che dalla Sicilia e Tunisi abbracciava tutto il bacino occidentale del Mediterraneo, Aigues-Mortes, le isole Baleari, Valenza fino ai porti dell'Atlantico.
I viaggi "con licenza" erano un'operazione collettiva: al fine di ovviare alle difficoltà insite nell'azione di galere obbligate a viaggiare in flotta, era parso vantaggioso ricorrere alla costituzione di un consorzio per il nolo e le spese, conferendo alla flotta stessa il monopolio per una stagione e un viaggio. Fu questa la soluzione scelta nel 1315 per il viaggio delle Fiandre. In quegli anni le vie attraverso la Lombardia e la Germania non erano sicure e il mare rimaneva l'unica alternativa possibile per accedere ai mercati occidentali. Ai candidati vennero promessi una sovvenzione mensile compresa tra le 12 e le 15 lire di grossi ("libre grossorum") e un prestito di 10.000 lire per poter reclutare gli equipaggi cui bisognava concedere degli anticipi; in cambio avrebbero dovuto caricare ai tassi di nolo fissati dal senato (192). Negli anni 1317-1318 agli operatori privati delle Fiandre fu concessa un'ulteriore sovvenzione sotto forma di uso gratuito delle galere statali: poterono così esportare vino di Creta, sete e spezie e ritornare con tessuti. Quando accostavano nei porti (193), le flotte delle Fiandre dovevano essere assai spettacolari: comandate dal "capitano", erano formate, nel 1322 come pure nel 1327, da "almeno sei galere" - così aveva disposto il senato - con più di 1.200 uomini armati (194).
Il viaggio del mar Nero era invece organizzato direttamente dal comune. Nel marzo del 1321 il maggior consiglio ordinò al senato di eleggere cinque savi - quelli che poi diventeranno i savii agli ordini - con il compito di armare le navi e prendere le disposizioni necessarie affinché, prima della fine di dicembre, i mercanti, chiaramente informati, potessero decidere degli investimenti.
Negli anni Venti, furono almeno 25 i mercantili che da Venezia salparono ogni anno per Cipro e l'Oriente, per il mar Nero e le Fiandre, senza contare i trasporti privati - ne esistevano ancora - in rotta per i porti dell'Adriatico o del Ponente mediterraneo (Barbaria o Sud della Francia).
A Venezia non esisteva separazione tra i capi d'impresa e il gruppo dei cittadini maggiorenti: le medesime persone comandavano le flotte navigando alternativamente a titolo privato o per il comune. Di volta in volta un Dardi Bembo o un Marino Cappello guidavano le galere delle Fiandre, portavano a termine missioni all'estero negoziando trattati commerciali o ricevevano il brevetto di ammiraglio della flotta per il mar Nero. Venezia non faceva mistero del suo interesse per il profitto dei commercianti: "quod nostri mercatores vadant ad lucrandum", raccomandava il senato a un comitato incaricato di esaminare l'allestimento, privato o comunale, delle unità (195). Tuttavia fu necessario cedere ai privati i viaggi organizzati dallo Stato, poiché l'arruolamento degli equipaggi risultava troppo dispendioso: nel 1320, per rinvenire le somme necessarie agli anticipi per le ciurme, si dovette ricorrere a un prestito dalla camera del grano, avvalendosi in seguito - come si è visto - anche della collaborazione dei procuratori di San Marco.
Al 1302 risale la creazione degli "extraordinarii" con l'incarico di incassare i noli delle galere gestite dal comune. L'importanza della loro funzione si accrebbe nel 1320 con la gestione comunale diretta dei viaggi nel mar Nero; erano loro a consegnare la ricevuta ("bulleta") ai padroni che avevano pagato i noli. La supervisione diretta dei viaggi da parte dello Stato finì per creare non pochi problemi: finanziamento dei viaggi, reclutamento degli equipaggi, riscossione dei noli, ecc. Nel 1329 le galere della Romània e del mar Nero passarono dalla gestione comunale allo statuto privato e furono noleggiate all'incanto agli "armatores", pratica che si generalizzò a tutte le galere mercantili. Il sistema divenne così più flessibile e i padroni prestarono la massima attenzione a che tutte le merci caricate avessero quietanzato i noli. L'ampliamento dell'Arsenale permise allora il varo di un numero superiore di galere, per le quali tuttavia fu soppressa la proprietà privata. Nel biennio 1331-1332 i viaggi a Cipro e in Armenia furono organizzati su imbarcazioni comunali affidate a operatori privati, cui lo Stato metteva ormai a disposizione 15 galere l'anno.
In quale percentuale il trasporto veniva ad incidere sul prezzo delle merci? Era meno dispendioso il viaggio per terra o per mare? I generi più costosi sopportavano meglio tale aggravio dei costi? Fino al secolo XIV le merci di lusso erano state le sole a circolare, con l'eccezione dei prodotti di prima necessità come il grano e il sale.
Dall'osservatorio privilegiato della casa commerciale fondata da Francesco Datini, il mercante pratese che disponeva anche di una filiale a Venezia, Federigo Melis credette di poter concludere che, nella seconda metà del Trecento, tutti i beni erano entrati in circolazione grazie ai progressi tecnologici delle navi, alle assicurazioni e ai nuovi itinerari, ma ancor più al fattore economico consistente nella discriminazione dei noli. Fino ad allora - egli ipotizzava - i prezzi dei noli si erano mantenuti tendenzialmente costanti, ma alla fine del secolo presero a oscillare notevolmente in funzione del valore delle merci trasportate. Fu questa una rivoluzione attuata da questo grande mercante, per il quale il trasporto era divenuto un elemento inseparabile dal servizio di scambio, un atto fondamentale sul cui costo si sarebbero ormai dovute stabilire le tariffe dei trasporti. Egli utilizzò i larghi margini di profitto dei beni più pregiati per abbassare i prezzi del trasferimento delle merci meno care, in modo da poterle inserire nel suo catalogo delle vendite. Egli mise a frutto le nuove possibilità di guadagno grazie ai progressi della contabilità che isolava i vari costi accessori per ogni lotto. Il noleggio di considerevoli quote del carico portava il prezzo unitario a livelli inferiori rispetto a quelli consentiti da carichi più frazionati; di conseguenza diveniva possibile il trasporto di beni meno remunerativi. In una nave che, nel 1398, andò dalla Catalogna a Motrone, il 5,8% delle merci di lusso fruttò il 32,5% dei noli cosicché anche la lana e i "boldroni" fruirono di un tasso moderato: i 4/5 del carico coprivano i 3/5 dei noli mentre il riso di Valenza viaggiava a tariffe ancora più convenienti: il 12,6% del carico al 4,9% del nolo (196).
Fu appunto la considerazione dell'elemento monetario quale unico criterio nella valutazione dei noli a sortire come effetto il ritardo con cui fu introdotta questa importante innovazione, la differenziazione dei noli. Negli Statuti marittimi (197) che, nella prima metà del secolo XIII, avevano codificato norme da tempo vigenti (198), erano catalogate le merci che i Veneziani spedivano dai porti orientali: i prodotti voluminosi come le fibre tessili, il cotone, i filati di cotone, la lana, il lino, le pellicce, gli "zambellotti", la lavanda e lo zucchero in casse; le spezie come il pepe, l'incenso, l'indaco, lo zenzero, lo zucchero "in capellis", la mirra, la lacca, la gomma arabica, l'aloe, la noce moscata, il chiodo di garofano (199), la cannella, il cumino, il macis e l'anice.
La scala dei noli comprendeva tre valori con un rapporto di 1-1,5-2, e un quarto valore, il piombo, esente qualora facesse parte della zavorra dell'imbarcazione. Il manoscritto veneziano dei primi del Trecento, noto con il nome di Zibaldone da Canal, elencava le merci calcolate uniformemente in "milliaria" di libbre, unità standard utilizzata nel calcolo dei noli, equivalente ai 2/3 del "milliarium" per i barili di olio, di pesce, di "gropeda" (o "gromma"), 3 bigonci e mezzo di vino o di acqua, 9 "stera" di frumento, di legumi secchi o di granaglie varie e 3/4 di "milliarium" per le noci, le nocciole e le castagne. Il prezzo dei noli era costante, l'unità di calcolo uniforme - il "milliarium" appunto -, ma variabile in funzione del valore e dell'ingombro del prodotto: esistevano tanti valori del "milliarium" per il computo del nolo quante erano le merci (200). Questo sistema di prezzi fissi e pesi variabili trovò di fatto ampia diffusione e restò a lungo vigente. La tavola dei noli notificava agli spedizionieri e ai mercanti quanto versare agli armatori per le merci in partenza dal porto lagunare. In Oriente, "in partibus ultramarinis", tutte le merci dovevano venir pesate a bordo, "in milliario vel kantariis", come precisavano gli Statuti marittimi dei dogi Tiepolo e Zeno (a tale scopo, ogni legno era dotato di una o due statere), prima di essere sistemate, contate e stivate. Le scale di conversione non erano costanti, bensì decrescenti e con ogni evidenza stabilite a vantaggio dei grossi tonnellaggi, superiori ai 750 "milliaria". Lo scopo era probabilmente quello di scoraggiare i piccoli trasporti dai viaggi oltremare, lì dove aveva vigore la legge.
Dall'inizio del Duecento i Veneziani attribuivano ai noli cinque diversi valori: il minore, pari a zero, valeva per i metalli che potevano fungere da zavorra; il valore 1 per i prodotti esportati su navi veneziane; 2, 3 e 4 per i carichi di ritorno dai porti siriani. Alla fine del secolo, si era avuta un'ulteriore differenziazione grazie al "mier", un'unità di computo diversificata per ogni singola merce; la scala dei noli si presentava già allora priva di qualsiasi carattere di omogeneità. I Veneziani avevano dato prova di scaltrezza scegliendo come base dell'unità di calcolo il cotone, un prodotto di scarsa densità. Secondo una legge votata dai pregadi il 28 luglio del 1332, la fibra veniva "avvitata" nelle stive passando attraverso un'apposita macchina lunga 5,5 piedi e con un'apertura di 3 piedi e 3/4. Le balle di 700 libbre così confezionate occupavano, una volta stivate, un volume di 60 piedi cubi (un piede cubo equivarrebbe a 42 decimetri cubi). Un cantaro di cotone occupava 2,5 metri cubi: allineare il nolo dei cantari di altri generi a quello del leggero cotone, equivaleva a fatturare sovrapprezzo gli spazi agli spedizionieri i quali pagavano un volume di 2,5 metri cubi per sistemare al massimo 1.500 libbre di spezie. In tal modo gli armatori moltiplicavano fittiziamente gli spazi occupati (201).
b) Lo Stato e il nolo delle galere
Numerosi esempi potrebbero dar prova della stretta collaborazione esistente, nel commercio marittimo, tra lo Stato e gli armatori. Per le galere da mercato, "il motore del meccanismo è il contratto stabilito fra lo Stato - che fornisce le navi - e gli armatori che, attraverso le aste, si assumono la responsabilità della navigazione e si assicurano i diritti di trasporto" (202). In realtà lo Stato trattava unicamente con i patrizi: avevano diritto di presenziare alle aste solamente i nobili maggiori di trent'anni e in grado di presentare soci garanti e "participes". Il comando spettava all'appaltatore; erano privilegiate le galere, che incassavano anche i noli relativi ai prodotti destinati ad esse ma trasportati in realtà su altre navi. Nella seconda metà del secolo infatti era frequente che, per mancanza di spazio, le galere non potessero caricare tutte le merci in attesa nei porti del Levante; in tal caso venivano inviate una o due cocche di concerto alle galere "ad ratam", per trasportare la "rata" di carico che altrimenti sarebbe rimasta nei depositi levantini se non, addirittura, acquistata dai rivali. Per evitare la concorrenza interna, le cocche salpavano da Alessandria solamente dopo la partenza delle galere stesse (203).
La gestione diretta dei noli spettava allo Stato il quale aveva cura che, nelle spedizioni condotte in comune su vascelli noleggiati dall'Arsenale, non si verificassero discriminazioni di sorta. Tutti si dovevano trovare in situazione di parità così da garantire, durante il viaggio, una solidarietà non compromessa da sordi dissidi commerciali, capaci di determinare il fallimento dell'operazione. Era dunque il comune a distribuire equamente i noli: quelli dell'andata venivano riscossi dagli extraordinari, magistrati che potevano vantare una particolare competenza in materia di navigazione; quelli del ritorno, da un pubblico ufficiale preposto dal senato al comando del convoglio, il capitano, il quale, all'arrivo a Venezia, doveva presentare un resoconto della propria gestione agli extraordinari (204) che a loro volta ripartivano il capitale - il "mons" - fra gli aventi diritto. Durante il viaggio, gli appaltatori non disponevano degli introiti per far fronte alla spesa, ma neppure avevano dovuto versare il prezzo dell'asta. I mercanti, a loro volta, essendo le banche di Rialto solidali nei pagamenti, disponevano di quarantacinque giorni per liquidare i noli. Il capitano, tuttavia, durante il viaggio, poteva affidare ai padroni una parte del loro credito cosicché potessero concludere affari "de loco ad locum".
I pagamenti in forma differita avevano obbligato lo Stato a mettere in piedi un sistema di prestiti e di sovvenzioni equiparabili, in realtà, ad anticipi sul pagamento dei noli. Il senato concedeva ai padroni delle galere da mercato prestiti che potevano raggiungere i 2.000 ducati finanziati dai provveditori; il rimborso era dato in pegno sui noli oppure "a varea", compreso cioè nel conto delle merci e dei mercanti. Ben presto, poiché pareva ingiusto far gravare sulle spalle dei mercanti l'intero costo, se ne addebitò la metà agli armatori e al prezzo dell'"incantum". Infine, prima di saldare i conti con i padroni, gli extraordinari procedevano a numerosi versamenti, al complemento del soldo ("refusure") dell'equipaggio, alle indennità per coloro le cui merci si erano avariate o all'Arsenale se la galera aveva subito danni durante il viaggio. Andavano poi ancora defalcati l'incanto e i prestiti che si erano rivelati, in qualche sorta, un vero e proprio pagamento anticipato. In generale, le galere erano "ad unum denarium", intendendo con ciò che tutti i noli venivano versati in una cassa unica, essendo le merci considerate in comune per tutta la flotta, qualsiasi fosse la loro destinazione: la Romània, il mar Nero, Cipro o, come nel 1347, Alessandria. La ripartizione dei noli, tuttavia, non era esente da problemi poiché, anche se le galere vi entravano a parità, i "participes" venivano retribuiti in proporzione al loro investimento - "catarada" - visto che con il suddetto sistema di pagamento a termine erano loro a finanziare quasi integralmente l'operazione. Gli extraordinari sapevano esattamente quali parti attribuire a ciascuno: nell'incanto delle galere delle Fiandre del 3 marzo 1347 era stato precisato che, se la galera salpava da Venezia con 96 millier di "habere subtile", un carato sarebbe equivalso a 4 millier(2O5). Mandich conferma qui le analisi di Antonio Scialoja tranne che su un punto: lo scopo cui si mirava non sarebbe stato tanto quello di assicurare la stretta eguaglianza fra i partecipanti quanto di garantire allo Stato un viaggio regolare, e soprattutto l'osservanza di tutte le clausole del capitolato d'appalto - il pagamento dell'asta e delle spese supplementari inevitabili in una missione ufficiale (trasporto di ambasciatori) o addirittura il pagamento di multe per l'eventuale infrazione delle disposizioni del contratto (206).
Un'organizzazione così complessa rivela la natura della solidarietà tra Stato, armatori e mercanti, in una sorta di mutua protezione contro i pericoli del mare e ancor più contro la concorrenza, fattore che, ai loro occhi, metteva in maggior pericolo il buon andamento degli affari. Il rimedio più idoneo a farvi fronte sembrava poter essere il monopolio con tutto ciò che ne seguiva, e in realtà più che di mutua assistenza, in assenza di una qualsivoglia concorrenza dall'interno e dall'esterno, di vero e proprio monopolio si trattava.
c) I costi d'uso dei mezzi di trasporto
Quale profitto ricavava la società veneziana da un'imbarcazione in navigazione nel Mediterraneo? Le fonti non ci hanno trasmesso conti dettagliati e di conseguenza, per poter determinare se la navigazione fosse veramente redditizia e a chi andasse il profitto, dobbiamo valutare tutta una serie di fattori (207).
Il primo elemento è il nolo, il prezzo del trasporto pagato dal mercante o dal suo incaricato all'armatore o al proprietario. Numerose erano le spese dell'armatore: la costruzione del mezzo o l'acquisto dello stesso o di una parte di esso se più "parcenevoli" preferivano condividere i rischi e dividersi i carati, così da investire e rischiare minori capitali. E tuttavia il frazionamento della proprietà non disperdeva il capitale armatoriale tra numerose famiglie, ma lo manteneva anzi concentrato in pochissime mani: si preferiva acquistare delle parti in quattro o cinque navi piuttosto che possederne una da soli. Il capitale investito nell'acquisto o nella costruzione poteva anche derivare da prestiti su cui l'armatore doveva versare degli interessi.
I costi d'uso di una nave variavano anche in funzione della retribuzione - di solito modesta - e del vitto dell'equipaggio; se gli uomini venivano retribuiti col sistema delle "portate" - ed era il caso più frequente si aveva un risparmio sui costi salariali diretti (208), ma lo spazio occupato gratuitamente dal materiale dei marinai diminuiva proporzionalmente il volume disponibile per le merci pesanti dei mercanti.
Gravavano sulle spese anche le riparazioni - quando si spezzava la catena dell'ancora o, addirittura, si perdeva l'ancora stessa, quando si rompeva un albero o si stracciava una vela o si doveva calafatare una falla o carenare lo scafo. C'erano poi i costi dell'ancoraggio nei porti, spesso proporzionali al numero degli alberi o alle dimensioni dello scafo. Si trattava di elementi difficili da valutare nel loro complesso in quanto la durata della navigazione dipendeva non solo dai venti e dalle correnti ma anche dalla difficoltà di attraccare in acque poco profonde - particolarmente a Venezia con le sue maree - e, conseguentemente, dalla necessità di alleggerire la nave ancorata in porto con la mobilitazione di un gran numero di barche che facessero la spola dalla nave ai depositi e viceversa (209).
Malgrado le difficoltà di calcolo l'armatore, per determinare il nolo da imporre alle merci, doveva valutare ogni costo, ben sapendo che la velocità di rotazione avrebbe influito sui costi e che quindi sarebbe stato conveniente completare il carico in uno stesso luogo piuttosto che dover fare scalo in porti diversi. Nel calcolo, il sale interveniva in maniera decisiva già alla fine del Duecento, ma a partire dal 1355 i suoi noli subirono un'impennata: se fino al 1345 era stato valutato a un prezzo medio di 3 ducati il moggio, alla ripresa delle importazioni, dopo un'interruzione di dieci anni - grazie anche all'intervento dello Stato - il prezzo era salito a 7-10 ducati. Un tale rialzo interveniva, alla fine del Medioevo, in un momento in cui i prezzi sui mercati erano crollati, aprendo così la via alla crisi dell'economia europea, ma anche in un momento in cui, come si è visto, pur con tassi di interesse del 30-40% prevaleva una politica di rincaro del denaro. Era d'altra parte il periodo in cui si andava affermando la cocca, i cui costi diminuivano in proporzione alla maggiore produttività della manodopera. I drammatici avvenimenti della metà del secolo contribuirono all'abbandono delle pesanti navi latine (210), soppiantate dal nuovo trasporto che, a pari capacità, utilizzava un equipaggio ridotto di tre volte e mezzo. Lo Stato tuttavia accettò, contemporaneamente, di triplicare il prezzo del sale promesso ai mercanti, pur di sovvenzionare la navigazione e il commercio marittimo, dando così modo agli armatori di costruire legni e di usarli nelle tradizionali vie di navigazione, con la garanzia di un carico di ritorno ad alto reddito.
Gli squilibri strutturali del mercato
Il secolare conflitto con Genova era dovuto innanzitutto e quasi esclusivamente alle necessità dell'espansione commerciale, all'esigenza della crescita e dell'intensificazione degli scambi, all'apertura di nuovi sbocchi, al consolidamento del sistema coloniale nella Romània, all'apertura di nuove rotte, alla protezione dei mercati d'Occidente, in Lombardia, in Germania, nella Linguadoca e in Francia. Il mercante veneziano doveva costantemente affrontare due pericoli, la concorrenza straniera e l'irregolarità degli scambi, prendendo di anno in anno le disposizioni più consone alle circostanze. Per superare le resistenze dei vicini, si passava dunque dalla "elargitio terre" alla "strictura", dalla liberalizzazione all'embargo, e si modulavano le aste pubbliche in funzione di parametri come la congiuntura, l'insicurezza del mare, le prospettive commerciali in Occidente e il volume delle merci da caricare in Oriente. Si tentava attivamente di mantenere un equilibrio stabile evitando sia la saturazione che la rarefazione del mercato e adattando l'offerta alle sue reali capacità di assorbimento. Due scogli in particolare erano difficilmente evitabili: l'afflusso delle importazioni, la cui responsabilità incombeva soprattutto sui mercanti veneziani, e il deflusso delle esportazioni, mal controllato dalla Repubblica che si trovava a dipendere dalla situazione dei mercati occidentali. L'equilibrio poteva dunque essere ricercato esclusivamente nelle importazioni, settore in cui i Veneziani erano arbitri di se stessi (211).
Il 5 agosto del 1324 il senato decise di limitare il valore delle merci che ogni veneziano poteva importare o far importare a Venezia a un ammontare pari al suo patrimonio imponibile ("quod faciunt de imprestitis"), provvedimento che difficilmente sarebbe stato preso per mettere in opera "la sospensione quasi totale del commercio marittimo". Il patrimonio imponibile dei più abbienti non era in effetti piccola cosa, tanto più che, per sua natura, concerneva più i beni immobiliari che la ricchezza mobile e gli investimenti; d'altra parte le formule di investimento nelle compagnie commerciali associavano numerose categorie della popolazione al commercio marittimo. Tale misura aveva innanzitutto un carattere di incitamento fiscale: i Veneziani residenti fuori città e che non partecipavano ai prestiti obbligatori potevano navigare e commerciare con le somme di cui disponevano sotto forma di denaro contante e che dichiaravano al rappresentante del comune (bailo, rettore o console). Questi ne comunicava l'ammontare agli "officiales navigantium" in modo che, successivamente, potessero essere loro imposte le tasse. Ma il provvedimento senatoriale aveva anche, e incontestabilmente, un carattere di classe, perché con esso i patrizi e i cittadini più abbienti intendevano riservarsi la maggior parte dei profitti del commercio marittimo, trasformando il sistema finanziario comunale (i prestiti) in un mezzo fiscale restrittivo nei confronti degli scambi; e aveva infine un carattere economico, poiché era destinato a proteggere l'equilibrio del bilancio fra l'afflusso dei prodotti orientali e le potenzialità di assorbimento dei mercati occidentali, che rischiavano ad ogni momento di provocare la caduta dei prezzi dei prodotti di lusso levantini - il fondamento stesso, cioè, della ricchezza veneziana.
Stranamente, la Repubblica abbandonò questa politica dopo pochi mesi e sciolse l'"officium". La circolazione delle notizie - cioè la diffusione degli ordini degli ufficiali nelle piazze del Levante, ove operavano i mercanti veneziani - era infatti così lenta che a malapena si risentirono gli effetti delle misure adottate. Ne erano stati informati solamente quanti stavano salpando da Venezia con la muda di settembre. Le misure restrittive furono rinnovate dal 1331 al 1338, probabilmente perché nelle Fiandre sottoposte all'embargo delle lane inglesi gli affari dei Veneziani incontravano grosse difficoltà. Nel 1336 e nel 1337 subirono un embargo anche le importazioni dalla Romània i cui fondachi si riempirono di scorte.
Si ricorse allo stesso provvedimento - con durata biennale - nel 1361, in occasione della ricostituzione di rilevanti scorte nei depositi veneziani. Il 22 novembre 1363, il senato, considerando che "nulla può maggiormente favorire e migliorare la situazione della nostra città che il favorire generosamente [dare largitatem et causam] l'importazione delle merci e che ciò avvenga a Venezia piuttosto che altrove", ritornò alla "libertà commerciale", nel senso tradizionale che il termine aveva assunto a Venezia, dove i patrizi erano "mercanti privilegiati". Tale "libertà" comportava una notevole limitazione: gli stranieri cui era stata concessa la cittadinanza - con il conseguente diritto di esercitare il commercio - dovevano rispettare la norma che vietava loro di investire negli affari somme superiori al loro estimo (212). La legge sottolineava anche come, tra i due mali, fosse preferibile avere delle eccedenze piuttosto che combatterle e favorire così la concorrenza straniera. Si passava dunque da un estremo all'altro, dalla politica della "largitas", della libertà eletta regola fino alla saturazione del mercato, a quella della "strictura", cioè della contrazione degli affari che favoriva soprattutto la concorrenza straniera con tutte le sue ripercussioni negative. Conveniva a questo punto cercare di estendere i mercati verso ovest.
La politica legislativa dell'ufficio di navigazione getta luce sulla partecipazione al commercio marittimo di una categoria sociale molto lontana dal patriziato, costituita da lavoratori con le più svariate qualifiche: marinai specializzati e non, uomini dell'equipaggio e maestranze. Per lo più costoro non percepivano alcuna retribuzione, ma l'armatore metteva a loro disposizione uno spazio dove sistemare le merci personali ("portate") caricate in porto franco, in attesa di venderle agli scali, dove avrebbero potuto acquistarne altre da rivendere altrove. Quanto riuscivano a guadagnare costituiva il loro salario: nella marina veneziana tutti i marinai erano mercanti, e mercanti attivissimi. Si trattava certamente di gente umile, che si accontentava di poco, ma nessun regolamento impediva loro di accettare in colleganza prodotti altrui, in particolare di stranieri che così potevano beneficiare del porto franco e delle relative facilitazioni o aggirare il divieto loro imposto di commerciare a Venezia e sulle navi della Repubblica. I marinai erano dunque i procuratori del capitale straniero. Il risultato fu evidente: nel dicembre del 1361, quando fu ridiscussa l'opportunità di riattivare l'"officium de navigantibus", Dardi Polani, uno dei savi, propose una serie di emendamenti che tendevano ad autorizzare i marinai all'imbarco di merci per un valore di 20 lire di grossi (200 ducati) "di loro personale proprietà [si aliquis marinarius navigaret de suo]", suggerendo inoltre, per quanti avessero superato i quindici anni e che "non habent soldum navigii", di elevare la somma a 600 se non addirittura, previa autorizzazione del collegio dei savii agli ordini, a 1.000 ducati. L'emendamento, rigettato in prima istanza, venne adottato dieci giorni più tardi (213).
La Tabella 1 evidenzia le curiose inversioni di tendenza: se, nel suo insieme, la muda della Romània-mar Nero aveva goduto delle preferenze dei patrizi che organizzavano le aste (73 galere e il 57,6% delle aste), non pochi erano gli anni in cui non era stato organizzato alcun viaggio a causa delle aste insufficienti - come specifica Thiriet - e frequenti erano le defezioni: 1335, 1337, 1341, cui vanno aggiunti il 1333 e il 1336 per Cipro e Lajazzo e il 1334 per Tana e per la Romània. Dov'è dunque la veneziana inosservanza delle leggi - di cui pure si è scritto -, e l'incapacità di far rispettare i decreti per più di una settimana? Al contrario, abbiamo qui una chiara dimostrazione dell'efficacia della politica restrittiva operata dall'" officium de navigantibus" fino al
1338 (214). Fino al 1340 il traffico con Tana e la Romània era stato il più proficuo 39.000 ducati contro i 17.000 di Cipro e Armenia - ma, a partire dal 1342, con 24.610 ducati fu Cipro a soppiantare il mar Nero, per il cui traffico ne erano stati offerti solamente 14.150. D'altra parte, se nel 1332 erano state vendute all'asta 17 galere, a partire dal 1333 la cifra passò da 10 a 8 e poi a 0, mentre negli anni dal 1338 al 1340 il prezzo medio delle aste diminuì della metà rispetto alle eccellenti annate 1334 e 1336, per risalire infine piuttosto rapidamente tra il 1342 e il 1345. Era come se l'"officium de navigantibus" avesse ottenuto risultati caotici: nel 1334 e nel 1336 non fu in grado di evitare il surriscaldamento del commercio con il Levante, ma entrambi questi anni furono seguiti dall'assenza totale degli incanti. Infine, con l'abbandono delle restrizioni, il commercio veneziano faticò non poco a recuperare l'antico vigore.
b) I Veneziani nel mar Nero
Quali erano il volume e il valore dei commerci dei Veneziani (215)? Negli anni compresi tra il 1320 e il 1340, la Repubblica inviò nel mar Nero, con cadenza annuale, 7 o 8 galere in grado di trasportare 150 tonnellate di merci, per un totale di 1.100 tonnellate, e i carichi potevano essere completati a Costantinopoli o in Morea. Nel 1399, alla ripresa dei viaggi, il senato stimò quale soglia minima di redditività un investimento di 12.000 ducati per galera, cifra del resto assai spesso superata se è vero che nel 1396 le due galere della Romània scaricarono a Venezia 130.000 ducati di spezie. Non di rado il capitale iniziale era assai consistente: nel 1372, sette Veneziani in viaggio da Trebisonda a Tabriz in Persia furono derubati di 17.500 ducati, 2.500 ciascuno; nel 1320, quando salpò la prima muda di galere per Trebisonda, il senato impose una tassa su tutte le merci negoziate sulla piazza dai Veneziani. Secondo il rapporto del bailo, il 12 agosto 1320 le imposte, a un tasso dello 0,5% accresciuto di uno 0,25% per la formazione di un caravanserraglio, avevano reso quasi 5.000 lire "ad grossos", tanto che il volume degli affari conclusi a Trebisonda sfiorò le 650.000 lire. Tra il 1320 e il 1350 il principale porto del mar Nero frequentato dai Veneziani fu Trebisonda, che accolse 168 galere, mentre Tana, l'altro "emporium" di Venezia, solamente 59. Inversamente, dal 1356 al 1399 Trebisonda fu raggiunta soltanto da 58 galere e Tana da 125 (216).
Tana era il terminale di una delle vie che attraversavano l'Asia centrale e la Cina; era il più remoto dei centri commerciali istituiti da Venezia. I suoi mercanti, residenti in forma permanente o temporanea, erano grossi importatori di vini, impenitenti trafficanti di schiavi caucasici, tatari o mongoli, negozianti in perle, oro, caviale, pelli, seta, cera e spezie, che trattavano indifferentemente con Genovesi, Tatari, Russi, Armeni, Greci, Fiorentini, Catalani ed Ebrei. Nel 1332 il khān dell'Orda d'oro, Uzbek, aveva concesso loro un appezzamento di terreno paludoso di 365 metri di perimetro per fondarvi una colonia come ad Acri e a Trebisonda (217).
c) Il ritorno a Alessandria
Prima del 1344 i viaggi verso Alessandria erano stati proibiti dai decreti pontifici favorendo così il successo di Cipro e di Lajazzo dove le navi cristiane o musulmane portavano i prodotti dell'Oriente dopo aver fatto scalo nel continente. La muda di Cipro caricava a Famagosta le merci transitate per i porti controllati dai Musulmani, Alessandria, Acri, Beirut o Tripoli. In seguito a un incidente, nel 1343 i Veneziani, attaccati a Tana, dovettero rifugiarsi con le galere a Costantinopoli, perdendo così una delle principali basi commerciali d'Oriente. Si adoperarono dunque per far revocare i divieti pontifici e inviarono Nicolò Zeno a negoziare con il soldano d'Egitto, prospettandogli condizioni favorevoli alla consegna dell'argento. Il papa autorizzò, per i cinque anni successivi, 6 galere e 4 navi tonde ma, poco informato di affari marittimi nonché dell'astuzia dei Veneziani, non si era preoccupato di precisare il tonnellaggio. Il senato mise dunque in cantiere galere grandi abbastanza da trasportare 450 millier - anziché 300 - e velieri della capienza di 13.000 staia di grano. Tale era l'attesa per la riapertura della rotta commerciale che la vigilia della partenza ogni galera dovette lasciare a terra 50 millier di prodotti e destinarli alla Romània (218). A partire dal 1345, dunque, la ripresa del movimento degli affari con l'Oriente ebbe un'accelerazione. Il ritorno delle galere di Alessandria, nel 1344, con un carico d'oro africano, scatenò un movimento monetario senza precedenti: fra il 1320-1328 e il 1360 il metallo prezioso si svalutò del 35% rispetto all'argento.
Nel 1345 il senato, organizzando apertamente il viaggio di Alessandria, rispondeva ai desideri del ceto mercantile che acquistò 2 galere nel 1345, 3 l'anno successivo, 5 nel 1347 e 10 nel 1349. La progressione era tanto più notevole in quanto, nello stesso periodo, dalle 8 alle 11 galere continuavano a essere caricate per le tradizionali destinazioni, Famagosta e Lajazzo. Tale successo dimostra, di fatto, un'altra costante della politica veneziana, che aveva sempre voluto mantenere due grandi scali in Oriente ove caricare le favolose mercanzie della lontana Asia, come conferma del resto il fatto che Alessandria ritrovasse il suo ruolo, proprio nel momento in cui su Tana e sul mar Nero incombevano minacce da più parti: la guerra civile in quel che restava dell'impero greco, l'animosità dei Genovesi di Pera contro i mercanti veneziani, l'ostilità del khān tataro dell'Orda d'oro Çanibek, l'abbandono della colonia veneziana di Tana. Beninteso, la politica riprendeva in questo frangente la sua influenza ed esercitava un peso non indifferente sull'economia: ad Alessandria i Veneziani ritrovarono le spezie e le sete ma dovettero rinunciare a prodotti del Nord che potevano giungere solo attraverso Tana, come il caviale che veniva spedito in barili verso la città lagunare, il grano delle pianure ucraine, la canapa, le pellicce, gli schiavi presi nelle razzie delle steppe. Per non perdere questo mercato, Venezia riprese la rotta di Trebisonda dal 1344 al 1347 (219), ma ne fu presto dissuasa dall'epidemia di Peste Nera che andava devastando quei territori, una prova di prudenza che non valse a scongiurare - come sappiamo - la terribile catastrofe che si abbatté, nel 1348, sulla Serenissima e su quasi tutta l'Europa.
d) L'irregolarità dei viaggi
Il "film della navigazione medievale", presentato da Alberto Tenenti e Corrado Vivanti a partire dai registri degli incanti del senato, mostra come i viaggi delle galere fossero ben lontani dallo svolgersi con quella regolarità che si sarebbe portati a immaginare. Dal 1337 al 1373, furono solo sette gli anni in cui ebbe luogo il viaggio delle Fiandre; e quando i mari non erano sicuri, durante la guerra con i Genovesi, non fu organizzata nessuna spedizione. Soltanto nel 1347, nel 1357-1358, dal 1374 al 1376 e dopo il 1386 furono raggiunte tutte e quattro le destinazioni tradizionali (220). Ancora nella seconda metà del Trecento succedeva che nessuno si presentasse alle aste; lo Stato si sostituiva allora agli armatori, come nel 1361 quando le 6 galere di Alessandria furono armate dal comune; parimenti successe nel 1341, per la rotta di Cipro (221).
Il sale e la politica economica dello Stato
Malgrado tutte le difficoltà o meglio, proprio per tentare di farvi fronte, lo Stato veneziano applicò pienamente la sua politica di sviluppo commerciale. Fin qui abbiamo potuto accostarne gli elementi sul piano sociale, finanziario, diplomatico, militare, coloniale ed economico, ma vi è un prodotto che riunisce in sé tutti questi aspetti: il sale (222). Per oltre un secolo e mezzo, dal 1280 circa al 1450-1460, Venezia ostacolò sistematicamente la produzione delle saline adriatiche, a Pirano, a Pago, nelle isole della costa dalmata, distruggendo perfino le proprie risorse in modo da privilegiare il commercio marittimo che andava a cercare il sale sempre più lontano, all'estero. La Repubblica incoraggiò le proprie navi e i commercianti a ricercare i sali mediterranei più lontani, non a Trapani o a Cagliari, ma a Ibiza, in prossimità delle coste della Spagna meridionale; non a Corfù, Nauplia o Candia, terre della Romània, ma in Crimea, a Cipro e ad Alessandria; non a Barletta o a Siracusa bensì a Rās el-Makhbez, sulle coste della Tripolitania. Il commercio del sale doveva coprire i viaggi più lunghi consentendo di ammortizzare i costi della navigazione e dell'uso della galera.
Venezia, a propria difesa e per la protezione delle rotte come dei punti d'appoggio sulle coste, aveva bisogno di una flotta consistente, permanente, il cui uso era tuttavia sporadico e circoscritto, limitato al periodo di guerra. Soltanto il commercio poteva assicurare l'uso continuativo di una marina mista, mercantile e militare al contempo; ma ancora, bisognava ammortizzare i costi delle grandi imbarcazioni utilizzandole a fini commerciali e, possibilmente, trarne profitto. La soluzione scelta fu quella di usare su navi e cocche come originale zavorra il sale, un prodotto negoziabile e che, di conseguenza, poteva reggere noli considerevolmente alti.
Era tradizione per gli esportatori pagare il nolo solamente sul carico, laddove il prezzo di trasporto della zavorra era prossimo a zero e non offriva alcuna remunerazione dei servizi dell'armatore il cui naviglio avesse imbarcato un prodotto pesante indispensabile alla sua stabilità e sicurezza in mare. Per il sale, tuttavia, lo Stato acconsentì a versare ai mercanti-armatori prezzi assai elevati, costituiti per la maggior parte dalle sovvenzioni per il trasporto e, in misura minore, dal rimborso del prezzo d'acquisto sui luoghi di produzione. I noli sul sale permettevano agli armatori la contrazione dei costi di trasporto del carico che venivano così suddivisi tra questo e la zavorra. Di conseguenza, essendo i noli imposti sulle merci tanto più gravosi quanto maggiore era il loro valore, il sale faceva da calmiere: su di esso i mercanti-armatori facevano pesare una parte importante del costo di navigazione, ma si trattava di noli pagati dallo Stato il quale cercava di recuperarli vendendo il sale importato.
A Venezia i sali mediterranei viaggiavano esclusivamente sui grandi legni armati, di maggior tonnellaggio. Un'imbarcazione disarmata, sebbene fosse in grado, dal punto di vista strutturale, di raggiungere Alessandria o Barcellona, non era autorizzata a lasciare l'Adriatico e a superare il canale d'Otranto. Il trasporto delle spezie, della seta e dei tessuti di lana era riservato alle galere delle mude e, nel caso non fossero riuscite a caricare l'intera mercanzia per mancanza di spazio, alle navi tonde. L'ordine del sale imponeva perentoriamente alle navi e alle cocche di seguire le stesse rotte e di raggiungere gli stessi porti delle galere. Gli acquirenti delle galere cedute all'asta dallo Stato erano quegli stessi mercanti-armatori che si spartivano la proprietà delle parti delle navi tonde, e non era loro difficile dividersi i noli pareggiando i costi di navigazione fra tutte le merci caricate sulle galere e sulle navi. Il sale poi, benché viaggiasse sulle sole navi tonde armate, sovvenzionava tutti i trasporti marittimi in quanto i prezzi di mercato delle derrate offerte dai mercanti, tenuti bassi grazie al trasporto dello stesso, si facevano altamente competitivi e Venezia affrontava la concorrenza in condizioni assai favorevoli. Il sale serviva dunque egregiamente gli interessi del ceto mercantile.
Il commercio marittimo del sale si sviluppò, alla fine del secolo XIII, come risposta alla crisi delle esportazioni di spezie verso Ponente. Per uscire dalla stasi che paralizzava i depositi di Rialto, lo Stato incoraggiò i mercanti a sondare sistematicamente i mercati occidentali per smaltirvi le spezie del Levante; li autorizzò inoltre, con la promessa di un acquisto a prezzo favorevole, a rientrare con un carico di sale calcolato in proporzione alle spezie esportate all'andata. In un periodo in cui gli affari in Occidente ristagnavano, gli esportatori di spezie si vedevano garantire da un carico di ritorno - il sale - un introito grazie al quale potevano suddividere i noli tra i viaggi di andata e di ritorno, diminuire i costi delle spezie esportate e, in seguito al calo dei prezzi, vuotare i depositi.
Il sale era una fonte di reddito per l'armatore o questi lo viveva come una maledizione che lo costringeva a piegarsi alla volontà sovrana dello Stato? Il nolo rappresentava tra il 150 e il 200% del prezzo del sale a bordo o dal 60 al 66% del prezzo pagato a Venezia. Questo rapporto era valido quando il prezzo del moggio non raggiungeva i 3 ducati, quando cioè i noli del sale erano ancora piuttosto bassi. A partire dal 1355, il valore al moggio raggiunse i 7-8 ducati d'oro e in seguito alla politica fiscale sul sale i prezzi a bordo quadruplicarono in venti anni (223). Il rialzo era dunque imputabile all'aumento dei costi alla produzione e alla "tratta" quanto alla vertiginosa lievitazione del costo del denaro (tassi di interesse). Un prezzo di cessione sui 7-8 ducati d'oro a Venezia comportava un nolo di 3-4 ducati, con un raddoppio rispetto alla prima metà del Trecento.
Per poter vendere occorreva creare un mercato, eliminare la concorrenza esterna e, quando necessario, ridurre la produzione interna di Chioggia o di Pago per far posto ai sali provenienti dalle lontane spiagge mediterranee. Lo Stato aveva istituito un organismo, l'ufficio del sale, con il compito di distribuire il prodotto importato, raccogliere e gestire i proventi della vendita e ripartire il dovuto fra i mercanti-importatori. I consumatori stranieri della Lombardia, acquistando questo prodotto così essenziale e di scarso valore commerciale, finanziavano l'importazione di derrate di alto valore, dai costi artificialmente ribassati, destinate alla rivendita in tutti i grandi mercati europei.
La navigazione lagunare era l'indispensabile complemento delle vie marittime, e ciò a doppio titolo. Da un lato le imbarcazioni di ritorno a Venezia imboccavano i disagevoli canali della Laguna attraverso i porti di San Nicolò o di Malamocco, poiché ben presto ci si era resi conto dei rischi di insabbiamento provocati dal Brenta. Venezia era allora circondata dalla palude, da uno spazio che non è ancora laguna ma acquitrino invaso da falaschi, da "velme", e dai miasmi della malaria che colpiva Costanziaco-Ammiana e addirittura Torcello; in quegli stessi anni la distruzione dei lidi e l'interramento dei porti minacciavano sempre più gravemente la Laguna. D'altro canto, quando ripartivano cariche dei prodotti da riesportare, le barche circolavano ancora sui canali lagunari prima di raggiungere i fiumi e, quando le vie d'acqua si fossero fatte impraticabili, cedere il posto ai carri, ai muli e ai cavalli imbastati che portavano la "soma" delle merci.
Navigare in Laguna era pericoloso, tanto che era possibile naufragare nelle acque di San Michele di Murano. Fu proprio quel che accadde a un mercante: dei pescatori che raccoglievano ostriche recuperarono tre borse di cuoio piene di monete d'argento che dovevano essere appartenute allo sventurato e che furono consegnate al visdomino del fondaco (224). Un mercante appartenente a un gruppo di Brandeburghesi e di Boemi appena giunti a Venezia affogò invece in un fossato vicino a Mestre (225). Alla fine del secolo, per rendere gli accessi meno pericolosi, il senato decise di affidare ai "magistris cavatoribus [...] pro comodo mercatorum Teutonicorum euntium et venentium per viam Latisane, Forojulii [...] Venetias" la sistemazione di due antichi canali abbandonati: il Poveiole e il Dracho (226).
b) Le vie di terra
La strada di Latisana e del Friuli, che attraverso Villach collegava la Carinzia a Venezia, era una delle più frequentate dai mercanti tedeschi; ma si trattava di percorsi che mutavano con gli avvenimenti. I regolamenti commerciali veneziani imponevano ai Tedeschi che partivano da Venezia con olio o altre derrate di seguire la via del Friuli, ma numerosi furono quelli che protestarono poiché temevano i pericoli della guerra che sconvolgeva quella regione. Alla loro richiesta di poter passare per la città e per il territorio di Treviso, il senato acconsentì a condizione che un agente veneziano li accompagnasse per controllare che l'olio non venisse venduto nella Marca (227): l'importazione in Germania doveva avvenire senza porsi in concorrenza con Venezia, nei suoi mercati tradizionali. Durante le ostilità contro il Carrara, signore di Padova e di Treviso, i Tedeschi, nella loro ricerca di itinerari sicuri, esplorarono due percorsi alternativi: nel 1387, due mercanti di Norimberga scelsero la via del Po e di Mantova, l'uno con 5 balle di merci, l'altro con 4 casse di vetro lavorato (228).
A Norimberga era forse giunta notizia della tragica fine dei commercianti di Ratisbona uccisi dai briganti sulle terre di Francesco da Carrara, in quegli anni bui (229): era accaduto che due mercanti di Monaco e di Ratisbona, mentre rientravano per la strada di Treviso e per la valle del Piave, venissero svaligiati da tre cavalieri assoldati dai signori da Camino. La lista delle merci perdute può darci un'idea della condizione di quei mercanti, che non erano specializzati in un prodotto unico, ma trasportavano da Venezia un po' di tutto e in piccole quantità: il mercante di Monaco aveva 125 libbre di "verzino", 12 pezze di tela, 5 di "bochano" e 12 libbre di argento dorato; il suo compagno di sventura denunciò il furto di 75 libbre di seta chiara, ma c'era sicuramente qualcosa di losco in quanto al fondaco erano state registrate solo 43 libbre di seta per le quali erano state pagate 6 lire, 15 soldi e 4 denari di grossi. Il comune tentò comunque di recuperare il possibile e la restituzione dei beni avvenne nelle abitazioni private di un segretario ducale e di uno "spicier", in presenza di un interprete (230): non che le calli fossero più sicure delle grandi vie di comunicazione, specialmente la notte; la città era assolutamente infida, tanto che uno degli impiegati del fondaco, costretto a lavorare fino alla mezzanotte passata, non osava più avventurarsi sul cammino del ritorno - i suoi servigi erano però essenziali per i mercanti tedeschi e dunque il maggior consiglio lo autorizzò a portare con sé un'arma da difesa (231).
È nota l'opera sostenuta dal conte del Tirolo per mantenere in buono stato i sentieri e le mulattiere nei suoi domini: modernizzò le strade, edificò locande e costruì ponti al posto dei traghetti, appaltò gli introiti dei pedaggi per mantenere in buono stato i ponti e le strade, aprì nuove mulattiere per evitare i passi rocciosi dell'Isarco fra Bolzano e Chiusa - grazie ai lavori, portati a termine negli anni 1305-1320, Innsbruck fu collegata direttamente con Bolzano - e migliorò i contatti con Merano effettuando tutta una serie di lavori sullo Jaufenpass. Le merci venivano affidate a proprietari di carri o di animali i quali avevano l'obbligo - o il privilegio - di guidarle attraverso le valli e i passi.
Si trattava di un servizio chiamato "rota", parola di origine ladina, evoluta poi in "Rod"; i guidatori erano i "Rodführer" o "Rodleute" e i depositi "Rodstätten". I carrettieri di ogni distretto, uniti in una corporazione cui uno statuto scritto imponeva di assicurare i trasporti, percepivano un salario versato dal mercante per il quale avevano lavorato. Beneficiari del sistema erano i proprietari fondiari o di tiri di bestie, membri delle comunità montane che godevano di un diritto esclusivo sulle imprese di trasporto, fonte di guadagni non trascurabili visto che l'obbligo al servizio di trasporto cominciava non appena le bestie fossero libere dai lavori agricoli (232). E probabile che Venezia abbia contribuito economicamente alla manutenzione delle vie di terra - anche di quelle situate al di fuori del suo dominio - come dimostra il provvedimento riguardante le vie per Augusta e per Basilea, votato dal senato il 6 aprile del 1364. Al fine di rientrare nelle spese, il comune tassò allo 0,5% le merci da e per le Fiandre, nel momento stesso in cui attraversavano la linea delle Alpi; diritto che veniva percepito dalla "tavola dei Lombardi " (233).
c) Gli itinerari alternativi
Augusta occupava un posto di primaria importanza per gli itinerari delle Fiandre. Nel 1365, nel clima bellico che sollevava gli uni contro gli altri i duchi d'Austria e di Baviera, "al fine di recuperare la via di terra del viaggio delle Fiandre, per la prosperità del traffico e dei mercanti", il senato propose di inviare ambasciate onde ricordare al vescovo di Augusta, al conte e ai signori bavaresi che, se Venezia doveva al commercio la sua ricchezza, avrebbe anche potuto raggiungere le Fiandre. Ciò utilizzando itinerari differenti, in particolar modo quelli della Francia e di Basilea, essendo fra l'altro in ottimi rapporti con le autorità che li controllavano; essi inoltre non dovevano scordare che i Veneziani facevano transitare per Augusta 600 balle di merci nei due sensi. Non appena le strade fossero state riaperte, l'ambasciatore avrebbe dovuto inviare lettere a Bruges e a Venezia (234). Il testo sopra riportato ci mette finalmente in grado di valutare quale fosse il volume di affari fra due dei maggiori centri dell'economia europea nella seconda metà del Trecento. E non si trattava che di una frazione (un terzo? un quarto?) della totalità del commercio via terra con le Fiandre. Il resto seguiva la grande via renana o i passi alpini occidentali attraverso la Lombardia. Quattro giorni più tardi, invece, si decise di soprassedere all'invio di ambasciate in quanto dal notaio Tomà di Bonincontro erano giunte buone notizie riguardo la Baviera e la riapertura della via di Monaco (235). Il duca però, continuava a temporeggiare e Venezia, in dicembre, chiese al notaio di cercare di ottenere assicurazioni, scritte in latino e in tedesco o, se ci si fosse dovuti accontentare del testo tedesco, che ne certificasse la conformità alle richieste veneziane. Non potendo fare affidamento né su Augusta né su Monaco, si tentarono degli abboccamenti con Norimberga. Il senato scoprì che "la via di Germania attraverso Norimberga era, per i mercanti diretti nelle Fiandre, la più facile e agevole": ci è consentito nutrire qualche dubbio sulla sincerità dei senatori, dato che ogni strada sembrava la più sicura quando non fosse possibile ottenere i salvacondotti per le altre vie.
L'itinerario alternativo offriva dunque, pur se non sempre alle condizioni economiche più vantaggiose, una soluzione a qualsiasi difficoltà potesse presentarsi. Anche in Italia i mercanti tedeschi in partenza da Venezia potevano contare su diverse soluzioni. Nel novembre del 1375, a causa della guerra scoppiata due anni prima con i duchi d'Austria Alberto III e Leopoldo III, i mercanti tedeschi e del ducato austriaco, non potendo passare per Serravalle, scelsero in sostituzione Verona e Padova, la strada cioè del Brennero e dell'Adige: "consideravano buone quelle terre [faciunt ipsas terras bonas]". Venezia voleva invece incoraggiarli a transitare attraverso Treviso e Ceneda, prima di raggiungere Serravalle, come nel passato. Si comunicò inoltre ai mercanti di Salisburgo, della bassa Baviera, della Boemia e di Passau, che la via per Latisana era aperta e che non avevano niente da temere se non portavano le loro merci nelle terre ducali (236). Solamente i sudditi del duca d'Austria erano colpiti dalle interdizioni, ma quando si venne a sapere che la concorrenza della bassa Baviera passava per Serravalle, Augusta chiese di poterne parimenti usufruire.
Nell'agosto del 1378 alcuni mercanti tedeschi avevano fatto uscire dal fondaco 110 "fardelli" sigillati, ma il patriarca di Aquileia aveva loro vietato il transito per il Friuli; furono invece autorizzati a rientrare a Venezia per depositare il carico nel fondaco (situazione che si riprodurrà pari pari nel 1385) (237). Nell'aprile del 1379 la via del Friuli era ancora bloccata e alcuni mercanti fermati a Latisana ottennero l'autorizzazione a raggiungere la Germania, con le loro merci, passando per Verona (238). Nell'intento di rompere il blocco che impediva regolari commerci con la Germania, il 2 maggio Venezia cedette Treviso al duca d'Austria e il 20 dello stesso mese comunicò a Leopoldo che i mercanti del Ducato sarebbero stati i benvenuti a Venezia dove sarebbero stati trattati "benigne, amicabiliter et fraterne". I buoni rapporti tuttavia furono rapidamente offuscati da una guerra doganale voluta dal duca il quale, per ritorsione alla "muda" (tassa doganale) imposta dai Veneziani a Mestre, decise a sua volta di imporre, a Castelnuovo presso Feltre, un "datium" che colpiva soprattutto i commercianti di legname i quali dovevano pagare il 50% sulle tavole, sulle assi e sulle "zattere" destinate a Venezia (239).
Malgrado la scomparsa degli archivi economici veneziani e le numerose lacune, quanto sussiste consente tuttavia di intravvedere i mutamenti intervenuti, la nuova prosperità, il confluire degli itinerari attorno ai centri economici sorti nel corso del Trecento. Ne abbiamo già parlato a proposito delle miniere; ma un episodio altrettanto rappresentativo dei mutamenti intervenuti è la creazione di nuovi legami con Ravensburg. Nel 1390 un mercante di quella città, un certo Konrad Segelbach, la moglie e i figli firmarono un riconoscimento di debito di 1.100 "fiorini di buon oro e di giusto peso, chiamati ducati" in favore dei veneziani Nicolò Morosini e Francesco Amadi "racione mercimonium". Promettevano un rimborso in ragione di 100 fiorini annui, moneta d'oro sonante o tela di lino, ripartiti in due rate. Henry Simonsfeld ha rinvenuto il documento in un registro della biblioteca di Costanza e Aloys Schulte (240) ha potuto dimostrare come, nella seconda metà del Trecento, nella regione del lago di Costanza si fossero sviluppate la filatura del lino nelle campagne e la tessitura delle tele, industria controllata dai mercanti cittadini, che a partire dagli anni Ottanta aveva fatto la fortuna di quel modesto borgo sorto nel cuore dei distretti tessili: i mercanti si erano associati nella Grande Compagnia ("Grosse Gesellschaft") che assicurò all'unione dell'industria tessile rurale dell'alta Svevia - incentrata fino ad allora sulla lavorazione del lino, di tradizione locale - il nuovo apporto della tessitura del cotone acquistato a Venezia e trasformato in fustagni. Nel secolo successivo, la Grande Compagnia di Ravensburg aveva esteso la sua rete commerciale a tutta l'Europa occidentale. In ogni modo, poco dopo la firma dell'atto, Segelbach sparì; ne seguì un nutrito scambio di lettere fra Ravensburg e la Serenissima, intenzionata a rendere responsabile del debito il fratello se sette influenti mercanti, probabilmente conosciuti al fondaco, non avessero giurato che i fratelli erano sempre stati indipendenti negli affari(241). Successivamente i Veneziani rinvennero un atto di tre anni prima, dal quale risultava che i due, congiuntamente, avevano chiesto un prestito di 1.800 ducati. La faccenda si complicava; i Segelbach erano grandi trafficanti d'oro e i loro commerci erano una vera e propria testimonianza del fatto che Venezia non trascurava alcun nuovo centro quando si trattava di allargare la rete dei rapporti commerciali.
d) La via della Francia
La politica veneziana era interessata a un'altra via di terra, la "strada Francigena" o "Francesca" che "rappresentava la principale arteria di comunicazione dell'Italia medievale ed era una sorta di assemblaggio di percorsi di antiche vie romane che nel suo corso settentrionale collegava il Veneto orientale con Verona, Brescia, Bergamo, Como, Milano, Novara, Vercelli, Ivrea, Aosta ed i passi alpini, oltre i quali si aprivano, senza soluzione di continuità, i tracciati delle strade centroeuropee" (242). Il primo tratto collegava Venezia a Milano e costituiva la strada della Lombardia, grande via d'accesso al mercato svizzero e, attraverso lo Spluga, a Basilea. Venezia, da parte sua, accordava molta attenzione alla strada e alle signorie da essa attraversate, negoziando con ciascuna accordi miranti a stabilizzare pedaggi e diritti doganali a livelli che non impedissero la circolazione delle merci. La via di terra aveva un ruolo notevole: permanente sembra - nel trasporto delle merci meno voluminose e più preziose, che non si affidavano volentieri ai vortici della navigazione fluviale; accessorio o secondario invece, in sostituzione della navigazione, quando questa cessasse di essere praticabile. D'altra parte, la via della Lombardia e della Francia, ben più a nord del Po, costituiva un itinerario alternativo di primaria utilità, quando nascessero difficoltà tra Venezia e le città attraversate dal fiume, come Ferrara. Sul commercio diretto fra Venezia e la Francia disponiamo di scarse informazioni, forse perché veniva affidato a intermediari milanesi o lombardi. È incontestabile però che la Lombardia occupasse un posto di primo piano negli scambi veneziani.
Era per la via fluviale che le merci pesanti in genere - le granaglie, i materiali edilizie il legno (243) - giungevano a Venezia, e sempre per la stessa via partiva il sale. La storia di queste merci non è ancora stata scritta e le monografie a nostra disposizione si limitano esclusivamente ad alcuni settori del movimento fluviale e alla relativa organizzazione (244), Per rimanere nei meccanismi del traffico, senza voler qui proporre una vera e propria storia delle merci - che risulterebbe fuori luogo in questo lavoro -, ci basterà mostrare con un esempio puntuale quanto i diversi prelievi potessero accrescere i costi di trasporto e i prezzi in generale, facendosi insostenibili per i mercanti e per i trasportatori. La Tab. 2 presenta un "elenco dei diritti che dovevano pagare le merci naviganti sul Po" (245).
Da Serravalle, indipendentemente dalle tasse esatte dagli Este a Ferrara e nelle loro terre, fino a Pavia, un moggio di sale trasportato lungo il fiume pagava, in diritti vari, all'incirca 10 ducati mentre la "soma" di altre mercanzie saliva agli 11 grossi e mezzo e 57 soldi imperiali, senza tener conto di quanto veniva pagato per la nave. È facile capire come, in queste condizioni, Venezia abbia sempre prestato la massima attenzione
alle tasse indirette che gravavano sulle merci in arrivo o in partenza dalla città; si capisce anche perché si adoperasse tanto per far includere nei trattati via via conclusi con i comuni della terraferma clausole ben precise che regolassero tali diritti. Un ultimo sguardo al contenuto del trattato firmato con Brescia, a Milano il 19 aprile del 1339, ci darà un'idea precisa delle merci oggetto del commercio veneziano, le "mercanzie provenienti dai paesi d'oltralpe" e le "mercanzie dirette" verso quelle terre. Gli operatori erano quei mercanti veneziani che viaggiavano in carovane - "sociati et non soli (intelligantur de mercadantiis que conducantur per dictos Venetos de civitate Veneciarum ultra montes, et ab ultra montes per dictos Venetos ad civitatem Veneciarum)" - e che entravano a Brescia o nel suo distretto dalle strade di Mantova, Verona, Cremona e Bergamo.
Il commercio con i paesi d'Oltralpe (si tratta qui solo di quello) riguardava spezie, zucchero, cosmetici, prodotti preziosi, carta, pergamena, tessili semilavorati, tessuti e
pellicce: dunque per lo più prodotti di lusso destinati a una clientela ricca e aristocratica (pellicce, seta, avorio, tessuti) ma non mancavano anche tele più grossolane come le "sarçie".
Conclusioni
Sarebbe stata una vera e propria impresa voler completare il presente studio dei meccanismi regolanti il traffico veneziano nel periodo del primo secolo dello Stato patrizio con la presentazione del complesso degli affari, tante e tanto gravi sono le lacune. Nessuna monografia ha finora tentato di ripercorrere l'evoluzione del traffico di prodotti come le spezie, il grano, i tessuti, né di tracciare un grafico degli incanti delle galere capace di coprire tutto il secolo, grafico che potrebbe fornire validi indizi sulle tendenze del mercato. Sono finora disponibili, infatti, unicamente degli studi di insieme per il sale, per i "prestiti" e per il ruolo ricoperto nel commercio dai procuratori di San Marco. Per il resto, si è dovuto spigolare in saggi non sempre particolarmente interessati alla storia dell'economia. Sarebbe ormai tempo che i ricercatori ricorressero a nuove fonti, conducessero lo spoglio dei fondi - di inestimabile ricchezza - dei notai veneziani, molti dei quali sono stati già pubblicati e quindi di facile accesso; solamente così si potranno realizzare dei veri progressi. Ma ci sono stati anche altri impedimenti: la storia economica di Venezia è stata segnata da due grandi maestri, Gino Luzzatto e Frederic C. Lane, che hanno lasciato due magnifiche opere di sintesi, due libri magistrali che faranno testo ancora per molto tempo. Sarebbe stato imprudente copiarli o anche solamente ispirarsene troppo da vicino. Per parte nostra, crediamo di essere riusciti a evitare il rischio, grazie a una sistematica consultazione dei lavori più recenti, compresi quelli degli storici più giovani.
Interessarsi ai "meccanismi del traffico" nello Stato patrizio, costituiva uno stimolo ad avvicinare problematiche nuove e a privilegiare lo studio delle strutture politiche, sociali, demografiche, finanziarie, monetarie, economiche, marittime e coloniali in cui, nella Venezia del Trecento, si era andato strutturando il commercio. Passo dopo passo, è apparsa chiara l'importanza dello Stato, di un senato di cui si è detto che operava come un "consiglio di amministrazione" di una società di navigazione, ma anche di altri consigli, come il maggior consiglio che via via si spogliò delle proprie prerogative, della quarantia, o degli organi di governo quali il collegio, le magistrature e innumerevoli altri uffici. Si trattava di organi riservati ai membri del patriziato o da essi diretti. E sono ancora le famiglie patrizie a imporsi, non appena si tenti di identificare i proprietari veneziani in terraferma, i mercanti di grano in Sicilia, i mercanti che si associavano in viaggi alla volta di Delhi, gli speculatori della camera del sale, i ricchi coloni che speculavano sulle piantagioni cipriote, i mercanti residenti a Costantinopoli, i "parcenevoli" della più antica cocca veneziana, gli appaltatori delle galere da viaggio, i commercianti che seguivano le innumerevoli vie della Germania e delle Fiandre. Lo Stato da essi retto ne organizzava a sua volta gli affari nel loro massimo interesse, mirando a stroncare qualsiasi concorrenza interna o esterna con generose sovvenzioni concesse apertamente o per vie traverse. La guerra stessa aveva la funzione di garantire la supremazia del commercio veneziano nei mercati e lungo le lontane rotte marittime o sulle vicine vie di terra.
Alla guerra però Venezia si decideva solo quando tutte le altre soluzioni - la diplomazia o l'intimidazione - si fossero rivelate impossibili. Ma l'aspetto più rilevante è la combinazione di tratti arcaici con altri modernissimi. Venezia si muoveva in una società ancora impregnata dello spirito medievale, in un mondo feudale di cui utilizzava risorse come le rendite fondiarie, la produzione che i feudatari ricavavano dalle colonie e perfino i privilegi dei patrizi i quali, soli, avevano il diritto di esercitare il commercio marittimo, di sedere nei consigli del governo e di inquadrare la produzione artigianale della bottega in un sistema corporativo. Tuttavia, gli studi condotti sugli investimenti hanno dimostrato la modernità di questa società, che disponeva di una rete di banche, e mostrava già grande abilità nel giocare tra i tassi di interesse, propensione alla speculazione finanziaria, prontezza nell'impadronirsi dei progressi raggiunti altrove, nell'innovare e adottare nuovi sistemi man mano che le situazioni di crisi lo richiedessero. Si pensi ai massicci acquisti di schiavi, all'autorizzazione data agli Ebrei di concedere prestiti, all'adozione della cocca, alla creazione di nuove vie commerciali e di nuove forme di traffico, dal viaggio delle galere delle Fiandre al ritorno ad Alessandria. Ma i Veneziani dovevano la loro tranquillità alla protezione del monopolio e dello Stato; meccanismi che sempre funzionarono a dovere, anche nel Trecento, quando imperversavano le crisi e le catastrofi, al punto che la città e il suo commercio, rapidamente risollevatisi dopo l'ultima guerra con Genova, poterono aprirsi al nuovo secolo con un risoluto spirito di conquista.
Traduzione di Dario Formentin
1. Alla fine del Quattrocento, nuovi protagonisti si affacciarono sulla scena del commercio internazionale: nazioni che a lungo avevano dovuto ricorrere alla mediazione italiana e che, cresciute economicamente, potevano ormai inviare direttamente i loro prodotti tessili in Oriente, senza intermediari.
2. Successivamente, quando nella seconda metà del Quattrocento e nel Cinquecento i traffici veneziani si scontrarono con difficoltà via via maggiori, la terra divenne un investimento alternativo assai apprezzato.
3. Ciro Manca, Un modello di sviluppo economico delle città marittime italiane dal XIV al XVI secolo, "Nuova Rivista Storica", 60, 1976, pp. 249-268.
4. Fernando Fagiani, Schizzo storico-antropologico di un gruppo dirigente: il patriziato veneziano (secoli XII-XV), "Studi Veneziani", n. ser., 15, 1988, pp. 15-69.
5. Ibid., pp. 21-22.
6. Gino Luzzatto, Vi furono fiere a Venezia?, in Id., Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, p. 207 (pp. 201-209).
7. F. Fagiani, Schizzo storico-antropologico, p. 46.
8. Ibid., pp. 49-50. Le pp. 46 ss. sono fra le migliori dell'autore, che ha rapidamente percorso gli inizi dell'avventura marinara di Venezia.
9. Dennis Romano, Patricians and Popolani. The Social Foundations of the Venetian Renaissance State, Baltimore 1987, p. 29. Si veda anche Franco Brunello, Arti e mestieri a Venezia nel Medioevo e nel Rinascimento, Vicenza 1980; Nella Fano, Ricerche sull'arte della lana a Venezia nel XIII e XIV secolo, "Archivio Veneto", ser. V, 18, 1936, pp. 73-213; Richard Mackenney, Tradesmen and Traders: the World of the Guilds in Venice and Europe, c. 1520 - c. 1650, Totowa (N J.) 1987; Id., Arti e stato a Venezia tra tardo Medio Evo e '600, "Studi Veneziani", n. ser., 5, 1981, pp. 127-143.
10. Telesforo Bini, I Lucchesi a Venezia. Alcuni studi sopra i secoli XIII e XIV, I-II, Lucca 1853-1856.
11. D. Romano, Patricians and Popolani, pp. 67-68.
12. Peter Humphrey-Richard Mackenney, The Venetian Trade Guilds as Patrons of Art in the Renaissance, "The Burlington Magazine", 128, 1986, pp. 317-330.
13. R. Mackenney, Arti e stato, p. 128.
14. Frederic C. Lane, Venice, a Maritime Republic, Baltimore 1973 (trad. it. Storia di Venezia, Torino 1978), p. 156; Michel Mollat-Philippe Braunstein - Jean-Claude Hocquet, Réflexions sur l'expansion vénitienne en Méditerranée, in Venezia e il Levante fino al secolo XV, a cura di Agostino Pertusi, I/2, Firenze 1973, pp. 515-539.
15. Henry Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutsch-venetianischen Handelsbeziehungen, I-II, Stuttgart 1887: I, doc. 158.
16. Reinhold C. Mueller, The Procurators of San Marco in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: A Study of the Office as a Financial and Trust Institution, "Studi Veneziani", 13, 1971, pp. 151-152 (pp. 105-220).
17. Raimondo Morozzo della Rocca, Lettere di mercanti a Pignol Zucchello (1336-1350), Venezia 1957; Egidio Rossini, Venezia: merci e vie di scambio nei secoli XIII-XV, in Mercanti e vita economica nella Repubblica veneta (secoli XIII-XVIII), a cura di Giorgio Borelli, Verona 1985, pp. 197-269. L'autore, a partire dall'esame delle fonti pubblicate dal Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, ha compilato un lessico delle merci importate a Venezia alla fine del Medioevo. Si veda anche Florence Edler, Glossary of Medieval Terms of Business Italian Series (1200-1689), Cambridge (Mass.) 1934.
18. Jean-Claude Hocquet, Le sel et la fortune de Venise, I-II, Lille 1978-1979: II, Voiliers et commerce en Méditerranée 1200-1650, pp. 455-465 (trad. it. Il sale e la fortuna di Venezia, Roma 1990). Si veda anche Id., Guerre et finance dans l'État de la Renaissance: la Chambre du Sel et la dette publique à Venise, in Études sur la fiscalité au Moyen Âge (Actes du 102e Congrès national des Sociétés Savantes, Limoges 1977), "Bulletin Philologique et Historique du Comité des Travaux Historiques", 1979, pp. 118-120 (pp. 109-131).
19. Roberto S. Lopez, Les influences orientales et l'éveil économique de l'Occident, "Cahiers d'Histoire Mondiale", 1, 1954, pp. 594-622; Id., Venezia e le grandi linee dell'espansione commerciale nel secolo XIII, in AA.VV., La civiltà veneziana del secolo di Marco Polo, Firenze 1955, pp. 37-82; Id., .Nuove luci sugli Italiani in Estremo Oriente prima di Colombo, "Studi Colombiani", 3, 1952, pp. 337-398; Id., L'extrême frontière du commerce de l'Europe médiévale, "Le Moyen Âge", 69, 1963, pp. 479-490.
20. Michel Balard - Angeliki E. Laiou - Catherine Otten-Froux, Les Italiens à Byzance, Paris 1987; Angeliki E. Laiou, Un notaire vénitien à Constantinople: Antonio Bresciano et le commerce international en 1350, ibid., pp. 79-151; Nicolas Oikonomides, Hommes d'affaires grecs et latins à Constantinople (XIIIe-XVe siècles), Montréal-Paris 1979; Chryssa A. Maltezou, Il quartiere veneziano di Costantinopoli (Scali marittimi), "Thesaurismata", 15, 1978, pp. 30-61; Donald M. Nicol, Byzantium and Venice. A Study in Diplomatic and Cultural Relations, Cambridge 1988, e in partic. il cap. 15, Byzantium: The Victim of Commerciai Rivalry.
21. A.E. Laiou, Un notaire vénitien, p. 92; Charles Verlinden, La colonie vénitienne de Tana, centre de la traite des esclaves au XIVe et au début du XVe siècle, in AA.VV., Studi in onore di Gino Luzzatto, II, Milano 1950, pp. 593-669.
22. Sul traffico degli schiavi a Venezia, Charles Verlinden, Le recrutement des esclaves à Venise aux XIVe et XVe siècles, "Bulletin de l'Institut Historique Belge de Rome", 39, 1968, pp. 83-202; Id., Venezia e il commercio degli schiavi provenienti dalle coste orientali del Mediterraneo, in Venezia e il Levante fino al secolo XV, a cura di Agostino Pertusi, I/2, Firenze 1973, pp. 911-929.
23. Gino Luzzatto, Sindacati e cartelli nel commercio veneziano dei secoli XIII e XIV, in Id., Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, pp. 195-200.
24. Id., Capitalismo coloniale nel Trecento, ibid., p. 117 (pp. 117-123).
25. Id., Les activités économiques du Patriciat vénitien (Xe-XIVe siècles), ibid., p. 136 (pp. 125-165).
26. H. Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi, doc. 22.
27. Ibid., doc. 23.
28. Ibid., docc. 251 e 101.
29. Ibid., docc. 25 e 27.
30. H. Demarest, De Florentijnse Loge, "Brugs Ommeland", 18, 1978, pp. 193-240; André Vandevalle, Van Genuese Loge tot Saaihalle, in Id. et al., De Genuese Loge van natiehuis tot bankingstelling, Brügge 1983, pp. 15 ss.; Jean R. Marèchal, De betrekkingen tussen karmelieten en Hanzeaten te Brugge van 1347 tot 1423, "Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis ῾société d'émulation' te Brugge", 100, 1963, pp. 206-227; Marc Ryckaert, Geographie eines Weltmarktes: Handel und Stadttopographie im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Brügge, in Brügge-Colloquium des Hansischen Geschichtsvereins, 26-29 mai 1988, Referate und Diskussionen, a cura di Klaus Friedland, Köln-Wien 1990, pp. 3-12.
31. Henry Simonsfeld ha pazientemente riunito e pubblicato la documentazione conservata e di facile accesso, relativa ai rapporti tedesco-veneziani e che costituisce il primo volume (Urkunden) del suo magistrale studio sul fondaco dei Tedeschi (citato alla n. 15) che comprende anche alcuni documenti di origine tedesca. La maggior parte della sua documentazione proviene dai registri delle Grazie, i condoni concessi dal maggior consiglio dopo una condanna. Si pone così il problema delle fonti dello storico: del complesso degli affari trattati dai Veneziani e dai Tedeschi, la documentazione esistente riporta in realtà solamente quelli illegali che, dopo aver determinato una condanna da parte delle differenti giurisdizioni commerciali, si risolvevano con la grazia, a meno che non si trattasse di proteste veneziane contro atti di brigantaggio perpetrati sulle strade tedesche. In definitiva, non sempre disponiamo di un quadro d'insieme e, non essendoci pervenuti i registri dei visdomini del fondaco, si dovrebbero scoprire gli atti di un notaio specializzato in questo genere di transazioni. Lo storico si trova altrimenti nella necessità di ricostruire quell'intensa vita commerciale, disponendo unicamente di pochi documenti, tutti con lo stesso oggetto, di norma un condono.
32. Philippe Braunstein, Remarques sur la population allemande à Venise à la fin du Moyen Âge, in Hans G. Beck - Manoussos Manoussacas - Agostino Pertusi, Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secc. XV-XVI), Firenze 1977, pp. 233-243.
33. H. Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi, doc. 247.
34. Reinhold C. Mueller, Aspetti sociali ed economici della peste a Venezia nel Medioevo, in AA.VV., Venezia e la peste, 1348/1797, Venezia 1979, pp. 71-76; Mario Brunetti, Venezia durante la peste del 1348, "Ateneo Veneto", 32, 1909, pt. 1, pp. 289-311 e nr. 2, pp. 5-42; Stephen Richard Ell, Citizenship and Immigration in Venice, 1305-1500, tesi di Ph.D., Chicago University, 1976. A Venezia la "decima" era un tributo che i Veneziani pagavano una sola volta, al momento del trapasso, come tassa sul patrimonio accumulato in vita. La Peste Nera turbò gravemente il sistema: molte famiglie persero tre generazioni di eredi maschi, di modo che le eredità si sarebbero decurtate di tre decime in brevissimo tempo. Il comune e il vescovo di Castello giunsero all'accordo che il comune avrebbe versato 12.000 ducati per le decime passate e un contributo annuo di 7.000 ducati per le future. Il papa ottenne condizioni più vantaggiose: 28.000 ducati per le decime del 1348 (fino al giorno di san Pietro) e il rispetto degli "antichi diritti" per quelle ulteriori.
35. Barièa Krekić, Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398), in AA.VV., Studi in memoria di Federigo Melis, II, Napoli 1978, pp. 379-394. L'autore rettifica in molti punti gli studi citati alla n. 21.
36. Freddy Thiriet, La Romanie vénitienne au Moyen Âge, Paris 1959, pp. 327-329; Marian Malowist, Capitalismo commerciale e agricoltura, in AA.VV., Storia d'Italia, Annali, I, Dal feudalesimo al capitalismo, Torino 1978, p. 465 (pp. 453-507), riprende le conversioni di Thiriet senza opporre alcuna critica.
37. Jean-Claude Hocquet, A la jonction du commerce maritime et des trafics terrestres, les mesures à Venise: muid, setier et minot, in Henri Dubois-Jean-Claude Hocquet - André Vauchez, Horizons marins, itinéraires spirituels (Ve-XVIIIe siècles), I-II, Paris 1987: II, Marins, navires et affaires, pp. 3-19; Id., Mesure dominante et mesures dominées dans la République de Venise, XVe-XVIe siècles, in Acta Metrologiae Historicae Il, a cura di Harald Witthöft-Cornelius Neutsch, Linz 1989, pp. 84-116; Id., Tonnages ancien et moderne: botte de Venise et tonneau anglais, "Revue Historique", 281, 1989, nr. 2, pp. 349-360; Id., Numbers and Proportions of Weights and Measures in Medieval Europe, with Particular Regards to Venetian Republic, in 26th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo, Michigan, AVISTA sessions, 9-12 May 1991, Kalamazoo (Mich.) 1991. I suddetti studi sono stati ripresi in Id., Anciens systèmes de poids et mesures en Occident, London 1992.
38. Marco Pozza, I Badoer. Una famiglia veneziana dal X al XIII secolo, Abano Terme 1982, ha nuovamente attirato l'attenzione sullo sviluppo precoce degli investimenti fondiari veneziani sulla terraferma.
39. Karol Modzelewski, Le vicende della 'pars dominica' nei beni fondiari del monastero di San Zaccaria di Venezia (secc. X-XV), "Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano", 5-6, 1963-1964, pp. 15-64.
40. Lesley A. Ling, La presenza fondiaria veneziana nel Padovano (secoli XIII-XII), in Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII e XIV). Sulle tracce di G.B. Verci. Atti del convegno Treviso 25-27 sett. 1986, a cura di Gherardo Ortalli - Michael Knapton, Roma 1988, p. 306 (pp. 305-320).
41. Trevor Dean, Venetian Economic Hegemony: the Case of Ferrara, 1220-1500, "Studi Veneziani", n. ser., 12, 1886, p. 89 (pp. 45-98).
42. Hans C. Peyer, Zur Getreidepolitik oberitalienischer Städte im 13. Jahrhundert, Wien 1950, pp. 94, 100.
43. Philippe Braunstein, Guerre, vivres et transports dans le Haut-Frioul en 1381, in Erzeugung, Verkehr und Handel in der Geschichte der Alpenländer. Herbert-Hassinger Festschrift, Innsbruck 1977, p. 89 n. 21.
44. M. Malowist, Capitalismo commerciale, p. 465.
45. Freddy Thiriet, Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie, Regestes, I, Paris 1966, reg. 26.
46. Fernand Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, I-II, Torino 1953: II, p. 613.
47. Antonino Lombardo, Un testamento e altri documenti in volgare siciliano del secolo XIV a Venezia, "Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani", 10, 1969.
48. Pietro Corrao, Mercanti veneziani ed economia siciliana alla fine del XIV secolo, "Medioevo. Saggi e Ricerche", 6, 1981, pp. 132-166.
49. Sarah Arenson, Food for a Maritime Empire: Venice and its Bases in the High Middle Ages, in El comercio y transporte marítano mundial de alimentos, Congreso Internacional Quinquenal de Historia Marítima, a cura di Christian Koninckx, Bruxelles 1990, pp. 1-14.
50. Marino Sanuto, I diarii, a cura di Federico Stefani et al., I-LVIII, Venezia 1879-1903: L, col. 65.
51. Joseph Bianchi, Documenta historiae Forojuliensis saeculi XIII summatim regesta, Wien 1861, p. 477.
52. Gino Luzzatto, Il costo della vita a Venezia nel Trecento, in Id., Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, pp. 285-297.
53. Philippe Braunstein, Pénurie et cherté à Venise pendant la guerre de Chioggia (1378-1380), Graz 1978, p. 20.
54. Id., Guerre, vivres et transports, pp. 85-106.
55. Jean-Claude Hocquet, Monopole et concurrence: Venise et le sel de Cervia du XIIe au XVIe siècle, "Studi Veneziani", 15, 1973, pp. 21-133; Id., La fiscalité du sel au service du pouvoir colonial de Venise en Dalmatie (XVe--XVIe siècles), in Ètat et colonisation au Moyen Age et à la Renaissance, a cura di Michel Balard, Lyon 1989, pp. 277-316.
56. Id., La politica del sale, nel volume II di questa Storia di Venezia, pp. 713-736.
57. Id., Le sel et la fortune de Venise, II, Voiliers et commerce en Méditerranée 1200-1650, pp. 199-211.
58. Wilhelm Von Heyd, Histoire du commerce du Levant au Moyen Âge, I-II, Amsterdam 1959-1967, ristampa dalla traduzione francese pubblicata nel 1923 a Leipzig. Edizione originale, in tedesco, Leipzig 1855-1856. Il fatto che l'opera sia stata riedita più volte è una dimostrazione del fatto che nessun'opera recente è venuta a sostituirla.
59. Il libro di cucina, a cura di Luigi Frati, Livorno 1899, citato da Bruno Laurioux, Spices in the Medieval Diet: a New Approach, "Food and Foodways", 1, 1985, pp. 43-75.
60. James Innes Miller, The Spice Trade of the Roman Empire, 29 BC to AD 641, Oxford 1969, con una carta fuori testo del traffico carovaniero in Asia, Cina, India, Persia e in Arabia da cui si rileva la lunga durata delle vie delle spezie (e della seta), al punto che potrebbe essere utilizzata in uno studio sulle strade medievali che terminavano nei porti del Mediterraneo orientale.
61. Andrée Guerillot Vinet - Lucien Guyot, Les épices, Parigi 1963. Si veda il prezioso catalogo delle spezie e delle piante aromatiche di E. Rossini, Venezia: merci e vie di scambio, pp. 251-256.
62. Eliyahu Ashtor, Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton (N. J.) 1983, p. 63.
63. Michel Balard, Les marchandises, in Id.-Jean-Claude Hocquet-Jacqueline Guiral-Hadziiossif-Henri Bresc, Le transport maritime des denrées alimentaires en Méditerranée, in El comercio y transporte maritimo mundial de alimentos, Congreso Internacional Quinquenal de Historia Maritima, a cura di Christian Koninckx, Bruxelles 1990. Michel Balard sta preparando un atteso studio sul commercio medievale delle spezie.
64. A Schwaz, nel Tirolo, lo sfruttamento del rame argentifero non si sviluppò anteriormente ai primi anni del Quattrocento (Rudolf Palme-Wolfgang Ingenhaeff, Stollen, Schächte, fahle Erze. Zur Geschichte des Schwaze Bergbaus, Schwaz 1990, p. 29); in Sassonia, invece, l'estrazione mineraria era cominciata già nel secolo XII nel distretto di Freiberg (Johann Köhler, Keime des Kapitalismus im Sächsischen Silberbergbau [1168 bis um 1500], Berlin 1955, pp. 23-24).
65. Desanka Kovacevic, Dans la Serbie et la Bosnie médiévales: les mines d'or et d'argent, "Annales E.S.C.", 15, 1960, pp. 248-258, carta e grafico.
66. H. Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi, docc. 15-16.
67. Ibid., doc. 229.
68. Ibid., doc. 216.
69. Ibid., doc. 109.
70. Ibid., doc. 227.
71. Ibid., doc. 68.
72. Ibid., doc. 809.
73. Gerhard Rösch, Venedig und das Reich. Handels- und verkehrspolitische Beziehungen in der deutschen Kaiserzeit, Tübingen 1982 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd. 53) (trad. it. Venezia e l'impero, 962-1250. I rapporti politici, commerciali e di traffico nel periodo imperiale germanico, Roma 1985).
74. T. Dean, Venetian Economie Hegemony, pp. 45-98.
75. Queste sdegnate espressioni erano citate ibid., p. 49
n. 13, tratte da Luigi Bellini, Le saline dell'antico delta
padano, "Atti e Memorie della Deputazione Ferrarese
di Storia Patria", n. ser., 24, 1962.
76. Nicolò Rodolico, I primi trattati veneziani di estradizione e L'arbitrato in trattati di commercio tra Venezia e Padova, in Id., Saggi di storia medievale e moderna, Firenze 1963, pp. 180-219.
77. Per un approccio globale al monopolio veneziano del sale, si può far riferimento a J.-C. Hocquet, Le sel et la fortune de Venise, I, Production et monopole; Id., Monopole et concurrence; Id., Il sale e l'espansione veneziana nel Trevigiano (secoli XIII-XIV), in Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII e XIV). Sulle tracce di G.B. Verci. Atti del convegno Treviso 25-27 sett. 1986, a cura di Gherardo Ortalli - Michael Knapton, Roma 1988, pp. 271-290.
78. Gerhard Rösch, I rapporti tra Venezia e Verona per un canale tra Adige e Po nel 1310 nell'ambito della politica del
traffico veneziano, Venezia 1979 (Quaderni del Centro
Tedesco di Studi Veneziani, 13), pp. 20-26.
79. T. Dean, Venetian Economie Hegemony, p. 89.
80. M. Malowist, Capitalismo commerciale e agricoltura, p. 465.
81. Gino Luzzatto, Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo, Venezia 1961, p. 73.
82. Ibid., p. 122.
83. Karl-Ernst Lupprian, Il Fondaco dei Tedeschi e la sua funzione di controllo del commercio tedesco a Venezia, Venezia 1978 (Quaderni del Centro Tedesco di Studi Veneziani, 6), p. 20; Id., Zur Entstehung des Fondaco dei Tedeschi in Venedig, "Münchener Historische Studien", 15, 1976, pp. 128-134.
84. H. Sinionsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi, doc. 114, 1345-1346.
85. Ibid., doc. 137.
86. Giovanni Orlandini, Officiali alla messetaria, in Id.,Storia delle Magistrature Venete (saggio), Venezia 1898.
87. H. Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi, doc. 19, 10 luglio 1302.
88. Ibid., doc. 37.
89. Ibid., doc. 241.
90. Ibid., doc. 236, 6 maggio 1376.
91. Ibid., doc. 163.
92. Frederic C. Lane, Exportations vénitiennes d'or et d'argent de 1200 à 1450, in Études d'histoire monétaire, XIIe-XIXe siècles, a cura di John Day, Lille 1984, pp. 29-48.
93. H. Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi, doc. 119.
94. Ibid., docc. 68-69.
95. Ibid., doc. 61, 1319.
96. Ibid., doc. 66.
97. Karl Schalk, Rapporti commerciali fra Venezia e Vienna, "Nuovo Archivio Veneto", n. ser., 23, 1912, pp. 52-95, 284-317.
98. Philippe Braunstein, Venezia e la Germania nel Medioevo, in AA.VV., Venezia e la Germania, Milano 1987, pp. 35-49.
99. H. Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi, doc. 30.
100. Ibid., doc. 84.
101. Ibid., docc. 26, 28.
102. Ibid., docc. 171-172.
103. Ibid., doc. 57.
104. Ibid., docc. 249-251.
105. Ibid., docc. 120-125, 127.
106. Ibid., doc. 133.
107. Ibid., docc: 149, 154.
108. Ibid., doc. 135.
109. Ibid., docc. 154-155.
110. John Day, Banca e moneta a Venezia fra Medioevo e Rinascimento, "Studi Storici", 27, 1986, nr. 3, pp. 737-742.
111. Gino Luzzatto, L'oro e l'argento nella politica monetaria veneziana dei secoli XIII-XIV, in Id., Studi di storia ecomomica veneziana, Padova 1954, pp. 259-270. Questo articolo è un vero e proprio modello di chiarezza e di intelligenza.
112. Josef Janacek, L'argent tchèque et la Méditerranée (XIVe et XVe siècles), in AA.VV., Histoire économique du monde méditerranéen, 1450-1650. Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel, I, Toulouse 1973, pp. 245-261; D. Kovacevic, Dans la Serbie et la Bosnie médiévales.
113. Frederic C. Lane, The First Infidelities of the Venetian Lire, in The Medieval City, a cura di Harry A. Miskimin - Abraham L. Udovitch, New Haven-London
1977, pp. 43-63.
114. Roberto Cessi, Problemi monetari veneziani fino a tutto il secolo XIV, Padova 1937.
115. Giorgetta Bonfiglio Dosio, Controllo statale e amministrazione della Zecca di Venezia tra XIII e prima metà del XVI sec., "Nuova Rivista Storica", 69, 1985, pp. 463-476; Ead., Lavoro e lavoratori nella Zecca veneziana attraverso il "Capitolar delle broche", XIV-XVI sec., in AA.VV., Viridarium Floridum, Padova 1984, pp. 255-276.
116. Enrico Besta, Il Senato veneziano (origine, costituzione, attribuzioni e riti), Venezia 1899, pp. 119-120.
117. G. Bonfiglio Dosio, Controllo statale, p. 469.
118. Roberto Cessi, Problemi monetari e bancari veneziani del secolo XIV, "Archivio Veneto-Tridentino", 9, 1926, pp. 217-301; Id., Problemi monetari veneziani.
119. G. Luzzatto, L'oro e l'argento, p. 270.
120. Reinhold C. Mueller, "Chome l'ucciello di passagio": la demande saisonnière des espèces et le marché des changes à Venise au Moyen Âge, in Études d'histoire monétaire, XIIe-XIXe siècles, a cura di John Day, Lille 1984, pp. 195-219.
121. Firenze, Biblioteca Nazionale, cod. Palatino, nr. 601, pt. 3a, cc. 65v-66, fornisce una esauriente descrizione del calendario del mercato dei cambi nella Venezia degli ultimi secoli del Medioevo. R.C. Mueller, "Chome l'ucciello di passagio", pp. 209-213, lo ha ben analizzato per gli anni 1389, 1394, 1399.
122. R.C. Mueller "Chome l'ucciello di passagio", p. 198.
123. Giulio Mandich, La prassi delle assegnazioni e delle lettere di pagamento a Venezia nel 1336-1339 (da un libro di conti), "Studi Veneziani", n. ser., II, 1986, pp. 15-46.
124. Levino Goldschmidt, Storia Universale del diritto commerciale, Torino 1913, p. 255 n. 100.
125. G. Mandich, La prassi delle assegnazioni, p. 16.
126. Ibid., p. 28.
127. Ibid., p. 32.
128. Ibid., p. 33 n. 30. Sarebbe imprudente ed esulerebbe dagli scopi del presente studio il volersi avventurare in una spiegazione riguardo alle monete in vigore a Venezia e in particolare alle monete di conto o immaginarie. Chi fosse interessato potrebbe rifarsi a due studi di grande interesse: Frederic C. Lane, Le vecchie monete di conto veneziane ed il ritorno all'oro, "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", 117, 1958-1959, pp. 49-78; Giulio Mandich, Monete di conto veneziane in un libro di commercio del 1336-1339, "Studi Veneziani", n. ser., 8, 1984, pp. 15-36.
129. Rayniond A. De Roover, L'évolution de la lettre de change, XIVe-XVIIIe siècles, Paris 1953; Id., The Bruges Money Market Around 1400, Bruxelles 1968.
130. G. Luzzatto, Vi furono fiere a Venezia?, pp. 201 ss.
131. Jean-Claude Hocquet, Domenico, prete di San Maurizio, notaio in Venezia (1309-1316), "Archivio Veneto", 130, 1972, pp. 109-114.
132. Gino Luzzatto, La commenda nella vita economica dei secoli XIII e XIV con particolare riguardo a Venezia, in Id., Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, pp. 67-68 (pp. 59-79).
133. R.C. Mueller, The Procurators of San Marco, pp. 123-132.
134. T. Dean, Venetian Economic Hegemony, p. 82.
135. Il doge Giovanni Dolfin aveva promesso a Cangrande di custodirgli il denaro nella massima sicurezza e di mantenerlo sempre disponibile. Alla sua morte, gli eredi reclamarono il tesoro e 250.000 ducati, gli interessi della camera del frumento. La situazione gettò in un grave imbarazzo i principali organi politici e finanziari del comune. Alla fine ci si accordò su un versamento annuo di 1.500 ducati, trasmissibile ai legittimi eredi, in luogo del capitale e degli interessi maturati.
136. Reinhold C. Mueller, Veronesi e capitali veronesi a Venezia in epoca scaligera, in Gli Scaligeri, 1277-1387, a cura di Gian Maria Varanini, Verona 1988, pp. 369-376.
137. Id., The Procurators of San Marco, p. 149 n. 93.
138. Ibid., p. 167 n. 122. Il 30 luglio 1360, Benedetto Emo definiva l'uso che gli eredi avrebbero dovuto fare dei suoi capitali: "Item voio che li sia mexi in emprestedi o dal formento o da la sal o darli ad usar in Rivoalto chon bona plizaria".
139. Ibid., p. 176.
140. Ibid., pp. 174-184.
141. Gino Luzzatto, Il debito pubblico della Repubblica di Venezia dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV, Milano-Varese 1963, pp. 59-71
142. Ibid., p. 75.
143. Frederic C. Lane, Investimento e usura, in Id., I mercanti di Venezia, Torino 1982, pp. 205-217; Gino Luzzatto, Tasso d'interesse e usura a Venezia nei secoli XIII-XV, in AA.VV., Miscellanea in onore di Roberto Cessi, I, Roma 1958, pp. 191-202.
144. L'articolo di Frederic C. Lane, La contabilità di impresa nella conduzione degli affari nel medioevo, in Id., I mercanti di Venezia, Torino 1982, pp. 143-152, si basa sulle contabilità commerciali dei quattro fratelli Soranzo (1406-1436), mercanti di cotone siriano, le più antiche conservate a Venezia, e sui libri di Andrea Barbarigo e Jacomo Badoer; Id., La contabilità a partita doppia e i mercanti residenti, ibid., pp. 153-168.
145. Ibid., e Federico Melis, Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI, Firenze 1972 (Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini), p. 69.
146. F.C. Lane, La contabilità a partita doppia.
147. Livio Piattoli, Ricerche intorno all'assicurazione nel Medioevo, II, Una scritta di sicurtà veneziana del 1395, "Assicurazioni", 5, 1938, pt. 1, pp. 357-364.
148. Giuseppe Stefani, L'assicurazione a Venezia dalle origini alla fine della Serenissima, Trieste 1956, nn. 2-4 e pp. 67-72.
149. Karin Nehlsen-Von Stryk, L'assicurazione marittima a Venezia nel XV secolo, Roma 1988, p. 33.
150. Jean-Claude Hocquet, Les routes maritimes du commerce vénitien aux XVe et XVIe siècles, in Atti del V convegno internazionale di studi colombiani, Navi e navigazione nei secc. XV e XVI, Genova 1990, pp. 581-605, ha consultato un registro genovese di assicurazioni, il Libro de sicurtà, ff. 147 (De Ferrari 234), conservato nell'Archivio storico del comune di Genova e studiato da Branislava Tenenti, I tassi assicurativi sulla piazza di Venezia: secc. XVI-XVII, "Studi Veneziani", n. ser., 10, 1985, p. 21 (pp. 15-55), secondo la quale gli assicuratori genovesi Maruffo e Sauli "agirono con parecchi altri loro conterranei molto attivamente sul mercato assicurativo veneziano".
151. Reinhold C. Mueller, I banchi locali a Venezia nel tardo Medioevo, "Studi Storici", 28, 1987, nr. 1, pp. 145-155.
152. Id., The Role of Bank Money in Venice, 1300-1500, "Studi Veneziani", n. ser., 3, 1979, p. 52 (pp. 47-96); R. Cessi, Problemi monetari veneziani, doc. 79, p. 73; Id., Il problema bancario a Venezia nel secolo XIV, "Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino", 52, 1916-1917, pp. 781-799.
153. "Inpero ch'esercitando el danaio, el danaio fa danaio", rispondeva, come un'eco al nostro testo, il fiorentino Andrea Arnoldi in un suo progetto sulla soppressione a termine del debito pubblico. Cf. Raymond A. De Roover, À Florence: un projet de monétisation de la dette publique au XVe siècle, in AA.VV., Histoire économique du monde méditerranéen, 1450-1650. Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel, I, Toulouse 1973, p. 516 (pp. 511-519).
154. R.C. Mueller, The Role of Bank Money, pp. 53-55.
155. Ibid., p. 57.
156. Ibid., pp. 68-69.
157. H. Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi, docc. 263-264.
158. Ibid., doc. 265.
159. Reinhold C. Mueller, Effetti della guerra di Chioggia sulla vita economica e sociale di Venezia, "Ateneo Veneto", n. ser., 19, 1981, pp. 27-41.
160. Id., Les préteurs juifs de Venise au Moyen Âge, "Annales E.S.C.", 30, 1975, pp. 1277-1302.
161. Ibid., p. 1294.
162. H. Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi, doc. 82, giugno 1329.
163. Ibid., doc. 24, 1° agosto 1308.
164. G. Mandich, Monete di conto veneziane, pp. 15-36; Id., Una compagnia fiorentina a Venezia nel quarto decennio del secolo XIV (un suo libro di conti), "Rivista Storica Italiana", 96, 1984, pp. 129-149.
165. Sul più noto dei Barbarigo nel secolo XV (non esistono monografie simili per quanto riguarda il secolo precedente) si veda il pregevole studio di Frederic C. Lane, Andrea Barbarigo, mercante di Venezia, 1418-1449, in Id., I mercanti di Venezia, Torino 1982, pp. 3-121.
166. Donatella Calabi-Paolo Morachiello, Rialto: un porto e un mercato tra persistenze e declino, in Città portuali del Mediterraneo. Storia e archeologia, a cura di Ennio Poleggi, Genova 1989, pp. 251-261; Ennio Concina, Mercanti in crisi e honor civitatis: strutture e lingua tra l'arsenatus communis e il chanal de San Marcho, ibid., pp. 219-230; Jean-Claude Hocquet, Les ports du sel en Europe méridionale, in I porti come impresa economica (XIX settimana di studio, Istituto internazionale di storia economica E. Datini, Prato 1987), a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze 1988, pp. 41-58.
167. D. Calabi - P. Morachiello, Rialto: un porto e un mercato, p. 253, precisano sulla pianta di Jacopo de' Barbari le attività amministrative e finanziarie del quartiere di Rialto, così come venivano esercitate in quegli anni.
168. J.-C. Hocquet, Le sel et la fortune de Venise, II, Voiliers et commerce en Méditerranée 1200-1650, pp. 104-108.
169. Id., Formes d'adaptation des armements navals de Venise, "Journal of European Economic History", in corso di pubblicazione; Id., Navires et navigation, in El comercio y transporte marítimo mundial de alimentos, Congreso Internacional Quinquenal de Historia Marítima, a cura di Christian Koninckx, Bruxelles 1990.
170. Gli statuti marittimi veneziani fino al 1255. Statuti delle tarrete del doge Rainieri Zeno (1255), a cura di Riccardo Predelli - Adolfo Sacerdoti, "Nuovo Archivio Veneto", n. ser., 5, 1903, pp. 314 ss. (pp. 314-336).
171. Ugo Tucci, La navigazione veneziana nel Duecento e nel primo Trecento e la sua evoluzione tecnica, in Venezia e il Levante fino al secolo XV, a cura di Agostino Pertusi, I/2, Firenze 1973, pp. 836-838 (pp. 821-841).
172. Jean-Claude Hocquet, Ibiza, carrefour du commerce maritime et témoin d'une conjoncture méditerranéenne (1250-1650), in AA.VV., Studi in memoria di Federigo Melis, I-V, Napoli 1978: I, pp. 513-514 (pp. 491-526).
173. Michel Balard, La Romanie génoise (XIIe - début du XVe siècle), Genova-Roma 1978, p. 536.
174. Detlev Ellmers, Kogge, Kahn und Kunstoffboot, "Führer des Deutschen Schiffahrtsmuseum", 7, 1976; Arne E. Christensen, Hanseatic and Nordic Ships in Medieval Trade. Were the Cogs Better Vessels?, in Medieval Ships and the Birth of Technological Societies, I, Northern Europe, a cura di Christiane Villain-Gandossi - Salvino Busuttil - Paul Adam, Malta 1989, ricorda che la cog anseatica era un legno di limitato tonnellaggio, che caricava mediamente solo 40-45 lasts.
175. Mario del Treppo, I mercanti catalani e l'espansione della corona d'Aragona nel secolo XV, Napoli 1972, p. 448.
176. Ibid., p. 452.
177. Lo Statuto di Marsiglia del 1253 ne segnalava la presenza: "[...] pro nave qualibet et hysneca vel coca". Così il sapiente re di Castiglia Alfonso X le elencava nelle Partidas (1256-1263): "Et otros menores que son desta manera e dicentes nombres porque sean conozcudos, asi como carracones, et buzos, et taridas, et cocas, et lenos, et haloques, et barcas", passo citato da Laureano Carbonell Relat, La coca, nave del Medioevo, "Revista de Historia Naval", 4, 1986, nr. 15, pp. 45-64.
178. Domenico, prete di San Maurizio, notaio in Venezia (1309-1316), a cura di Maria Francesca Tiepolo, Venezia 1970, con 20 documenti inseriti fra i nrr. 143-205.
179. J.-C. Hocquet, Le sel et la fortune de Venise, II, Voiliers et commerce en Méditerranée 1200-1650, pp. 109-118.
180. Id., Gens de mer à Venise. Diversité des statuts, conditions de vie et de travail sur les navires (XIIIe-XVIIIe siècles), in Le genti del mare Mediterraneo (XVIII Congresso di Storia Marittima, Napoli 1980), a cura di Rosalba Ragosta, I-II, Napoli 1981: I, pp. 133-139 (pp. 103-168); Frederic C. Lane, Dalle biremi alle triremi, in Id., Le navi di Venezia, Torino 1983, pp. 45-48; Riniero Zeno, L'arruolamento nel diritto medievale italiano, "Rivista di Storia del Diritto Italiano", 12, 1939, pp. 310-348; 13, 1940, pp. 253-291, 478-532.
181. Alberto Sacerdoti, Note sulle galere da mercato veneziane nel XV secolo, "Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano", 4, 1962, pp. 80-105.
182. Ciro Manca, Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale, Milano 1966, p. 278.
183. Ibid., p. 283.
184. Francesco Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, a cura di Allan Evans, Cambridge (Mass.) 1936, passim. La questione dei contenitori veniva affrontata di rado; si veda, ad esempio, l'articolo dal titolo significativo di Hannelore Zug Tucci, Un aspetto trascurato del commercio medievale del vino, in AA.VV., Studi in memoria di Federigo Melis, III, Napoli 1978, pp. 311-348.
185. Si confrontino i pregevoli studi di Antonio Scialoja, Partes navis, loca navis, in Id., Saggi di storia del diritto marittimo, Roma 1986, pp. 5-65.
186. John H. Pryor, Geography, Technology, and War. Studies in the Maritime History of the Mediterranean, 649-1571 Cambridge 1988 (Past and Present Publications).
187. Id., Winds, Waves, and Rocks: The Routes and The Perils along Them, in Colloque d'Histoire maritime, XVI Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Stuttgart 1985.
188. Frederic C. Lane, Fleets and Fairs, in Id., Venice and History. The Collected Papers of Frederic C. Lane, Baltimore 1966, pp. 128-141, segnala giustamente (p. 135) che a Venezia non esistevano fiere nel senso tradizionale in uso nel Medioevo, ma che con "fiera" devono intendersi le due ricorrenze annue di intensa attività, strettamente connesse con il ciclo dei "viaggi": la metà dell'inverno (dicembre - gennaio) e l'estate (giugno-agosto). Noi abbiamo preferito assimilare l'attività veneziana a una fiera permanente.
189. Id., Merchant Galleys, 1300-34: Private and Communal Operation, ibid., p. 194 (pp. 193-226).
190. Ibid., p. 201, ricorda che alla spedizione progettata per rendere più sicura la navigazione sulle coste pugliesi, nel 1300, avevano partecipato galere comunali e private.
191. Ibid., pp. 194-200.
192. Ibid., pp. 208-209; Adolf Schaube, Die Anfänge der venezianischen Galeerenfahrten nach Nordsee, "Historische Zeitschrift", ser. III, 5, 1908, pp. 28-29; Roberto Cessi, Le relazioni commerciali tra Venezia e le Fiandre nel secolo XIV, "Nuovo Archivio Veneto", n. ser., 27, 1914, pp. 5-116 (riedito in Id., Politica ed economia di Venezia nel Trecento, Roma 1952, pp. 71-172).
193. Francisco Sevillaino Colom, De Venecia a Flandes (Via Mallorca y Portugal, siglo XIV), "Boletín de la Sociedad Arqueologica Luliana", 808-809, 1968, pp. 1-33
194. F.C. Lane, Merchant Galleys, p. 211.
195. Ibid., p. 216.
196. Federigo Melis, Werner Sombart e i problemi della navigazione nel Medio Evo, in Id., L'Opera di Werner Sombart nel centenario della nascita, Milano 1964, pp. 85-149.
197. Gli statuti marittimi veneziani fino al 1255, a cura di Riccardo Predelli - Adolfo Sacerdoti, "Nuovo Archivio Veneto", n. ser., 4, 1902, pp. 113-161, 267-291; 5, 1903, pp. 161-251, 314-336.
198. John E. Dotson, Stowage Factors in Medieval Shipping, in Trasporti e sviluppo economico (V settimana di studio, Istituto internazionale di storia economica F. Datini), Prato 1973. Dotson è ritornato sull'argomento in Id., A Problem of Cotton and Lead in Medieval Italian Shipping, "Speculum", 57, 1982, nr. 1, pp. 52-62; si veda anche J. Bes, Chartering and Shipping Terms, Amsterdam 1951.
199. Gli statuti marittimi veneziani, 4, 1902, p. 288: "qualiter merces computari debeant ad caricandum".
200. Zibaldone da Canal, manoscritto mercantile del sec. XIV, a cura di Alfredo Stussi, Venezia 1967, pp. 39-41: "Queste si è le merchandatie scrite qua de soto como elle se dè metere in nave segondo como lo paron avesse nolliçado a balla o alltre merchadantie che se nolliçasse a millier".
201. Queste cifre possono sembrare modeste se rapportate a quelle elaborate da F. Melis, Werner Sombart, p. 137, secondo cui i noli più cari superavano i meno costosi di 3.333 volte. I primi venivano versati per ogni bene pregiato "che però è rarissimo e soprattutto circola per quantitativi irrisori rispetto alla capacità del naviglio", quali le perle cui Melis aveva peraltro applicato il normale coefficiente moltiplicatore di 100 lire-peso; il coefficiente meno caro sarebbe stato pagato per sale caricato a Ibiza, secondo il parere di F. Balducci Pegolotti, La pratica della mercatura, pp. 231-232, il quale si era limitato a indicare il prezzo d'acquisto del sale, il costo della "tratta" alle autorità di Maiorca e le spese di carico pagate ai padroni dei carri e delle barche che avevano trasportato il sale fino alle navi alla fonda; in totale, escludendo i noli, la spesa ammontava a I lira, II soldi e 6 denari "piccoli" di Maiorca, il "mondin". Il costo del carico a bordo ("per altre spese ad Eviza a caricarlo a nave") non corrisponde tuttavia al nolo o prezzo del trasporto. L'equivalenza del "mondin" non era stabilita, gli itinerari non erano tracciati e, se le perle circolavano probabilmente fra Venezia e la Catalogna, non era invece precisata la destinazione del sale e, di conseguenza, la lunghezza del tragitto e il tempo di navigazione. Per concludere, Melis segnalava che la quasi totalità dei noli si avvicinava ai 50 soldi ogni 100 lire-peso trasportate.
202. Alberto Tenenti - Corrado Vivanti, Le film d'un grand système de navigation: les galères marchandes vénitiennes, XIVe-XVIe siècles, "Annales E.S.C.", 16, 196, p. 84 (pp. 83-86).
203. J.-C. Hocquet, Le sel et la fortune de Venise, II, Voiliers et commerce en Méditerranée 1200-1650, pp. 144-145.
204. A. Sacerdoti, Note sulle galere, p. 97.
205. Antonio Scialoja, Le galee grosse della Repubblica veneta, I, Un precedente medioevale dei ῾pools' marittimi, in Id., Saggi di storia del diritto marittimo, Roma 1986, pp. 251-307.
206. Giulio Mandich, Forme associative e misure anticoncorrenziali nel commercio marittimo veneziano nel secolo Xl "Rivista delle Società", 6, 1961, p. 485 (pp. 471-508).
207. Jean-Claude Hocquet, Das Salz und die Gewinne aus der Handelsschiffahrt im Mittelmeer In Spätmittelalter, "Scripta Mercaturae. Zeitschrift für Wirtschaftsund Sozialgeschichte", 1, 1983, pp. 1-18.
208. Id., Gens de mer à Venise, pp. 161-164.
209. Id., Los puertos de la sal en la Europa meridional. Contribución al estudio de las estructuras materiales de un gran comercio, "Estudios d'Historia Economica", 1, 1988, pp. 5-26.
2 10. Id., Ibiza, carrefour du commerce.
211. Roberto Cessi, Politica ed economia veneziana del Trecento, in Id., Politica ed economia di Venezia nel Trecento, Roma 1952, pp. 7-22.
212. Id., L'"Officium de navigantibus" e i sistemi della politica commerciale veneziana nel secolo XIV, ibid., pp. 23-61.
213. Ibid., pp. 52, 61.
214. Freddy Thiriet, Quelques observations sur le trafic des galées vénitiennes d'après les chiffres des Incanti (XIVe-XVe siècles), in AA.VV., Studi in onore di Amintore Fanfani, III, Milano 1962, p. 508 (pp. 493-522).
215. Sergej P. Karpov, L'impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Ronza (1204-1461). Rapporti politici, diplomatici e commerciali, Roma 1986, p. 321; Id., Grecs et Latins à Trébizonde (XIIIe-XVe siècle). Collaboration économique, rapports politiques, in Etat et colonisation au Moyen Âge et à la Renaissance, a cura di Michel Balard, Lyon 1989, pp. 413-424.
216. Id., The Southern Black Sea Coast in the System of Economie Relations between East and West, XIIIth--XVth Centuries, "Byzantiaka", 60, 1986, pp. 49-55.
217. Michael E. Martin, The First Venetians in the Black Sea, "Archeion Pontou", 35, 1979, pp. 111-122; Id., Venetian Tana in the Later 14th and Early 15th Century, "Byzantinische Forschungen", II, 1987, pp. 375-379; E. Fenster, Zur Fahrt der venezianischen Handelsgaleeren in das Schwarze Meer 1362, "Byzantinoslavica", 39, 1978, pp. 161-195.
218. Frederic C. Lane, The Venetian Galles to Alexandria, 1344, in Id., Studies in Venetian Social and Economic History, London 1987.
219. S.P. Karpov, L'impero di Trebisonda, p. 84.
220. A. Tenenti - C. Vivanti, Le film d'un grand système, carta fuori testo.
221. A. Scialoja, Le galee grosse, pp. 295-296.
222. Jean-Claude Hocquet, Capitalisme marchand et classe marchande à Venise au temps de la Renaissance, "Annales E.S.C.", 34, 1979, nr. 2, pp. 279-304.
223. C. Manca, Aspetti dell'espansione, p. 86.
224. H. Sisionsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi, doc. 55.
225. Ibid., doc. 196.
226. Ibid., doc. 276.
227. Ibid., doc. 49, 20 gennaio 1317.
228. Ibid., doc. 256.
229. Ibid., doc. 257.
230. Ibid., docc. 88-89, dicembre 1330-febbraio 1331.
231. Ibid., doc. 72, aprile 1325.
232. Le vie transalpine sono state oggetto di molti studi: Hermann Kellenbenz, Lindau und die Alpenpässe, in Erzeugung, Verkehr und Handel in der Geschichte der Alpenländer, a cura di F. Huter - G. Zwanowetz, Innsbruck 1977 (Tiroler Wirtschaftsstudien, 33. Folge), pp. 199-219; sulla legislazione viaria, Henri V. Srbik, Rodordnungen des Ausferngebietes in den neueren jahrhunderten, in AA.VV.; Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde Tirols (= "Schlernschriften", 52. Bd.), Innsbruck 1947, pp. 247-269; Otto Stolz, Zur Geschichte der Organisation des Transportwesens in Tirol im Mittelalter, "Vierteljahrscrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte", 8, 1910, pp. 196-267; Id., Verkehrsgeschichte des Jaufen, in AA.VV., Festschrift zu Ehren Konrad Fischnalers (= "Schlernschriften", 12. Bd.), Innsbruck 1927, pp. 127- 175; Id., Neue Beiträge zur Geschichte des Niederlagrechtes und Rodfuhrwesens in Tirol, "Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte", 22, 1929, pp. 144-173; Id., Zur Verkehrsgeschichte des Inntales im 13. und 14. Jahrhundert, "Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum in Innsbruck", 12, 1932, pp. 69-109; Quellen zur Geschichte des Zollwesens und Handelsverkehr in Tirol und Vorarlberg vom 13. bis 18. Jahrhundert, a cura di Id. (= "Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Ncuzeit", 10. Bd., Deutsche Zolltarif des Mittelalters und der Neuzeit), I, Wiesbaden 1955; Id., Geschichte des Zollwesens, in AA.VV., Verkehrs und Handels durch Tirol und Vorarlberg von den Anfängen bis ins XX. Jahrhundert (= "Schlernschriften", 108. Bd.), Innsbruck 1953.
233. H. Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi, doc. 204.
234. Ibid., doc. 207.
235. Ibid., docc. 207-209.
236. Ibid., docc. 230-231.
237. Ibid., docc. 242, 251.
238. Ibid., doc. 243.
239. Ibid., docc. 244, 246.
240. Aloys Schulte, Geschichte der grossen Ravensburger Handelsgesellschaft (1380-1530), I-III, Stuttgart-Berlin 1923.
241. H. Simonsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi, doc. 269.
242. I patti con Brescia, 1252-1339, a cura di Luca Sandini, Venezia 1990 (Pacta Veneta, l), p. 17; sulla via della Francia, cf. anche Giuseppe Barelli, Le vie del commercio fra l'Italia e la Francia nel Medioevo, "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", 12, 1907, p. 121 (pp. 65-138); Luciana Frangioni, Milano e le sue strade. Costi di trasporto e vie di commercio dei prodotti milanesi alla fine del Trecento, Bologna 1983, pp. 18-22, 57-67.
243. La fluitazione e il trasporto del legname in zattere o a tronchi sciolti sono state fra le attività più considerevoli dei fiumi e dei torrenti alpini fino al secolo XIX. Luigi Simeoni, Il commercio del legname fra Trento e Verona nel sec. XIII, Rovereto 1907.
244. Sulla navigazione dell'Adige, Jean-Claude Hocquet, Le "Burchio", outil privilégié du transport du sel en Vénétie, in Le sel et son histoire, a cura di Guy Cabourdin, Nancy 1981, pp. 117-138; Laura Castellazzi, Uomini e attività urbane in rapporto all'Adige tra XV e XVIII secolo, in Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige, a cura di Giorgio Borelli, I-II, Verona 1977: I, pp. 209-241; Giorgio Beggio, Navigazione, trasporto, mulini sul fiume: i tratti di una tipologia, ibid.: II, pp. 483-567; Tommaso Fanfani, L'Adige come arteria principale del traffico tra nord Europa ed emporio realtino, ibid.: II, pp. 571-629; Guido Canali, I trasporti sull'Adige da Bronzolo a Verona e gli spedizionieri di Sacco, Roma 1939; Gina Faccioli, Verona e la navigazione atesina, Verona 1956. La letteratura sulla navigazione sul Po e sui suoi affluenti è ben nutrita: Giulio C. Zimolo, Canali e navigazione interna dalle origini al 1500, in AA.VV., Storia di Milano, VIII, Tra Francia e Spagna (1500-1535), Milano 1957, pp. 865-895; Id., Brescia e Bergamo nella storia della navigazione interna, "Archivio Storico Lombardo", ser. IX, 4, 1964-1965, pp. 362-389; Vincenzo Pancotti, I paratici piacentini e i loro statuti. Gli statuti dei navaroli piacentini e gli statuti Merchantiae et Nuxii, Piacenza 1927 (Biblioteca storica piacentina, XIV); Pietro Vaccari, Uno sguardo ai nuovi rapporti di scambi commerciali fra Lombardia e Venezia nei secoli XIV e XV, in AA.VV., Studi in onore di Amintore Fanfani, III, Milano 1962, pp. 559-575; Pierre Racine, Aperçu sur les transports fluviaux sur le Po au bas Moyen Âge, "Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest", 85, 1978, pp. 261-271; Emilio Paolo Vicini, Gli statuti dell'arte dei navigatori in Modena, I, Modena 1937; Id., La navigazione fluviale a Modena nel Medioevo, "Atti e Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena", ser. V, 1, 1935, pp. 49-64.
245. A.S.V., Libri Commemoriali, II, c. 65.