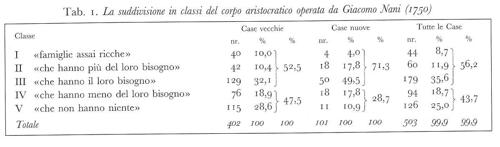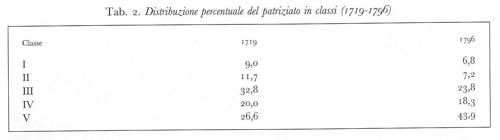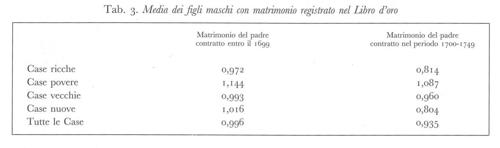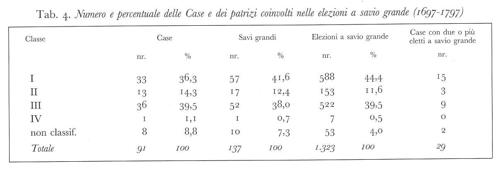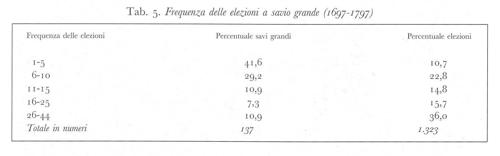Il corpo aristocratico
Il corpo aristocratico
Nell'attuale storiografia è invalsa l'abitudine di descrivere a rosee tinte il destino della nobiltà europea nei secoli precedenti e successivi alla Rivoluzione francese. Per la nobiltà il Seicento e il Settecento non sarebbero stati una fase di "crisi" e di "declino", come ritenevano tanti contemporanei e anche storici posteriori, bensì un periodo di "consolidamento" e di "trasformazione". Nonostante tutte le difficoltà politiche, sociali ed economiche con le quali la nobiltà si era trovata a combattere in passato, nel tardo Settecento essa sarebbe stata dovunque non solo solidamente trincerata, ma forse addirittura più potente di prima. Essa avrebbe superato relativamente illesa i disordini della grande rivoluzione e avrebbe mantenuto anche nell'Ottocento il suo potere e il suo influsso. L'unica a non rientrare in questo quadro complessivamente positivo sarebbe stata la nobiltà polacca la cui rovinosa caduta e la cui estinzione come ceto a sé stante sarebbero però da ascriversi unicamente alle spartizioni del paese e alla prolungata mancanza di autonomia statale (1).
Un crollo altrettanto drammatico subì solo pochi anni più tardi anche il patriziato veneziano, che il 12 maggio 1797, anche in questo caso in seguito ad un'aggressione militare, venne rimosso dalla sua secolare posizione di unica classe governativa e che alcuni mesi dopo dovette addirittura assistere al totale tramonto dello Stato che aveva rappresentato. Con il trattato di Campoformio anche la Repubblica di San Marco divenne una passiva unità di manovra nelle mani delle grandi potenze, mentre la nobiltà che un tempo la governava non era più che l'ombra di se stessa. La nobiltà polacca e quella veneziana non erano solo compagne di sventura, ma avevano in comune anche altre caratteristiche. Gli Stati che esse governavano erano le ultime grandi Repubbliche aristocratiche della vecchia Europa, e durante l'Ancien Régime erano stati entrambi e in modo simile sempre più scavalcati e infine annientati dai loro più potenti vicini a regime assolutistico. Comune ad ambedue le Repubbliche era anche la profonda lacerazione interna al corpo aristocratico e l'estrema polarizzazione fra gli interessi dei suoi diversi gruppi. La loro scomparsa dalla carta geografica d'Europa, verificatasi quasi contemporaneamente e in modo affine, non dipese solo dalla strapotenza dei loro nemici esterni, ma anche dalle debolezze costituzionali di entrambe le Repubbliche, e infine dal fatto che le profonde spaccature apertesi da tempo fra le diverse "classi" della nobiltà finirono col rivelarsi insanabili (2). Ne risultò, almeno nel caso di Venezia, una paralisi della capacità di azione sul piano politico: le riforme che da tempo sarebbero state necessarie venivano incessantemente discusse, ma mai realizzate, mentre l'attendere passivamente veniva considerato come il massimo dell'avvedutezza politica.
La burrasca che minacciava la Repubblica non si addensò all'improvviso, scoppiando come un fulmine a ciel sereno nel 1796 con la campagna di Napoleone Bonaparte in Italia. Gli indizi di un futuro difficile e incerto per la Repubblica si profilavano già da tempo all'orizzonte. La seconda guerra della Morea aveva drammaticamente rivelato le debolezze di Venezia in ambito militare e diplomatico. Alla conclusione della pace di Passarowitz Venezia si venne a trovare dalla parte dei vincitori grazie all'alleanza con Vienna e alla fortuna militare austriaca, ma si vide privata dei frutti della vittoria che non si era conquistata con le proprie forze. A quell'epoca il futuro doge Marco Foscarini ammonì se stesso e gli altri patrizi a non perdersi d'animo di fronte all'"ingiuria dei tempi" e alla "calamità di fortuna": "essendo che fin tanto che dureranno le Leggi, e che vi saranno uomini di valore, niuna cosa è tanto grande, a cui non siamo per poter giustamente pretendere sino a racquistare la perduta grandezza di prima [...]. Ma poiché maggior benefizio risulta allo Stato nostro dalla pace, che dalla guerra, più ragionevol confidenza d'ingrandimento è d'aversi nella condizione del tempo presente, in cui ricreati gl'animi colla quiete ponno mettere tranquillamente tutta l'intenzione del loro studio a rinvigorire il commercio, da cui sempre mai è derivata l'opulenza de' sudditi, e la grandezza della Repubblica" (3). In pratica non esistevano alternative alla politica di pace consigliata dal Foscarini. Infatti, come i Paesi Bassi dopo le guerre contro Luigi XIV, la Repubblica di Venezia era uscita talmente indebolita dalle guerre contro i Turchi, perduranti dal 1645, salvo due interruzioni, che l'unica via da seguire che le restava era quella di una rigida neutralità. Tuttavia non fu l'effetto intimidatorio della loro politica di neutralità armata a offrire ai Veneziani la possibilità di godere di quasi ottant'anni di pace, dopo il 1718, ma fu piuttosto la rivalità fra le grandi potenze. Che le cose stessero così è rivelato brutalmente dalle istruzioni ricevute nel 1779 dal nuovo ambasciatore di Francia alla vigilia della sua missione diplomatica a Venezia: "L'usage qui s'est perpétué depuis plus de deux siècles d'envoyer à Venise des ministres du premier ordre n'est pas le seul motif qui ait déterminé S.M. à charger le sieur marquis de Vergennes de cette honorable commission. Quoique déchue de son ancienne splendeur et réduite à ne s'occuper plus que de sa conservation, cette République occupe dans l'Europe un espace que sa situation rend important, elle a presque toujours été vouée aux intérêts de la France, son existence nous est utile, sa ruine nous pourroit être onéreuse". Pertanto il Vergennes venne incaricato di prestare particolare attenzione a ogni indizio dell'"annéantissement de cette République" e di esaminare "avec toute l'attention dont il est capable la marche de sa décadence, affin de mettre S.M. à portée de prévenir sa ruine" (4). Quando la Francia, nel frattempo rivoluzionaria o per meglio dire postrivoluzionaria, non considerò più "utile" l'"esistenza" della Repubblica, un oscuro segretario della Legazione francese, un certo Joseph Villetard, prese in mano la situazione politica a Venezia e con i suoi intrighi riuscì senza fatica a indurre il maggior consiglio ad abdicare a favore di un "governo rappresentativo".
La Repubblica era stata appena sepolta quando gli stessi ex patrizi cominciarono a chiedersi a chi andasse attribuita la colpa della sua caduta. "La mala fede e l'inganno dei Francesi" da una parte e la "rea innazione" della Repubblica stessa dall'altra, o in altre parole il "colmo di debolezza in chi presiedeva alle cose pubbliche" e il "colmo di perfidia in una nazione" erano dal punto di vista dei più le cause principali, o addirittura le uniche, che avevano condotto agli avvenimenti del maggio 1797 (5). A prescindere dalla minore o maggiore legittimità delle accuse di colpevolezza, chiunque ne fosse il destinatario, per capire questo crollo della Repubblica avvenuto all'improvviso, senza opporre resistenza e - per molti - ingloriosamente, va ricordato, insieme a Piero Del Negro, che non solo "il rullo compressore napoleonico" aveva travolto "in tutta la penisola i regimi prerivoluzionari", ma anche che allora "tutte le repubbliche nobiliari furono definitivamente colate a picco dalla tempesta di fine secolo" (6). Evidentemente l'epoca delle Repubbliche aristocratiche era tramontata, come dimostrano anche gli eventi verificatisi contemporaneamente in Polonia, e quei nobili che, non sottomessi ad alcun principe, erano stati gli unici citoyens actifs del loro Stato, si trovavano ad affrontare un futuro particolarmente nero, avendo perduto, in sostanza, insieme ai loro diritti sovrani anche la loro ragion d'essere. L'innegabile declino politico di Venezia nel Settecento, la scomparsa totale della Repubblica stessa e il destino della sua classe dirigente che, quando non sparì senza lasciare tracce, perse comunque ogni importanza politica, indussero non pochi storici a descrivere la storia del patriziato veneziano nel Settecento servendosi di termini come "declino", "crisi" o addirittura "suicidio" (7). Anche nelle pagine che seguono parleremo a volte di declino e di crisi; tuttavia il voler vedere ed interpretare solo dal punto di vista della sua conclusione una fase storica della durata di tre generazioni significherebbe restringere - in modo anacronistico - la prospettiva storica. Anziché fissare lo sguardo, come ipnotizzati, sulla fine della vicenda, per una migliore comprensione storica sarebbe più utile analizzare il corpo aristocratico del Settecento con le sue particolarità, innegabilmente vistose, considerandolo come il risultato di processi iniziati spesso in tempi assai lontani. Nel Settecento le tradizioni della sua lunga storia gravavano sul patriziato schiacciandolo con il loro peso. La minacciosa situazione internazionale rendeva però troppo rischioso scrollarsi di dosso tale peso, dando il via a riforme che avrebbero riguardato anche, anzi in primo luogo, la nobiltà stessa e la posizione del proletariato nobiliare. Inoltre tale strada era comunque impercorribile anche perché riforme radicali sarebbero inevitabilmente fallite, scontrandosi con i consolidati interessi dei singoli gruppi, e non erano conciliabili con il concetto che i patrizi avevano di se stessi e della loro supremazia. Essi non sarebbero stati in grado di evitare quel che avvenne il 12 maggio 1797, tutt'al più avrebbero potuto anticiparlo.
Una società nobiliare divisa in classi
Nel marzo 1762, due mesi prima di venir eletto doge, Marco Foscarini affrontò l'argomento dei rapporti fra i nobili in un memorabile discorso in maggior consiglio: "Molte disuguaglianze, el savemo tutti, passa fra i nobili. I somi ufizi e le dignità, le magiori aderenze o minori, le fortune domestiche e l'istesso favor dei animi gode più o meno introduzion de notabili diferenze fra i omeni de republica, ma nessuna di queste fa ingiuria a la sostanzial parità che core tra loro, parità coetanea a la nascita, e che forma la base d'ogni governo aristocratico". Poco prima, altri aveva riassunto questo concetto nella formula "uguaglianza di Dominio in disuguaglianza di fortune" (8). Queste asserzioni sono adattissime a fare da motto ai passi che seguono; infatti nel Sei e Settecento siamo ben lontani dall'epoca - ammesso e non concesso che essa sia mai esistita - in cui, come aveva detto Francesco Guicciardini, non si faceva distinzione "o per ricchezza o per stiatte" nell'affidare le cariche (9). È vero che la "sostanzial parità", l'"uguaglianza di Dominio", nel senso di una formale uguaglianza giuridica di tutti i nobili di sesso maschile, rimase fino alla caduta della Repubblica la massima più importante della sua costituzione, però le distinzioni e "notabili diferenze" fra i beni di fortuna, l'età e la considerazione di cui godevano le "stiatte" non solo rivestivano già da tempo un'importanza decisiva per la "distribuzione del potere all'interno del patriziato veneziano", ma determinavano anche quando e con chi un patrizio si sposava, quant'era profondo il suo legame allo "spirito di famiglia", quanto grande il suo ménage, come e dove egli faceva educare i suoi figli, se disponeva di una gondola o se andava a piedi, e tanti altri aspetti della vita di cui tratteremo in seguito.
Circa due anni dopo questa caratterizzazione degli "omeni de republica" ad opera del Foscarini, Cesare Beccaria pubblicò il suo famoso trattato nel quale fece i conti con lo "spirito di famiglia" accusando anche "gli uomini [...] più illuminati" e le "repubbliche più libere" di "aver considerato piuttosto la società come un'unione di famiglie che come un'unione di uomini" (10). In realtà i patrizi avevano considerato sin dai primordi non solo il loro ceto, ma in sostanza l'intero Stato come "un'unione di famiglie". A buon diritto è stato ripetutamente sottolineato che a Venezia ed altrove l'unità di base della élite nobiliare era la "famiglia" o la "casa" e che è possibile comprendere la società nobiliare solo partendo da tale premessa (11). Pertanto è indispensabile chiarire sin dall'inizio come vadano intesi gli ubiquitari termini delle fonti e quali persone di solito venissero attribuite ad una determinata famiglia o casa patrizia.
Se si segue la dotta definizione fornita alla fine del Settecento da Marco Ferro, anche a Venezia come altrove in Italia si era soliti mettere a confronto l'unità familiare più ristretta e quella più estesa: "la parola famiglia in senso stretto comprende il padre di famiglia, la madre di famiglia, [...] e i figliuoli [...]. Ma quando si prende la parola famiglia in un senso più esteso vi si comprendono allora tutti i parenti; perché, quantunque dopo la morte del padre di famiglia ogni figliuolo stabilisca una famiglia particolare e separata, nondimeno tutti quelli che discendono da uno stesso stipite, e che per conseguenza nascono da un medesimo sangue, sono riguardati come membri di una stessa famiglia". Ferro chiama la famiglia in senso lato anche "casato", al quale appartengono tutti coloro "che portano lo stesso cognome" (12). In altre fonti questo tipo di famiglia viene definito anche "casata", "casa", "schiatta" o semplicemente "famiglia". In effetti tale "parentela" basata unicamente sullo stesso cognome conservò la sua importanza giuridica fino alla caduta della Repubblica. I termini "famiglia" o "casa" significano però anche la famiglia coniugale, di cui il Ferro dà una definizione decisamente moderna, nonché la comunità domestica che costituiva l'unità più piccola nei censimenti della popolazione e della quale naturalmente facevano parte anche persone non legate da parentela al "capo di casa", ma che vivevano sotto lo stesso tetto.
Fra il "casato" ("lignaggio") da una parte e la famiglia coniugale o la comunità domestica dall'altra esisteva però anche un'altra dimensione di famiglia o di casa che, forse non dovunque, ma senz'altro a Venezia, costituiva la principale entità di riferimento. Si tratta del singolo "ramo" di un casato che tuttavia nelle fonti raramente compare sotto questo nome, in quanto evidentemente già da tempo i "rami" avevano dato luogo a "ceppi" autonomi. I Veneziani distinguevano esattamente fra "ramo" e "casato" nella sostanza, ma non nella terminologia. In un trattato del 1664, che si rivolge contro il "mito di Venezia", si legge: "Le famiglie, che ora entrano nel Gran Consiglio in quanto all'unità del cognome, sono trecento in punto; ma molto più se risguardansi le case, in cui molte famiglie si dividono, come la Moceniga, Contarina, Querina, Cornara, Morosina, Giustiniana e simili". Cinquant'anni dopo, un almanacco a stampa della nobiltà riportava che a quell'epoca (1715) le famiglie patrizie sarebbero state 216, divise in 667 case (13). In questi due passi col termine "famiglie" si intendono i casati e con il termine "case" i rami; in altri passi tuttavia i rami non vengono chiamati solo "casa", ma altrettanto spesso anche "famiglia" e a volte persino "casata", sebbene il ramo così denominato non fosse l'unica "casa" recante quel cognome. Per evitare una babelica confusione di linguaggio nelle pagine che seguono si parlerà di casato per indicare il complesso di rami recanti lo stesso cognome e di Casa per indicare il singolo ramo. L'insolita maiuscola si rende necessaria per escludere confusioni con la "casa" nel senso dei censimenti e con la casa nel senso di palazzo o di semplice domicilio.
Non è stato ancora chiarito quando i patrizi veneziani abbiano incominciato ad identificarsi più con la loro Casa che con il loro casato. Quei medievisti e quegli storici del Rinascimento che esaminano la nobiltà come un tutto unico e che pertanto difficilmente possono fare distinzioni fra le numerose Case dello stesso nome sono convinti che l'appartenenza ad un certo casato abbia costituito un fattore determinante in politica fino all'inizio del Cinquecento. Altri, invece, che si sono occupati della storia di singoli casati, distinguono esattamente i loro vari rami già dal Medioevo (14). Anche fra gli studiosi dell'Ancien Régime si può osservare tale differenza: quelli che si occupano della nobiltà nel suo insieme si orientano di preferenza ai nomi dei casati, facilmente identificabili, mentre per gli storici di singole "famiglie" il casato è praticamente privo di importanza in quanto oggetto del loro interesse è sempre la singola Casa (15). Al più tardi verso la metà del Seicento, e probabilmente molto prima, nel modo di pensare dei patrizi il casato aveva perso di importanza rispetto alla Casa. Ciò è dimostrato dalla produzione pubblicistica dell'"antimito" e da tutte le analisi tarde del corpo aristocratico, in particolare dai Ragionamenti politici di Nicolò Donà e dal Saggio politico di Giacomo Nani; nel constatare le scissioni della nobiltà in "famiglie" di "ricchi", "mezzani" e "poveri", di "grandi" e di "piccoli", di "proceri" e di "plebei", tutte queste opere si riferiscono alle Case e mai ai casati. Le ricerche di Del Negro e di alcuni altri storici hanno eliminato qualsiasi dubbio in proposito.
Le "notabili differenze" fra i patrizi constatate dal Foscarini risalgono ad un lontanissimo passato. La loro causa di gran lunga più importante va vista in un processo che si affermò con veemenza nel Cinquecento e che è stato definito con i termini ruralizzazione, feudalizzazione e aristocratizzazione. Con ciò si intende un generale nuovo orientamento del pensiero economico, il passaggio dall'attività commerciale alla proprietà terriera, dal profitto alla rendita. "La penetrazione economica dei Veneziani in Terraferma" (Beltrami) trasformò molti nobili in agiati proprietari terrieri, alcuni addirittura in latifondisti; tuttavia i più poveri di loro erano destinati a soccombere nella corsa alla terra. Come ha affermato Gaetano Cozzi, questa trasformazione economica costituì una "svolta decisiva" nella storia della nobiltà veneziana. Le disparità nella distribuzione della proprietà terriera innalzarono barriere durature fra i nobili ricchi e quelli poveri e condussero ad una scissione del corpo aristocratico fra i proprietari terrieri più o meno abbienti e i "plebei, che non hanno rendite o poderi" (Nicolò Donà); chi a quell'epoca era povero in linea di massima era destinato a rimanere povero per sempre (16). D'altro canto, le Case già ricche in passato rimasero ricche e potenti per lungo tempo, ma non per sempre. Per mezzo di fidecommessi e della limitazione dei matrimoni esse cercarono di trasmettere i loro beni integri e indivisi da una generazione all'altra, e fino alla metà del Settecento nella maggior parte dei casi ci riuscirono. Ma verso la fine del secolo molti dei più cospicui patrimoni erano quasi consumati dai debiti e svanirono completamente dopo il 1797, in seguito alle pretese finanziarie dei Francesi e degli Austriaci. Tuttavia questa crisi economica del patriziato ricco si manifestò tanto tardi da non infirmare fino alla fine della Repubblica la posizione di privilegio politico e sociale delle Case che dominavano da tempo.
L'impari distribuzione dei beni materiali fra i nobili costituiva già da secoli un luogo comune nelle descrizioni del corpo aristocratico e dalla metà del Seicento veniva indicata come una causa e un sintomo della "decadenza" del governo aristocratico e della Repubblica. Con la stessa formula, che sembra quasi tradotta letteralmente da Aristotele, i patrizi del primo Cinquecento sottolinearono ripetutamente l'esistenza di "tre qualità di nobili zoè poveri, mezani e fichi", i "mezani" venivano chiamati anche "mediocri". La stessa tripartizione venne usata all'inizio del Seicento anche dall'ambasciatore spagnolo Bedmar e sia prima che dopo la caduta della Repubblica ebbe una particolare diffusione. Un notevole influsso sulla storiografia posteriore fu esercitato da Samuele Romanin che nel 1860 suddivise la nobiltà in "tre ben distinte classi": la "nobiltà senatoria" che occupava le più alte dignità dello Stato; la "nobiltà giudiziaria", "una classe illuminata composta di uomini probi pratici delle leggi, facondi oratori", che dominava nei tribunali delle quarantie; e la "nobiltà barnabotta o bassa e povera", così chiamata dalla parrocchia di San Barnaba nella quale questa categoria di nobili sarebbe stata particolarmente numerosa (17).
Verso la metà del Settecento la tripartizione aristotelica venne temporaneamente abbandonata da due patrizi che sezionarono il corpo aristocratico con un bisturi più tagliente, vale a dire con una classificazione più precisa. Il primo, Nicolò Donà S. Fosca, nei suoi Ragionamenti politici (1736-1738) suddivise i membri del maggior consiglio in quattro classi: "proceri", "benestanti", "meccanici" e "plebei"; il secondo, Giacomo Nani, distinse addirittura in base al censo cinque classi di famiglie nobili (ovvero Case). L'opera del Nani, il Saggio politico del corpo aristocratico della Repubblica di Venezia per l'anno 1756, composto fra il 1749 e il 1756, costituisce un documento unico nel suo genere in quanto non si limita a una generica classificazione, come tutte le opere precedenti e successive, ma procede anche all'attribuzione di ogni singola Casa ad una delle cinque classi. Il Nani impostò la sua ricerca sul Libro d'oro a stampa per l'anno 1750 e, per valutare il patrimonio delle circa 560 Case che vi erano registrate, si servì probabilmente della redecima del 1740, che, sebbene comprendesse solo i beni immobiliari dichiarati al fisco, grosso modo rispecchiava ugualmente la situazione patrimoniale dei contribuenti. Rinunciando a priori al tentativo (che si sarebbe rivelato impossibile) di stabilire esattamente l'ammontare dei beni di ogni Casa, per determinare i possedimenti e i redditi delle famiglie patrizie il Nani si accontentò di criteri decisamente elastici, orientati ai "bisogni". Nel frattempo numerose ricerche hanno confermato che egli aveva valutato esattamente, tranne poche eccezioni, il rango socioeconomico occupato da ogni Casa nella piramide della nobiltà (18).
Poiché in seguito non si tratterà solo delle Case esistenti alla metà del Settecento, bensì di tutte le Case elencate nell'almanacco a stampa del 1719, la suddivisione delle Case nella Tab. 1 segue questo almanacco e non quello del 1750. Pertanto non è stato possibile tenere conto delle scissioni avvenute fra queste due date. Alcune volte Nani ha attribuito a classi diverse (la II e la III, o la IV e la V) due Case che nel 1719 erano ancora indivise; nella tabella abbiamo dovuto collocare rispettivamente in un'unica classe queste Case (dieci in tutto) con rami classificati diversamente (19). Inoltre il Nani ha semplicemente dimenticato quattro delle Case esistenti nel 1750 e ne ha omesse deliberatamente altre quindici "per non essere note a chi scrisse le loro fortune o perché non vengono mai a Consiglio".
L'informazione più importante che si ricava dalla tabella è che alla metà del secolo una maggioranza abbondante delle Case (56,2%) poteva ancora venir considerata benestante, e una Casa su undici disponeva addirittura di esorbitanti ricchezze. Fra le Case nuove, aggregate dal 1646, erano rare quelle ricchissime, ma relativamente numerose quelle di media ricchezza (classi II e III). Quindi a quell'epoca le Case povere (classi IV e V) erano ancora chiaramente in minoranza, eppure va considerato ugualmente come un segnale d'allarme il fatto che un patrizio attestasse che i membri di una Casa su quattro non avevano "niente" (classe V) e che quasi una Casa su cinque aveva meno del suo "bisogno" (classe IV). In realtà, come vedremo, è una enorme esagerazione affermare che tutti i membri della classe V non disponessero di alcun bene di fortuna e facessero letteralmente la fame. Tuttavia, a parte il fatto che alcuni di essi erano veramente in miseria, l'esistenza della classe V (ed entro certi limiti anche quella della IV) rappresentava per molti motivi una grave minaccia per l'unità del corpo aristocratico e persino per la sopravvivenza della Repubblica. La povertà non può venir misurata in assoluto, ma è sempre anche un problema culturale e specifico per determinati strati e ceti sociali. Molti di coloro che il Nani considerava patrizi poveri lo saranno stati senz'altro molto meno della maggioranza degli strati più bassi della popolazione veneziana. Però, in quanto patrizi e membri di una classe governativa privilegiata, dal punto di vista dei loro simili e dei sudditi essi potevano a buon diritto venir considerati come poveri, come un proletariato nobile, dato che non corrispondevano in alcun modo ad una delle correnti definizioni della nobiltà, in base alla quale essa sarebbe consistita in antiche ricchezze. In confronto ai patrimoni e alle rendite dei patrizi ricchi essi dovevano venir visti come declassati, e in effetti come tali venivano considerati e si consideravano essi stessi. Appartenere ai "plebei" (in sostanza ai membri della classe V) significava essere praticamente esclusi dalle più alte cariche dello Stato e condurre una vita miseranda - sempre relativamente al loro ceto - col sussidio di sinecure e di elemosine pubbliche. Un patrizio "plebeo" non aveva alcuna possibilità di sposare una donna appartenente a una Casa dei "grandi" e solo in rare eccezioni un "grande" si degnò di prendere in moglie una "plebea". L'abisso che separava i patrizi molto ricchi da quelli molto poveri era praticamente incolmabile; tuttavia il legame giuridico che li univa in quanto nobiluomini veneti non poteva venir semplicemente spezzato, perché un passo del genere sarebbe equivalso ad un rovesciamento della costituzione.
Forse i patrizi avrebbero potuto sopravvivere ancora un poco in questa situazione e con le tensioni che ne risultavano, se il rapporto numerico fra le classi fosse rimasto invariato. Ma ciò non avvenne, dato che i patrizi poveri si sposavano in media più spesso di quelli ricchi. Pertanto le Case ricche, pur essendo in maggioranza, già nel 1750 comprendevano solo la metà scarsa degli uomini patrizi adulti. Entro il 1797 la loro quota di nobili "capaci al Maggior Consiglio" si ridusse al 34,6% e quindi i rappresentanti delle classi IV e V finirono con l'avere una maggioranza di due terzi in maggior consiglio (20). A dire il vero i nullatenenti non riuscirono a strappare ai "grandi" e ai "mezzani" la loro posizione di privilegio politico, tuttavia con il potere esercitato per mezzo del voto contribuirono a rendere la Repubblica incapace di attuare riforme, a paralizzare le sue istituzioni, a conservare una miriade di cariche inutili, vere e proprie sinecure, e a far sì che la sorgente della beneficenza statale a favore delle loro famiglie non si inaridisse. Era inevitabile che il loro moltiplicarsi finisse con lo scalzare il tradizionale diritto della nobiltà ad essere l'unica classe dirigente. Infatti i patrizi "plebei" non vivevano per lo Stato, giustificando in tal modo i loro privilegi politici, bensì a spese dello Stato, e quindi contribuivano a privare della sua legittimità il governo aristocratico.
Nelle pagine seguenti ci affideremo alla classificazione del Nani per stabilire la posizione socioeconomica di una Casa, ma prima vanno verificati ancora due punti: innanzitutto se tale classificazione fosse giusta per l'epoca in cui il Nani scriveva, e poi se i redditi e la situazione patrimoniale delle Case, nel secolo precedente e nel mezzo secolo successivo al 1750, fossero stati così poco variabili da permettere di applicare anche alle generazioni precedenti e a quelle successive una classificazione valida per il 1750. Rispondere alla prima domanda è relativamente facile. Ad una classe troppo bassa il Nani attribuì un'unica Casa, quella dei Memmo S. Marcuola. A giudicare dal reddito dichiarato nelle redecime questa Casa apparteneva senza dubbio alla classe III; anche le quattro gondole, i dodici servitori e le tre "massere" di cui i Memmo disponevano nel 1761 testimoniano la loro agiatezza. Come tante altre Case un tempo fiorenti, anche i Memmo S. Marcuola sembrano essere caduti in miseria negli ultimi anni della Repubblica. Infatti nel 1791 Pietro Zaguri scriveva, a proposito di Andrea Memmo, che era stato eletto procuratore di San Marco sei anni prima: "Il Memmo non ha più barca, è ridotto a miseria" (21). Il Nani ha giudicato invece troppo rosea la situazione finanziaria di sei Case, inserendole nella classe III: almeno un membro di ciascuna di esse, e a volte più d'uno, aveva fatto domanda per ottenere un sussidio di povertà, una "provvigione patrizia", e per lo più gli uomini di queste Case si erano uniti in matrimonio con donne di famiglie povere (22). In tutti questi casi siamo rimasti fedeli alla classificazione del Nani, nonostante i dubbi sorti sulla sua esattezza.
Si può dare una risposta affermativa anche alla seconda domanda, vale a dire se la classificazione di Giacomo Nani possa venir estesa a tutto il Settecento e anche alla seconda metà del Seicento. Confrontando i redditi di novantotto Case, così come risultano dalle redecime del 1661 e del 1711, con la loro classificazione da parte di Nani è risultato che solo in tre casi la situazione finanziaria era notevolmente cambiata (23). Molti altri indizi fanno supporre che a quell'epoca la mobilità socioeconomica nelle Case patrizie fosse molto debole. Giacomo Nani aveva avuto una specie di predecessore nell'autore anonimo del trattato sulla Repubblica veneta del 1664, il quale aveva compilato un elenco delle "prime teste della Republica" e uno delle Case più facoltose. Dove è possibile identificare le più di cento "prime teste" come appartenenti alle Case prese in considerazione dal Nani, risulta che al massimo due di esse provenivano da Case della classe IV e nessuna dalla V; circa ventiquattro "prime teste" appartenevano alla classe I e qualcuna di più alla II e alla III. In cima alla lista delle "casate facultose dell'antica nobiltà" questo autore aveva collocato sette delle "famiglie assai ricche" del Nani (classe I) e i Badoer S. Moisè (classe II del Nani); per illustrare le "ricchezze nella nobiltà nuova" aveva menzionato i Widmann (classe I), i Labia (classe II) e quattro Case appartenenti alla classe III (24). Fra gli elenchi del Nani e quelli del trattato del 1664 si riscontra quindi una fondamentale coincidenza.
Se dalla convergenza di ricchezza e potere politico, dimostrata senza ombra di dubbio per la seconda metà del Settecento, si può trarre la conclusione che anche coloro che in passato avevano rivestito le più alte cariche statali ed ecclesiastiche provenivano da Case ricche, se ne possono ricavare ulteriori testimonianze di come la classificazione del Nani possa venir applicata al secolo precedente. Cominciamo con l'ufficio più alto, quello del doge. I trenta dogi eletti dopo il 1612 provenivano da venticinque Case diverse, cinque delle quali si erano già estinte all'epoca in cui il Nani scriveva; dodici delle altre appartenevano alla I classe, quattro alla II e quattro alla III. Dopo l'elezione di Carlo Contarini (1655-1656) accadde un'unica volta che venisse eletto doge un membro della classe III (Alvise Contarini 1676-1684) (25). Dati molto simili si riscontrano anche nel caso della seconda carica in ordine di prestigio. I procuratori di San Marco eletti dopo la guerra di Candia provenivano da novantasette Case, ottantadue delle quali ancora esistenti all'epoca in cui il Nani compì la sua classificazione. Egli attribuì trentanove di queste ultime alla classe I (47,6%) e altrettante (rispettivamente sedici e ventitré) alla II e alla III. In centocinquanta anni esatti questa carica venne affidata solo quattro volte a membri di Case più povere. Ma in parte anche queste quattro eccezioni alla regola di eleggere a questa carica, per i loro meriti politici o economici nei confronti della Repubblica, solo nobili provenienti da Case ricche (in tempo di guerra la carica poteva venir acquistata) sono solo apparenti in quanto fra loro si trovano il già menzionato Andrea Memmo, la cui Casa era stata classificata erroneamente dal Nani, e il famoso Zorzi Pisani che, pur provenendo da una Casa molto povera, l'8 marzo 1780 aveva conquistato la carica di procuratore come capo di una fronda di patrizi poveri in seguito ad una elezione di protesta politica (26). Queste poche eccezioni, vere o solo apparenti, infirmano solo minimamente la constatazione che, anche nel secolo precedente al Nani, i dogi e i procuratori di San Marco in pratica provenivano sempre da Case che egli più tardi classificò fra le molto ricche o le ricche. Solo quattro delle quarantaquattro "famiglie assai ricche" non potevano vantare neanche un doge o un procuratore di San Marco fra quelli eletti rispettivamente dal 1612 o dal 1645. Come vedremo anche i savi grandi venivano regolarmente scelti fra i membri delle famiglie del patriziato ricco.
Nella gerarchia ecclesiastica la predominanza delle Case ricche venne interrotta da occasionali eccezioni. Appartenevano alla classe IV due dei dieci patriarchi di Venezia, tutti nobili, che si erano susseguiti dal cardinale Federico Corner (1630-1644), che era figlio, fratello e prozio di dogi, a Federico Giovanelli (1776-1800): Pietro Barbarigo (1706-1725) e Alvise Foscari (1741-1758). Tutti gli altri erano di estrazione più agiata. Fra il 1647 e la caduta della Repubblica vennero eletti cardinali venticinque veneziani, tutti di famiglia patrizia; tranne un'unica eccezione essi provenivano tutti da Case di dogi e di procuratori o comunque da Case che il Nani considerava ricche (classi I-III).
L'unico cardinale fuori dell'ordinario fu Zuanne Battista Rubini, membro di una Casa aggregata nel 1646 e appartenente alla classe IV, insignito della porpora cardinalizia da papa Alessandro VIII, figlio del cancelliere grande Marco Ottobon che aveva anch'egli acquistato il patriziato nel 1646. Evidentemente era necessario che la Repubblica crollasse perché anche un patrizio molto povero, o per meglio dire un ex patrizio, potesse aspirare alla porpora, come Pietro Antonio Zorzi nel 1803 (27).
Dall'altra parte non mancano testimonianze per verificare che le Case collocate dal Nani alla base della piramide erano veramente povere e lo erano già da tempo. Dal punto di vista dei contemporanei, alla "gente [...] per povertà disperata" appartenevano i "candiotti", vale a dire quel centinaio di patrizi, appartenenti a circa trenta famiglie, che si erano rifugiati a Venezia in seguito alla guerra di Candia (28). Quattordici delle quindici Case "candiotte" comprese nella lista del Nani sono classificate fra quelle "che non hanno niente"; alla classe III sono attribuiti solo i Querini S. Giustina, una delle quattro Case cui spettava il titolo ereditario di cavaliere della stola d'oro. A Venezia esisteva già da secoli la consuetudine di soccorrere i nobili poveri assicurando loro modeste sinecure o concedendo ad essi delle pensioni. In seguito alla situazione di acuto bisogno creatasi dopo la guerra di Candia vennero istituite due forme di beneficenza, che andarono soprattutto a vantaggio della nobiltà povera: le "grazie dei cento uffici" (pure e semplici sinecure) e le "provvigioni patrizie", così chiamate a causa dei loro principali beneficiari, vale a dire pensioni di Stato regolari e in genere pagate a vita. Se si opera una distinzione fra le Case i cui membri, per lo più di sesso femminile, avanzavano eccezionalmente od occasionalmente una supplica al doge per venire a godere di una di queste agevolazioni e le Case i cui membri lo facevano invece spesso o regolarmente, si vedrà che nel Settecento il 13,6% delle Case apparteneva ad un gruppo e il 13,9% all'altro. Quattordici delle ottantasei Case del secondo gruppo appartengono alla classe IV del Nani, sessantanove alla classe V. Ciò significa che più della metà delle Case (54,3%) che Nani aveva classificato fra quelle "che non hanno niente" erano effettivamente così povere che parecchi dei loro membri, o addirittura la maggioranza di essi, avevano assoluto bisogno dei soccorsi pubblici (29).
Da tutto ciò si può trarre la conclusione che il Nani aveva analizzato con grande correttezza il corpo aristocratico; e si può anche affermare che il quadro da lui abbozzato può venir esteso nelle sue linee essenziali all'intera epoca compresa fra la guerra di Candia e la caduta della Repubblica. In tutti quegli anni sembra che solo pochissime Case avessero subito un vero e proprio declassamento dal punto di vista finanziario, ma ancora più rari, molto probabilmente, furono i patrizi che riuscirono ad innalzarsi da condizioni meschine e a raggiungere la ricchezza e l'influsso politico. Uno dei pochi cui riuscì questo pezzo di bravura fu Francesco di Zuanne Grimani S. Girolamo, "un povero svizzerotto" (in seguito classe III), che, grazie al matrimonio contratto nel 1647 con una cittadina, fu in grado di concorrere alle costose cariche di podestà di Vicenza e di Verona e ad avanzare nella gerarchia fino a savio grande e a procuratore di San Marco "per merito" (30). Anche i Bollani (nel 1750 appartenenti alla classe II), le cui rendite si erano quintuplicate fra la redecima del 1661 e quella del 1711, a partire dal 1720 si insediarono stabilmente in senato e nelle cariche assegnate da questo organo, alle quali avrebbero potuto aspirare solo eccezionalmente in precedenza, quando, secondo i criteri del Nani, appartenevano ancora al patriziato povero (31). Questi casi di ascesa economica e politica, che probabilmente furono anche qualcuno in più, erano troppo rari per poter parlare di mobilità all'interno del patriziato. In realtà, prescindendo dalle proverbiali eccezioni, un patrizio al di sotto dei "mezzani" non poteva sperare di cancellare per meriti personali il marchio della sua nascita povera e di assurgere alle più alte cariche della Repubblica. Ciò che ancora legava i membri del corpo aristocratico era in sostanza solamente quell'astratta "parità che core fra loro, parità coetanea a la nascita", vale a dire il diritto di seggio e di voto in maggior consiglio; ma questa parità era stata già da tempo sopraffatta da tali e tante "disuguaglianze [...] fra i nobili" che si può tranquillamente parlare di una società nobiliare divisa in classi senza peccare di anacronismo.
Le case patrizie non si differenziavano fra loro solo in base alle loro "fortune" e al loro influsso politico, che era in stretta relazione con le fortune stesse, ma anche in base all'età, cioè alla durata della loro appartenenza al corpo aristocratico. Le vecchie cronache e anche la storiografia più recente hanno dato grande importanza alla rivalità fra i casati più antichi e quelli un po' meno antichi, vale a dire fra quelli dei "Longhi" e quelli dei "Curti". Nel Quattrocento tali conflitti sarebbero stati ancora tanto virulenti che le famiglie dei Curti si erano accordate per escludere i membri dei Longhi dal dogato, cosa che sarebbe loro anche riuscita sino all'anno 1612 (32). Sia questa rivalità che quella fra le famiglie aggregate al patriziato prima della Serrata e quelle aggregate dopo la guerra di Chioggia non avevano più la minima importanza all'epoca in cui gli oneri finanziari connessi alle guerre contro i Turchi resero inevitabile mettere in vendita per 100.000 ducati il diritto di essere accolti in maggior consiglio. Fra il 1646 e il 1718 più di centoventi famiglie approfittarono di questa possibilità. La guerra di Candia non era ancora finita e già si parlava di una "nobiltà nuova" e di "famiglie nuove" in opposizione alle "case vecchie" e alla "nobiltà antica" e del contrasto fra "nobili vecchi" e "nobili nuovi"; solo pochi anni più tardi Amelot de la Houssaie sosteneva che i primi avrebbero provato "une horrible antipathie contre les nouveaux" (33). In questi passi con "nuove famiglie" si intendono evidentemente tutte quelle aggregate dopo il 1645 e con "vecchie" tutte quelle che appartenevano alla nobiltà già in precedenza. Nel 1797 Giovanni Pindemonte operò una suddivisione leggermente diversa: "Havvi in Venezia un'odiosissima distinzione oligarchica tra vecchie Famiglie e Famiglie nuove. Le prime quelle son che esistevano alla serrata del M.C. [...]. Son le seconde quelle Famiglie che o per prezzo o per iscelta, nelle varie aperture del libro d'oro si sono alla Nobiltà Veneta di tempo in tempo aggregate". Secondo la definizione del Pindemonte andrebbero annoverate fra le famiglie nuove anche quelle aggregate dopo la guerra di Chioggia e in diversi momenti nel corso del Tre e Quattrocento (34). Nel Sei e Settecento l'"antipatia" fra le Case vecchie e nuove si manifestò in primo luogo e quasi unicamente nelle diverse probabilità di conquistare le più alte cariche dello Stato. Da questo punto di vista non avevano più la minima importanza le vecchie rivalità fra Longhi e Curti ed è certo che anche i membri delle famiglie aggregate dopo la guerra di Chioggia non subirono alcuna discriminazione. Perciò in questa sede chiameremo "vecchie" tutte le famiglie che facevano parte della nobiltà prima del Cinquecento e "nuove" quelle aggregate dal 1646.
Non senza una certa amarezza personale, del tutto giustificata dalla sua appartenenza ad una delle ultime famiglie aggregate (1782), Giovanni Pindemonte affermava che le vecchie famiglie "per istolida consuetudine si sono sempre sopra le nuove una certa superiorità conservata, e alcuni posti di onore e di autorità in ogni tempo hanno a se medesime riserbati". Solo in anni recentissimi, essendo diminuito il numero delle vecchie famiglie e aumentato quello delle nuove, i "posti onorevoli" sarebbero diventati accessibili anche ai nuovi nobili, i quali ora avrebbero potuto diventare consiglieri ducali, membri del consiglio dei dieci, procuratori di San Marco e persino dogi; comunque nessuno di loro sarebbe stato ancora eletto alla più importante carica politica, quella del savio del consiglio. Effettivamente a metà del Settecento i nuovi nobili erano ancora molto rari in senato e fra i consiglieri ducali e non erano affatto presenti nel consiglio dei dieci; solo trent'anni dopo, invece, occupavano queste cariche nelle stesse proporzioni dei nobili vecchi (35). Per molto tempo i nuovi nobili avevano potuto raggiungere la dignità più alta della Repubblica dopo il doge, quella di procuratore di San Marco, solo acquistandola oppure grazie alla loro parentela con un papa; questo discriminante stato di cose cessò solo nel 1763 con l'elezione di Ludovico Manin, che, come è noto, fu il primo doge appartenente a una Casa nuova e l'ultimo doge in assoluto. Tuttavia fino alla fine i vecchi nobili non fecero la benché minima concessione riguardo alla più importante roccaforte del loro potere, il saviato del consiglio. Pertanto nell'analizzare come fosse distribuito il potere politico all'interno del patriziato occorrerà tener conto non solo delle fortune, ma anche dell'età di una Casa.
Il "depauperamento" del maggior consiglio
Non appena i Veneziani, con la pace di Passarowitz, ebbero definitivamente concluso gli scontri armati con i Turchi, le "sacre porte" del maggior consiglio si richiusero davanti a nuovi aspiranti. Di questa occasione, l'ultima per lungo tempo, di venire accolti nel patriziato avevano tratto profitto durante la guerra altre otto famiglie, le ultime due delle quali, i Grassi e gli Zini, vennero accolte nel patriziato solo nel giugno 1718, quando le trattative di pace stavano già per concludersi. I patrizi stessi e il largo pubblico poterono rendersi conto delle dimensioni raggiunte nel frattempo dal corpo aristocratico consultando l'almanacco della nobiltà pubblicato l'anno seguente con il titolo Nomi, cognomi, età, de' Veneti Patrizj viventi, e de' genitori loro defonti, con croce distinti. Matrimonj, e figli d'essi nel Libro d'Oro registrati. [...] Opera che sarà annualmente migliorata, come pure corretta, e rimodernata. Questi almanacchi (il primo dei quali aveva già visto la luce nel 1715) in effetti non uscirono tutti gli anni, ma pur sempre almeno diciotto volte fra il 1719 e il 1758 e dopo questa data ogni anno, come supplemento al "Protogiornale [...] ad uso della Serenissima Dominante Città di Venezia". Dal confronto fra l'almanacco del 1719 e quello del 1796 si ricava che solo trecentosessantanove delle seicentoventidue Case esistenti all'inizio del secolo (59,3%) assistettero alla caduta della Repubblica. Nello stesso periodo il numero dei patrizi al di sopra dei venticinque anni, età legale per l'ingresso in maggior consiglio, era diminuito da milleottocentoquaranta a milleduecentoquarantacinque (36).
Naturalmente neanche ai contemporanei rimasero celati il continuo assottigliamento del corpo aristocratico e l'estinzione di più di tre case all'anno in media, anche perché di quando in quando gli almanacchi pubblicavano elenchi sempre più lunghi delle famiglie estinte. Tuttavia sembra che i patrizi stessi non abbiano rivolto una grande attenzione a questo fenomeno né che se ne siano preoccupati fino al 1775, quando i cinque correttori delle leggi eletti l'anno precedente presentarono in maggior consiglio la proposta di procedere ad una nuova aggregazione di quaranta famiglie nobili della Terraferma che disponessero di una rendita annua di almeno 10.000 ducati, proveniente da beni legati da fedecommessi. Nicolò Balbi, storico della Correzione, addusse come motivo di questa inattesa proposta "il depauperamento palesemente da non molti anni successo del Maggior Consiglio". Nonostante le gravi perdite demografiche subite dalla fine dell'ultima aggregazione, la proposta di legge dei correttori fu accolta dapprima da una quasi "universale disapprovazione". Con parole suadenti e quasi imploranti i correttori cercarono di far capire ai loro avversari che una nuova aggregazione era "necessaria alla sussistenza della Repubblica" per "preservar intatta la Costituzione del Governo", e che per compiere questo passo non si poteva aspettare che fosse troppo tardi e che "il Corpo politico della Repubblica [...] ridotto fosse all'estremità della naturale sua decadenza". Il maggior pericolo insito nel "deperimento", nella "decadenza" del maggior consiglio era quello del "dominio dei pochi", del "potere de' pochi". Le "Istorie delle Repubbliche antiche e moderne" cadute "vitime della forza, della violenza, della oppressione" - da Atene, Roma e Firenze, fino agli esempi più recenti della Corsica e della Polonia - dimostravano a che rischi si esponesse il governo repubblicano "qualora mancante fosse del sufficiente numero de' Cittadini". Il correttore Alvise Emo S. Simeon Piccolo (classe III) scongiurò i suoi ascoltatori di rendersi conto dei pericoli che minacciavano la Repubblica dall'interno: "[...] il tenue numero de' suoi Cittadini, piuttosto che conservar l'Aristocrazia del suo Governo, precipitata l'avrebbe nell'Oligarchia, cioè nel poco numero de' grandi e potenti, che in pochissimo corso di tempo avrebbe del tutto esclusa l'altra molto più numerosa de' piccoli, quali non avrebbero più potuto ressistere alla forza, et alla violenza de' primi" (37).
Gli avversari della aggregazione proposta sostennero invece che i milletrecento o i millequattrocento (su questo punto non erano completamente d'accordo) individui capaci al maggior consiglio sarebbero stati "sufficentissim[i] per tutte l'esiggenze del publico governo". Cattarin Corner S. Cassan (classe I) affermò che, se davvero fossero scarseggiati i "Cittadini per tutte coprire le pubbliche esterne Rappresentanze", si sarebbe dovuto minorare il numero di queste ultime anziché "superfluamente introdur fra Patrizi tanti nuovi individui"; inoltre propose un "altro espediente" per "rimediare alla mancanza de Cittadini atti a sostenere i pesi de Regimenti", e cioè di "togliere il danosissimo abuso, già da qualche tempo introdotto, ma in presente di troppo impudentemente espanso delli molteplici falsi Collarini Ecclesiastici, col delusorio mezzo de quali tanti de più comodi, et anzi opulenti Cittadini rinunciando agli onori, e prerogative del Patriziato, si sottragono ancora dal prestar alcun benché minimo serviggio alla Patria". Un altro avversario, Antonio Diedo S. Fosca (classe III), invecchiato nell'ufficio di savio grande, nel suo interminabile discorso espresse addirittura la speranza "che da qui a venti anni susseguenti vi sarà maggior numero de Cittadini, mentre se si estingueranno venti, o trenta Famiglie, che hanno in adesso uno, o due soli individui, tante altre più fatte maggiormente comode, e facoltose dalle eredità delle estinte, più agevolmente potranno intraprendere de matrimonj, e collo stabilimento delle loro Case moltiplicare la propagazione, et il numero al Maggior Consiglio" (38).
Obiezioni del genere non avevano nulla a che vedere con la situazione reale, tant'è vero che persino dopo la pace di Passarowitz erano state raddoppiate alcune "esterne rappresentanze", ad esempio il posto di tesoriere ad Udine e quello di camerlengo a Vicenza, per procurare un ufficio ed un salario a dei nobili poveri; e ci si guardava bene dall'eliminare reggimenti di indubbia inutilità. Non corrispondeva alla realtà neanche l'affermazione che "in presente" sempre più nobili avrebbero abbracciato lo stato ecclesiastico per sottrarsi ai loro doveri di "cittadini" (39). E già i contemporanei avranno sorriso sull'ingenuità dell'idea che l'eredità delle Case estinte andasse a vantaggio dei patrizi desiderosi di sposarsi e li incoraggiasse a mettere al mondo dei figli. Che non ci si peritasse di far ricorso agli argomenti più logori purché la proposta dei correttori non venisse accettata, dipendeva anche dal fatto che nella lunga storia del maggior consiglio non si era mai verificata un'aggregazione di nuove famiglie per motivi unicamente demografici. Molti patrizi avranno sicuramente ritenuto che accettare un'aggregazione di questo tipo equivalesse in pratica ad abbandonare il principio della nobiltà ereditaria. I primi a dover insistere sull'intransigente difesa di questo principio erano proprio i patrizi poveri, in quanto solo così si poteva giustificare il fatto anomalo che dei nullatenenti non solo avessero voce in capitolo, ma addirittura la maggioranza all'interno di un'istituzione cui era affidata "la somma autorità di tutta la Repubblica" (G. Contarini). Una prima votazione fallì "per mancanza del numero", ma alla fine i correttori riuscirono a far accettare la loro proposta, anche se con una maggioranza tutt'altro che schiacciante (quattrocentoquindici sì, duecentosettanta no, sessantuno "non sinceri"). L'enorme perdita di prestigio subita dalla Repubblica e dalla sua classe dirigente dopo Passarowitz è rivelata dal fatto che la dignità di nobiluomo veneto, che un tempo veniva agognata e pagata 100.000 ducati, ormai appariva desiderabile a ben pochi. In base alla decisione del 19 marzo 1775 vennero aggregate non quaranta, ma solo dieci famiglie della Terraferma. Decisamente troppo poche per arrestare il depauperamento del maggior consiglio, tanto più che nel 1796 partecipavano attivamente alla vita politica solo nove uomini provenienti da queste famiglie (40).
È tutt'altro che certo che, come hanno affermato anche alcuni storici, la rarefazione degli individui capaci al maggior consiglio costituisse veramente un pericolo per il governo aristocratico e che vada considerata come un sintomo del suo declino. Quantomeno non si può ignorare la diagnosi assai diversa di alcuni patrizi, tutti "mezzani". Non pubblicamente, ma in scritti che si guardarono bene dal pubblicare, essi indicarono il numero troppo elevato dei patrizi e quella che già Traiano Boccalini intorno al 1600 aveva definito "la sproporzionata disuguaglianza di ricchezze" come i due veri malanni di cui soffriva la Repubblica (41). Per Nicolò Donà S. Fosca, che scrisse negli anni Trenta del Settecento, due fra i principi fondamentali di un governo aristocratico erano che "dee esser composto da un numero moderato di persone" e che "non dee passare molta differenza fra le loro facoltà". Nel caso di Venezia entrambi i postulati non gli sembravano soddisfatti, dato che il maggior consiglio era popolato da "un'intiera Cittade" e che le quattro "classi" di "proceri", "benestanti", "meccanici" e "plebei" erano divise da una "perniziosissima e fatale differenza di facoltà". Tanto Nicolò Donà quanto Giacomo Nani, che stese le sue riflessioni alcuni anni più tardi, erano preoccupati soprattutto per la polarizzazione fra "estrema povertà" ed "eccedente ricchezza", che minacciava di spaccare l'unità del corpo aristocratico. Entrambi riflettevano su come si potesse "minorare" il numero dei "plebei" e porre un freno alla strapotenza dei "proceri" dividendo le Case più ricche. Le loro opinioni erano condivise anche da un altro "mezzano", Leopoldo Curti, che solo pochi anni prima dello scioglimento del maggior consiglio lo considerava ancora troppo numeroso. In questa circostanza e nella "extrême inégalité dans les fortunes" delle famiglie patrizie egli vedeva "le principalvice du gouvernement vénitien". Dal punto di vista di questi patrizi il danno più grave per il corpo aristocratico non era la lenta scomparsa dei suoi membri, ma l'indebolimento di quella classe di cittadini di cui uno Stato, come insegnava già Aristotele, ha maggior bisogno per il suo benessere.
Una schiacciante conferma dei loro timori è offerta dalle cifre relative alla composizione del corpo aristocratico. Mettendo da parte le cento Case abbondanti che si estinsero fra il 1719 e il 1750 e considerando solo quelle attribuite dal Nani ad una delle sue cinque classi, si ottiene il seguente risultato: fra il 1719 e il 1796 la classe III perse duecentoquaranta individui capaci al maggior consiglio, le due prime classi ne persero insieme centosessanta e la IV un centinaio, mentre la classe V, sebbene contasse trenta Case in meno, ne guadagnò almeno cento (42). Pertanto il peso relativo delle singole classi cambiò radicalmente.
Mentre le prime quattro classi subirono tutte perdite più o meno gravi, fra l'8,5% (classe IV) e il 38,5% (classe II), i "plebei" aumentarono il loro peso relativo del 65%. Insieme ai patrizi un po' meno poveri della classe IV, essi, che all'inizio del secolo erano stati ben lontani dall'avere anche una maggioranza semplice, alla fine del secolo stavano per raggiungere una maggioranza di due terzi. Il fatto che il corpo aristocratico in questo arco di tempo avesse perso due quinti delle Case elencate nell'almanacco del 1719, ma solo un terzo scarso dei suoi uomini adulti, va attribuito quasi completamente alla forte espansione demografica di una minoranza di Case povere e alla nascita, per divisione, di un buon numero di nuove Case povere le quali tuttavia in questa sede vengono calcolate insieme a quelle da cui si erano scisse.
A volte i patrizi riconobbero le cause del declino demografico del loro ceto con maggior acume di alcuni storici moderni. Il fatto che fra la fine del Cinquecento e la fine del Settecento la popolazione aristocratica si fosse dimezzata viene attribuito da alcuni storici ad una drastica diminuzione della fertilità e da altri alla diminuzione della frequenza dei matrimoni, già iniziata nel Cinquecento. La prima ipotesi è senz'altro errata in quanto una riduzione della fertilità si verificò non prima del Settecento e rimase a lungo tanto modesta da non poter avere influenzato, se non in minima misura, la diminuzione del corpo aristocratico che era invece iniziata già da tempo. La seconda spiegazione si può appoggiare sul fatto che il numero dei matrimoni contratti annualmente dai patrizi si era dimezzato fra il Cinque e il Settecento. Tuttavia la popolazione nobile era già in diminuzione nel Cinquecento, quando il numero dei matrimoni era ancora alto il doppio. I cambiamenti verificatisi nella frequenza dei matrimoni (vale a dire nel numero dei matrimoni contratti su ogni mille uomini patrizi al di sopra dei venticinque anni) erano di entità assai minore rispetto a quelli del numero assoluto dei matrimoni. Fino alla fine della guerra di Candia la frequenza dei matrimoni rimase pressoché invariata, fatta eccezione per occasionali sbalzi, poi diminuì fortemente per cinquant'anni e ricominciò a crescere costantemente dopo la pace di Passarowitz. Nella generazione precedente al 1797 essa aveva di nuovo raggiunto i livelli del primo Cinquecento (43). Questo risultato paradossale - costante calo della popolazione nobile, tanto in un'epoca in cui venivano contratti molti matrimoni quanto in un periodo di crescente frequenza dei matrimoni - suggerisce l'ipotesi che i patrizi per tutto l'arco di questi tre secoli abbiano contratto un numero di matrimoni troppo basso per mantenere al corpo aristocratico le imponenti dimensioni raggiunte nel Rinascimento.
Il primo - e finora l'unico - ad esprimere questa opinione evidentemente giusta, e cioè che una limitazione dei matrimoni deve essere stata praticata non a partire dalla prima età moderna, ma già dal tardo Medioevo, fu Piero di Zuanne Garzoni. Quest'ultimo, che visse novant'anni, fu trentaquattro volte savio grande, fu storiografo pubblico e generò otto figli, nel 1725 scrisse che "le ῾sacre porte del Maggior Consiglio' sarebbero potute rimanere chiuse, se non avesse attecchito anche a Venezia ῾l'uso dannevole introdotto nel decimoquinto secolo dal demonio in Italia, che nelle case nobili un solo per lo più si destini alle nozze'" (44). Anche a prescindere dalla esatta datazione del calo dei matrimoni, questa asserzione è degna di nota per un altro motivo ancora. Nel riflettere sui destini demografici della loro classe, sempre che vi riflettessero sopra, i patrizi, proprio come Garzoni, prendevano in considerazione solo il comportamento matrimoniale dei loro simili e ignoravano completamente tutte le altre variabili demografiche. Non dobbiamo stupircene, infatti, dal loro punto di vista, poteva dipendere solo da troppo pochi matrimoni il fatto che una Casa dopo l'altra si estinguesse e che il maggior consiglio si rimpicciolisse costantemente. Sembra che non passasse loro neanche per la testa l'idea che da alcuni matrimoni potessero anche non nascere dei figli maschi, o che questi potessero non raggiungere la maggiore età. Che i figli venissero loro donati o tolti precocemente, non dipendeva da loro, ma esclusivamente dalla Divina Provvidenza.
Inoltre alcuni patrizi si rendevano acutamente conto del fatto che le famiglie dei ricchi fossero le più rigide nel praticare la limitazione dei matrimoni e pertanto le più esposte al rischio dell'estinzione. Zuanne Antonio Muazzo lo osservò già alla fine della guerra di Candia (45). Nel corso del Settecento i "mezzani" compresero con sempre maggior chiarezza che gli uomini della loro classe rifuggivano dal matrimonio ancor più dei ricchi, mentre i patrizi poveri si sposavano senza remore. All'inizio degli anni Trenta, all'ancor giovane Bernardo Nani sfuggì una prognosi assai pessimistica: "Ora si vedono i principi di qualche mutazione nel governo. I poveri nobili si moltiplicano, tutti si maritano, tutti figliano. Nei richi rarissime volte più d'uno per casa per conservar indivisibile il patrimonio, per esser sempre potenti di ricchezze; onde moltiplicandosi tanto i poveri, che sono esenti per lo più dalle cariche, eccetto le più basse, delle quali i maggiori non si degnano, potrebbero far cambiamento". Qualche anno dopo anche il fratello minore di Bernardo, Giacomo Nani, constatò con preoccupazione che i patrizi poveri avevano l'abitudine di far sposare tutti i loro figli; ma, con più acume del fratello, Giacomo osservò anche che coloro che si sposavano con minor frequenza non erano i ricchi, ma i "mezzani". All'epoca in cui egli già riteneva inevitabile il tramonto della Repubblica, osservò con rassegnazione che "la classe dei medi [aveva] preso il partito di lasciar estinguere le proprie famiglie" (46). Nel 1775 un altro "mezzano", il correttore Lodovico Flangini, sostenne la necessità di permettere l'accesso di nuove famiglie al maggior consiglio con l'argomento che la "Classe intermedia", essendo "la più aliena da matrimonj", andava rinforzata per mezzo di una aggregazione; ciò si sarebbe reso necessario perché "l'estreme ricchezze, accolate in una Classe de Cittadini, l'estreme disgrazie, opprimenti l'altra Classe, facevano si, che frà di loro fossero estremamente disgregate, rimote, e disgiunte, se la terza Classe per fortuna intermedia non li congiungesse, accostando se stessa all'una, et all'altra" (47). Queste osservazioni di patrizi che si erano dedicati anima e corpo al servizio dello Stato, come in particolare il Garzoni e i due fratelli Nani, colpiscono esattamente nel segno, colgono in pieno i problemi demografici che la nobiltà si trovava ad affrontare nel Settecento. Alcuni patrizi erano profondamente scossi dalla diminuzione degli individui capaci al maggior consiglio e dal pericolo che ne derivava, cioè che il governo aristocratico potesse degenerare in oligarchia. Altri invece vedevano nel depauperamento del maggior consiglio un problema più qualitativo che quantitativo: l'assottigliamento della "classe intermedia" minacciava di spezzare in due il corpo aristocratico, e il moltiplicarsi dei nobili poveri comportava il pericolo che essi un giorno potessero provocare un "cambiamento", una "mutazione nel governo". Potremo verificare quanto fossero fondati tali timori, ma per prima cosa occorre cercare di stabilire quanto incidessero sull'entità della popolazione nobile le variabili demografiche finora trascurate: migrazione, fertilità, mortalità.
Bisogna occuparsi brevemente anche della migrazione in quanto, sebbene la nobiltà sia una classe a cui si appartiene per nascita, poteva anche accadere che delle persone vi accedessero o ne uscissero per altre vie che non quelle della nascita e della morte. Un tipo di immigrazione era dovuto all'aggregazione di nuove famiglie. Negli anni di guerra compresi fra il 1646 e il 1718 acquistarono l'accesso al patriziato centoventitré famiglie che, in seguito ad alcune scissioni, formarono ben presto centotrenta Case (48). Quindi il numero complessivo delle Case aumentò temporaneamente di un buon quinto; tuttavia il guadagno demografico - che non era stato lo scopo di quelle aggregazioni - fu piuttosto modesto. Infatti i nobili nuovi contrassero solo un matrimonio su otto fra tutti quelli notificati dal 1646 all'avogaria di comun (gli unici da cui potevano nascere i futuri membri del maggior consiglio). E solo cinque furono gli uomini provenienti dalle famiglie aggregate in seguito al decreto del 1775 che fecero registrare i loro matrimoni nel Libro d'oro entro il 1797. Questa particolare forma di immigrazione poté dunque solo rallentare un poco il declino demografico del patriziato, ma non riuscì ad arrestarlo. Un'emigrazione vera e propria, nel senso dato comunemente a questo termine, sembra non essersi verificata affatto. Alcuni patrizi, soprattutto membri della nobiltà nuova, risiedevano più o meno stabilmente fuori Venezia, e forse alcuni di essi non si dettero la pena di far registrare le loro nozze e la nascita di figli maschi dall'avogaria di comun; eppure dalla metà del Seicento non risulta che il patriziato abbia perso anche una sola Casa a motivo dell'emigrazione. Molto più importante dell'emigrazione in senso proprio era invece un'altra forma di separazione dal corpo aristocratico, praticata da tutti i patrizi che, nel disprezzo delle prescrizioni di legge, omisero di notificare i loro matrimoni e le nascite dei figli maschi all'avogaria di comun e in tal modo esclusero per sempre la loro discendenza dal corpo aristocratico. Le conseguenze di questa trascuratezza furono paragonabili a quelle di una emigrazione: nel secolo successivo al 1719 il patriziato perse in questo modo un decimo delle Case.
Per illustrare il punto seguente, cioè la fertilità dei coniugi patrizi, di cui si è tanto discusso, dapprima faremo ricorso ad un esempio. Nel 1746 Gasparo Gozzi, per entrare nelle grazie di Michiel Grimani S. Maria Formosa (classe II), dedicò la sua Medea alla moglie di quest'ultimo, Pisana Zustinian Grimani, "feconda madre / di graziosa e tenerella prole" (49). La "feconda madre" proveniva dalla Casa Zustinian Lolin (classe II) e, all'inizio del 1736, a poco più di vent'anni, era andata sposa al Grimani, proprietario di due teatri veneziani. All'epoca in cui le venne dedicata la tragedia dell'antica infanticida, Pisana aveva già dato alla luce otto figli e due anni dopo ebbe un altro maschietto, che però morì in fasce, come la primogenita. Fra le patrizie di quei tempi una madre di nove figli era tutt'altro che un'eccezione; caso mai era insolito il fatto che alla sua morte, avvenuta nel 1763, ben sette dei suoi figli fossero ancora in vita. Quasi un terzo delle nobildonne sposatesi nella prima metà del Settecento mise al mondo nove o più figli; in media queste madri avevano fra i sei e i sette figli (50). Nella generazione successiva al 1730, quella in cui si verificò il matrimonio di Pisana e in cui nacque la maggior parte dei patrizi che popolavano il maggior consiglio alla fine della Repubblica, la fertilità delle coppie patrizie diminuì solo di poco (neanche un figlio in meno, in media). Peraltro non disponiamo di alcun indizio che avvalori la tesi di un cosciente e sistematico tentativo di limitazione delle nascite. Il mezzo allora più efficace e più diffuso per limitare le nascite era quello di rimandare il matrimonio, ma nel patriziato veneziano non veniva praticato a tale scopo. Effettivamente fra la seconda metà del Seicento e la seconda metà del Settecento l'età nuziale delle nobildonne veneziane si alzò di tre o quattro anni (un po' meno per le spose di famiglie ricche), tuttavia le patrizie che si sposavano solo a venticinque o addirittura a trent'anni non avevano in media neanche un figlio in meno di quelle che si erano sposate più giovani di cinque o dieci anni.
Il fatto che nel Settecento nessuna delle popolazioni nobili europee avesse una prole più numerosa di quella veneziana dipese in buona parte dall'abitudine delle madri patrizie di non allattare i figli, se non in casi eccezionali. In conseguenza di ciò gli intervalli intergenesiaci di queste madri, fino al penultimo parto, in media non erano più lunghi di sedici o, al massimo, di ventiquattro mesi; i più frequenti intervalli fra due parti (fino all'ultimo figlio) erano di tredici, quattordici o sedici mesi. Non è possibile che le nobildonne ignorassero che la probabilità di una nuova gravidanza è assai più alta per una madre che non allatta che per quelle che allattano a lungo e regolarmente. Nelle costumanze matrimoniali veneziane risiede probabilmente uno dei motivi del fatto che le nobildonne, o più esattamente i loro mariti, rimanessero fedeli alla vecchia consuetudine di affidare i figli ad una balia anche in un'epoca in cui gli illuministi vedevano nella madre che allatta la quintessenza della vera maternità. Infatti nella maggior parte delle famiglie, soprattutto in quelle ricche, nel Settecento si era ancora soliti affidare ad un unico figlio il compito di garantire la successione. Per riuscire in questo intento, il figlio designato prendeva in moglie una donna molto giovane e cercava di averne molti figli, sperando che in tal modo almeno uno dei maschi raggiungesse l'età virile e potesse provvedere alla successione. Le balie erano un'istituzione normalissima non solo nelle famiglie ricche - ad esempio, come testimonia un quadro di Pietro Longhi, nella casa del doge Carlo Ruzzini, allora da poco scomparso - ma anche in famiglie tanto povere da dover far ricorso ad una provvigione patrizia per poter pagare la mercede alla balia, come quella di Bortolo Antonio di Nicolò Pisani S. Vidal (classe V) o quella di sua sorella Chiara, che aveva sposato un patrizio altrettanto povero (51).
La mobilità geografica del patriziato era tanto alta che solo pochi nobili morirono nella stessa parrocchia in cui erano nati o nella quale avevano fissato la loro residenza dopo il matrimonio. Una famiglia patrizia su due abitava in affitto, circostanza che favoriva un frequente cambiamento di domicilio e che non riguardava solo i nobili poveri, ma anche molte famiglie ricche che disponevano di un palazzo proprio, ma preferivano affittarlo ad altri (52). Inoltre abitavano fuori città, per lo più per sedici mesi o per due anni, tutti i patrizi a cui venivano affidati reggimenti sulla Terraferma o nello Stato da Mar, spesso anche più volte consecutivamente; circa duecentocinquanta patrizi erano sempre lontani da Venezia. Perciò nella maggior parte di questi casi non si conoscono né il luogo né la data della loro morte, e di quella delle loro mogli e dei loro figli; di conseguenza finora non è stato possibile calcolare esattamente la mortalità del patriziato veneziano. Tuttavia esistono indizi sicuri del fatto che la mortalità dei patrizi, e soprattutto quella delle madri, dei lattanti e dei bambini piccoli, continuò ad essere molto alta anche quando le guerre sanguinose e le epidemie di peste appartenevano ormai al passato (53). Un quarto dei matrimoni non durava neanche quindici anni, in tre casi su quattro a causa della morte prematura della moglie; probabilmente una madre su tredici, se non una su dodici, moriva in seguito ad una gravidanza o ad un parto.
In mancanza di statistiche esatte, valga un esempio ad illustrare quanti rischi corressero soprattutto i bambini più piccoli. Flaminio di Zuanne Battista Corner S. Cancian (classe III), il grande storiografo delle chiese di Venezia e di Torcello, nel suo testamento steso nel 1777, all'età di ottantacinque anni, fece un bilancio demografico della sua Casa: "Di cinque figli dattimi e conservati in vita dal Signore tre hanno abbracciato lo stato religioso, cioè Don Giovanni Pietro Antonio monaco Camaldolense, Domina Maria Adelaide e Domina Maria Ediltrude, monache Benedittine in S. Zaccaria [...]. Al secolo mi restano due figli maschi, Giuseppe Maria e Tomà, a' quali s'uniscono due figli maschi de ser Tomà [...] et in oltre due figlie femmine dello stesso N.H. ser Tomà una di nome Margherita, et altra Paolina" (54). Quest'ultima nipotina, che allora aveva un anno, morì già cinque mesi dopo e ancora più piccoli erano morti altri due figli di Tomà. Flaminio aveva tutte le ragioni di insistere tanto sui figli che gli erano rimasti o che il Signore aveva conservato in vita. Infatti nove dei suoi quattordici figli, cinque femmine e quattro maschi, erano morti prima di compiere i cinque anni. Il figlio scapolo, Giuseppo Maria, morì dieci anni dopo e quindi la Casa sopravvisse solo nei figli di Tomà. Certamente la mortalità dei lattanti e dei bambini non era sempre così alta (come dimostra ad esempio "la tenerella prole" di Michiel Grimani e Pisana Zustinian), ma a volte lo era anche di più, tanto che in alcune Case non sopravviveva nessun maschio, sempre che ne fossero nati, per garantire la successione. I Corner S. Cancian sono un esempio tipico, e quindi rappresentativo per la maggioranza delle Case, dell'incoscienza con cui i patrizi continuavano ad affidare la sopravvivenza della Casa al matrimonio di un unico figlio. Pertanto questa famiglia si presta ad illustrare il fondamentale problema demografico del patriziato. Infatti l'estinzione di una metà abbondante delle Case fra l'inizio del Settecento e quello dell'Ottocento fu dovuta in primo luogo ad un colossale errore di calcolo demografico: i patrizi sottovalutavano enormemente le disgrazie e gli incidenti demografici di cui poteva restar vittima una Casa che ritenesse sufficiente a garantire la sopravvivenza della sua linea maschile un solo matrimonio in ogni generazione, o tutt'al più due. È incomprensibile come essi potessero essere letteralmente ciechi di fronte al pericolo della morte, che era sempre in agguato anche nei loro palazzi e si portava via un gran numero dei loro figli prima dell'età adulta. Sembra che i patrizi si rifiutassero di trarre qualsiasi insegnamento da queste esperienze quotidiane che si ripetevano invariabilmente in ogni generazione. Quantomeno non ne trassero l'unica conseguenza che sarebbe stato loro concesso di mettere in pratica, e cioè di sposarsi di più.
Da qualche tempo i demografi storici sono arrivati a capire ciò che ancora era assolutamente ovvio per un Malthus, e cioè che l'entità, la crescita, il ristagno e la diminuzione delle popolazioni della prima età moderna non dipendevano tanto dalla fertilità né dalla mortalità, a prescindere dalle gravi crisi demografiche, quanto dalla nuzialità. Pertanto, riguardo ad altre popolazioni, ci si è chiesti quante donne si sposassero e a che età lo facessero, dato che in sostanza il numero dei bambini nati in una generazione dipendeva da queste due variabili. Invece per il destino demografico del patriziato veneziano non era decisiva la nuzialità femminile bensì quella maschile. Infatti si era patrizi veneziani per nascita solo se il proprio padre apparteneva a quella classe, mentre il ceto della madre non aveva alcuna importanza a questo riguardo, fatta eccezione per vistosissime mésalliances. Da un punto di vista puramente teorico, per l'entità del corpo aristocratico era assolutamente indifferente che le nobildonne si sposassero tutte o che non se ne sposasse nessuna. Contava solamente il numero dei matrimoni dei nobiluomini, ed inoltre che la donna presa in moglie rispondesse ai precetti della legislazione nobiliare e che il matrimonio venisse registrato dall'avogaria di comun (55). Quest'ultimo punto, che in altre inchieste demografiche non avrebbe la minima importanza, è invece fondamentale per i matrimoni del patriziato veneziano.
Allo scopo di conservare "pura et immaculata" la nobiltà cittadina, dall'inizio del Cinquecento i patrizi erano tenuti a notificare le loro nozze e le nascite di figli maschi all'avogaria di comun, in modo che tali eventi potessero venir registrati a imperitura memoria nel Libro d'oro delle nascite e dei matrimoni. Il vincolo matrimoniale di un patrizio che non avesse avuto l'approvazione degli avogadori di comun non era legittimo dal punto di vista della legislazione nobiliare; almeno dopo la metà del Seicento non è mai avvenuto che dei figli nati da matrimoni non registrati abbiano ereditato la nobiltà del padre (56). Ogni patrizio che non faceva registrare il suo matrimonio sapeva benissimo che cosa ciò avrebbe comportato per i suoi figli; purtuttavia non furono pochi coloro che privarono in tal modo la loro prole della nobiltà paterna. Dalla fine del Seicento alla definitiva chiusura del Libro d'oro, cioè fra il 1696 e il 1801, vennero registrati dall'avogaria duemiladuecentotrentacinque matrimoni (57), mentre circa cinquecento altri matrimoni non le furono notificati; pertanto da un matrimonio su cinque o su sei non sarebbe mai potuta nascere una nuova generazione di nobiluomini. I matrimoni non validi dal punto di vista del diritto canonico e alcuni discussi matrimoni clandestini, in totale non più di una dozzina, non incidono quasi affatto sui matrimoni non registrati; due terzi di tutti gli altri matrimoni canonicamente irreprensibili ma non validi civilmente erano stati celebrati segretamente col permesso del patriarca di Venezia, e un terzo con il normale rito religioso. Circa nella metà di tutte le Case accadde, una volta o più volte, che un matrimonio canonicamente valido non venisse fatto registrare.
Alcuni sposi patrizi avevano validi motivi di mantenere segreto il loro matrimonio, o perché la donna che intendevano sposare non rispondeva alle condizioni poste dalla legislazione nobiliare, o perché temevano le critiche e i pettegolezzi a causa della loro età avanzata o dell'età della sposa, o perché supponevano che i loro parenti avrebbero cercato di impedire le nozze. Ma per la maggior parte dei matrimoni segreti non sono riconoscibili motivi del genere. Sembra piuttosto che centinaia di patrizi abbiano in un certo senso abusato dell'istituzione del matrimonio di coscienza, non ricorrendovi "ex gravissima et urgentissima causa", ma per evitare le conseguenze civili e soprattutto quelle del diritto ereditario che un matrimonio reso pubblico avrebbe comportato. Non sorprende che i patriarchi abbiano concesso con la più grande generosità la loro autorizzazione a matrimoni che avevano lo scopo di salvaguardare gli interessi delle famiglie patrizie e la conservazione del patrimonio in un'unica linea. Però i matrimoni segreti - e anche gli altri matrimoni non notificati all'avogaria - erano un'arma a doppio taglio, in quanto vi si poteva far ricorso non solo nell'interesse della famiglia, ma anche per sposarsi senza l'autorizzazione o contro la volontà dei genitori, per emanciparsi dalla patria potestà e per liberarsi dalle pesanti catene della ragione di famiglia. In casi limite la mancata registrazione di un matrimonio poteva mettere in gioco persino la sopravvivenza di una famiglia e la sua appartenenza al patriziato.
Si può calcolare con una certa precisione quante Case abbia perso il corpo aristocratico a causa di questi mariti dimentichi dei loro doveri nei confronti dello Stato, ma si può invece solo intuire l'entità del danno demografico complessivo da loro arrecato. Da alcune delle nozze non registrate era praticamente impossibile che nascessero dei figli a causa dell'età già avanzata degli sposi, e proprio per questo motivo essi avevano scelto il rito segreto. Ma, d'altra parte, la mancata notificazione poteva proprio essere dovuta al timore che nascessero dei figli aventi diritto all'eredità e che si potesse verificare una scissione della Casa. Probabilmente nel desiderio di evitare la nascita di un ramo collaterale va visto il motivo principale per cui, dalla metà del Seicento, in un quarto scarso delle Case ancora esistenti nel 1796 tutti i matrimoni che potevano mettere in pericolo la sopravvivenza della Casa in un solo ramo non furono fatti registrare. Un gran numero di indizi permette di supporre che non tutti i matrimoni non registrati (e i concubinati) dei patrizi fossero stati infecondi, ma che anzi da essi fossero nati non solo femmine (la cui esistenza ci è nota nel caso che esse avessero sposato un patrizio), ma anche maschi, che però non avevano diritto né al titolo di nobiluomo né al seggio in maggior consiglio (58). Per fare solo un esempio, Piero Antonio di Marc'Antonio Querini S. Lunardo (classe II) privò i suoi due figli di questi diritti perché omise di notificare all'avogaria di comun il matrimonio contratto nel 1745 con una donna non nobile, Matilda di Alessandro da Ponte. Conosciamo l'esistenza di uno dei figli, Stefano, solo perché egli venne ritratto nel 1772 da Pietro Longhi e dell'altro, Alessandro, perché è menzionato sul retro del quadro stesso. Pietro Longhi eseguì anche un ritratto della madre ed uno della loro sorella Marina, che era nata nel 1757, si era sposata a vent'anni con Piero di Vettor Benzon, ne aveva avuto un figlio che ai suoi tempi fu un celebre poeta, e teneva a Venezia uno dei più famosi salotti letterari, frequentato anche da Lord Byron (59).
Occorre infine tornare alla questione che anche alcuni patrizi consideravano determinante per il futuro demografico della loro classe già dal tardo Seicento, quella della frequenza troppo bassa dei matrimoni. Se è lecito generalizzare i risultati di un'analisi effettuata su un campione di duecentonovantotto famiglie (coniugali), per lo più ricche, se ne ricava il quadro seguente: fra il tardo Seicento e la fine del Settecento, dei trecentocinquanta figli maschi nati da queste unioni e vissuti sino ai cinquant'anni ed oltre, quasi la metà esatta (49,1%) contrasse un matrimonio registrato dall'avogaria di comun, altri ventidue (6,3%) si sposarono, ma non notificarono le loro nozze, trentasette (10,6%) scelsero lo stato ecclesiastico; dei rimanenti centodiciannove, di cui non conosciamo lo stato civile, si può supporre che fossero rimasti celibi. Quindi la metà di questi patrizi, fra i quali i poveri erano molto pochi, non contrasse mai un matrimonio da cui sarebbero potuti nascere individui capaci al maggior consiglio. Pertanto la quota dei patrizi regolarmente coniugati anche dal punto di vista civile era notevolmente più bassa che in altre popolazioni nobili europee. Quote di celibato molto simili o quasi identiche a quelle calcolate per Venezia si riscontrano invece negli uomini di altri due patriziati cittadini, quelli di Milano e di Firenze (60), che vivevano anch'essi principalmente delle loro rendite, come i nobili veneziani delle classi I, II e III. Si può quindi trarre la conclusione che in un determinato tipo di società nobiliare la rigorosa limitazione dei matrimoni era il sistema preferito per mantenere unito il patrimonio famigliare e per conservare una posizione eminente.
L'influsso di una quota di celibi così alta sulla sopravvivenza del totale delle Case si può valutare approssimativamente chiedendosi quanti fossero in media i figli maschi di un padre che si sposavano e che facevano registrare il matrimonio nel Libro d'oro.
Già durante il primo periodo, e ancor più durante il secondo, dal totale dei matrimoni non proveniva, in media, neanche un figlio regolarmente sposato; ciò significa che, presupponendo che la fertilità e la mortalità fossero rimaste costanti, nell'intero periodo il corpo aristocratico dev'essere stato in diminuzione, dapprima in modo quasi impercettibile e poi sempre di più, a causa di una frequenza dei matrimoni troppo bassa. A prima vista le differenze fra le cifre relative alle Case ricche e alle Case povere possono sembrare modeste, ma in realtà esse significano che nelle case dei ricchi durante il primo periodo si sposava in media il 15% in meno dei figli rispetto a quelle povere, e durante il secondo addirittura il 25,1%.
I valori medi riportati nella Tab. 3 appena analizzata, rivelano che già durante il primo periodo (nel quale vennero concepiti i figli che raggiunsero l'età virile nella prima metà del Settecento) dal 18,7% dei matrimoni dei patrizi ricchi non provenne nessun figlio regolarmente coniugato e dal 67,9% solo uno. Il rimanente 13,4% delle coppie ebbe due o tre figli sposati. Queste cifre dimostrano chiaramente che la grande maggioranza delle Case ricche si era imposta la regola di far sposare solo un figlio per ogni generazione. Il fatto che nel 13,4% dei casi se ne fossero sposati due o rarissimamente anche tre (2,6%) non significa affatto che tutti questi matrimoni fossero superflui. Molti di essi infatti si erano resi assolutamente necessari per la sopravvivenza della Casa in quanto dal matrimonio del primo figlio sposato non erano nati figli maschi. Per spiegare il fatto inquietante che il 18,7% dei matrimoni di patrizi ricchi non avesse avuto discendenza maschile coniugata, occorre riprendere in esame le duecentonovantotto famiglie di cui si è già fatta menzione e di cui conosciamo in tutti i particolari i destini demografici. In settanta di queste famiglie (23,5%) nessun figlio notificò il suo matrimonio all'avogaria di comun. Ed eccone i motivi: diciannove coppie ebbero solo figlie femmine; in ventisette famiglie l'unico maschio o tutti i maschi erano morti bambini; in dodici casi i figli maschi erano ancora celibi a ventotto anni (età nuziale media degli uomini; alcuni si sposarono solo dopo il 1797); i figli di sette coppie lo erano ancora a cinquant'anni suonati e pertanto possono venir considerati come scapoli impenitenti. In un caso tre dei maschi avevano scelto lo stato ecclesiastico e gli altri tre erano rimasti celibi. Nelle ultime quattro famiglie, infine, qualche figlio si sposò, ma nessuno notificò il suo matrimonio all'avogaria di comun.
Presupponendo che quei figli di dodici coppie che erano ancora scapoli a ventotto anni avessero avuto l'intenzione di sposarsi più tardi e di notificare il loro matrimonio all'avogaria di comun, ma non abbiano potuto farlo essendo morti prima, oppure a causa della caduta della Repubblica, rimangono solo dodici famiglie (4% del totale) ai cui figli sembra esser stato indifferente il destino della propria Casa. E neanche questi ultimi possono venir tutti accusati di aver avuto tale atteggiamento. Infatti, nonostante il rifiuto del matrimonio, due di queste Case sopravvissero ugualmente grazie a rami collaterali. Anche ai tre figli ecclesiastici di Faustin di Francesco Maria Zustinian (classe III) non si può rivolgere tale rimprovero, in quanto all'epoca in cui avevano pronunciato i voti non potevano sapere che nessuno dei loro fratelli si sarebbe sposato. Altri patrizi, rinunciando a prender moglie, si saranno detti che alla Repubblica gli uomini non erano mai mancati (come alcuni sostennero con veemenza in maggior consiglio persino nel 1775) e che i figli che non sarebbero nati da loro sarebbero stati generati da un altro nobiluomo della loro Casa o del loro casato o di un altro casato. Quando però si era in molti a pensarla così poteva accadere facilmente ciò che si verificò nel casato degli Zustinian, che era ampiamente ramificato: nel corso del Settecento si estinsero cinque dei suoi nove rami. Non riusciremo mai a far luce sui motivi personali che indussero singoli patrizi a scegliere il celibato, laico o ecclesiastico, oppure un matrimonio non riconosciuto dalle leggi dello Stato. Invece le cause che furono determinanti per la sopravvivenza o per l'estinzione delle Case nel loro complesso si possono riconoscere in buona parte già dalla forma assunta dai loro alberi genealogici.
I testamenti rivelano senza ombra di dubbio che quando un obbediente rampollo di famiglia patrizia si addossava "il peso del matrimonio", lo faceva per garantire la "successione della casa". Tuttavia servire la propria Casa non significava solo contrarre almeno un matrimonio per generazione, ma anche rinunciare ai matrimoni superflui. Sposarsi era come passare lo stretto tra Scilla e Cariddi: da una parte era in agguato il pericolo dell'estinzione della Casa, dall'altra incombeva la minaccia della scissione in più linee della Casa e del patrimonio. Evidentemente i patrizi temevano questa seconda eventualità almeno quanto la prima e quindi ridussero i loro matrimoni notificati al minimo fisiologico. Nella metà delle Case ancora esistenti nel 1797, nell'arco di centocinquanta anni, non venne contratto neanche un matrimonio superfluo ai fini della sopravvivenza oppure non vennero fatti registrare nel Libro d'oro quelli superflui. Pertanto gli alberi genealogici di queste Case hanno una forma perfettamente diritta con qualche piccola escrescenza solo nelle generazioni in cui da un matrimonio non era nato il desiderato erede e quindi si era dovuto far ricorso a un secondo o addirittura ad un terzo matrimonio per garantire la successione. In altre Case (18%) si verificarono e furono registrati alcuni matrimoni superflui, che però, per un motivo o per l'altro, rimasero privi di discendenza. In una Casa su sette si verificò una scissione, temporanea o duratura, in due linee. Nei confronti del matrimonio, quindi, i membri di quattro quinti delle Case sopravvissute si erano imposti una ferrea disciplina, come del resto, probabilmente, quelli della maggior parte delle Case estintesi in precedenza, la cui fine spessissimo si dovette anche ad una troppo rigorosa limitazione dei matrimoni. Le Case, in gran maggioranza "plebee", nelle quali ci si sposava senza alcun freno costituivano solo una piccola minoranza, neanche il 10% di tutte le Case comprese nell'almanacco della nobiltà del 1719. Alla fine del presente contributo vedremo come l'offensiva demografica di un numero tanto piccolo di Case abbia minato il labile equilibrio fra le classi e deformato l'aspetto della piramide sociale patrizia.
Gli alberi genealogici della maggior parte delle Case erano esili arbusti, eternamente esposti al pericolo di spezzarsi e di morire. In tre quinti delle Case estinte nel secolo successivo al 1719 erano stati notificati all'avogaria di comun tutti i matrimoni contratti nell'ultima generazione. Ma anche l'obbedienza alle leggi non salvaguardava dagli imprevedibili disastri demografici: matrimonio sterile, nessun figlio maschio, morte precoce dei figli maschi, delle madri e dei padri. Gli uomini di alcune Case reagirono coraggiosamente a queste fatalità, provvedendo a contrarre un secondo ed eventualmente anche un terzo matrimonio; a sposarsi erano o il figlio rimasto vedovo, o uno dei suoi fratelli, a volte anche il padre o uno zio (61). Alcuni di questi tentativi furono coronati da successo, altri no. In un secondo gruppo di Case gli uomini si rassegnavano subito, al primo colpo del destino, e si consolavano con la coscienza di avere fatto il loro dovere di eredi, sposandosi almeno una volta. Ad un terzo gruppo di Case fu fatale la circostanza di non aver fatto registrare quei matrimoni che sembravano superflui all'epoca della loro celebrazione; i figli nati da questi matrimoni non erano in grado di fungere da sostituti se il "matrimonio di casa" aveva fallito il suo scopo. In un ultimo gruppo di settantaquattro Case - il 21,3% delle Case estintesi dopo il 1719 - non mancavano i figli maschi, uno o più, ma nessuno di essi fu disposto a sposarsi. Nel loro caso lo "spirito di famiglia" si era così affievolito da passare in seconda linea rispetto alle inclinazioni personali. L'ironia della sorte volle però che anche i patrizi nei quali era ancora vivo lo spirito di famiglia causassero l'estinzione di ulteriori Case sottoponendosi ad una troppo rigorosa disciplina matrimoniale.
I patrizi nella vita privata
Solo poche delle trecentocinquanta Case e più che assistettero alla caduta della Repubblica sono sopravvissute fino ai nostri giorni. Più duraturi sono stati invece i loro palazzi, "i quali noi [Veneziani] chiamiamo case per modestia, non avendo nome di Palazzo, altro che quello del Doge" (62). Le case dei patrizi, o i loro palazzi, come loro stessi a volte le chiamarono nel Sei e Settecento, e come oggi vengono normalmente definite, hanno suscitato spessissimo l'interesse degli storici e in particolare degli storici dell'arte. Sappiamo invece assai meno su ciò che accadeva dietro le loro facciate, su come si svolgeva la vita privata dei patrizi, a che forme di convivenza i membri delle singole Case davano la preferenza, che rapporti esistevano fra genitori e figli, fra padri e figli maschi, fra fratelli adulti.
Un viaggiatore francese, Joseph de Lalande, che aveva soggiornato in Italia nel 1765-1766, riassunse così quel che aveva appurato sulla vita famigliare dei patrizi: "Les familles vénitiennes sont ordinairement très-unies: les frères et les soeurs vivent ensemble, (même après avoir perdu leur père et leur mère) sans avoir de discussion d'intérêts, et même sans partager les biens de la famille, ce qui paroîtra extraordinaire à des François ". Il Lalande illustra il rapporto fra i fratelli per mezzo di un esempio fittizio che egli attribuisce ad una delle Case dei Mocenigo. Un padre di famiglia aveva lasciato alla sua morte tre figli e due figlie, una delle quali si era fatta monaca, mentre l'altra aveva sposato un giovanotto con un vasto parentado, "ce qui procure beaucoup de balles dans les élections, cela forme une relation d'intérêts entre les beaux-frères et leurs parens". La figlia sposata aveva ricevuto una dote adeguata ed aveva rinunciato al resto dell'eredità, mentre i tre fratelli erano rimasti insieme nella stessa casa e possedevano "en commun" i beni rimasti. Essi disponevano di un amministratore, spesso un ecclesiastico, che versava mensilmente a ciascuno di loro una certa somma per spese e domestici personali. Ordinariamente, testimonia ancora Lalande, non c'è che un maschio per Casa che si sposi, "alors ses frères lui cèdent une portion plus forte que la leur; si l'un est dans un emploi qui exige de la dépense, dans une ambassade, une place de podestà onéreuse, le surcroît de sa dépense est pris sur la masse commune, parce qu'il exempte ses frères de semblables charges: cette union est cimentée par le besoin qu'ils ont d'avoir beaucoup de voix dans le grand conseil, et par la nécessité d'employer une partie de leur fortune au service de la république. Le même esprit s'étend à toutes les familles depuis les plus opulentes jusqu'à celles qui le sont le moins" (63).
A prescindere dall'ultima affermazione, e cioè che tale modo di pensare sarebbe stato condiviso anche dalle famiglie meno abbienti, il Lalande fornisce una descrizione corretta della fraterna (senza peraltro citare il nome di questa istituzione), cioè del modo in cui la maggior parte delle famiglie patrizie era solita regolare gli affari finanziari e domestici. La fraterna, le cui origini risalgono ai primordi della storia delle città mercantili italiane, nel tardo Settecento era ancora così vitale che Marco Ferro le dedicò parecchie pagine del suo Dizionario del diritto comune e veneto. In primo luogo essa era una "compagnia [di] quei fratelli, che dopo la morte del comun padre continuarono la comunità dei beni, né fecero ancora le divisioni. Dura la medesima compagnia anche fra i nipoti e germani maschi fino a tanto che divengano alla divisione" (64). Il perdurare della comunione dei beni, che è dimostrato da centinaia di dichiarazioni dei redditi per le redecime e da innumerevoli testamenti, dipendeva principalmente dal fatto che i patrizi veneziani, a differenza della maggior parte delle altre società nobiliari dell'Ancien Régime, non adottarono mai il regime successorio, che privilegiava un unico figlio come erede, e rimasero invece fedeli al modello medioevale di divisione eguale fra tutti i figli maschi. Dal momento che tutti i figli godevano allo stesso modo del diritto ereditario si rendeva assolutamente necessario far sì che i figli vivessero in fraterna o quanto meno che si impegnassero a lasciare la loro quota di eredità paterna ai discendenti maschi di quel fratello che aveva contratto il "matrimonio di casa".
Dal punto di vista giuridico la fraterna forse non era altro che una pura e semplice comunione dei beni; ma coloro che ne facevano parte erano tenuti ad obbedire ad un codice ben più ampio, le cui leggi non scritte riguardavano anche gli ambiti più importanti e più intimi della vita dei membri di una Casa. L'appartenenza a una Casa organizzata in fraterna comportava il dovere di vivere insieme, di rinunciare all'indipendenza economica, di subordinare la decisione di sposarsi o meno agli interessi della Casa e di accettare sacrifici economici personali per permettere ad uno dei fratelli una carriera politica costosa, ma utile al prestigio della Casa. Pertanto fin qui, come si vedrà, il Lalande ha descritto correttamente la fraterna; l'ha vista invece in una luce troppo rosea affermando che fra i membri delle fraterne non si sarebbero verificati conflitti di interesse. La sua interpretazione andrà quindi modificata su questo punto e integrata da un altro importante aspetto sul quale salta agli occhi che egli sorvoli: la fase della vita famigliare in cui il padre era ancora in vita ed esercitava la patria potestà sui figli.
Un'occasione di esprimere le loro opinioni sulla fraterna era offerta ai patrizi dalla stesura dei testamenti, che comportava la riflessione sulla situazione attuale e sul futuro della loro Casa. Il testamento di Zuanne Battista di Bastian Venier S. Maria Formosa (classe III) illustra assai bene la vita condotta dai fratelli in una fraterna o, per meglio dire la vita che essi avrebbero dovuto condurre nelle intenzioni dei loro genitori. Zuanne Battista, il minore di due fratelli, aveva sposato nel 1726, all'età di trent'anni, la nobildonna Paolina Capello S. Lunardo (classe II), più giovane di lui di circa dieci anni. Tre dei loro sei figli erano morti poco dopo la nascita e la figlia Laura aveva preso il velo nel convento di Santa Lucia, quindi nel 1776, al momento della stesura del testamento paterno, vivevano in casa, oltre ai genitori, il figlio maggiore Bastian, celibe, e suo fratello Piero Girolamo, sposatosi nel 1766, con sua moglie e i suoi bambini. A detta di alcuni, questi ultimi sarebbero i bambini ritratti insieme ai loro precettori sotto al ritratto del doge Sebastiano Venier eseguito da Pietro Longhi (65). La situazione finanziaria dei Venier non imponeva particolari restrizioni, dato che già nel 1761, quando i membri della famiglia erano ancora di meno, essi si potevano permettere sei servitori, due "massere" e una gondola. Questo padre di famiglia si immaginava così il futuro della sua Casa, nella quale già da più di duecento anni non era stato celebrato alcun matrimonio superfluo: "Essendo il principale e ben giusto desiderio d'un padre, che vede con prole uno de' suoi figli da lui maritato, cioè che essi continuino in amorosa fraterna compagnia, ed unione de' beni, unico mezzo per cui, massime nelle famiglie patrizie, si può sostenere il decoro, ed aumentarne lo stato, perciò con tale doveroso, e salutare paterno oggetto, di tutti li miei beni [...] instituisco nominatamente ed egualmente miei eredi universali li carissimi miei figli ser Sebastiano, e ser Pier' Girolamo da me maritato col consenso anco e volontà di suo fratello, onde continuar debbano in amorosa fraterna compagnia, unione, e comunione de' beni, sicché in tal modo possano sostenere con egual impegno il decoro, ed aumentare il buon stato della famiglia. Dei suddetti Nobili Homini miei figli ed eredi il maritato ser Pier' Girolamo, a sollievo del fratello ser Sebastiano, che si dimostra alieno del tutto dalle domestiche cure e sollecitudini, doverà con amorosa fraterna intelligenza avere il peso dell'amministrazione di tutte le rendite della casa; avendo fatto pratica del foro col decoroso carico della Quarantia, e col frequente esercizio de' domestici affari, e perciò facilmente ed utilmente supplirà a tutti i pesi ed aggravj della famiglia colla direzione della medesima. Ciascuno di essi due fratelli doverà conseguire dalla cassa comune un'eguale mesata di zecchini sette; ed al N.H. ser Sebastiano, oltre la tavola comune, la solita sua servitù, e mesata, doverà essere pagata dalla cassa suddetta la gondola, ed un barcarolo, quando però lo stato economico della famiglia lo permetta con sufficiente aummento di rendite, poiché al presente la troveranno sbilanciata. [...] Come io non posso dubitare, che il N.H. ser Pier' Girolamo, avendo il premuroso impegno della discendenza, non sia per procurare possibilmente dal canto suo che mai seguano divisioni con N.H. suo fratello, così se questo volesse dividersi o dasse motivo di divisioni, contro la provida paterna espressa mia volontà, in questo caso ordino e voglio che, di tutta la sopraddetta mia facoltà, abbia il detto ser Sebastiano a conseguire la sola sua legitima nella quale lo istituisco mio erede; e di tutto il rimanente resti mio solo e libero erede il N.H. ser Pier' Girolamo al quale restano altresì tutti i pesi del matrimonio, e della casa, dando ad ambidue miei carissimi figli la paterna benedizione". Animata dallo stesso spirito del marito, tre anni più tardi fece testamento anche Paolina Capello e lasciò al figlio sposato due terzi e a quello scapolo un terzo del suo patrimonio, "e ciò col riflesso, che il primo ha il peso del matrimonio contratto di consenso della famiglia, e perché mi sembra giusto, e conveniente a sollievo degl'impegni maggiori che sostiene, di dover prediligerlo con qualche distinzione". In un codicillo aggiunto solo pochi giorni dopo la madre espresse il desiderio "che la mia famiglia stia sempre unita per gli oggetti d'una ben regolata economia"; in caso di separazione fra i due fratelli era sua ferma volontà "che se mai il detto N.H. ser Sebastian Venier mio figlio volesse dividersi dall'altro mio figlio, e suo fratello Gerolamo, o dalli di lui figli, in questo caso il detto ser Sebastian perda ogni diritto sopra la mia eredità, e decada da ogni beneficio della medesima, ed abbia solamente ad avere, e conseguire per titolo, e ragion di legato, e per una volta tanto la somma di ducati 200 correnti". Nonostante la caduta della Repubblica, almeno alcuni dei desideri e delle speranze di questi genitori vennero esauditi, dato che uno dei loro nipoti sposò nel 1810 una donna di nobiltà veneziana e che la famiglia continuò a risiedere nel palazzo degli avi presso Santa Maria Formosa (66).
Ritengo che sia lecito, anche dal punto di vista dell'epoca, considerare come una pretesa piuttosto pesante gli insistenti appelli rivolti da questi genitori ai due figli perché si assoggettassero in tutto e per tutto alle loro disposizioni in nome del "buon stato" e del "decoro" della famiglia. Infatti per il figlio maggiore, Sebastiano, vivere in "amorosa fraterna compagnia" significava rinunciare a sposarsi, in quanto il fratello minore si era già accollato "il premuroso impegno della discendenza"; entrambi i fratelli dovevano accontentarsi di una "mesata" prestabilita e tenere "tavola comune", e Sebastiano doveva rinunciare a disporre di una gondola e di un barcaiolo personale almeno fintanto che lo "stato economico" della Casa fosse rimasto "sbilanciato". Inoltre quest'ultimo doveva tollerare di essere soggetto, in un certo senso, al fratello minore, incaricato di provvedere alla "direzione" della famiglia e all'"amministrazione di tutte le rendite della casa". A sua volta Piero Girolamo aveva dovuto assoggettarsi à un matrimonio di famiglia, contratto "col consenso anco e volontà di suo fratello", e assumersi per tutta la vita l'onere di condurre i "domestici affari". Evidentemente entrambi i genitori consideravano realistica la possibilità che il figlio maggiore non accettasse queste disposizioni e perciò minacciarono di diseredarlo, in caso di disobbedienza, riducendo la sua eredità alla sola legittima e il lascito materno ad un legato di 200 ducati. Anche molti altri genitori presero nei loro testamenti disposizioni simili a quelle di Zuanne Battista Venier e di Paolina Capello, ed alcuni misero in pratica le minacce, diseredando un figlio disobbediente.
A volte pressioni di questo tipo, esercitate dai genitori approfittando della loro libertà di testatori, erano effettivamente necessarie per piegare i figli all'idea di vivere in fraterna; tuttavia sembra che in buona parte dei casi, se non addirittura nella maggior parte, i figli accettassero senza palese resistenza la fraterna, come una forma di vita codificata dalla tradizione e imposta dalla ragione di famiglia. Infatti, all'epoca del censimento del 1761, in tre quinti delle Case patrizie tutti gli uomini adulti vivevano ancora sotto lo stesso tetto, eccezion fatta per i chierici regolari. In tutti questi casi, pertanto, non v'era alcuna differenza fra la Casa in senso genealogico e la casa come palazzo e domicilio comune. Sembra quasi che i patrizi, dopo secoli, avessero ancora presente il monito di Leon Battista Alberti: "Vorrei tutti i miei albergassero sotto uno medesimo tetto, a uno medesimo fuoco si scaldassono, a una medesima mensa sedessono" (67). Perché non sorgano impressioni errate riguardo alle dimensioni e alla composizione dei ménages patrizi, occorre però ricordare che nel 1761 solo nel 42,3% dei ménages vennero censiti due o più "uomini da 18 fin 50" o "vecchi da 50 in sù". Poiché molti di questi "uomini" erano in realtà ancora figli giovanotti, i veri e propri ménages in fraterna, cioè quelli con due o più uomini veramente adulti (che avessero cioè superato l'età nuziale media di ventotto anni), saranno stati un terzo di tutti i ménages o ancora di meno. Ciò va attribuito alla precaria situazione demografica in cui si trovavano allora molte Case e che è rivelata dall'estinzione della metà di esse nel corso del Settecento. L'esclusione programmatica di matrimoni superflui e la rinuncia ad alcuni matrimoni indispensabili per la sopravvivenza della Casa avevano condotto ad un preoccupante sfoltimento di molti alberi genealogici. Da ciò deriva che spessissimo anche Case i cui appartenenti di sesso maschile vivevano tutti in un unico ménage costituissero in realtà solo famiglie coniugali semplici e, qualora nessuno dei figli avesse ancora compiuto i diciotto anni, venissero censite nel gruppo dei ménages con un solo uomo.
Quando però una Casa disponeva di più uomini in età adulta, essi rimanevano effettivamente fedeli in misura insolita per quei tempi all'uso secondo cui tutti i discendenti maschi di un antenato comune coabitavano in unico ménage. Almeno quattro uomini e vecchi erano presenti in un ménage su otto, e in più di due dozzine di casi risiedevano sotto lo stesso tetto cinque e più uomini (al massimo otto) che erano da tempo in età da potersi sposare o da poter metter su casa per proprio conto. Il vedovo Polo Renier (il futuro doge) nel 1761 viveva non solo insieme a suo figlio e ai suoi nipoti, ma anche ai suoi cinque fratelli, il più giovane dei quali si avviava alla quarantina. Nella Casa dei vicini, quella dei Bon S. Stae (classe III), coabitavano tre e cinque fratelli di due diverse generazioni, di età compresa fra i quarant'anni scarsi e gli ottanta abbondanti. Anche in Case più povere, ad esempio in quelle degli Avogadro e dei Marcello S. Maria Formosa (entrambe classe IV), accadeva che vivessero ancora in un unico ménage cinque fratelli che avevano da tempo raggiunto un'età in cui avrebbero potuto essere "capi di casa"; i primi vivevano con uno zio celibe, i secondi con i genitori.
Le tacite regole da cui dipendeva il fatto che una Casa fosse costituita da un solo ménage o da due, tre e più (al massimo sei o sette) si possono ricostruire facilmente esaminando quei due quinti delle Case che non coincidevano con un unico ménage. Due terzi di esse erano Case povere (classi IV e V), nelle quali evidentemente si era perso da tempo il senso dell'unità della Casa. In queste Case, gli uomini che avevano voglia di sposarsi non vedevano alcun motivo di rimanere scapoli o di contrarre un matrimonio segreto, non denunciandolo all'avogaria, solo per salvaguardare l'unità della Casa e del suo patrimonio. La preoccupazione di frantumare il patrimonio famigliare contraendo un matrimonio superfluo non li sfiorava neanche, in quanto le loro Case non disponevano o quasi di beni materiali. Gli almanacchi della nobiltà pubblicati alla fine del secolo, informati al tradizionale modo di pensare genealogico, continuavano a considerare come appartenenti ad unica Casa anche padri e figli o zii e nipoti che avevano contratto sei o più matrimoni, fondando altrettanti ménages a sé stanti, mentre in realtà ormai queste Case si erano smembrate in una quantità di famiglie singole. Essi avevano una casa nella quale abitavano, ma non più una Casa nel senso di una comunità famigliare comprendente più generazioni e a volte anche un ramo collaterale. Non nel significato attuale del termine, ma in quello della famiglia nobile, essi erano diventati persone "senza casa".
Tuttavia nel 1761 anche i membri di un buon numero di Case ricche - in tutto quarantadue, pari a una Casa su sei fra quelle delle prime tre classi - abitavano in ménages separati (68). Nella maggioranza dei casi è abbastanza facile riconoscere i motivi che li avevano spinti a non convivere con i loro parenti più stretti. In dodici di queste Case si erano sposati due o più fratelli in una stessa generazione, dando luogo a rami collaterali che naturalmente abitavano per proprio conto. In altrettanti casi si trattava di vedove che preferivano vivere in un proprio ménage e non con i loro parenti. In altri otto casi era stato un matrimonio segreto, clandestino o comunque non registrato, o una mésalliance, ad indurre un figlio, un fratello o un nipote a non coabitare con il resto della famiglia. Quindi, a prescindere dal fenomeno delle vedove che vivevano da sole, in tutti gli altri casi era stato un matrimonio superfluo o un "matrimonio a capriccio" a spezzare l'unità della Casa e a produrre un secondo ménage accanto a quello del continuatore della stirpe. I patrizi celibi, anche in età avanzata, si staccavano solo molto di rado da un ménage in fraterna. Per ovvi motivi abitavano da soli il patriarca di Venezia e il primicerio di San Marco; ma gli altri ecclesiastici, vale a dire anche tutti gli scapoli impenitenti che si fregiavano del titolo di abate, si separavano raramente dal resto della famiglia. I casi di patrizi celibi con un ménage a sé stante erano meno di dieci.
Questo risultato permette di stabilire le due regole fondamentali seguite dai patrizi nel costituire un ménage famigliare. La prima norma, seguita dai patrizi di tutte le classi, era in certo qual modo di natura negativa ed equivaleva al rifiuto della "frérèche": due o più fratelli coniugati o altri uomini sposati della stessa generazione non dovevano abitare sotto lo stesso tetto. Nelle Case dei patrizi ricchi probabilmente non esisteva neanche un caso di ménage multiplo in senso orizzontale. Il motivo è ovvio: la "frérèche" era in assoluto contrasto col senso di famiglia dei ricchi, orientato a conservare l'albero genealogico in un'unica linea; come si può ripetutamente osservare, i figli di padri ricchi che contraevano un matrimonio superfluo si affrettavano a fondare un proprio ménage. Allo stesso modo, ma per motivi completamente diversi, i ménages multipli di questo tipo erano evitati anche nelle Case dei patrizi poveri. Il secondo principio, cui obbediva la gran maggioranza dei patrizi ricchi e una minoranza di quelli poveri, era che tutti gli uomini di una Casa, eccezion fatta per quelli che avevano contratto un matrimonio superfluo, dovevano abitare sotto lo stesso tetto. Tale norma venne seguita dagli uomini di due terzi delle Case e dalla quasi totalità dei patrizi ricchi (69).
Secondo il Lalande, uno dei motivi, forse il più importante, che spingeva i patrizi a restare fedeli all'istituzione della fraterna nonostante le molteplici limitazioni della libertà personale che essa comportava, era "la nécessité d'employer une partie de leur fortune au service de la république". Proprio i testamenti dei ricchi patrizi dimostrano che le cose stavano effettivamente così. Anche l'ottantenne Lorenzo di Zuanne Correr S. Fosca pensava ai doveri nei confronti della patria e della salvaguardia della libertà, quando, nel 1707, pochi mesi prima della sua morte, ammonì i suoi tre figli "a contentarsi d'una mesata moderata, governando tutto il resto in fraterna con amore per procurar in tal forma d'andar avanzando qualche cosa da poter impiegar in servitio della Patria, e lustro della casa". I figli presero a cuore la paterna ammonizione, tant'è vero che il secondo (e in seguito anche un nipote) riuscì ad assurgere alla carica di savio grande, mentre il minore nel 1734 fu eletto patriarca di Venezia (70). Nel fare appello ai figli perché vivessero d'amore e d'accordo in una fraterna, i padri di famiglia erano mossi dalla convinzione che per dei fratelli viventi in comunione dei beni e sotto lo stesso tetto fosse più agevole adempiere ai doveri nei confronti della patria e della Casa. Il primo dovere nei confronti della Casa era quello di garantirle un erede maschio nato da un matrimonio valido a tutti gli effetti; inoltre, per aumentare il "lustro della casa", almeno uno dei figli doveva dedicarsi al "servitio della Patria". Invece evidentemente non era soggetto a regole fisse quale dei figli dovesse assumersi l'uno o l'altro compito, oppure amministrare il patrimonio famigliare, o abbracciare lo stato ecclesiastico. Infatti, sempre che una famiglia disponesse di più di un figlio maschio, il "matrimonio di famiglia" veniva contratto in egual misura dal figlio maggiore o da uno dei minori. Il compito di provvedere alla successione della Casa toccava ad un unico figlio, o a più fratelli l'uno dopo l'altro, se dal primo matrimonio non era nata la sperata discendenza; da questo punto di vista la fraterna prevedeva una rigida divisione delle competenze. Tuttavia colui che era destinato ad assicurare la successione non doveva necessariamente rinunciare ad una carriera politica. Tredici dei venticinque più eminenti uomini di Stato del Settecento (si intendono con ciò i patrizi che rivestirono più di quindici volte ciascuno la carica di savio grande) avevano contratto uno o più matrimoni necessari alla sopravvivenza della loro Casa; eppure dieci di essi avevano uno o più fratelli che, pur essendo celibi, dimostravano un minore impegno politico (71). Fra gli undici dogi del Settecento, cinque avevano contratto, molto prima della loro elezione, un "matrimonio di famiglia", dal quale però non sempre era nato il desiderato erede. Che un patrizio di famiglia ricca si dedicasse con grande impegno e con successo alla politica dipendeva soprattutto dalle sue inclinazioni e capacità individuali e non dall'essere primogenito o cadetto, coniugato o celibe. Con ciò si spiega probabilmente anche il fatto che in alcune famiglie tutti i figli fossero, chi più chi meno, politicamente attivi, come Polo Renier e i suoi cinque fratelli, mentre in altre famiglie si può constatare una vistosa differenza fra il grande impegno politico di un fratello e il disinteresse degli altri, come ad esempio fra i sei figli di Francesco di Antonio Savorgnan S. Geremia (classe I) (72).
Proprio nelle famiglie ricche o ricchissime il mantenimento della fraterna era anche una necessità finanziaria. Infatti erano necessarie le forze economiche riunite dell'intera Casa per mettere uno o più dei suoi membri in condizione di intraprendere una carriera che potesse culminare nelle cariche più alte. Chi voleva riuscire in politica di solito doveva avere assunto una o due volte durante il suo cursus honorum la reggenza di una delle grandi città della Terraferma, cosa che poteva costare facilmente alcune decine di migliaia di ducati. Chi poi, aspirando alle più alte cariche politiche, si faceva mandare come ambasciatore presso una corte straniera, doveva affrontare spese tanto forti da costringere persino le famiglie più ricche a riempirsi di debiti. La comunione dei beni era un mezzo per distribuire questi oneri finanziari fra più persone, rendendoli in tal modo sopportabili (73). Pertanto uno dei motivi della fedeltà serbata alla "compagnia fraterna" fino al 1797 da tante famiglie del patriziato ricco va visto nella costituzione repubblicana che imponeva ai "cittadini nobili", desiderosi di distinguere se stessi e le loro famiglie con l'assunzione delle cariche più elevate, oneri tanto gravosi da non poter essere affrontati da un singolo, ma solo grazie agli sforzi comuni di tutti i membri della sua Casa.
Per quanto interessante e curiosa potesse essere per i viaggiatori stranieri la sopravvivenza della fraterna, occorre però ricordare che a quell'epoca anche a Venezia la famiglia nobile era di tipo assolutamente patriarcale; al suo interno esisteva una particolarissima tensione fra gli elementi autoritaristici e quelli cooperativistici. Alla legislazione veneziana della fine del Settecento non erano affatto estranei i concetti, derivanti dalla tradizione del diritto romano, del "padre di famiglia, quello che trovasi alla testa e al governo di una famiglia da esso derivante" e dei "figliuoli di famiglia, che sono sotto la podestà e dipendenza del loro padre, o avo paterno". Alcune norme giuridiche citate da Marco Ferro rivelano quanto fosse ancora ampia la patria potestà: "Per le leggi Venete sono proibiti i contratti dei figliuoli di famiglia [...] senza il consenso de' padri, tutori, o commissarii". In altre parole, i figli non erano abilitati agli affari; un "figliuolo ingrato, e colpevole di altri delitti contro il padre" poteva venirne diseredato. Per chiarire quale modo di comportarsi di un figlio fosse tanto sconveniente da giustificare un provvedimento così grave, il Ferro aggiunge che era da considerarsi non valido agli effetti civili il matrimonio contratto da un figlio non ancora venticinquenne senza il consenso del padre, della madre, dei tutori e dei curatori, e che un testatore aveva il diritto di diseredare chi avesse contratto un matrimonio contro la sua volontà (74).
Un figlio poteva affrancarsi dall'autorità del padre o del tutore in tre modi: con l'emancipazione, con il semplice distacco dal padre o raggiungendo la maggiore età dopo la morte del padre. Nelle fonti settecentesche ci si imbatte solo di rado in figli di patrizi che si erano liberati dalla patria potestà per mezzo di un formale atto di emancipazione; erano invece abbastanza frequenti le "divisioni" fra padre e figlio o fra fratelli; a far uso di entrambe le possibilità legali di separarsi dalla casa paterna erano soprattutto i patrizi poveri. Nella maggior parte delle Case ricche vigeva invece la massima stigmatizzata da Cesare Beccaria: "Nella repubblica di famiglie i figli rimangono nella potestà del capo, finché vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una esistenza dipendente dalle sole leggi" (75). Solo al compimento del venticinquesimo anno di età i figli dei patrizi erano politicamente maggiorenni, vale a dire "capaci al Maggior Consiglio" e in grado di esercitare un ufficio giudiziario o amministrativo nelle province. Altrettanto a lungo dovevano aspettare, di solito, anche per poter accedere all'eredità del padre o di un altro testatore. A dir il vero, secondo le leggi veneziane potevano "essere sottoposti a commissaria i figliuoli, quantunque adulti e maggiori", ma la maggior parte dei testamenti prevedeva che un erede maschio potesse godere pienamente dell'eredità che gli spettava "nel giorno che incomincierà à votar nel Serenissimo Maggior Conseglio" (76). Come si legge in numerosissimi testamenti di padri, fino ai venticinque anni i figli dovevano rimanere soggetti ai "commissarii" da loro designati (spesso la madre, ma anche altri parenti al suo posto o accanto a lei) e essere esclusi dalla "direzione" della casa. Nella maggioranza delle Case ricche, il primo o l'unico matrimonio di un figlio si verificò quando il padre era ancora vivo; naturalmente in questi casi i figli rimasero "figli di famiglia" anche dopo essersi sposati e continuarono ad abitare, con moglie e figli, nella casa paterna.
Un esempio estremo del dispotismo con cui un padre poteva esercitare la patria potestà è offerto dal procuratore Zuanne di Polo Querini S. Maria Formosa (classe I). Quando gli venne in mente di destinare allo stato coniugale il suo terzogenito, Andrea, l'interessato ventenne apprese i progetti del padre dal direttore del collegio padovano in cui stava compiendo gli studi. Andrea scrisse subito al padre per chiedergli se si trattasse di uno scherzo o se il matrimonio fosse stato effettivamente combinato, dichiarandosi pronto, in quest'ultimo caso, ad obbedire "in tutto e per tutto alle disposizioni paterne". E in effetti, da figlio obbediente, Andrea sposò nel 1732 la donna che gli era stata destinata, ma si ribellò invece con fermezza al padre quando quest'ultimo decise di far sposare la nipote Pisana, figlia di Andrea, senza il benché minimo riguardo verso i desideri del padre di lei. Alle proteste di Andrea e di suo fratello Polo, che a quell'epoca erano entrambi già sulla cinquantina, il padre rispose sospendendo il pagamento della loro "mesata". Anche un altro fratello, Girolamo, aveva all'incirca la stessa età quando il padre lo privò a lungo della "mesata", a quanto sembra perché, contro la volontà paterna, voleva concorrere a cariche pubbliche che comportavano oneri finanziari per la famiglia. Oltre tutto in Casa Querini le mesate erano così esigue che il figlio di Andrea, Zuanne Antonio, già da uomo sposato, allungò le mani più di una volta sull'argenteria di famiglia per poter pagare i suoi debiti di giuoco. Inoltre lo stesso Zuanne Antonio dovette subire aspri rimproveri da parte di suo padre perché, quand'era ambasciatore della Repubblica alla corte madrilena, si era servito per la sua corrispondenza privata di carta da lettere di formato troppo grande, causando in tal modo superflue spese postali (77).
I tirannici soprusi subiti come figli di famiglia non impedirono agli uomini di Casa Querini di esercitare a loro volta un analogo dispotismo nei confronti dei propri figli. Quando fu tempo di destinare al matrimonio uno dei quattro figli di Zuanne Antonio perché provvedesse alla successione, gli interessati si chiedevano a vicenda chi di loro sarebbe stato il prescelto. Una volta presa la decisione, il più giovane scrisse al maggiore: "Alvise [il terzogenito] è poi destinato per lo sposo di casa, va benissimo, egli è paziente e saprà sopportare con flemma questo matrimonio. Mi si scrive che il nono è contento [...]. Mio padre è contento e tutti noi fratelli abbiamo dato volentieri il bene placet" (78). Se Alvise e suo nonno Andrea furono letteralmente costretti ad assumere il ruolo di "sposo di casa", se il procuratore Zuanne si arrogava il diritto di scegliere a suo piacimento il marito per una nipote, ci si può immaginare che nella scelta della moglie e del marito la libera volontà dei figli non avesse alcun peso. La validità di un matrimonio non dipendeva dal consenso dei genitori, tuttavia, fintanto che questi ultimi potevano legalmente diseredare un figlio che si fosse sposato contro la loro volontà, il diritto canonico della libera scelta del coniuge non era altro che una chimera. Almeno nelle famiglie ricche, osservanti della tradizione e attente al loro prestigio, si era soliti combinare i matrimoni. Nicolò di Andrea Giulio Corner S. Maurizio (classe I) che, non ancora ventenne, era rimasto vittima di una "combinazione" del genere, definì come "Matrimonio di Famiglia" il fatto di essere stato costretto, con un contratto matrimoniale stipulato due anni prima delle nozze, a sposare Marina Pisani, nipote del doge Alvise Pisani, nonostante fosse legato da "forti vincoli" a Maria di Piero Marcello S. Polo (classe I), la quale aspettava un figlio da lui (79).
In questo caso l'intervento della famiglia si era reso necessario in quanto Nicolò Corner, unico sopravvissuto di tre figli maschi, era in procinto di sposare una donna nata dal matrimonio non registrato di un patrizio di pessima fama, e pertanto, con questo passo, egli avrebbe provocato la fine dell'appartenenza al patriziato della sua Casa. Comunque non era solo per evitare tali vistose mésalliances che i padri e le madri si arrogavano il diritto di imporre un determinato coniuge ai loro figli. Dal punto di vista delle famiglie un'unione matrimoniale era un evento troppo importante perché si potesse affidare la scelta del coniuge agli interessati stessi. Infatti nel patriziato ricco un matrimonio non serviva solo alla sopravvivenza della Casa, ma anche ad allargarne il "parentado" e quindi a procacciarle un aumento di influsso politico e di prestigio. Ad una famiglia l'occasione di raggiungere tali scopi per mezzo di un'unione matrimoniale fra due Case non capitava più di due volte, in media, per ogni generazione, anche tenendo conto dei matrimoni delle figlie; tanto più importante era, quindi, non lasciarsi scappare nessuna di queste rare occasioni. In una Repubblica aristocratica, il maggior vantaggio che poteva derivare ad una famiglia dalle nozze di un suo membro era quello di allacciare stretti rapporti con una famiglia partecipe del potere politico, accrescendo in tal modo il proprio rango e il proprio influsso. Nella scelta del coniuge i figli e le figlie delle famiglie più eminenti, fintanto che fossero soggetti alla patria potestà o alla tutela di altre persone, erano meno liberi che in qualsiasi altro aspetto della vita. Forse era loro più facile rifiutare categoricamente lo stato coniugale che scegliersi liberamente un compagno. Per questo motivo, nel corso dell'intero Settecento, accadde un'unica volta che un matrimonio necessario alla successione della Casa venisse contratto fra un "grande" e una "plebea" (80). L'unico rampollo di una Casa della classe I che ebbe l'audacia di sposare una nobildonna della classe V fu Zuanne di Ferigo Corner S. Polo. Questo nipote di un doge poté permettersi tale libertà solo perché aveva avuto la disgrazia, o la fortuna, di rimanere orfano di padre all'età di dieci anni, ed era da tempo uscito dalla tutela della madre e dello zio nel 1757, anno in cui, seguendo i dettami del cuore, aveva sposato Orsola di Iseppo Maria Venier S. Agnese, appartenente ad una Casa tanto povera da dover far ricorso alle sovvenzioni statali. Sembra che Zuanne Corner si rendesse conto di quanto la sua scelta fosse disdicevole, tant'è vero che il matrimonio venne celebrato segretamente in casa del suocero e solo un anno e mezzo dopo fu notificato agli avogadori di comun perché lo registrassero nel Libro d'oro. Nelle famiglie patrizie di impostazione patriarcale e a volte governate dispoticamente si saranno verificati conflitti e tensioni, ma in sostanza, per quel che si può dedurre dai matrimoni dei "grandi", la patria potestà rimase intatta sino alla fine della Repubblica.
I patrizi nella vita pubblica
"Gli affari di questa Serenissima Repubblica sono amministrati dai nobili capaci al Maggior Consiglio; e perché sieno maneggiati con quella maturità e senno che meritano, furono determinate le varie età, che secondo l'importanza delle incombenze fossero le più convenienti" (81). Di norma i patrizi acquisivano il diritto di seggio e di voto in maggior consiglio all'età di venticinque anni; ma potevano accedervi già a vent'anni coloro che nel ballottaggio del giorno di santa Barbara avevano estratto una "balla d'oro". E anche nel Settecento veniva accordata la grazia di entrare in maggior consiglio prima dell'età di legge anche a molti altri, soprattutto a patrizi poveri che avessero già rivestito cariche minori militari o civili al servizio della Repubblica. A quell'epoca a più di un terzo dei patrizi (36%) era già stato affidato un incarico pubblico, una o più volte, prima del venticinquesimo compleanno. In due terzi di questi casi si trattava di patrizi appartenenti a Case delle classi IV e V (82). Certamente non tutti questi giovani funzionari, alcuni dei quali non avevano nemmeno vent'anni, erano membri del maggior consiglio; pertanto rimane una certa insicurezza sul numero dei membri di questo consesso. I nobiluomini dai venticinque anni in su (esclusi gli ecclesiastici) all'inizio del Settecento erano circa millesettecento; alla fine del secolo erano diminuiti a circa millecento, ma rimanevano pur sempre in numero doppio rispetto ai membri della camera dei comuni britannica.
Il maggior consiglio era necessariamente più numeroso di altri parlamenti in quanto non si trattava di un organo esclusivamente legislativo; il suo compito principale consisteva piuttosto nell'eleggere all'interno delle proprie file i membri degli altri consigli (quarantie, senato e zonta, consiglieri ducali, consiglio dei dieci) e circa la metà dei pubblici magistrati in carica fuori e dentro la città - dal maniscalco di Udine ai procuratori di San Marco e allo stesso doge. Il diritto di eleggere il collegio dei savi spettava al senato il quale inoltre eleggeva anche gran parte delle magistrature più importanti (83). Grazie a una minuziosa ricerca che abbraccia il periodo 1646-1797, condotta da Oliver Thomas Domzalski, sappiamo ora esattamente quanti nobiluomini fossero necessari per occupare tutti questi consigli e la miriade di cariche amministrative, giudiziarie e militari: a Venezia, oltre ai centocinquantadue uffici nelle quarantie (che comprendevano anche il consiglio dei venti e quello dei dodici), al maggior consiglio spettava l'attribuzione di altri ottantotto incarichi che, intorno alla metà del secolo, essendo stato nuovamente aumentato il numero delle vere e proprie sinecure, richiedevano l'impiego di circa trecento persone. Dopo il 1718 - a causa delle perdite subite nello Stato da Mar e di alcuni posti che talvolta rimasero vacanti per anni - solo circa centocinquanta patrizi occupavano cariche nei centoottantotto reggimenti, anche se in una buona dozzina di casi si trattava di cariche rivestite da due persone. Al senato, i cui membri avevano sempre anche un altro incarico, spettava la distribuzione di circa duecentocinquanta uffici regolari e di due o tre dozzine di incarichi occasionali. Un'altra ventina di cariche dipendeva dal consiglio dei dieci. Pertanto, per occupare tutti i seggi nei consigli e tutte le cariche pubbliche, occorrevano circa novecento patrizi, prescindendo da posti occasionalmente vacanti e dalle persone che rivestivano contemporaneamente più di un incarico (84). Trovare questi novecento patrizi idonei non sarà stato un grosso problema all'inizio del secolo, ma lo sarà stato probabilmente verso la fine. Infatti in ogni epoca ci furono anche patrizi che prendevano parte solo sporadicamente alla vita pubblica o che se ne astenevano completamente.
Di norma solo tre quinti dei patrizi di età superiore ai venticinque anni partecipavano alle votazioni in maggior consiglio. La metà di coloro che non comparivano ogni domenica in maggior consiglio era costituita dai duecento-duecentocinquanta patrizi che rivestivano un incarico fuori città e la cui assenza era quindi giustificata. L'altro gruppo, leggermente più numeroso, comprendeva coloro che si astenevano dalla vita politica. Contando anche i patrizi ecclesiastici, che a causa del loro stato erano esclusi dal maggior consiglio e da tutti gli altri uffici pubblici, circa un patrizio su cinque non rivestiva alcun incarico pubblico in tutto l'arco della sua vita. Negli altri quattro quinti, costituiti dai patrizi che nel corso della loro vita rivestirono almeno un incarico pubblico, erano in minoranza (43%) coloro che erano stati eletti da una a nove volte; la maggioranza (57%) era costituita da patrizi eletti dieci o più volte e che avevano avuto successo almeno nell'82,5% delle votazioni. Ovviamente la probabilità di venire eletti più o meno frequentemente a rivestire un incarico pubblico dipendeva anche dalla minore o maggiore longevità dei candidati. Pertanto il Domzalski ha calcolato dei "tassi di attività politica" dai quali risulta la frequenza con cui un patrizio eleggibile, a partire dai vent'anni di età, veniva eletto nel corso di un anno. Se non si tiene conto di quella quinta parte dei patrizi che si asteneva completamente dalla vita politica, risulta che ogni patrizio veniva eletto in media 0,54 volte all'anno. In altri termini, più facilmente comprensibili, ciò significa che tutti i patrizi politicamente attivi venivano eletti in media almeno una volta ogni due anni.
Poiché la durata di molti incarichi non era limitata a sei, dodici o sedici mesi, ma raggiungeva a volte i ventiquattro o i trentadue mesi - soprattutto nel caso di uffici e di reggimenti riservati ai patrizi poveri - una elezione che si verificava solo ogni due anni o ancora più raramente poteva significare che l'eletto ricopriva ininterrottamente una qualsivoglia carica (85). Ad esempio i "quarantiotti" partecipavano di rado ad elezioni, pur disponendo ininterrottamente di un incarico ben remunerato. Infatti un patrizio eletto nella quarantia civil nuova passava automaticamente dopo otto mesi a far parte della quarantia civil vecchia, poi della quarantia criminal e infine riceveva un altro ufficio (consiglio dei venti, collegio dei dodici, otto di rispetto). Per le quarantie non erano previsti periodi di astinenza (contumacia); pertanto un giudice di quarantia poteva riproporre la sua candidatura ogni trentadue mesi e trascorrere così in questo ufficio la maggior parte della sua vita. Un tipico "quarantiotto" fu, ad esempio, Candiano di Tranquillo Bollani alla Pietà (classe IV), morto nel 1786. Egli venne eletto solo ventitré volte, raggiungendo quindi un tasso di attività politica dello 0,42, vale a dire inferiore alla media. Poiché però era stato eletto diciotto volte alle quarantie, trascorse in questo ufficio quarantotto dei cinquantacinque anni di vita in cui fu eleggibile; nei rimanenti sette anni rivestì quattro volte cariche subalterne dipendenti dal maggior consiglio e una volta ricevette un incarico che lo rendeva ex officio membro del senato (86). Pertanto i tassi di attività politica possono condurre fuori strada, se non si tiene conto della durata dei singoli incarichi; tuttavia finora non esiste un indice migliore per trarre conclusioni globali sull'intensità dell'impegno politico di singoli patrizi o di interi gruppi.
Rispetto ai patrizi appartenenti a Case vecchie, i membri di Case aggregate al patriziato durante la guerra di Candia avevano il 60% in meno di probabilità di venire eletti e ancora meno (più del 70%) ne avevano gli uomini di famiglie aggregate solo durante le guerre della Morea (87). La discriminazione politica dei patrizi nuovi non cessò mai del tutto, ma si affievolì nel corso della seconda metà del secolo, essendo diventato sempre più difficile trovare un numero di patrizi di vecchia nobiltà sufficiente a ricoprire tutte le cariche. È probabile che molti patrizi nuovi si siano astenuti dalla vita politica a causa dell'atteggiamento di rifiuto in cui il loro gruppo si scontrava, tanto più che solo di rado essi avevano bisogno delle retribuzioni connesse agli incarichi. Tuttavia alcune nuove famiglie - come i Crotta, i Manin, i Widmann - non si scoraggiarono e riuscirono a fare eleggere due dozzine di volte un membro delle loro Case ad un "grande reggimento", successo per il quale vennero ricompensati anche con l'elezione ad altre cariche onorifiche. I patrizi poveri, pur presentando il minor numero di astensioni totali dalla vita politica, avevano però tassi di attività politica più bassi; ciò si spiega col fatto che essi non venivano eletti mai, o solo di rado, a cariche assegnate dal senato, i cui detentori spesso venivano rieletti prima ancora della scadenza in un altro ufficio o ricoprivano contemporaneamente due incarichi. I patrizi poveri, tanto appartenenti a Case vecchie quanto a Case nuove, non tentavano neanche di mettersi in vista sulla scena politica per mezzo di frequenti candidature, disponendo comunque di scarsissime possibilità di ascesa; potevano già considerarsi fortunati se riuscivano a venire eletti con una certa regolarità ad una delle cariche minori retribuite o alle quarantie, integrando in tal modo le loro misere rendite.
La vera e propria competizione per ottenere incarichi e onori si svolgeva soprattutto fra i patrizi delle Case vecchie e ricche. Divergenze dal tasso medio di attività politica (0,45), fino a un massimo del 100%, si verificavano verso il basso nel 34,4% delle Case e verso l'alto nel 22,2%. Il 28,9% delle Case non raggiungeva neanche la metà del valore medio, mentre tredici Case (14,4%) lo superavano di più del doppio. Si delinea quindi un gruppo relativamente piccolo di Case, tutte di vecchia nobiltà, che svolgeva un ruolo insolitamente attivo nell'ambito del senato e del consiglio dei dieci. A prescindere da due Case della classe IV, i Diedo S. Trovaso e i Renier S. Margarita (88), esse appartenevano tutte al patriziato ricco (classi I-III). Nel gruppo di trenta Case vecchie e ricche analizzato più a fondo dal Domzalski se ne trova una sola i cui uomini si astennero quasi completamente dall'attività politica (Savorgnan S. Stae, classe II); solo altre due presentano tassi di attività politica inferiori di circa il 25% alla media (89). Quasi uno su sette (14,6%) dei quattrocentododici uomini appartenenti a queste trenta Case non esercitò alcuna attività politica, la metà scarsa degli altri (48,9%) venne eletta meno di dieci volte e i restanti centoottanta patrizi (51,1%) vennero eletti in media quarantotto volte ciascuno. Come veri sovrani della vita politica vanno considerati quei patrizi che, grazie alla loro lunga vita e al loro notevole talento politico, riuscirono ad essere eletti più di cento volte ad una carica per lo più di alto prestigio. Questi stacanovisti della vita politica, che raccolsero su di sé i voti di una elezione su sette o una su otto a cariche di livello superiore alle quarantie, furono quindici in tutto; quattordici di essi appartenevano alle trenta Case di cui sopra (quattro a Case della classe II e dieci a Case della III), mentre l'unico patrizio povero in questa illustre cerchia fu Lancilotto Maria di Daniel Renier S. Margarita (classe IV) che nel corso della sua lunga vita (1645-1730) prestò quasi ininterrottamente servizio in senato e nel consiglio dei dieci o in una delle cariche distribuite da tali istituzioni.
Un patrizio come Giacomo Nani, contraddistinto, al pari di suo padre e di suo fratello Bernardo, da un impegno politico eccezionalmente forte e imparentato da parte di madre con gli Emo S. Simeon Piccolo (classe III), politicamente ancora più attivi, poteva forse permettersi di accusare molti dei "signori giovani e agiati" di rendersi colpevoli di "disprezzo al pubblico servizio"; è invece assolutamente priva di fondamento l'opinione avanzata più volte, secondo cui nel Settecento un numero sempre più alto di patrizi sarebbe sprofondato nell'"apatia politica" (90). Solo nel caso dei "grandi rettorati" (che erano venti in tutto) e - in minor misura - in quello delle ambascerie si presentarono notevoli difficoltà per trovare patrizi disponibili. Queste cariche implicavano spese così esorbitanti da parte dei loro detentori che un patrizio su cinque che fosse stato eletto rettore di una delle grandi città della Terraferma e uno su dieci degli ambasciatori eletti vi rinunciava e preferiva pagare una multa, modesta in confronto alle spese che l'accettazione dell'incarico avrebbe comportato, ed essere temporaneamente bandito da ogni ufficio. Più spesso gli eletti riuscivano ad ottenere una "dispensa" dall'assumere subito l'incarico; molti in realtà desideravano solo una dilazione e assunsero in seguito effettivamente un reggimento "di spesa". Il fatto che molti patrizi fossero intimoriti dalle notevoli spese connesse a queste cariche prestigiose non implicava però assolutamente un "generale disprezzo del pubblico servizio". Infatti solo il 2% degli eletti si rifiutava di accettare l'elezione e solo l'1,1% otteneva una dispensa (91).
Si tratta di cifre molto basse, se si considera quanti doveri e sacrifici a spese della vita privata comportasse il privilegio di essere un nobiluomo veneto per coloro che prendevano sul serio il ruolo di citoyen actif, toccato loro per nascita e non per libera scelta. Per la maggior parte dei patrizi poveri tale privilegio era un bene prezioso in quanto già di per sé li preservava dal perdere qualsiasi rilievo sociale; inoltre il fatto che i nobili detenessero il monopolio delle cariche pubbliche garantiva in buona o in massima parte la loro sussistenza. Anche ai patrizi più agiati non erano affatto indifferenti i vantaggi materiali derivanti dal loro stato privilegiato; essi accettavano ben volentieri cariche lucrative, come quella di bailo a Costantinopoli della quale si dice che avesse fruttato un patrimonio a Polo Renier. Anche altri uffici offrivano la possibilità di arricchire se stessi e le proprie Case, non ultimi i numerosi benefizi ecclesiastici per i quali alcuni patrizi rinunciavano di buon grado ad una carriera politica. Tuttavia l'attività politica quotidiana era assai meno attraente e richiedeva certamente una buona dose di "spirito di patria" da coloro che, senza poter aspirare a vantaggi materiali legati a determinati uffici, partecipavano ogni domenica alle interminabili votazioni in maggior consiglio, sacrificavano due pomeriggi alla settimana alle sedute del senato, si riunivano come membri del consiglio dei dieci tutti i giorni feriali nei quali non si riuniva il senato, e passavano incessantemente da una carica all'altra, tutte comportanti doveri di ogni genere.
Il fatto che non tutti i patrizi appartenenti a Case vecchie e ricche considerassero come il più alto onore quello di servire la patria con tutte le loro forze, e che anzi uno su sette, come si è detto, non volesse saperne, mentre la metà scarsa degli altri si accontentava di occasionali elezioni all'uno o all'altro ufficio, non va attribuito solo alla mancanza di buona volontà o di disposizione per gli affari pubblici. Evidentemente il maggiore o minor impegno politico dei patrizi era determinato anche dai riguardi nei confronti della propria Casa. Per incrementare lo "stato", il "lustro", il "decoro" di una Casa era sufficiente che prendesse parte attiva al governo della Repubblica solo qualcuno dei suoi membri, in certo senso come suo rappresentante. È probabile che l'impegno politico di molti dei suoi uomini giovasse ancor più al prestigio di una Casa, ma evidentemente ciò non era del tutto indispensabile. Si spiega così la circostanza vistosa che solo estremamente di rado tutti gli uomini di una Casa abbiente e di vecchia nobiltà presentassero per più generazioni consecutive tassi di attività politica molto inferiori alla media, come nel caso già citato dei Savorgnan S. Stae. Invece evidentemente non danneggiava il prestigio di una Casa il fatto che, di più fratelli, alcuni si dedicassero al servizio dello Stato ed altri meno o per nulla. Anche nella Casa di Giacomo Nani venne praticata questa divisione dei compiti fra fratelli: il fratello maggiore, Bernardo, venne indirizzato programmaticamente ad una carriera politica, alla quale si dedicò anima e corpo fino alla sua morte precoce; Giacomo, che fino ad allora aveva prestato servizio soprattutto in marina, subentrò solo in seguito al suo posto, accettando anche di sobbarcarsi, a quasi cinquant'anni, "il peso del matrimonio", dato che dalle nozze del fratello non erano nati figli maschi. Invece ad Alvise, il fratello di età intermedia, era stata affidata l'amministrazione del patrimonio famigliare ed egli pertanto, rispetto ai suoi fratelli, ebbe un ruolo del tutto marginale nella vita pubblica. Quasi escluso ne rimase il quarto fratello, Zuanne, che abbracciò la carriera ecclesiastica e divenne vescovo di Brescia. Alla stessa stregua di quelle dei fratelli furono sistematicamente pianificate nell'interesse della Casa anche le vite delle sei sorelle di Casa Nani: due vennero unite in matrimonio a nobiluomini di Case della classe III e le altre quattro entrarono in convento (92).
In definitiva "la sostanzial parità che core tra [i nobili], parità coetanea a la nascita, e che forma la base di ogni governo aristocratico" si limitava al fatto che essi erano tutti "individui capaci al Maggior Consiglio" e pertanto autorizzati ad eleggere e ad essere eletti nei "pubblici magistrati". Che esercitassero o no il diritto attivo di voto in maggior consiglio dipendeva dalla loro volontà e dalla carriera a cui la famiglia li aveva destinati. Una certa eguaglianza risiedeva nel fatto che, sempre che non fossero nobili nuovi, ciascuno di loro aveva la possibilità di essere eletto ad una carica. Tuttavia la differenza fra le chances dei singoli era enorme e i più non avevano la minima opportunità di giungere a ricoprire "i somi ufizi e le dignità" della Repubblica; pertanto, parafrasando le parole di Marco Foscarini, si potrebbe dire che la base del governo aristocratico veneziano era formata da "una disuguaglianza coetanea alla nascita". La carriera politica di un patrizio era già segnata a grandi linee ancor prima della sua nascita; infatti ai fini della carriera non erano decisivi i "talenti", le "virtù", le "capacità", come nelle intenzioni dei rivoluzionari del 1789, bensì le "fortune domestiche", in base alle quali era determinato il posto di ciascuna Casa nella piramide sociale della nobiltà o nella classificazione del Nani.
I risultati delle elezioni confermano clamorosamente questo stato di cose: l'87% dei nobiluomini eletti alle cariche più modeste assegnate dal maggior consiglio e il 90% di quelli destinati ai piccoli reggimenti appartenevano alle classi IV e V; viceversa un "plebeo" aveva solo una probabilità su cinquanta di venire eletto in senato o in uno degli uffici regolari dipendenti dal senato. Leggermente più alte erano le sue probabilità di assurgere al consiglio dei dieci o al ruolo di consigliere ducale. Il vertice della fortunata carriera di un "plebeo" era costituito dalle quarantie; e in effetti gli uomini della classe V occupavano un buon quarto dei posti di questa magistratura (27,6%), dominata dai loro colleghi un po' meno poveri della classe IV (43,1%). Questi ultimi avevano anche probabilità notevolmente più grandi di entrare a far parte del senato (una su nove). Queste cifre permettono di indovinare facilmente da quali patrizi fossero dominati la signoria, il senato, il consiglio dei dieci e gli uffici assegnati da queste due ultime istituzioni: i nobiluomini delle prime tre classi ne costituivano - a seconda del consiglio e dell'ufficio - dall'80 al 100% (quest'ultima percentuale si riferisce ai savi di Terraferma e savi grandi). Sulla strada per raggiungere le cariche alte o somme lo sbarramento decisivo era localizzato fra la classe III e la IV per i patrizi di vecchia nobiltà e fra la II e la III per i nobili nuovi. Ciò significa che gli appartenenti alla metà delle Case erano pressoché equiparati nelle probabilità di servire la Repubblica in tutte le cariche più elevate. Da una sola carica, quella di doge, i "mezzani" erano esclusi già dalla fine del Seicento. Pertanto il gruppo delle famiglie dirigenti era relativamente grande e non era ermeticamente chiuso verso il basso. Le possibilità di carriera dei "plebei" erano estremamente modeste, ma quelle degli appartenenti alla classe IV erano grandi abbastanza per permettere loro di svolgere un ruolo di un certo peso nella parte centrale della scala burocratica, fino al consiglio ducale.
L'esempio di una famiglia, quella dei Marin, valga a spiegare cosa significasse per i nobili molto poveri il diritto, acquisito per nascita, di poter ricoprire una carica di Stato. I Marin (classe V) appartenevano al patriziato già dai primordi della Repubblica, sembrano aver risieduto per un certo tempo a Candia, ma già alla fine del Cinquecento erano ritornati a Venezia, dove conducevano una vita abbastanza modesta e inosservata. Quasi l'unico Marin che viene talora menzionato nelle opere di storiografia è Carlo Antonio di Zuanne Battista, autore di un'opera in più volumi, Storia civile e politica del commercio de' Veneziani (1798-1808), altrettanto noto come primo marito della bella Isabella Teotochi di Corfù, la quale, dopo aver ottenuto l'annullamento del suo matrimonio con il Marin, sposò segretamente nel 1796 Zuanne Battista VI di Zuanne Battista I Albrizzi (classe II) e, come una delle gran dame salottiere, si conquistò un posto nella storia di Venezia. Un altro Marin non del tutto dimenticato è Domenico Iseppo, fratello del precedente, che pubblicò due libri di storia naturale e che nel 1800 compì il tentativo, subito represso dalla censura austriaca, di ristampare la rivista "Il Caffè", uno dei manifesti dell'Illuminismo (93). Per il resto i Marin rimasero nell'ombra e quindi sono rappresentanti tipici del patriziato povero, anche dal punto di vista della frequenza con cui andavano a nozze. Tutti i Marin vissuti nel Settecento erano discendenti diretti di Baldissera di Antonio Marin, unitosi in matrimonio nel 1633 con Cecilia di Domenico da Mosto. Tre dei loro figli si erano sposati, poi sei nipoti, e nelle generazioni successive rispettivamente nove, dieci e due discendenti maschi. Diciannove di queste trenta famiglie risalenti a Baldissera vivevano in tale povertà che, nel corso delle ultime due generazioni precedenti al 1797, cinquanta dei loro membri richiesero allo Stato una o più provvigioni patrizie o una "grazia dei cento uffizi", compreso Carlo Antonio, il quale era rimasto orfano di padre a soli quindici anni. Solo sedici dei discendenti di Baldissera sposarono una nobildonna, proveniente in dodici casi da una famiglia altrettanto povera e in quattro casi da una famiglia della classe IV (94). Pertanto non si può mettere in dubbio che la maggior parte dei Marin appartenesse al nucleo più povero dei "plebei" patrizi.
A partire da Giacomo, Ferigo e Girolamo, i tre figli di Baldissera, fra i Marin nati prima della metà del Settecento erano quarantaquattro gli uomini in grado di porre la loro candidatura ad un ufficio pubblico. La metà di essi venne eletta almeno dieci volte (in media diciotto volte), altri diciannove vennero eletti meno di dieci volte (in media sette) e solo tre si astennero dal prendere parte alla vita pubblica (95). Ciò significa che in centoventi anni i discendenti di un unico "plebeo" vennero eletti cinquecentotrentaquattro volte e quindi ricevettero complessivamente circa mille anni di retribuzione. In duecentoquarantanove casi i Marin prestarono servizio in cosiddetti reggimenti "di guadagno" e in centonovantadue casi in altre cariche subalterne. Pertanto l'82,6% delle loro elezioni ricade in questi due gruppi di uffici, il cui scopo principale era quello di non lasciare sprovvisti di incombenza e di salario i nobili poveri. L'elezione alle quarantie, ben più attraente per un patrizio povero, sia dal punto di vista finanziario che da quello del prestigio sociale, toccò in questi anni quarantadue volte ad un Marin. Quattro Marin erano veri e propri "quarantiotti" essendo stati eletti complessivamente trentanove volte a questa magistratura. I "quarantiotti" eletti più spesso furono i due fratelli Andrea e Piero di Antonio Marin (residente nel 1761 nella parrocchia di Santa Maria Zobenigo), la cui Casa fu l'unica a non rimanere in eterno al gradino più basso delle carriere patrizie. Infatti Alvise e Giacomo, altri due fratelli di questi due "quarantiotti", il cui padre aveva esercitato solo uffici di bassissimo grado, furono gli unici Marin membri regolari del senato e vennero eletti ben quarantadue volte o lì o ad uno degli uffici che ne dipendevano o ad una carica che li rendeva senatori ex officio (96). Anche il figlio minore di Antonio, Bernardin, fece un'ottima carriera, culminata nella sua elezione a vescovo di Treviso. L'unica pecora nera, per così dire, fu il sesto figlio, Girolamo, che anziché pensare alla carriera si era sposato segretamente a soli ventitré anni e che morì dopo solo pochi anni di matrimonio lasciando in miseria la vedova e le due figlie; fra i discendenti di Antonio queste ultime furono le uniche a dover richiedere una provvigione patrizia (97). La gran massa dei patrizi molto poveri era destinata a rivestire a rotazione cariche che fruttavano qualche soldo e che la sballottavano da un estremo all'altro dei domini veneziani, ma a non salire mai i gradini che conducevano agli uffici più prestigiosi. Il fatto che eccezionalmente, come nel caso di due dei figli di Antonio Marin, si aprissero davanti a loro le porte del senato, poteva indurre anche i meno fortunati a credere nel riconoscimento dei talenti e dei meriti individuali e a nutrire la speranza che persino a loro toccasse un giorno una simile sorte. Il nonno, due prozii e il padre di queste due fortunate eccezioni avevano trascorso la gran parte della loro vita attiva di patrizi poveri nei subalterni reggimenti "di guadagno" (per sessantadue volte complessive). Il loro vagabondare da una sede amministrativa all'altra era stato senza dubbio faticoso, ma talvolta illuminato da raggi di sole. Infatti a Pirano (in Istria) Antonio aveva trovato la sua prima moglie, figlia di un nobile locale e sorella della moglie di suo fratello Baldissera, e in un'altra tappa della sua modesta carriera, a Veglia, sposò nel palazzo del Provveditore, sede del suo ufficio, la seconda moglie e futura madre dei suoi dotati figli. La corrispondenza di un altro "plebeo", Camillo di Marc'Antonio Venier S. Martin, attivo come podestà e capitanio di Conegliano (1772-1774), illustra assai bene in che cosa consistessero gli affari quotidiani di un patrizio finito in una cittadina di provincia. Il detentore di tali funzioni era una specie di tuttofare e si doveva occupare di questioni politiche, ecclesiastiche, giudiziarie, economiche, fiscali e militari. La sua mansione principale consisteva nel rendere noti i proclami che gli giungevano da Venezia e nell'inviare in città continui rendiconti su ciò che avveniva nel suo distretto amministrativo. In veste di principale rappresentante della Repubblica doveva comunicare ai parroci locali le circolari veneziane relative alle questue "per il riscatto de' poveri schiavi" oppure proibire a determinati ordini religiosi la raccolta delle elemosine. Doveva occuparsi di persona della costruzione di una nuova chiesa parrocchiale o della conversione di un giovane ebreo. Grande attenzione andava rivolta alla precaria situazione economica aggravata dai cattivi raccolti; Camillo Venier cercò di porvi rimedio con la moltiplicazione dell'armento e con interventi a favore della locale Accademia agraria. Il suo progetto più ambizioso era la ricostruzione di una importante strada danneggiata da una "terribile alluvione". A questo scopo egli richiese al savio alla scrittura quattro soldati a cavallo "per imprimer l'ubbidienza e la soggezione ne' villici, che devono prestarvi l'opera". In altri casi si trattò di comporre una lite fra nobili locali o di persuadere le suore di un convento a non rispedire una delle loro consorelle presso la sua famiglia di origine. Occupandosi di affari del genere, e soprattutto vergando i rapporti da inviare mensilmente al savio cassier, probabilmente sedici mesi passavano abbastanza in fretta e già giungeva l'ora di accettare altrove un altro incarico simile, in quanto un podestà e capitanio di Conegliano non era rieleggibile (98).
La vita pubblica di un patrizio appartenente a una Casa benestante si svolgeva in una sfera completamente diversa. Prendiamo ad esempio i Bollani S. Trovaso: finché questa Casa si era trovata in condizioni economiche modeste, altrettanto modeste erano state le carriere politiche dei suoi membri (99); in seguito però Francesco di Zuanne Bollani, che, come suo padre prima di lui, aveva rivestito solo cariche assegnate dal maggior consiglio, venne in possesso di una notevole ricchezza che gli permise di farsi costruire un bel palazzo sul rio San Trovaso. Più tardi la famiglia sarebbe stata stimata dal Nani come appartenente alla classe II. A questo punto le cose cambiarono e, come per magia, ai suoi tre figli si spalancarono le porte del senato e degli uffici da esso assegnati. Non appena il figlio maggiore, Zuanne, nato nel 1689, compì i venticinque anni e fu quindi abile al maggior consiglio, venne eletto savio agli ordini, dapprima come supplente e poi come ordinario, vale a dire che assurse subito alla carica con cui iniziava quasi sempre una fortunata carriera di senatore. Le tappe seguenti - altrettanto tipiche anche per altre carriere di questo genere - furono l'elezione a camerlengo di comun e poi a podestà di Chioggia, unico ufficio che per sedici mesi allontanò il Bollani da Venezia. Tornato in città, prestò servizio per ventotto mesi in cariche fiscali. In questo periodo (1722) andò a nozze con una figlia del senatore Francesco Savorgnan S. Geremia (classe I), Teresa, di dodici anni più giovane. Da questo matrimonio nacquero due figli e una figlia morta poco dopo la nascita. I due anni seguenti furono gli unici in cui il Bollani si astenne da incarichi pubblici. Nel giugno 1725 Zuanne venne eletto come sostituto nella zonta dei pregadi, qualificandosi così per un ufficio del senato. Solo un mese dopo era già uno dei quattro aggiunti ai riformatori dello Studio di Padova. In seguito alla sua elezione ai tre sopra gli atti del sopragastaldo divenne membro del senato con diritto di voto. Trascorsi sedici mesi in questo ufficio, il senato lo elesse provveditore alle beccarie. Appena due mesi più tardi, il 1° ottobre 1729, l'ormai quarantenne Zuanne fu eletto alla zonta e divenne pertanto membro regolare del senato, posizione che mantenne, tranne un'unica interruzione, per tutta la sua vita. Nel luglio 1731 il maggior consiglio lo elesse consigliere ducale per il sestiere di Dorsoduro; egli perse così il suo posto nella zonta, ma continuò ad essere membro del senato ex officio. Finito il suo servizio nella signoria, venne eletto regolarmente, un anno dopo l'altro a partire dal 1° ottobre 1732, come membro regolare della zonta dei pregadi; alla sua morte, avvenuta il 16 novembre 1756, egli era stato eletto ventotto volte in questa istituzione. Dal momento della sua stabile appartenenza al senato, fu destinato ad altri diciotto uffici e ricoprì altre dieci funzioni su incarico del consiglio dei dieci. Un'unica volta egli rifiutò di accettare una carica: nel 1733, quando il maggior consiglio lo elesse capitanio a Padova, ottenne di venirne dispensato e in seguito non fu più destinato ad un reggimento "di spesa".
La carriera di Zuanne Bollani è tipica per gli uomini appartenenti a Case vecchie e ricche, in quanto egli non dovette mai ricoprire una carica subalterna e accettò almeno una volta l'elezione ad un reggimento "di spesa". Inoltre, come molti altri patrizi della sua classe, percorse una carriera essenzialmente senatoriale e non venne mai eletto al consiglio dei dieci. Sembra che i motivi in base ai quali alcuni patrizi venivano eletti più volte in questo esclusivo consiglio, mentre altri non lo erano mai, non dipendessero dal prestigio di una persona o della sua Casa, ma piuttosto da una precisa divisione dei compiti e dalla specializzazione in determinati ambiti di competenza. A quell'epoca forse il politico più influente in assoluto era il procuratore Zuanne di Piero Emo S. Simeon Piccolo († 1760), che non fece mai parte del consiglio dei dieci, ma fu eletto savio grande più volte di ogni altro. Zuanne Bollani è rappresentativo per la maggioranza dei senatori anche in questo senso, cioè per il fatto di non essere mai assurto ad una delle cariche di massimo prestigio ed influsso politico (savio di Terraferma, ambasciatore, savio grande, procuratore di San Marco). Non sappiamo se se ne sia tenuto volontariamente lontano, oppure se gli siano mancate le doti e le relazioni politiche necessarie per arrivare tanto in alto. Probabilmente la sua costante presenza in senato bastava a soddisfare le ambizioni politiche della sua Casa e a rappresentarla. Infatti i suoi fratelli minori, Girolamo e Zuanne Battista, vennero eletti solo due volte per ciascuno in senato e anche in generale presentano tassi di attività politica assai inferiori a quelli di Zuanne (100). Era desiderio di quest'ultimo che almeno uno dei suoi due figli si dedicasse agli affari pubblici. Poche settimane prima che il maggiore, Girolamo Francesco, raggiungesse l'età di accesso al maggior consiglio, il padre dispose per testamento che un capitale di 10.100 ducati rimanesse inattingibile "sino a tanto succederà il caso, che ò l'uno, ò l'altro de miei figlioli, dovesse portarsi in publico servizio in qualche regimento, nel qual caso si dovranno valere del detto capital"; era inoltre suo ardente desiderio che fra i due fratelli regnassero sempre "ottima armonia e scambievole amore [...] in maniera tale, che succedendo, che ò l'uno, ò l'altro di essi debba portarsi in qualche publico servizio, non traliascieranno di vicendevolmente assistersi all'occorenze, come lo richiede il sangue, il decoro, e susistenza della famiglia, e l'esempio sempre tale de suoi maggiori" (101). Girolamo Francesco non rimase sordo a questo appello e percorse una carriera quasi identica a quella del padre; invece Antonio, il figlio minore, morto a soli trentacinque anni, comparve appena sulla scena politica.
Di quanto prestigio godessero ancora nel Settecento il senato, il consiglio dei dieci e la signoria si deduce anche dal fatto che i patrizi ricchi appartenenti a Case vecchie tentassero con ogni mezzo di tenerne lontani i patrizi poveri e, fino alla metà del secolo, anche i ricchi nobili nuovi. Chi faceva parte di queste istituzioni aveva buon motivo di ritenersi partecipe dell'establishment politico della Repubblica, ma era tuttavia ancora ben lontano dalle leve di comando del potere. Gli storici moderni concordano con quei patrizi che avevano un atteggiamento critico nei confronti delle istituzioni del loro Stato nel ritenere che una magistratura, quella dei sei savi del consiglio, o savi grandi, disponesse di un influsso politico superiore a quello di tutte le altre. Verso la fine della guerra di Candia, un profondo conoscitore della situazione politica asserì che a quell'epoca non ci sarebbero stati più di quattordici o quindici senatori in grado di venir eletti savi grandi: "E questi fanno tutto quello che vogliono, perché fanno fare al Senato tutto quello che vogliono". Poche settimane prima della caduta della Repubblica anche Giovanni Pindemonte espresse un giudizio affine sui savi grandi: "[...] sono i maneggiatori e gli arbitri di tutti gli affari [...]; essi tra di loro consigliano tutti gli affari, e fra di loro formano le proposizioni, le quali lette nel Pregadi [...] diventano tanti decreti del Senato" (102). Anche ammettendo che in queste asserzioni il potere dei savi grandi venga gonfiato esageratamente con intento polemico, non v'è però dubbio che il vero centro del potere della Repubblica risiedesse nel saviato del consiglio. Quindi un'analisi di coloro che raggiungevano tale ufficio può fornire le risposte ad alcune questioni, rivelare cioè quanti fossero gli uomini o le Case che appartenevano nel senso più stretto alla classe dirigente della Repubblica, se la ricchezza fosse una condizione indispensabile per venire ammessi nella cerchia delle "famiglie di Collegio", e se la Repubblica fosse effettivamente degenerata in un'oligarchia dei "grandi", come molti hanno affermato.
In via puramente teorica moltissimi patrizi avrebbero potuto venire eletti a questo ufficio, dato che i savi restavano in carica solo per sei mesi, cui facevano seguito altri sei mesi di "contumacia". Inoltre questa carica non poteva diventare appannaggio di poche Case o casati, in quanto nel collegio dei savi (del quale facevano parte, oltre ai sei savi grandi, anche i cinque savi agli ordini e i cinque savi di Terraferma) non erano ammessi contemporaneamente due rappresentanti di uno stesso casato. Nel corso del Settecento, per l'esattezza fra il 1697 e l'ultima elezione tenutasi il 29 aprile 1797, il senato ebbe milletrecentoventitré volte occasione di assegnare questo prestigioso ufficio, dato che molti savi grandi lo deposero prima del termine, essendo stati eletti ad un'altra funzione, o morirono in carica. Eppure durante questo lungo periodo, nel quale vissero fra i quattro e i cinquemila nobili capaci al maggior consiglio, vennero eletti savio grande solo centotrentasette patrizi appartenenti a novantuno vecchie Case (103).
Prescindendo dalle otto Case che si erano già estinte prima della metà del Settecento e che quindi mancano nella classificazione del Nani, un quinto (20,6%) delle Case vecchie apparteneva alle "famiglie di Collegio". Espresse in numeri assoluti le Case dei "grandi" e quelle dei "mezzani" erano all'incirca alla pari. Tuttavia non si può parlare di un'approssimativa eguaglianza fra di esse, in quanto più di quattro quinti (82,5%) di tutte le vecchie Case della classe I erano rappresentate da almeno uno dei loro membri in questo ufficio esclusivo, mentre solo un quarto abbondante (27,7%) delle Case della classe III vi aveva un rappresentante (104). Le Case dei "grandi" si differenziavano da quelle delle altre classi anche perché da loro provenivano due o più savi grandi molto più spesso che dalle altre (105). È quindi innegabile che i "grandi" avessero una posizione di predominio nel saviato del consiglio, ma è altrettanto evidente che erano ben lontani dall'esercitarvi un monopolio assoluto. La regola ferrea secondo cui a questo ufficio non accedevano mai patrizi poveri venne infranta un'unica volta: il 31 dicembre 1790, in anni in cui forse già cominciava a farsi sentire la mancanza di uomini politici ricchi di doti e di senso del dovere nei confronti dello Stato, venne eletto per la prima volta savio grande, e poi rieletto negli anni successivi, un patrizio appartenente ad una Casa della classe IV, Alessandro I di Lorenzo Alessandro II Marcello alla Maddalena (suo padre, come correttore delle leggi, nel 1761 aveva parteggiato per i "grandi"; rispettivamente suo nonno e un suo prozio erano i compositori Alessandro e Benedetto). Invece il fatto che i due quinti delle elezioni andassero a favore di un "mezzano" significa che un gruppo sorprendentemente grande di uomini di questa classe - ancora all'inizio del secolo la più numerosa - apparteneva all'élite del governo repubblicano.
Tuttavia non era in primo luogo l'appartenenza a una determinata Casa o classe a fare di un patrizio un savio grande. Un certo benessere economico, che peraltro poteva essere anche mediocre, era unicamente una premessa, ma non la causa decisiva dell'elezione a savio grande. Sebbene la carica fosse a disposizione almeno dodici volte all'anno, il gruppo degli eletti era assai ristretto e la maggioranza dei patrizi molto ricchi non ne fece mai parte. Alcune Case di "grandi", ad esempio quella dei Gradenigo S. Simeon Grande e quella dei Pisani S. Maria Zobenigo furono rappresentate in questo collegio solo per un semestre nell'intero secolo. Molti appartenevano alle "famiglie di Collegio", come le chiamò Giovanni Pindemonte, ma di "Senatori capaci d'esser Savi grandi" ce n'erano ben pochi, come aveva giustamente osservato l'Anonimo del 1664. E ancor meno numerosi erano quelli che dopo la loro prima elezione venivano praticamente rieletti ogni anno per tutta la loro vita o fino al dogato. Il gruppo relativamente più ampio (41,6%) è costituito da coloro che ricoprirono tale carica non più di cinque volte; all'incirca altrettanti sono coloro che vennero eletti fra le sei e le quindici volte. In cento anni solo venticinque patrizi vennero eletti con frequenza ancora maggiore (il vertice massimo è costituito da quarantaquattro elezioni a savio grande), ma riuscirono a concentrare su di sé più della metà di tutte le elezioni.
Se è vera l'affermazione che i savi grandi sarebbero stati i "maneggiatori e gli arbitri di tutti gli affari", lo è particolarmente per queste venticinque persone.
Quali patrizi (e Case) siano compresi nella seguente lista dei savi grandi eletti più spesso dipende anche da alcuni casi fortuiti. Ad esempio la lista comprenderebbe certamente anche il nome di Francesco di Andrea Loredan S. Stefano (classe I), se egli non fosse stato eletto doge il 18 marzo 1752 e cioè due settimane prima di venire probabilmente eletto savio grande per la sedicesima volta. Con tutta probabilità anche Polo Renier sarebbe stato eletto più di tredici volte se non fosse salito sul trono ducale nel 1779. Inoltre, che un patrizio mancasse di poco o superasse di poco o di molto il limite di almeno sedici elezioni a savio del consiglio, scelto un po' arbitrariamente, dipendeva anche dalla sua longevità. Infatti coloro che si erano installati stabilmente in questa istituzione di solito vi ricomparivano regolarmente fino alla morte o fino al dogato. Ad alcuni patrizi l'accesso al collegio era temporaneamente impedito dal fatto che già vi sedeva un loro parente o un portatore dello stesso cognome. A partire dal marzo 1730 il futuro doge Carlo Ruzzini e suo nipote Zuanne Antonio IX vi vennero eletti quattro volte di seguito a semestri alternati; dopo l'elezione al dogato dello zio, il nipote dovette aspettarne la morte per poter di nuovo occupare ogni anno, dal marzo 1735 in poi, il suo posto in collegio. Occorre tener conto di tali circostanze nell'osservare la lista dei savi grandi eletti più spesso.
La cosa più sorprendente di questa lista è che meno dell'1 per mille dei nobili capaci al maggior consiglio fosse costantemente presente in questa istituzione in più della metà dei milleduecento semestri di ufficio. Alcuni patrizi furono eletti per venti o trent'anni di seguito per un nuovo semestre di carica sempre nella stessa delle quattro elezioni annuali. Solo una piccola minoranza dei patrizi sopraelencati uscì dal collegio per alcuni anni una volta o più volte. Evidentemente per l'elezione a savio grande, e soprattutto per la ricorrente rielezione, erano determinanti l'impegno politico e le capacità governative dei candidati. Un patrizio non veniva eletto a questo ufficio al termine della sua carriera politica, per così dire come ricompensa per anni di fedele servizio allo Stato, bensì nel fiore degli anni. Solo pochi riuscirono ad essere eletti prima dei quarant'anni, età prevista dalla legge, ma la grande maggioranza dei savi grandi permanenti iniziò la sua lunga carriera al culmine della scala burocratica a quarant'anni precisi o poco più tardi. Il fatto che in questa illustre cerchia si trovino undici "mezzani", e che anzi costituiscano la maggioranza fra coloro che vennero eletti più di trenta volte, significa che evidentemente a Venezia i meriti e i talenti personali, sempre che fossero accoppiati ad una certa agiatezza, tale da permettere di vivere di rendita, venivano riconosciuti e ricompensati con i grandi e con i massimi onori. Al contrario, anche le più grandi ricchezze non costituivano di per sé una premessa sufficiente per poter pretendere un posto stabile nel centro del potere politico. Infatti nella lista sono comprese solo sette delle quaranta Case più ricche di vecchia nobiltà (enucleate in base alle rendite dichiarate nella redecima del 1740) (106). Un "mezzano" non poteva sperare di salire ancora più in alto che fino a savio del consiglio o a procuratore di San Marco: il dogato, l'ultimo gradino della scala, era riservato già dalla fine del Seicento alle famiglie più abbienti. Tuttavia in età illuministica, per conquistare la più alta dignità della Repubblica, alla ricchezza doveva accoppiarsi anche una prolungata esperienza di affari pubblici. Tutti i dogi in carica fra Carlo Ruzzini e Polo Renier avevano dimostrato la loro idoneità a questa carica con anni di servizio presso il saviato del consiglio.
I savi grandi in continuo servizio, per così dire le stelle fisse nell'incessante andirivieni del collegio, venivano integrati all'incirca ogni tre anni da un homo novus, il quale rimaneva circondato da colleghi più anziani e più esperti fintanto che la sua iniziazione agli arcana imperii non si fosse compiuta ed egli stesso fosse in grado di iniziarvi i nuovi arrivati. Questo cauto meccanismo di integrazione e di salvaguardia di una continuità personale nell'alta carica cominciò ad incepparsi proprio nel momento in cui la Repubblica aveva più bisogno che mai di saggezza e di risolutezza politica. A cominciare dall'elezione del marzo 1796, all'approssimarsi di una possibile rottura e di un conflitto militare con la Francia, dalle file dei vecchi campioni vennero eletti al saviato solo Piero Zen ai Frari e il procuratore Francesco Pesaro. Tutti gli altri erano chi più chi meno principianti: tre degli eletti non avevano mai ricoperto questa carica e gli altri undici solo poche volte (107). La generazione dei gran vecchi che, dopo i quaranta, avevano trascorso quasi tutta la loro vita in collegio, era uscita di scena alla fine degli anni Ottanta e all'inizio dei Novanta, con Alvise I Contarini, Antonio Diedo, Andrea Tron, Francesco II Morosini, Francesco Foscari, Alvise Zusto, Nicolò Barbarigo e alcuni altri. Ai loro successori mancavano non solo la saggezza e l'esperienza politica, ma anche l'accordo su questioni politiche di principio e sui provvedimenti da prendere in vista dei pericoli che minacciavano l'esistenza della Repubblica. A questo punto venne a costare cara anche l'alterigia dei patrizi di vecchia nobiltà che non avevano mai permesso ad un nobile nuovo l'accesso al saviato. Pertanto Ludovico Manin fu il primo doge, dopo Alvise III Mocenigo (1722-1732), a non aver mai prestato servizio fra i savi del consiglio negli anni e nei decenni precedenti alla sua elezione. Gli era quindi stata preclusa la possibilità di acquistare quell'esperienza e routine politica di cui la Repubblica allora avrebbe avuto urgente bisogno. Probabilmente anche un altro al suo posto non sarebbe riuscito a cambiare il corso del destino; tuttavia, con al vertice una classe dirigente più unita e decisa, forse la Repubblica sarebbe tramontata in circostanze meno umilianti.
Epilogo
Il 12 maggio 1797 nella sala del maggior consiglio si riunirono per l'ultima volta cinquecentotrentasette patrizi e, tanto frettolosamente quanto unanimemente, presero la memorabile decisione di rinunciare ai loro privilegi e di sanzionare la fine del regime aristocratico (108). A firmare l'atto di morte della Repubblica si presentò solo la metà degli individui capaci al maggior consiglio, ma in realtà il loro numero era solo di poco inferiore a quello dei patrizi che avevano regolarmente partecipato alle sedute del maggior consiglio negli ultimi mesi ed anni. Poiché a quell'epoca i due terzi dei seggi in maggior consiglio erano occupati da patrizi appartenenti alle Case povere o poverissime, si può supporre che questi ultimi fossero in maggioranza anche fra i votanti del 12 maggio; in ogni caso la decisione di quel giorno non sarebbe stata presa se i "plebei" vi si fossero opposti con decisione. Ma, come già in passato, anche in questo momento decisivo per la sopravvivenza della Repubblica essi lasciarono fare ai "grandi" e ai "mezzani". Dalle loro cerchie provenivano anche Francesco Donà S. Fosca (classe III), Lunardo Zustinian Lolin (classe II) e Alvise I Mocenigo S. Samuel (classe I), i tre inviati che, muniti di pieni poteri, ebbero il compito di concludere con Bonaparte un "trattato di pace e di amicizia" in nome del maggior consiglio. Firmando questo trattato il 16 maggio a Milano i tre inviati accettarono le ingenti pretese del conquistatore francese, ma poterono vantarsi di aver salvato dalla confisca, con la loro remissività, gli enormi possedimenti patrizi sulla Terraferma che erano già occupati dal nemico.
Tuttavia le trattative condotte in maggio con i Francesi non riguardavano solo tale questione essenziale per i patrizi possidenti, ma anche il destino dei nobili nullatenenti che, insieme ai loro privilegi politici, rischiavano di perdere anche i loro mezzi di sussistenza, cioè i proventi delle cariche e delle pensioni statali, e di cadere nella totale miseria. Per salvaguardarli da tale sorte fu introdotta nell'articolo 2 del trattato di Milano una clausola a favore dei "pauvres gentilhommes": "Le Grand Conseil de Venice ayant à coeur le bien de sa patrie et le bonheur de ses concitoyens, [...] renonce à ses droits de souveraineté, ordonne l'abdication de l'aristocratie héréditaire et reconnoit la souveraineté de l'Etat dans la réunion de tous les citoyens, sous la condition cependant que le gouvernement garantira la dette publique nationale, l'entretien des pauvres gentilhommes qui ne possèdent aucuns biens-fonds, et les pensions viagères accordées sous le titre de provisions" (109). Il fatto che Bonaparte, che non aveva fama di essere particolarmente scrupoloso, si sia piegato a tale concessione rivela quanto fosse acuto il problema dei patrizi poveri. E in effetti lo era. Ogni anno i patrizi rivolgevano al Serenissimo Principe un centinaio di suppliche, implorando "una delle solite provvigioni, con la quale provvedere alla [loro] misera condizione". In una famiglia su tre, fra quelle fondate dai patrizi nei cinquant'anni precedenti al 1797, almeno un membro, ma nella maggior parte dei casi più d'uno, usufruiva di una pensione vitalizia di Stato. In base al censimento del 1761 un ménage patrizio su sette doveva cavarsela senza neanche un "servitore" e alcuni non potevano permettersi nemmeno una "massera". Tanto più numerosa era invece la servitù dei patrizi ricchi: quattro quinti di essi disponevano di almeno cinque servitori e massere e il 46% ne aveva più di dieci. La discrepanza riguardo al numero delle gondole era altrettanto grande: più della metà dei ménages poveri non ne aveva nemmeno una, mentre quelli dei ricchi in media ne avevano due (110).
Dal punto di vista topografico i ricchi e i poveri, i "grandi" e i "plebei" vivevano in stretta simbiosi - come ad esempio Benetto Antonio di Piero Magno S. Polo in Calle Bernardo e Domenico di Piero Grimani S. Polo Canal Grande. Il primo, che in seguito alla morte precoce dei suoi figli era l'ultimo uomo della sua Casa, non aveva nessun servitore, né tantomeno una gondola, mentre il suo vicino, un fratello minore del doge Piero Grimani (1741-1752), la cui famiglia era composta di undici persone, disponeva di trentanove servitori, di otto massere e di sette gondole. Si può supporre che individui dalle possibilità economiche e dallo stile di vita tanto diversi vivessero in sfere sociali nettamente separate; effettivamente la scelta dei coniugi rivela che i "grandi" e i "plebei" evitavano intenzionalmente qualsiasi contatto reciproco. Un abisso separava lo stato sociale degli uni e degli altri, mentre dal punto di vista giuridico essi erano uguali e in maggior consiglio il voto di un Benetto Antonio Magno contava quanto quello del senatore Domenico Grimani. Sin da quando esisteva un patriziato veneziano erano esistiti anche i nobiluomini poveri, ma, fatte le debite relazioni, essi non furono mai tanto numerosi quanto negli ultimi decenni della Repubblica e il loro moltiplicarsi sembrava irrefrenabile. Le famiglie abbienti restavano saldamente fedeli al principio di non permettere ai figli matrimoni superflui al fine della successione della Casa, mentre i "plebei" iniziarono una vera e propria offensiva demografica. All'epoca della guerra di Candia un matrimonio su quattro veniva contratto da un uomo appartenente alla classe V, mentre nell'ultima generazione precedente al 1797 un matrimonio su due toccava ai "plebei" che, insieme ai loro fratelli un po' meno poveri della classe IV, avevano già da tempo raggiunto la maggioranza dei seggi in maggior consiglio. Per Nicolò Donà questo sviluppo era tanto pericoloso per la sopravvivenza del governo aristocratico da indurlo già negli anni Trenta a riflettere fra sé e sé su come si potesse ottenere la necessaria e urgente "minorazione" dei "plebei" (111).
Nel Settecento anche la Repubblica aristocratica polacca si trovò ad affrontare problemi assai simili. In Polonia il contrasto fra i privilegi politici di cui godevano anche i membri più poveri della szlachta e la loro totale impotenza economica era almeno altrettanto forte quanto nel patriziato veneziano. Ma, diversamente che a Venezia, in Polonia vennero avviate riforme costituzionali allo scopo di ristabilire l'equilibrio fra patrimonio e diritti politici. Questi sforzi vennero coronati dalla costituzione del 3 maggio 1791 e da alcune leggi complementari con le quali più di trecentomila nobili privi di possedimenti terrieri vennero privati in un sol colpo dei loro diritti politici. Tuttavia le riforme della dieta polacca giunsero troppo tardi per poter infondere allo Stato nuova forza vitale e anzi ne accelerarono la rovina (112). Non si potrà affermare che Venezia sia stata meno toccata dallo spirito dell'Illuminismo e dall'impulso riformatore di quanto non lo fosse la Polonia, ben più lontana dai centri dell'Illuminismo. Al contrario, a Venezia e nel Veneto le idee illuministiche trovarono numerosi seguaci e occasionalmente vennero compiute addirittura riforme decisamente radicali, ad esempio nel ridurre i diritti e i possedimenti ecclesiastici. Ma tali interventi rimasero frammentari e inorganici e a Venezia fu sempre assai grande la distanza fra l'Illuminismo come movimento di idee e l'Illuminismo come prassi riformatrice. Gianfranco Torcellan ha osservato che "nessuno degli stati italiani offre forse nel Settecento un più stridente contrasto tra la varietà delle iniziative culturali e la meschina, impacciata realtà della prassi politica; mai, credo, tanto immobile fatalismo nascose ed oscurò più fermenti e più polemiche, più vivacità di interessi, di studi, di discussioni" (113).
Non solo la prassi riformatrice era particolarmente deludente, anzi quasi inesistente, ma lo era anche il dibattito pubblico su tutte le questioni relative all'ordinamento politico della Repubblica e alle molte disfunzioni della sua costituzione. Fra il 1761 e il 1780 il maggior consiglio deliberò tre volte una correzione delle leggi, ma in tutti e tre i casi perse l'occasione di intraprendere la via di riforme costituzionali. In fondo questa constatazione è anacronistica perché in realtà la gran massa dei patrizi non voleva proprio delle riforme che rendessero più efficaci il governo, l'amministrazione e la giurisdizione. E ancor meno degli altri lo volevano i patrizi poveri; essi difendevano con la massima tenacia il monopolio patrizio delle cariche statali, che dava un senso alla loro vita e al contempo costituiva il fondamento della loro sussistenza economica. Neanche i "grandi" avevano motivo di cambiare la situazione esistente, fintanto che il maggior consiglio continuava a funzionare come un docile organismo di votazione e non metteva in pericolo la loro posizione privilegiata. Molti di essi avranno condiviso il modo di pensare di Francesco Pesaro che nel 1770 scrisse a Zuanne Antonio Querini S. Maria Formosa: "quel che più mi duole s'è, come saprete, che in Venezia non mancano degli uomini amanti di novità. La peggior cosa che potesse arrivare sarebbe un qualche cambiamento nell'interno nostro sistema" (114). Comunque gli "uomini amanti di novità" aborriti dal Pesaro erano ben lontani dal desiderare cambiamenti "alla polacca", anzi le loro mire erano rivolte all'indietro. L'uguaglianza auspicata dal "partito degli innovatori", guidato da Zorzi Pisani e da Carlo Contarini, entrambi appartenenti a Case della classe V, non era l'uguaglianza civile di tutti i possidenti, ma l'uguaglianza politica e - come sua premessa - l'uguaglianza economica di tutti i "cittadini nobili". Per poterla realizzare essi idearono il fantastico progetto di una lex agraria che avrebbe reso proprietari terrieri tutti i nobili "plebei", quelli "che non hanno rendite o poderi" (Nicolò Donà), e in tal modo ne avrebbe giustificato e consolidato in eterno i privilegi politici. Dal punto di vista di questi frondisti "plebei" è più che comprensibile la difesa a oltranza dei loro privilegi politici, che costituivano il loro patrimonio più prezioso e spesso l'unico, ma i loro piani erano talmente contrari allo spirito dei tempi da non avere la benché minima possibilità di riuscita. Tuttavia la loro attività bastò a turbare notevolmente la vita politica veneziana e a rafforzare l'opposizione ad ogni genere di cambiamenti. I "signori" aggrediti soffocarono sul nascere la "congiura" del Pisani con marginali concessioni e con esemplari condanne dei caporioni. A quell'epoca Giacomo Nani, nei suoi Principi d'una Amministrazione Ordinata e Tranquilla (1780-1781), tirò un bilancio profondamente pessimistico della situazione politica: i "mali della vecchiezza" che avevano colpito la costituzione veneziana sarebbero stati "incurabili" e ne avrebbero "corrosi tutti li Fondamenti". Pertanto l'unico rimedio possibile sarebbe stato "il mantenimento dell'ordine", "il solo mezzo che oggidì può conservare in pace e tranquillità"; ne risultava il rifiuto di ogni cambiamento - "lontana stia adunque qualunque adesione a riforma" (115).
E quindi le cose restarono immutate e la Repubblica trascorse in una specie di dormiveglia i suoi ultimi anni, fino a quando le cannonate francesi non la scossero dal suo letargo. La resistenza avrebbe salvato l'onore, ma non aveva alcuna prospettiva di successo e avrebbe causato vittime e sacrifici incalcolabili. Per placare l'ira di Bonaparte i patrizi erano ora pronti addirittura a sacrificargli la loro costituzione. Affinché l'imposto passaggio ad un governo "rappresentativo" avvenisse salvando almeno l'apparenza di un legale cambiamento della costituzione era necessario che esso venisse approvato anche da coloro dai quali si pretendevano le maggiori - materiali - rinunce. I patrizi poveri accettarono il baratto e votarono a favore dell'"abdicazione dell'aristocrazia ereditaria" in cambio dell'assicurazione che il governo avrebbe garantito il loro sostentamento. Il nuovo governo, la municipalità provvisoria, si sentì in dovere di mantenere i patti e il giorno stesso della sua entrata in carica, il 16 maggio, promulgò in un manifesto: "Desiderando inoltre di dare in nome della Nazione una distinta prova della sua riconoscenza alli ex-Patrizj di poche fortune, che in questa circostanza hanno sacrificato i loro interessi personali al bene della Patria, dichiaro che saranno stabilite sopra i Beni Nazionali, o sopra una Lotteria, delle pensioni per la loro sussistenza, finché avranno ottenuto nel nuovo Governo degl'Impieghi d'un corrispondente profitto, e le medesime misure saranno prese per l'Ex-Patrizie, che parteciperanno delle beneficenze pubbliche" (116). Tenendo conto dell'erario dissanguato e delle insaziabili pretese di contributi da parte dei Francesi, saggiamente non si fece parola dell'entità delle pensioni previste. In realtà esse risultarono estremamente esigue, troppo poco per vivere e troppo per morire. Tuttavia la promessa data venne formalmente mantenuta non solo dal primo governo "democratico", ma anche da tutti i regimi seguenti. Durante la prima dominazione austriaca ricevettero una pensione più di cinquecento degli ex patrizi che nel 1797 formavano il corpo aristocratico, durante il Regno Italico circa quattrocento e all'inizio della Restaurazione ancora quasi duecento. Nel frattempo la morte aveva notevolmente diradato le loro file. Il triste destino della maggior parte degli ex patrizi poveri fu di trascorrere la vecchiaia sopravvivendo alla meno peggio grazie alle elemosine di signori stranieri. Infatti ai più mancava la competenza o la volontà di servire i regimi postrepubblicani in quelle cariche amministrative o giudiziarie che un tempo erano loro toccate per diritto di nascita. Sua Maestà Imperiale Reale fu a dire il vero tanto generosa da non escludere dalla conferma della nobiltà repubblicana neppure i più poveri fra i patrizi, così che essi nella nuova nobiltà erano nuovamente in maggioranza. Ma alla conferma della nobiltà non si accoppiava alcun nuovo privilegio e quindi le tracce della maggior parte degli ex patrizi e dei loro discendenti si persero nel corso di solo due o tre generazioni dopo il tramonto della Serenissima (117).
Traduzione di Benedetta Heinemann Campana
1. Hamish M. Scott - Christopher Storrs, Introduction: The Consolidation of Noble Power in Europe, c. 1600-1800, in AA.VV., The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, I-II, London 1995: I, p. 9 (pp. 1-52); Hamish M. Scott, Conclusion: The Continuity ofAristocratic Power, ibid., II, pp. 274. s. (pp. 274-291).
2. Sulla nobiltà polacca v. Michael G. Müller, Der polnische Adel von 1750 bis 1863, in AA.VV., Europäischer Adel 1750-1950, Göttingen 1990, pp. 217-242; Robert I. Frost, The Nobility of Poland-Lithuania, 1569-1795, in AA.VV., The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, I-II, London 1995: II, pp. 183-222.
3. Marco Foscarini, Necessità della storia e Della perfezione della Repubblica veneziana, a cura di Luisa Ricaldone, Milano 1983, pp. 207 s.; cf. Piero Del Negro, Proposte illuminate e conservazione nel dibattito sulla teoria e la prassi dello stato, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 5/II, Il Settecento, Vicenza 1986, pp. 127 ss. (pp. 123-145).
4. Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les Traités de Westphalie jusqu'à la Révolution Française, XXVI, Venise, a cura di Pierre Duparc, Paris 1958, pp. 275 ss.
5. Piero Del Negro, La memoria dei vinti. Il patriziato veneziano e la caduta della Repubblica, in AA.VV., L'eredità dell'Ottantanove e l'Italia, Firenze 1992, pp. 351-370.
6. Id., Il patriziato veneziano e la fine della Serenissima, in AA.VV., L'Europa delle corti alla fine dell'Antico Regime, Roma 1991, p. 429 (pp. 429-440).
7. Giovanni Tabacco, Andrea Tron e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia, Udine 19802; James C. Davis, The Decline of the Venetian Nobility as a Ruling Class, Baltimore 1962; Gianfranco Torcellan, Una figura della Venezia settecentesca: Andrea Memmo. Ricerche sulla crisi dell'aristocrazia veneziana, Roma-Venezia 1963; Jean Georgelin, Venice au siècle des lumières, Paris-La Haye 1978, pp. 800 ss.: "Crise d'un État et crine d'un groupe dirigeant"; Laura Megna, Riflessi pubblici della crisi del patriziato veneziano nel XVIII secolo: il problema delle elezioni ai reggimenti, in Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII), a cura di Gaetano Cozzi, II, Roma 1985, pp. 253-299; Renzo Derosas, Aspetti economici della crisi del patriziato veneziano tra fine Settecento e primo Ottocento, in AA.VV., Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni, Milano-Roma-Bari 1992, pp. 80-132; In., La crisi del patriziato come crisi del sistema familiare: i Foscarini ai Carmini nel secondo Settecento, in AA.VV., Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venezia 1992, pp. 309-331; Luca De Biase, Amore di Stato. Venezia. Settecento, Palermo 1992 (vi si parla di "suicidio").
8. Piero Del Negro, La distribuzione del potere all'interno del patriziato veneziano del Settecento, in AA.VV., I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea, Udine 1984 p. 311 (pp. 311-337).
9. Francesco Guicciardini, Dialogo del reggimento di Firenze, in Id., Opere, a cura di Emanuella Lugnani Scarano, I, Torino 1970, p. 406 (pp. 297-473).
10. Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di Franco Venturi, Torino 19942, p. 56.
11. H.M. Scott-C. Storrs, Introduction, pp. 5 e 13; cf. Robert Finlay, Politics in Renaissance Venice, London 1980, p. 81.
12. Marco Ferro, Dizionario del diritto comune e veneto (1778-1781), I-II, Venezia 1845-18472: I, pp. 294 e 700 s.
13. Relazione dell'anonimo (1664), in Pompeo G. Molmenti, Curiosità di storia veneziana, Bologna 1919, p. 368 (pp. 359-456); Giornale, col Libro d'Oro, Venezia 1715, p. 252.
14. Raimond J. Loenertz, Les Ghisi. Dynastes vénitiens dans l'archipel, 1207-1390, Firenze 1975; Marco Pozza, I Badoer. Una famiglia veneziana dal X al XIII secolo, Abano Terme 1982; Irmgard Fees, Reichtum und Macht im mittelalterlichen Venedig. Die Familie Ziani, Tübingen 1988.
15. James C. Davis, A Venetian Family, and Its Fortune 1500-1900. The Donà and the Conservation of Their Wealth, Philadelphia 1975; Giuseppe Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta. Storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro vicende patrimoniali tra 1705 e 1836, Roma 1984; Id., I Loredan di Santo Stefano: cenni storici, in AA.VV., Palazzo Loredan e l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 1985, pp. 11-33; I Querini Starnpalia. Un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, a cura di Giorgio Busetto-Madile Gambier, Venezia 1987; R. Derosas, La crisi del patriziato.
16. Daniele Beltrami, La penetrazione economica dei Veneziani in Terraferma: forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 1961; Gaetano Cozzi, Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano, Venezia 1995, p. 360.
17. Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, IX, Venezia 1860, p. 6; cf. Volker Hunecke, Der venezianische Adel am Ende der Republik 1646-1797. Demographie, Familie, Haushalt, Tübingen 1995, p. 55.
18. Giacomo Nani, Saggio politico del corpo aristocratico della Repubblica di Venezia per l'anno 1756, in Padova Biblioteca Universitaria, cod. 914 (sono profondamente grato a Piero Del Negro per avermi messo a disposizione una copia di quest'opera); sul Nani e il suo Saggio v. Piero Del Negro, Giacomo Nani. Appunti biografici, "Bollettino del Museo Civico di Padova", 60, 1971, nr. 2, pp. 115-147; In., Proposte illuminate, pp. 138-140.
19. V. Hunecke, Der venezianische Adel, p. 56 n. 116.
20. Oliver Thomas Domzalski, Politische Karrieren und Machtverteilung im venezianischen Adel (1646-1797), Sigmaringen 1996, p. 50; Marion Lühe, Der venezianische Adel nach dem Untergang der Republik, 1797-1830, Diss. phil., Technische Universität Berlin, a.a. 1995, p. 29.
21. P. Del Negro, La distribuzione del potere, p. 328 n. 47; O.T. Domzalski, Politische Karrieren, p. 54; Pompeo Molmenti, Lettere inedite del patrizio Pietro Zaguri a Giacomo Casanova ordinate e annotate, "Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", 70, 1910-1911, pt. II, p. 127 (pp. 81-204).
22. Le Case di cui Giacomo Nani probabilmente aveva sopravvalutato il patrimonio sono: Bembo S. Agnese sulle Zattere, Cassetti, Dandolo SS. Giovanni e Paolo, Manzoni, Nosadini, Zane S. Stefano.
23. O.T. Domzalski, Politische Karrieren, pp. 54 s.; si tratta dei Foscolo S. Basegio (classe V), dei Minotto S. Pantalon (classe III) e dei Bollani S. Trovaso (classe II).
24. Relazione dell'anonimo (1664), pp. 370-418.
25. Su questa cesura v. Piero Del Negro, Forme e istituzioni del discorso politico veneziano, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 4/II, Il Seicento, Vicenza 1984, p. 427 (pp. 407-436). Tre dogi provennero dalla Casa dei Corner S. Polo e rispettivamente due da quelle dei Contarini S. Francesco della Vigna, dei Mocenigo S. Stae e dei Valier (la Casa dei dogi Bertucci [1656-1658] e Silvestro Valier [1694-1700]; padre e figlio, si estinse con quest'ultimo).
26. La Casa di Alessandro di Imperial Contarini S. Benetto (classe V), che nel 1668 aveva acquistato la dignità procuratoria per 25.000 ducati, sembra essersi successivamente impoverita. L'unico altro procuratore proveniente da una Casa della classe V fu Andrea di Zuanne Corner S. Girolamo, eletto "per merito" nel 1678. Non conosciamo la sua situazione patrimoniale all'epoca dell'elezione.
27. La nonna del Rubini era una sorella del papa, circostanza che spiega la sua nomina.
28. Cf. V. Hunecke, Der venezianische Adel, p. 61.
29. Sulle cifre riportate nel testo v. ibid., p. 62 n. 131. Sul problema della povertà patrizia v. Laura Megna, Nobiltà e povertà. Il problema del patriziato povero nella Venezia del '700, "Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", classe di scienze morali, lettere ed arti, 140, 1981-1982, pp. 319-340.
30. Relazione dell'anonimo (1664), p. 373; Alexander F. Cowan, The Urban Patriciate: Lübeck and Venice, 1580-1700, Köln-Wien 1986, p. 170 n. 606.
31. O.T. Domzalski, Politische Karrieren, p. 55; sulla carriera di Zuanne di Francesco Bollani v. più avanti.
32. R. Finlay, Politics in Renaissance Venice, pp. 92 ss.
33. Relazione dell'anonimo (1664), pp. 368 s., 416 ss.; P. Del Negro, Forme e istituzioni, p. 420.
34. Giovanni Pindemonte, Poesie e lettere, a cura di Giuseppe Biadego, Bologna 1883, p. 338.
35. Ibid., pp. 338 s.; P. Del Negro, La distribuzione del potere, p. 336; sulla integrazione politica dei nobili nuovi v. anche Roberto Sabbadini, Il nuovo patriziato veneziano: analisi del suo inserimento politico e sociale (metà sec. XVII - metà sec. XVIII), tesi di laurea, Università degli Studi di Venezia, a.a. 1987-1988, cap. 4, e O.T. Domzalski, Politische Karrieren.
36. Non sono stati considerati i Gonzaga alle Romite, i Lambertini, i Pallavicino e gli Spatafora che non compaiono nell'almanacco del 1719, ma solo in edizioni più tarde, nonché le dieci famiglie aggregate dopo il 1775. Nel calcolare il numero dei patrizi di età superiore ai venticinque anni è stato tenuto conto solo dell'anno e non del mese e del giorno della loro nascita; pertanto le cifre menzionate possono leggermente discostarsi da quelle reali.
37. Nicolò Balbi, Relazione delle cose occorse in Maggior Consiglio nella Correzione dell'anno 1775, in A.S.V., Correttori alle leggi, b. 3, lettere VII e VIII; cf. J.C. Davis, The Decline of the Venetian Nobility, pp. 96 ss., e Franco Venturi, Settecento riformatore, V/2, L'Italia dei lumi. La Repubblica di Venezia (1761-1797), Torino 1990, pp. 182 ss.
38. N. Balbi, Relazione, lettera VII.
39. Fra i patrizi di età superiore ai vent'anni registrati negli almanacchi della nobiltà, la quota degli ecclesiastici (compresi gli abati "veri e finti") fra il 1719 e il 1796 calò dal 7% al 6,5%.
40. Non è stato contato Piero Vettor di Vettor Pisani S. Polo (classe I), un figlio illegittimo che il 7 maggio 1785 riuscì ad ottenere la sua iscrizione nel Libro d'oro; cf. G. Gullino, I Pisani, pp. 3 ss., 397 s.
41. Su quanto segue v. P. Del Negro, Proposte illuminate (da questo fondamentale contributo sono tratte anche le citazioni seguenti); sul Boccalini cf. Claudio Donati, L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII, Roma-Bari 1988, p. 204.
42. Solo patrizi di età superiore ai venticinque anni, compresi gli ecclesiastici; da non confondere con i membri effettivi del maggior consiglio (v. sopra n. 20); per le cifre riportate nel testo vale la riserva espressa alla n. 36.
43. V. Hunecke, Der venezianische Adel, p. 391, tav. 12.
44. P. Del Negro, Proposte illuminate, p. 130.
45. Sul Muazzo cf. Ernesto Garino, Insidie familiari. Il retroscena della successione testamentaria a Venezia alla fine del XVIII secolo, in Stato, società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII), a cura di Gaetano Cozzi, II, Roma 1985, p. 363 (pp. 301-778); v. anche Pietro Garzoni, Istoria della Repubblica di Venezia, pt. I, Venezia 1712, p. 77.
46. P. Del Negro, Proposte illuminate, p. 132; Id., La distribuzione del potere, p. 320; L. Megna, Nobiltà e povertà, p. 324.
47. N. Balbi, Relazione, lettera VIII; cf. ibid. il discorso di Giulio Antonio Contarini S. Stae: "[...] giacché sempre più scarseggiano li Matrimoni, specialmente trà le Famiglie di mediocri fortune".
48. Sul numero delle famiglie aggregate dal 1646 in poi cf. V. Huneche, Der venezianische Adel, p. 35, in particolare n. 50.
49. Piero Del Negro, Gasparo Cozzi e la politica veneziana, in AA.VV., Gasparo Gozzi. Il lavoro di un intellettuale nel Settecento veneziano, Padova 1989, pp. 55 s. (pp. 45-63). Sulla demografia del patriziato v. V. Hunecke, Der venezianische Adel, capp. III-V; ivi anche tutti i riscontri per le cifre che citeremo in seguito.
50. In questi calcoli sono incluse solo le donne che hanno avuto almeno un figlio, perché non disponiamo di dati attendibili sulle cosiddette coppie sterili; cf. V. Huneche, Der venezianische Adel, pp. 73 s., 80.
51. Pietro Longhi, catalogo della mostra di Venezia, Milano 1993, pp. 108 s. (nr. 53), 229; A.S.V., Avogaria di Comun, reg. 190, ad dies 4 dicembre 1747, 16 gennaio 1747 m.v., 18 settembre 1749.
52. Laura Megna, Comportamenti abitativi del patriziato veneziano (1582-1740), "Studi Veneziani", n. ser., 22, 1991, pp. 272 55. (pp. 253-323).
53. Fra la battaglia di Lepanto e la guerra di Candia, cioè fra il 1571 e il 1669, morirono più di ottocento nobiluomini abili alle armi e al maggior consiglio in conseguenza delle guerre e della peste.
54. A.S.V., Notarile, Testamenti, Atti Pietro Pensa 897.20; cf. Paolo Preto, Corner, Flaminio, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXIX, Roma 1983, pp. 191-193.
55. Nelle considerazioni che seguono non terremo più conto dell'età nuziale delle donne patrizie in quanto, come si è accennato, essa praticamente non influiva sulla fecondità dei matrimoni.
56. In questi casi i figli tutt'al più potevano acquistare l'accesso al patriziato, come si verificò ancora tre volte dopo il 1646 (cf. V. Hunecke, Der venezianische Adel, pp. 105-107).
57. Senza considerare i trentanove matrimoni contratti da uomini appartenenti alle famiglie papali o aggregate ad honorem (cf. ibid., p. 391).
58. Ibid., pp. 247 ss.
59. Terisio Pignatti, Pietro Longhi, Milano 1974, nrr. 200-202. Non si capisce bene il motivo per cui Piero Antonio Querini non fece registrare il suo matrimonio; infatti il fratello maggiore Stefano, grazie alla cui numerosa discendenza la Casa si perpetuò, si sposò solo nel 1757 con una figlia di Pisana Zustinian Grimani, la nobildonna celebrata come "feconda madre" dal Gozzi. Stefano Querini viene più volte menzionato in un contesto inglorioso da Giacomo Casanova.
60. Dante E. Zanetti, La demografia del patriziato veneziano nei secoli XVII, XVIII, XIX, Pavia 1972, p. 84; Robert Burr Litchfield, Demographic Characteristics of Florentine Patrician Families, Sixteenth to Nineteenth Centuries, "Journal of Economic History", 29, 1969, p. 197 (pp. 191-205).
61. Il fatto che almeno l'8,6% dei patrizi che fecero registrare i loro matrimoni dall'avogaria di comun fossero nati da seconde o terze nozze denuncia quanto esse fossero importanti per la sopravvivenza di una Casa.
62. Francesco Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare, con le aggiunte di Giustiniano Martinioni, Venetia 1663 (riprod. anast. 1968), p. 381; cf. Ennio Concina, Venezia nell'età moderna, Venezia 1989, p. 127.
63. Joseph de Lalande, Voyage en Italie, VIII, Paris 17862, pp. 477-479; cf. J. Georgelin, Venise au siècle des lumières, pp. 643 s.
64. M. Ferro, Dizionario, I, pp. 772 s.
65. Pietro Longhi, pp. 184 s. (nr. 83), 229.
66. A.S.V., Notarile, Testamenti, Atti Gio. Leonardo Tassini 945.25 e Atti Ruggero Mondini 643.38 e 39.
67. Leon Battista Alberti, I libri della famiglia, a cura di Ruggiero Romano-Alberto Tenenti, Torino 1972, p. 232; sulle cifre citate fin qui e in seguito v. V. Hunecke, Der venezianische Adel, pp. 308 ss.
68. Senza il sestiere di San Marco, i cui moduli di censimento sono andati smarriti; pertanto è possibile che le cifre citate nel testo si discostino leggermente da quelle reali.
69. Una possibilità di assentarsi almeno temporaneamente dal ménage comune era offerta dai "casini", particolarmente numerosi nella parrocchia di San Moisè; cf. Alberto Fiorin, Ritrovi di gioco nella Venezia settecentesca, "Studi Veneziani", n. ser., 14, 1987, pp. 216 e 221 (pp. 213-245).
70. A.S.V., Notarile, Testamenti, Atti Giovanni Zon 1281.138 (testamento del 6 ottobre 1707).
71. Non è compreso in questo numero Andrea Tron, per trentaquattro volte savio grande, il cui matrimonio, contratto all'età di sessant'anni, non aveva lo scopo di assicurare la continuazione della Casa.
72. O.T. Domzalski, Politische Karrieren, pp. 153 ss.
73. Sulle spese causate dai rettorati nelle grandi città di Terraferma e dalle ambasciate v. J.C. Davis, The Decline of the Venetian Nobiliy, pp. 81-88; G. Gullino, I Pisani, pp. 273, 315, 376, 380; Renzo Derosas, I Querini Stampalia. Vicende patrimoniali dal Cinque all'Ottocento, in AA.VV., I Querini Stampalia. Un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, Venezia 1987, pp. 69 s. (pp. 43-88).
74. M. Ferro, Dizionario, I, pp. 748 s.; II, pp. 252 s., 376 ss.
75. C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, p. 57.
76. M. Ferro, Dizionario, I, pp. 439, 689; la seconda citazione è tratta dal testamento di Antonio di Zuanne Francesco Loredan, del 12 febbraio 1694 (A.S.V., Notarile, Testamenti, Atti Marco Antonio Bigaglia 171.21).
77. R. Derosas, I Querini Stampalia, pp. 61, 67, 69, 81.
78. Madile Gambier, I carteggi privati dei Querini, in AA.VV., I Querini Stampalia. Un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, Venezia 1987, p. 93 (pp. 89-95).
79. L. De Biase, Amore di Stato, p. 69.
80. Fra "grandi" e "plebee" si verificarono altri quattro matrimoni, ma nessuno di essi aveva lo scopo di assicurare la successione della Casa, come quello fra Andrea Tron e Cattarina Dolfin, già menzionato alla n. 71. Da una di queste unioni nacque l'unica nobildonna che nel corso del Settecento sposò a sua volta un "plebeo" (v. V. Hunecke, Der venezianische Adel, pp. 180 ss.).
81. M. Ferro, Dizionario, I, pp. 689 s.
82. O.T. Domzalski, Politische Karrieren, pp. 31-35; cf. L. Megna, Riflessi pubblici, pp. 272 s.
83. Un piccolo numero di cariche dipendeva dal consiglio dei dieci.
84. O.T. Domzalski, Politische Karrieren, p. 93. La ricerca del Domzalski è la prima e finora l'unica che analizza in toto le cariche della Repubblica e le carriere politiche di circa milleduecento patrizi.
85. Ibid., pp. 111 ss. Questa asserzione, come molti altri dati tratti dall'opera di Domzalski, si riferisce all'intero periodo compreso fra il 1646 e il 1797; può essere considerato sicuro che la quota dei patrizi che si astenevano totalmente dalla vita politica diminuì nel corso del Settecento.
86. Ibid., pp. 128 ss. e Appendice relativa; sulle quarantie v. anche Piero Del Negro, Politica e cultura nella Venezia di metà Settecento. La ῾poesia barona' di Giorgio Baffo ῾quarantiotto', "Comunità", 184, 1982, pp. 329 ss. (pp. 312-425).
87. Le considerazioni che seguono si basano sui risultati di O.T. Domzalski, Politische Karrieren, Appendici 3 e 4, che ha analizzato un campione di novanta Case comprese nella classificazione del Nani.
88. Discendenti di Daniele di Andrea; da non confondere con la Casa dei Renier S. Margarita estintasi nel 1761 (classe III; discendenti di Girolamo di Zuanne) contraddistinta da un impegno politico ancora più forte.
89. Gli assai prolifici Gradenigo S. Simeon Grande (classe I). Dieci dei loro ventisei uomini capaci al maggior consiglio appartenevano al gruppo dei politici particolarmente attivi (eletti almeno dieci volte); pertanto la Casa Gradenigo, i cui uomini nel corso di centocinquanta anni vennero eletti trecentottantatré volte, non può essere annoverata fra le Case che si astenevano dalla politica. Cinque membri della Casa dei Minotto S. Pantalon (classe III, ma temporaneamente impoverita) rimasero completamente al di fuori della vita politica; altri tredici vennero eletti complessivamente duecentoventotto volte.
90. L. De Biase, Amore di Stato, p. 103; J.C. Davis, The Decline of the Venetian Nobility, pp. 77 ss., 103.
91. O.T. Domzalski, Politische Karrieren, pp. 101 s.; Laura Megna, Ricchi e poveri al servizio dello Stato. L'esercizio della ῾distributiva' nella Venezia del '700, in AA.VV., I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea, Udine 1984, pp. 369-371 (pp. 365-380).
92. P. Del Negro, Giacomo Nani; O.T. Domzalski, Politische Karrieren, p. 155, Appendice relativa.
93. Piero Del Negro, Appunti sul patriziato veneziano, la cultura e la politica della ricerca scientifica nel secondo Settecento, in AA.VV., La Specola dell'Università di Padova, Brugine 1986, pp. 260-262 (pp. 247-294); Michele Gottardi, L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca 1798-1806, Milano 1993, pp. 257 s.
94. Il Nani attribuì alla classe III la Casa di Maria di Enrico Dandolo S. Pantalon, che sposò nel 1785 Alvise di Antonio Marin. In realtà però questo ramo dei Dandolo viveva in ristrettezze economiche: nel 1761 i ménages di Enrico e di suo fratello Andrea disponevano di un solo servitore, il loro fratello Silvestro non ne aveva neanche uno e la vedova e tre figli di quest'ultimo furono costretti a ricorrere alla beneficenza pubblica.
95. Questo e i dati seguenti sono tratti da O.T. Domzalski, Politische Karrieren, Appendice; pp. 69, 96 s.
96. Giacomo, il Marin con il tasso più alto di attività politica (0,71), fu l'unico della sua Casa a venir eletto ad una delle cariche dipendenti dal consiglio dei dieci. Suo fratello, il "quarantiotto" Andrea, fu il terzo Marin eletto più di una volta ad una carica che gli permise l'accesso al senato ex officio. Le restanti sei elezioni di un Marin ad un ufficio elevato toccarono, per motivi inspiegabili, a membri sempre diversi di questa Casa.
97. Antonio aveva altri due figli maschi che morirono giovani.
98. Piero Del Negro, ῾Virtù, zelo, e prudenza'. Per una storia del ῾mestiere' di rettore veneziano in Terraferma alla luce delle ῾Lettere responsive' di Camillo Venier, podestà e capitanio di Conegliano dal 1772 al 1774, "Atti e Memorie dell'Ateneo di Treviso", 1992-1993, nr. 10, pp. 139-159.
99. Ciò che segue si basa su O.T. Domzalski, Politische Karrieren, pp. 140-142; v. anche sopra.
100. Tassi di attività politica: Zuanne (1,32), Girolamo (0,75), Zuanne Battista (0,29).
101. A.S.V., Notarile, Testamenti, Atti Pietro juniore Bracchi 76.103 (testamento del 16 luglio 1750).
102. Relazione dell'anonimo (1664), p. 425; G. Pindemonte, Poesie e lettere, p. 337.
103. A.S.V., Segretario alle Voci, Elezioni in Pregadi, regg. 21-26. In questo passo vengono attribuiti alla classe III anche i Memmo S. Marcuola, classificati erroneamente dal Nani, alla cui Casa apparteneva Andrea di Costantin (1670-1754) che con ventotto elezioni fu uno dei savi grandi in carica più spesso; anche suo nipote Andrea di Piero ottenne una volta questa carica. Ringrazio di cuore Andrea Zannini che ha gentilmente compilato per me una lista completa di tutti i savi grandi eletti dal 1697.
104. Quota delle Case appartenenti alla classe II: 31%.
105. Diciannove Case ebbero due savi grandi, cinque Case tre, tre Case quattro e due Case cinque; queste ultime sono i Foscarini S. Stae, in seguito ai Carmini (classe I), e gli Erizzo S. Martin (classe III).
106. Contarini S. Benetto, Foscarini ai Carmini, Mocenigo S. Stae, Morosini S. Cancian, Morosini S. Stefano, Pisani S. Stefano, Ruzzini S. Giobbe e Tiepolo S. Aponal; cf. R. Derosas, Aspetti economici, pp. 127 s. n. 25.
107. Sei patrizi da una a cinque volte e anche gli altri cinque al massimo sei o sette volte.
108. Sulla fine della Repubblica e sugli eventi che la seguirono v. i contributi di Piero Del Negro e di Giovanni Scarabello in questo stesso volume.
109. Recueil des traités de la France, I, 1713-1802, a cura di de Clercq, Paris 1880, p. 324.
110. V. Hunecke, Der venezianische Adel, pp. 402 s., tavv. 23 e 24.
111. P. Del Negro, Proposte illuminate, p. 134.
112. R.I. Frost, The Nobility of Poland-Lithuania, pp. 216 ss.
113. Gianfranco Torcellan, Settecento veneto e altri scritti storici, Torino 1969, p. 320; cf. anche Marino Berengo, Il problema politico-sociale di Venezia e della sua Terraferma, in Storia della civiltà veneziana, a cura di Vittore Branca, III, Firenze 1979, p. 158 (pp. 151-163); sull'età delle riforme a Venezia e nel Veneto v. F. Venturi, Settecento riformatore, V/2, e il contributo di Paolo Preto in questo volume.
114. M. Gambier, I carteggi privati dei Querini, p. 94.
115. P. Del Negro, Giacomo Nani, pp. 136 s.; sulla correzione del 1780-1781 cf. F. Venturi, Settecento riformatore, V/2, pp. 198 ss.
116. Raccolta di carte pubbliche, istruzioni, legislazioni ec. ec. ec. del nuovo Veneto Governo Democratico, I, Venezia 1797, pp. XIII s.
117. Cf. M. Lühe, Der venezianische Adel nach dem Untergang der Republik, passim.