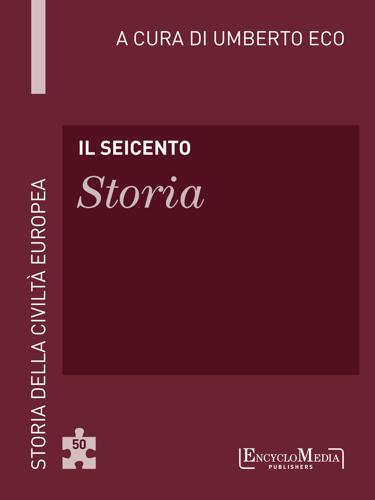Il Seicento: L’Impero ottomano
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Le Capitolazioni sono lo strumento con il quale gli Ottomani cercano di procurarsi alleati in Europa e di acquisire vantaggi commerciali, ma alla fine si rivelano un’arma a doppio taglio, in quanto permettono alle potenze europee di utilizzare il loro potere economico per scardinare le fondamenta dell’impero. Ma il Seicento è anche il secolo che costa agli Ottomani la perdita della supremazia militare, costringendo l’impero alla difensiva su più fronti e segnando un notevole ridimensionamento dei suoi confini.
Gli inizi del declino. Le Capitolazioni
È opinione comune fra gli storici considerare l’epoca di Solimano il Magnifico non solo come il periodo di massimo fulgore dell’Impero ottomano, ma anche come la fase nella quale ha inizio il suo progressivo declino. L’idea, pur non priva di fondamento, è certamente condizionata dal senno di poi, perché per almeno altri due secoli l’impero di Istanbul continua a rappresentare una seria minaccia per le potenze europee. Alla fine del XVII secolo i Turchi sono ancora in grado di porre Vienna sotto assedio e nella prima metà del secolo successivo grandi sussulti di vitalità non sembrano annunciare il definitivo tramonto della potenza ottomana.
Fra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, tuttavia, si rende sempre più evidente la potenzialità corrosiva di uno strumento che gli Ottomani avevano utilizzato per ottenere vantaggi politico-diplomatici, ma che alla fine si rivelerà il grimaldello grazie al quale il potere economico degli Europei riesce a scardinare le fondamenta dell’impero. Le “capitolazioni” (in turco imtiyazat) erano in origine concessioni unilaterali che il sultano concedeva a una potenza straniera, al fine di procurarsi alleati in seno all’Europa e di ottenere benefici di carattere economico e commerciale. I primi a beneficiare di queste Capitolazioni (così chiamate perché le concessioni prevedevano una serie di articoli o capitoli) furono i Genovesi, nel XIV secolo, ma col passare del tempo i sultani fecero sempre più ricorso a questo strumento apparentemente vantaggioso. Così, agli inizi del Seicento, le Capitolazioni sono ormai divenute prassi comune negli accordi fra Istanbul e varie città o Stati d’Europa.
In sintesi, ogni Capitolazione permette al beneficiario di mantenere una base nell’Impero ottomano e al tempo stesso di godere di una serie di privilegi. In cambio di una pacifica e amichevole intesa, la concessione garantisce uno statuto di extraterritorialità a coloro che ne usufruiscono, in modo da poter svolgere liberamente le proprie attività, da godere di un regime fiscale vantaggioso, da vedere tutelate persone e beni e da avvalersi delle leggi e dei tribunali del proprio Paese d’origine. Nella seconda metà del XVI secolo gli Stati “capitolari” ufficialmente riconosciuti dal sultano sono Venezia, la Polonia e la Francia, ma è soprattutto quest’ultima a trarre vantaggio dalla situazione. Per godere dello stesso trattamento, i mercanti inglesi, portoghesi, spagnoli, catalani o siciliani sono costretti a navigare sotto la bandiera della Francia, che diventa così una sorta di alleato privilegiato degli Ottomani, incrementando il volume dei propri traffici commerciali e soprattutto sperando di sfruttare questa alleanza in funzione antiasburgica. Ma nel 1580 il sultano Murat III (1574-1595) decide di concedere il favore della capitolazione anche a Elisabetta d’Inghilterra, dando inizio a una vera e propria guerra fra le potenze europee per accaparrarsi questo genere di vantaggi. Per tutto il Seicento, Francia e Inghilterra si confrontano sul terreno della penetrazione commerciale nell’impero, un terreno sul quale si aggiungono ben presto altri concorrenti, come l’Olanda, che riusce a ottenere le sue prime Capitolazioni nel 1612, o l’Impero asburgico, che consegue vantaggi analoghi nel 1667. La Francia tenta di riconquistare una posizione dominante facendosi nominare “protrettrice” di tutti i mercanti cristiani che non avevano un ambasciatore a Istanbul, ma le pressioni inglesi alla fine riescono a far prevalere il principio della nazione più favorita, che autorizzava i commercianti a scegliere una potenza di loro gradimento. Ai Francesi rimane solo il simbolico privilegio di tutelare i pellegrini cristiani che si recano in Terrasanta, che in seguito permette loro di autoproclamarsi protettori di tutti i cattolici presenti nei territori dell’impero.
Nel lungo periodo, il risultato di queste vicende sarà letale per l’Impero ottomano. Le concessioni commerciali si trasformano con l’andare del tempo in potentati capaci di erodere, grazie alla penetrazione economica, il potere politico di Istanbul. Da favori unilaterali concessi dall’imperatore, le Capitolazioni diventano stabili accordi bilaterali, che sempre più procurano vantaggi alle potenze europee e impongono squilibri doganali così sfavorevoli agli Ottomani da far sì che la loro produzione artigianale e industriale giunga infine al tracollo. Se lo Stato ottomano non subirà mai la dominazione coloniale diretta, tuttavia le Capitolazioni restano il classico esempio di una “invasione” che, senza conquiste o occupazioni militari, sarà nondimeno decisiva nel determinare l’agonia dell’impero.
Il confronto con l’Austria
Come si è detto, il Seicento vede gli Ottomani ancora una volta protagonisti di importanti imprese militari, anche se l’impero deve impegnarsi su molteplici fronti e con alterni successi. Il confronto con l’Austria, che per tutto il secolo è uno dei più significativi, inizia nel segno della pace di Zsitva Torok del 1606, poco rilevante sul piano politico e non molto duratura, ma estremamente significativa sul piano simbolico: per la prima volta un sultano, nella fattispecie Ahmet I, rinuncia alle pretese di dominio universale e riconosce al suo omologo d’Austria una dignità pari alla propria. Questo cedimento su una questione di principio non fa che rispecchiare il mutato rapporto di forze fra gli Ottomani e i loro maggiori avversari europei, i quali hanno ormai colmato il divario tattico e organizzativo che a lungo aveva garantito la superiorità militare dei Turchi.
Lo scoppio in Europa della guerra dei Trent’anni (1618-1648), se da una parte concede all’Impero ottomano un periodo di relativa tranquillità nello scontro con gli Asburgo, dall’altra non fa che accentuare il declino dell’esercito. Mentre le potenze europee, proprio grazie a quella guerra, escono rafforzate sul piano dell’ organizzazione militare e nell’uso delle armi, le armate ottomane non si aggiornano altrettanto rapidamente, rimanendo ancorate a schemi e princìpi non più in grado di reggere il confronto con quei nemici. Le riforme tentate da Murat IV (1632-1640), definito “l’ultimo sultano guerriero”, non riescono a piegare le resistenze di un esercito che si presta malvolentieri alle innovazioni, condannandosi a metodi obsoleti e sempre meno adeguati alle esigenze della guerra moderna. In quello stesso periodo cessa definitivamente anche il devshirme, la leva di giovani cristiani allevati nell’islam per essere addestrati a compiti amministrativi e militari, che tanta parte aveva avuto nei successi dei secoli precedenti. Così, nel corso del Seicento, il fronte asburgico rappresenta per gli Ottomani una spina nel fianco.
Nella seconda metà del secolo emergono le figure di alcuni energici gran vizir (una specie di primi ministri), che cercano di arginare il declino e di dare nuova linfa alla spinta espansiva dell’impero, senza mai riuscire, però, a portare a buon fine i loro progetti. Il primo fra questi personaggi politici d’eccezione è un albanese, Köprülü Mehmet, che inaugura una vera e propria dinastia di gran vizir. Assunto l’incarico nel 1656, mette mano a un’opera di rafforzamento e di riordino dell’impero, proseguita poi dal figlio Köprülü Fazïl Ahmet, che gli succede nella carica a partire dal 1661. Due anni dopo il gran vizir decide di riprendere in grande stile le operazioni contro l’Austria, ma l’anno successivo viene sconfitto al San Gottardo sul Raab dalle truppe guidate da Raimondo Montecuccoli. Il trattato che ne segue, siglato a Vasvar nel 1664, è tuttavia ancora sostanzialmente favorevole agli Ottomani, che conservano gran parte delle loro conquiste, illudendoli sulla capacità di proseguire una politica di espansione.
Si giunge in tal modo all’ultima grande guerra fra l’Austria e l’Impero ottomano (1682-1699), durante la quale un altro gran vizir, Qara Mustafa Pascià, si affaccia di nuovo alle porte di Vienna. Si dice che abbia in mente un progetto grandioso: una volta conquistata Vienna, le sue truppe avrebbero proseguito nel cuore dell’Europa, lungo il Reno, per sconfiggere anche il regno di Francia e per calare infine su Roma, dove la basilica di San Pietro sarebbe diventata una stalla per i cavalli turchi. Vienna viene effettivamente posta sotto assedio il 17 luglio 1683 e le sorti di quell’impresa rimangono a lungo incerte, tanto da spingere molti degli abitanti della capitale e lo stesso imperatore a fuggire dalla città. In tutta Europa si diffonde il timore di una nuova Costantinopoli, ma le truppe di Giovanni Sobieski, il “baluardo della cristianità”, e di Carlo di Lorena riescono infine ad avere ragione degli assedianti, sconfitti definitivamente il 12 settembre dello stesso anno. L’Europa poteva tirare un respiro di sollievo e riprendere l’iniziativa, e su impulso del papa Innocenzo XI organizza una nuova Lega Santa fra Austria, Polonia e Venezia, che si propone di ricacciare i Turchi in Asia. Anche in questo caso l’ambizioso obiettivo non è raggiunto, ma l’Impero ottomano esce fortemente ridimensionato dalla sconfitta. Se, infatti, i Turchi mantengono molti dei loro possedimenti europei, la pace di Karlowitz che pone fine al conflitto (1699) restringe in modo significativo i confini dell’impero: l’Austria acquisisce l’Ungheria, la Transilvania, la Croazia e la Slavonia, Venezia si riprende la Morea e buona parte della Dalmazia, e la Polonia prende possesso della Podolia. Il nuovo assetto, cruciale per la successiva storia europea, dà anche inizio al tramonto delle ambizioni ottomane.
L’Impero russo e la nuova minaccia da Est
Con il suo tradizionale nemico orientale, l’Iran, l’Impero ottomano riesce nel corso del Seicento a mantenere un confine stabile. I conflitti non mancano, ma la loro portata è tutto sommato secondaria rispetto alla situazione sugli altri fronti. La vera minaccia da est è rappresentata da un nuovo avversario, l’impero degli Zar. La grande eredità dell’Orda d’Oro, i discendenti delle conquiste mongole, si è frammentata in diversi potentati musulmani che dominano le terre di confine fra il mondo slavo e l’Impero ottomano. I Khan tatari di Kazan, di Astrakhan e di Crimea cercano di porre un argine alla crescente espansione dell’elemento russo, ma il rapporto di forze si va col tempo alterando e con sempre maggiori difficoltà quei regni riescono a opporsi alle pressioni di Mosca. In qualche caso le alleanze con Istanbul permettono di offrire una resistenza più efficace, ma alla lunga il loro destino sarà quello di soccombere definitivamente agli Slavi, anche se il Khanato di Crimea cesserà ufficialmente di esistere solo nel 1783. L’Impero russo adotta nei confronti delle popolazioni tatare una politica di durissima repressione (che cesserà solo nel XVIII secolo sotto la grande Caterina), costringendo quelle genti all’espulsione o all’assimilazione forzata, compresa la conversione al Cristianesimo ortodosso.
Le ambizioni russe verso il Mar Nero e il Caspio si trovano così in diretta concorrenza con l’Impero ottomano. Il Khanato tataro di Crimea, retto dalla famiglia dei Ghiray, discendenti di Gengis Khan, cerca ancora di ritagliarsi un ruolo da protagonista in quei frangenti, ma è ormai evidente che i veri attori della contesa sono l’Impero russo e quello turco. In un confuso intreccio di instabili alleanze fra Tatari, Cosacchi, Russi e Turchi si dipana per tutto il secolo un conflitto lungo i confini orientali dell’Impero ottomano che, se non ha sul momento un chiaro vincitore, rappresenta per Istanbul un elemento di costante preoccupazione. Dopo una guerra con la Polonia che frutta loro l’Ucraina orientale (1672-1676), gli Ottomani si vedono ben presto strappare quella conquista al termine del loro primo conflitto con l’Impero russo (1677-1681). Le aspirazioni di Mosca in direzione del Mar Nero si concretano in modo ancora più chiaro alla fine del secolo, con la conquista della città di Azov (1696) ad opera di Pietro il Grande: si è ormai aperto il lungo conflitto che vedrà opporsi gli zar e i sultani per tutto il secolo successivo.