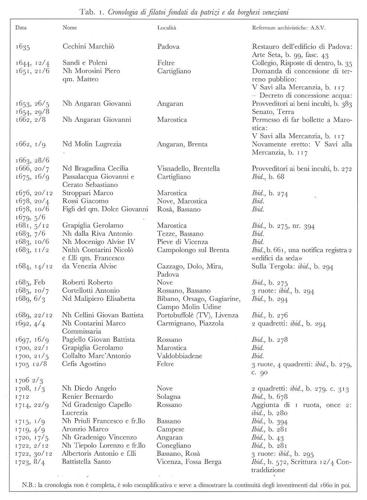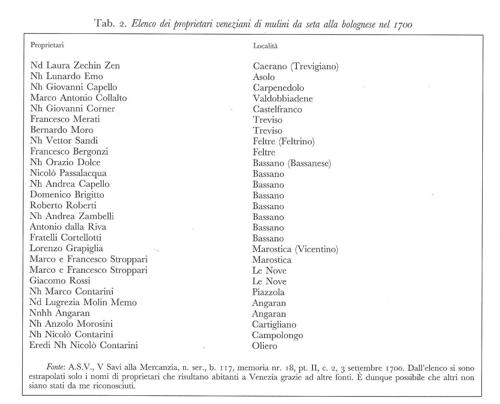Intraprese produttive in Terraferma
Intraprese produttive in Terraferma
L’economia veneziana dal rischio di collasso alla resistenza
Negli anni 1632-1636 i governanti, i mercanti, gli artigiani sopravvissuti alla morìa pestilenziale si impegnarono a stilare bilanci frequenti dei commerci e delle manifatture veneziane allo scopo di trovare rimedio ai molti malanni che l’epidemia aveva aggravato. In quel quinquennio sembrarono far groppo tutte le tendenze congiunturali negative che man mano avevano colpito i settori portanti dell’apparato commerciale veneziano sin dall’inizio del secolo. Con vigore sintetico i savi alla mercanzia lo rendevano evidente in una relazione del 1632:
Lo stato nel quale s’attrova la città ci porta a considerazioni di grand’applicazione per ridur il negozio a miglior partito di che ora si trova et non si vadi scemando come tuttavia alla giornata si pruova. Sono notissimi li pregiudizi che già da tempo ha ricevuto questa Piazza per esserle stato levato dal Levante le speciarìe, quali capitate qui con le navi veneziane si diffondevano poi per tutte le città d’Italia, Alemagna, et potemo dire per tutta Europa con grande emolumento dei suoi dazi dell’intrada e uscita. È anco davantaggio noto che li ponentini padroni della navigazione dell’Indie portano l’istesse speciarìe et infinite mercanzie ancora a Genova, Livorno, Marsilia et altre scale di dove lo sforzo delle città d’Italia si provedono e ben spesso le reliquie delle istesse merci capitano con nostra ammirazione in questa città. Si vanno anco di modo i ponentini profittando nelli viaggi del Levante che si provvedono di sede, di filadi e di che serve al consumo delle loro città et d’altri stati ancora spogliando questa città delle cose che erano state per lungo tempo sue proprie [...] (1).
Non vi era comparto dei traffici e delle manifatture ad essi legate che non avesse subito l’erosione della concorrenza straniera o il decadimento a causa di fattori interni.
Era dall’inizio del Seicento che il mondo economico e politico di Venezia aveva dovuto registrare l’indebolimento di tutti i tradizionali punti di forza dell’economia della città. Sotto i colpi della concorrenza francese, inglese e olandese ai Veneziani era sfuggita di mano l’intermediazione tra il Levante ed i mercati francesi e inglesi. S’era perso il commercio delle spezie e il traffico della seta di Persia e del cotone di Siria e Turchia. Nel 1608 si segnalava la diminuzione del traffico con il mondo germanico. Nel primo ventennio del Seicento decadde rapidamente un ramo importante della tessitura serica veneziana, quella dell’ormesino basso da fondaco, un tessuto di scarso pregio destinato principalmente alla Germania. La decadenza della produzione veneziana fu determinata dal sorgere di nuovi centri di produzione nei villaggi e nei borghi del Trentino.
Nel 1610, basandosi sui forti cali degli introiti daziari, Girolamo Priuli aveva segnalato che rispetto a pochi anni prima il negozio del Levante si era ridotto a poco più di un terzo e la capacità esportativa aveva perso circa il 30% (2). Il dato relativo al quadrante levantino si era prolungato fino al 1617, quando gran parte del naviglio mercantile (sette vascelli destinati alle scale di Cipro e Siria, Alessandria e Costantinopoli) era stato mobilitato per i servizi nelle operazioni belliche intraprese contro gli Asburgo per eliminare la pirateria degli Uscocchi e il resto era stato bloccato in porto (tre navi destinate ad Alessandria e alle scale siriane), sicché i flussi commerciali erano risultati annientati (3).
I cinque savi alla mercanzia nel 1610, nel quadro generale della depressione dei traffici, avevano annotato che i fallimenti negli ultimi due anni erano ascesi a oltre 2 milioni di ducati con vergogna delle ditte di «maggior nome e di maggior facende» (4).
Anche le principali manifatture veneziane che fornivano le più importanti contropartite da inviare Oltremare entrarono man mano in crisi. La manifattura dei pannilana e la loro esportazione flettevano dai picchi raggiunti all’inizio del secolo: nel quinquennio 1606-1610 la media delle pezze prodotte annualmente s’era abbassata del 18% circa. I telai che lavoravano la seta erano passati dai circa duemilaquattrocento dell’inizio del secolo ai poco più di millesettecento del 1610.
Nel 1611 furono presentate parecchie suppliche per ottenere la cittadinanza de intus et extra da parte di tessitori di seta che dovevano supplire alle deficienze delle commissioni mercantili. Ad esempio, Francesco Uberti di Bergamo emigrato a Venezia da trentatré anni si lagnava:
Hora che il negotio del Levante va mancando e che difficilmente si trova chi voglia mandarvi panni di seda, convengo abbandonare l’arte [...] se non ottengo la cittadinanza de intus et extra per poter mandare il poco capitale che si trova nelle parti del Levante (5).
Il saponificio resistette anch’esso fino al terzo decennio del secolo. Ma dopo il 1625 nuovi dazi imposti sull’olio importato avevano fatto rincarare il prezzo del sapone veneziano incoraggiando la produzione all’estero. Nel 1627 esportare sapone era diventato molto più difficoltoso perché fabbriche concorrenti operavano ormai nella Repubblica di Genova, a Livorno, nel Ferrarese, nel Mantovano e nella Marca pontificia. La quantità di sapone esportata s’era quasi dimezzata e, per conseguenza, le trentanove caldaie attive nelle saponerie nel 1625 si erano ridotte rapidamente a ventisei. Nel 1634 ne erano in attività soltanto venti (6).
Dal 1618 in poi lo sviluppo della guerra dei Trent’anni e la crisi monetaria avevano provocato altre restrizioni e difficoltà ai commerci con i mercati tedeschi che avevano assunto un peso sempre maggiore nell’assetto generale dei commerci veneziani dagli ultimi decenni del Cinquecento (7).
I giorni più neri furono portati dalla peste. La sequenza di carestia e di peste che funestò il quadriennio dal 1628 al 1632 provocò prima disordine finanziario e monetario, poi l’aumento del costo della manodopera e la perdita di competenze artigianali (8). Il dopo peste si presentava drammatico alle osservazioni dei magistrati:
Il stato della quale [di questa città] è in gran debolezza per essersi diminuito tanto numero di abitanti et operai che ora le mercedi sono ridotte a prezzi così esorbitanti et le merci così incarite che ci pare impossibile vi sia richiesta di pannine di lana e di seta, oltre che queste sono così maltrattate, che s’intendi vogliono rimandar dalla Turchia li panni di lana a Spalato rispetto alla loro imperfezione. Sopra che andiamo pensando qual possa essere il rimedio [...]
scrivevano i savi nel dicembre del 1632 (9). Nel 1633 si contavano appena quattrocento tessitori di pannilana contro i circa milletrecento degli anni precedenti la peste e i mercanti dovevano contendersene i servigi (10).
Nel setificio
li testori erano in altri tempi — come appare da loro capitoli — 7 in 8 mila e dalla parte del senato 163, 11 febbraio si vede che erano più di 10 mila. Ora sono in numero 3.293, cioè capomaestri n. 619, tutti gli altri sono mogli, figli, lavoranti, garzoni. Li teleri che lavorano sono n. 1.497; queli che non lavorano 582, diminuzion considerabile cagionata oltre da quanto si è detto dall’introduzione della pannina forestiera. I filatogi nel 1597 erano n. 96, ora sono ridotti in 48. Allora lavoravano con vallighi n. 285, ora lavorano con vallighi n. 152 e ve ne sono 124 che non lavorano, diminuzione causata da mercanti per comprar li orsogli forestieri (11).
Anche il settore dei traffici attraverso Spalato era entrato in rapida crisi dopo i culmini raggiunti nel 1626 (12). I concorrenti che si muovevano tra Ragusa ed Ancona mordevano la polpa del lucroso traffico balcanico e i savi evidenziavano
inoltre come l’insidie che vengono tese al più florido negozio di questa città qual è quello della Scala di Spalato si vadino maggiormente fomentando dall’avvantaggio che trovano li mercanti turchi bossinesi et hebrei con far capitare dalla Turchia le loro mercantie de curami, pelami et cere dalla strada de Ragusi in Ancona dove li turchi stessi vi capitano e sono ben veduti e accarezzati (cosa che non erano per avanti) (13).
La preferenza dello scalo di Ancona da parte dei mercanti turchi aveva come conseguenza la rovina di due delle attività di trasformazione più redditizie per la città.
Il negotio delle cere è stato in tutti li tempi riputato de migliori, de più pregiati et più profittevoli che habbia questa città, per la singolar perfezione a che si riducono le biancheggiate, al pari di questo non si facendo in altra parte del mondo. Questo negotio si è conservato florido per lungo tempo d’anni con impiego di tanto numero d’operari et profitto dei suoi cittadini che ne cavavano grossi emolumenti dagli orti et di queste cere abbundantemente se ne serviva l’Italia et altre parti ancora (14).
Ora, però, le cere lavorate non trovavano più sbocchi in Romagna, nel Regno di Napoli, in Toscana, «come già soleva» a causa dei loro costi di lavorazione. Anche la lavorazione dei pellami, uno «dei più importanti negozi che si maneggi» era in crisi perché i mercanti turchi erano scoraggiati dal portare a Venezia le pelli non essendovi più di quattro o cinque mercanti compratori (15).
La situazione appariva davvero prossima al collasso. Ma nella percezione degli osservatori degli elementi della congiuntura commerciale e manifatturiera veneziana l’economia della Terraferma e i rapporti tra economia della metropoli ed attività economiche delle province suddite non avevano rilevanza alcuna. Dalla Terraferma provenivano due delle merci che fornivano le contropartite delle importazioni d’Oltremare, il riso e la carta. Anzi la carta era stata il punto di forza anche di un’attività poderosa come quella dell’editoria veneziana cinquecentesca. Inoltre il commercio e la produzione della carta si erano trovati in controtendenza rispetto al trend commerciale delineato nei primi decenni. Per loro si può parlare di espansione fino agli anni Venti. All’inizio del secolo c’erano state iniziative per incrementare gli impianti e fino al 1622 le informazioni confermavano che la domanda estera di carta concorreva con quella degli editori a promuovere gli investimenti nel settore (16). Grazie alla carta delle province soggette si era sostenuta la produzione libraria, che, seppure in declino, aveva seguitato a mantenersi ancora a buoni livelli con una trentina di torchi in attività nel primo trentennio del secolo.
Solo di recente, carestia e peste avevano colpito gravemente anche tali settori. Ma il loro andamento critico non era tematizzato dai savi alla mercanzia insieme con quello dei traffici d’Oltremare. In quel drammatico periodo l’economia di Terraferma era presa in considerazione solo sotto due aspetti: innanzitutto per le sue capacità di assorbimento delle merci importate o prodotte dalla Dominante, in secondo luogo come potenziale concorrente da stroncare per il bene delle manifatture veneziane.
Nel 1632 i savi alla mercanzia lodavano i buoni effetti conseguiti alla diminuzione delle tariffe daziarie deliberata nel 1626,
vedendosi per li conti essersi cavata più entrata per le mercantie regolate nel dazio di che si faceva prima coll’intiero dazio oltre li altri benefici che si sono ricevuti dal negozio, dalli vascelli che hanno portato via anco mercanzie [e si compiacevano che il dimezzamento del dazio d’uscita avesse incrementato la riesportazione delle lane di Spagna in quantità considerabile e] anco ne è seguito buon effetto per la diminuzione delle altre scale, poiché li Bergamaschi se ne provvedevano da Genova, che hora con la metà del dazio le cavano per il più da questa città. [E l’obiettivo che sapevano indicare era quello di adottare provvedimenti repressivi del contrabbando] perché di questa maniera [...] a viva forza converiano provedersi in questa città (17).
D’altra parte l’attenzione dei magistrati veneziani era attirata specialmente dalle attività manifatturiere della Terraferma che potevano competere con quelle della metropoli. Ad esempio, nel 1635 provveditori di comun e savi alla mercanzia erano d’accordo nel rilevare il «pregiudizio che riceve la pannina veneziana dalli panni che si fabricano nel Trevisano di lana spagnola con segni e cimose alla veneziana». Poiché attraevano gli operai da Venezia, essi proponevano non solo il divieto di imitare le cimose di tipo veneziano ma anche quello di concedere licenze d’esportazione della lana spagnola per il Trevigiano e il Bassanese in modo da impedire che si fabbricassero quei panni (18).
La sola forma di integrazione possibile appariva, fino ad allora, quella che poteva originare dalla subordinazione della periferia al dominio economico del centro.
L’economia veneziana non collassò sotto tanti disastri e fu capace di resistere alle ulteriori ondate congiunturali negative che percorsero tutto il secolo fino ad essere pronta a profittare della svolta secolare negli anni Venti del Settecento. Si impone, dunque, alla comprensione il problema della resistenza e della capacità di adattamento dell’economia veneziana nell’età della crisi. Quali decisioni e quali comportamenti adottarono i governanti, i mercanti e gli artigiani allo scopo di reagire ai nefasti andamenti congiunturali? Dare una risposta richiederebbe di esaminare i numerosi atti di politica daziaria, le agevolazioni alle produzioni, i provvedimenti favorevoli all’incremento delle maestranze, le sostituzioni di prodotti, le brevi congiunture europee favorevoli... Ma, tra molte altre cose che portarono all’adattamento dell’economia della città ai mutamenti che si erano susseguiti negli ultimi decenni e dopo la peste, il processo di decisioni attraverso il quale i redditi dei Veneziani divennero capitali investiti in imprese produttive in Terraferma è l’aspetto più innovativo, poiché comportò sia una maggiore estroversione economica di` Venezia verso le province soggette, sia una complementarità più paritaria. Questo può essere considerato il fatto più significativo tra i mutamenti indotti dalla crisi del Seicento.
La vicenda più singolare e di più ampie conseguenze per l’economia veneziana accadde nel settore serico e perciò ad essa va la priorità della trattazione. Riguardò la costituzione di un patrimonio di risorse tecniche, di aziende manifatturiere, di competenze gestionali e mercantili attinenti alla produzione e commercializzazione di un filato chiamato «orsoglio alla bolognese». Era un organzino di seta lavorato mediante macchine inventate e a lungo usate solo a Bologna. Gli orsogli o organzini servivano per confezionare l’ordito delle pannine di seta veneziane. Le macchine erano per lo più mosse da energia idraulica, ma nello stato veneziano si catalogavano «alla bolognese» anche parecchi filatoi mossi da energia manuale (19).
Il setificio della Terraferma come settore chiave
La superiore tecnologia dei filatoi idraulici alla bolognese si affermò nelle province venete nel periodo secentesco. La sua diffusione è fenomeno che si verificò dal 1635 in poi e il suo sviluppo legò a doppio filo un settore trainante dell’economia veneziana con un ampio settore dell’economia di Terraferma. Il settore importante veneziano era quello della produzione di pannine seriche destinate all’esportazione. Era un settore vitale prima del 1632 e fin dal 1578 — in conseguenza della peste — aveva fatto ricorso in modo sempre più ampio all’impiego degli organzini bolognesi a scapito anche dei filatoi veneziani (20). La tessitura della seta continuò ad essere importante nel corso del Seicento proprio grazie all’impianto di filatoi di orsogli alla bolognese nelle province orientali dello stato.
Nel 1670 i provveditori e aggiunti all’ufficio della seta (che rappresentava i mercanti di seta) potevano enfatizzarne così l’importanza strategica nell’economia urbana:
L’arte della seda tiene subordinate altre arti che sono filatogli, tentori, manganeri, tiraoro e battioro. Oltre che particolari persone fuori di esse arti, che sono le maestranze abitanti in s. Nicolò, Zuecca, Muran, Buran et altri lochi che lavorano le sete grezze, altre che le binano, altre che incannano le trame et orsogli tenti, altre che construiscono li ordimenti, altre li rimettono nelli lizzi e petteni, altre che inviano le tele sopra li teleri, li disegnatori et levatori delle opere e quelli che tirano li lazzi per far le opere stesse et altri ancora che danno l’acqua ad alcune sorti di pannine, che in tutto vien calculato il numero di 40 mila in circa che s’esercitano et sustentano col detto ministero in questa città [...] (21).
Il numero era palesemente esagerato. Infatti in quegli stessi anni si calcolava più prudentemente che le due Arti della lana e della seta mantenessero
in questa città, con li molti operari inservienti, più di 30.000 persone [oltre moltissime in Terraferma], le quali per il solo consumo del comestibile a ravaglio [= ragguaglio] del vitto daziato portano giusto quello si calcola in ogni occasione ducati 12 per ogni persona (22).
Nel 1673 un’altra supplica restringeva il calcolo ai lavoratori dei telai che «tra maestri, garzoni e lavoranti contano nelle loro case 8 mila e più persone». Era quello ancora un anno della crisi congiunturale cominciata nel 1665 e nel frattempo si erano verificate emigrazioni; perciò possiamo presumere che tra il 1635 ed il 1665 la tessitura della seta fosse tornata ai livelli di occupazione e di produzione antecedenti alla peste. Ciò può spiegare il tono compiaciuto col quale i dirigenti dell’ufficio indicavano che gli affari erano stati soddisfacenti fino ad allora (23).
Per quanto riguarda la Terraferma i settori interessati erano quelli della produzione di orsogli alla bolognese, della trattura della seta, dell’allevamento dei bachi. Un comparto che implicava una gran parte del mondo rurale dei territori orientali. Nel 1670 vi si contavano oltre cinquanta filatoi dove si producevano — si diceva con esagerazione — circa duecentosettantamila libbre di orsogli del valore di oltre 5 milioni di lire (24). A monte dei filatoi c’erano coloro che traevano la seta grezza mediante i fornelli e a monte, ancora, c’erano le miriadi di famiglie contadine nelle quali si allevavano i «cavalieri» (che era il termine col quale si dava lustro al più nobile dei vermi).
Tale solidarietà di interessi era una creazione veneziana. Atti di governanti e iniziative investitrici di privati cooperarono alla riuscita.
L’azione dei governanti
L’arte della filatura della seta al modo bolognese era stata introdotta nello stato veneziano nel 1604 dall’immigrato Ottavio Malpigli di Modena. Egli aveva fatto conoscere i segreti dei manifattori bolognesi, ma la sua attività non era riuscita a promuovere il decollo della produzione. Nel 1634 erano ancora appena due i mulini da lui impiantati: l’uno a Padova, l’altro a Feltre (25). L’esclusiva non fu sufficiente a far sviluppare e a moltiplicare l’attività del Malpigli. La scadenza del privilegio ventennale non incitò nessuno a imitare il suo esempio nel corso dei dieci anni seguenti.
L’apparato per la filatura della seta nella Terraferma orientale, com’era descritto dai consoli dei mercanti, nel 1636 appariva formato da filatoi ordinari simili a quelli di Venezia (mossi a mano), da filatoi ad acqua che fabbricavano orsogli ordinari e dai due mulini ad acqua che filavano alla bolognese. Vi erano ottanta filatoi ordinari a Vicenza che lavoravano ventimila libbre di seta spedite in Germania; a Padova ventiquattro filatoi lavoravano dodicimila libbre di seta; nel Bassanese ve ne erano cento per lavorare venticinquemila libbre di seta in orsogli, in parte ordinari, in parte alla bolognese, esportati per lo più in Fiandra, a Milano e Lione, a Firenze e in Germania. I mulini ad acqua che lavoravano al modo ordinario erano in Vicenza da sedici a venti e lavoravano sedicimila libbre di seta. Nel Trevigiano ve ne erano solo due che lavoravano poco per mancanza di donne abili. In effetti a quelli enumerati dai consoli dobbiamo aggiungere i circa cento mulini veronesi che — nel 1654 — appartenevano a circa quaranta padroni (26). Dei mulini alla bolognese si ricordavano quello di Feltre, che lavorava tremila libbre di seta, e quello padovano dotato di otto valichi ma produttivo solo con due di essi, «per non esservi mercanti che diano da lavorare». Risalta la disparità produttiva tra filatoi manuali e quelli idraulici ordinari, da una parte, e i mulini da seta alla bolognese, dall’altra. Ma neanche le evidenti convenienze produttive avevano incentivato la diffusione di una tecnologia superiore non più segreta (27). La tessitura veneziana era rimasta dipendente dalle forniture di organzini provenienti da Bologna, Modena e Reggio.
Invece dopo il 1636, in dieci anni, i mulini diventarono quindici (28). Lo sviluppo più forte si verificò nei tre decenni successivi. Il numero dei filatoi nelle sole province orientali quasi quadruplicò. Nel 1700 un elenco registrava quarantotto impianti, ma non era completo. Bisogna aggiungere altri sette impianti nel Vicentino e tener conto che l’elenco non prendeva in considerazione il Friuli (29).
La storia di questa crescita è interessante poiché coinvolge in pieno gli attori della scena economica veneziana: governanti, mercanti, patrizi, lavoratori e lavoratrici. Nel 1633 i savi alla mercanzia sollecitarono la risposta dei dirigenti dell’ufficio della seta circa la convenienza e l’opportunità di incoraggiare la fabbrica degli orsogli abolendo per i mercanti il divieto di entrare in qualche forma di società con i filatori. I dirigenti dell’ufficio risposero che non era il caso di abolire la norma corporativa che in Venezia teneva distinte nettamente le funzioni mercantili da quelle produttive. Però ritenevano che sviluppare la produzione degli orsogli alla bolognese sarebbe stato vantaggioso.
Ma il farne in questa città che servino per rasi che è pannina che in gran copia se ne fabbrica tenimo impossibile per la difficoltà si ha di maestranze et edifici, ricercando quest’opera numero grande di genti, non essendovi acqua che lavori, il che seguiria con quella spesa et despendio [...] che causeria anco altezza di prezzi nelli panni.
Inoltre consideravano che le sete lavorate alla bolognese, in Modena, Reggio ed altri luoghi dello stato estense e in Imola, importate a Venezia venivano a costare 3 o 4 lire meno per ogni libbra rispetto a quelle mandate da Bologna. Concludevano che se i filatori avessero avuto animo di fondare mulini a Venezia avevano le mani libere. Ma a loro parere era molto più promettente impiantarli fuori di Venezia, nei territori soggetti, dove le acque erano abbondanti e anche più adatte di quelle che scorrevano a Bologna. Non c’erano divieti alla costituzione di società tra mercanti e filatori per l’attività di manifatture in Terraferma. I mercanti raccomandavano che fossero esentati da gravami fiscali sia i filatori immigrati sia le sete grezze di Romagna e di Lombardia e di altri luoghi.
Era il primo atto di una intesa da cui sarebbe scaturita una deliberazione di grande efficacia. Il secondo atto ebbe per protagonisti il parroco di S. Tomà e i mercanti. Il 20 luglio 1634 il prete Marchiò Cechini — appartenente ad una famiglia cittadinesca —, divenuto proprietario del filatoio che il Malpigli aveva impiantato a Padova in contrada Pellattieri, chiedeva ai savi di indurre l’Arte della seta a prenderlo in affitto e a metterlo in produzione a beneficio di tutti i mercanti «acciò d’una zogia [= gioiello] tale com’è stimato detto edificio da tutti che ne han cognitione et unica in questo Serenissimo Dominio per il lavoro alla bolognese non perisca per il corso del tempo stando senza lavorare». In subordine — nel caso del rifiuto dell’Arte — il prete chiedeva che i savi gli procurassero un finanziamento, perché con «grave incommodo» egli stesso lo farebbe «incamminare et lavorare ma senza capitali» non gli era possibile. A lui mancavano, del resto, i capitali perché aveva speso già migliaia di ducati per restaurare l’edificio e per ridurlo in «stato sufficiente e di buona perfezione». Gli sembrava persuasivo l’argomento che — una volta risaputo che il filatoio padovano era in funzione — i produttori bolognesi avrebbero diminuito i prezzi degli orsogli e di conseguenza si sarebbero abbassati i prezzi delle pannine, «poiché se bene le sete siano a precio onesto nondimeno per la scarsezza di detti orsogli sempre li panni di seta saranno in prezzo alto» (30).
La risposta dell’ufficio della seta fu decisamente negativa. I mercanti ricordavano di aver già riconosciuto l’utilità che si producessero nel territorio suddito orsogli sufficienti per la fabbricazione della pannina veneziana. Ma avevano costatato che il filatoio di Malpigli non riusciva a produrre neanche duecento libbre di orsogli alla settimana,
quantità apunto che viene lavorata al più in altro edificio in Feltre (che stimiamo loco più proprio di Padova, ma per quanto lavora in maggior quantità è un niente al bisogno) che per essere insensibile non è ne meno bastevole al continuo lavoro che facci un solo mercante, non che l’università tutta. Per il bisogno del quale vi vorrebbono decine di molini che in continuo lavorassero et questi doverebbero essere esercitati e sostentati, non da mercanti ma da filatogi, che è loro propria professione et hanno libertà di lavorare tanto per loro conto quanto per conto di altri. [I mercanti concludevano che la proposta era] non solo infrutuosa, ma dispiacevole et dannosa alli mercanti tutti (31).
Ma ai savi giunse anche il parere del mercante Alberto Gozzi. Egli riprendeva nella sostanza i termini della risposta del 1633 e li ribadiva. Sottolineava ancora una volta che era impossibile impiantare mulini da orsogli a Venezia sia per l’insufficienza dell’energia idraulica sia per la mancanza di maestranze sia per le spese eccessive (lo dimostrava l’esperienza stessa del Malpigli che «avendo ottenuto [...] privilegio e drizzato molini, in breve tempo, ha convenuto abbandonarli e riportarsi in Padova ove per qualche anno ha continuato il suddetto lavoro») e che perciò occorreva adoperarsi a diffondere la fabbricazione di orsogli nelle città dello stato come Padova e altrove. Suggeriva come incoraggianti una molteplicità di agevolazioni: a) ai mercanti si concedessero la licenza di fabbricare mulini da orsogli, la libertà di valersi delle acque, la possibilità di disporre di «luoghi atti e sufficienti con affitto conveniente alli patroni di fondi», la libertà di potersi valere indifferentemente di filatori sudditi o veneziani o forestieri e, infine, la concessione del legname necessario; b) ai lavoratori immigrati venissero assicurati privilegi ed esenzioni da fazioni; c) esenzioni daziarie totali dovevano attirare le sete grezze del Frignano (nello stato estense), e quelle romagnole e dello stato della Chiesa «attissime a far detti orsogli», che attualmente erano tutte condotte a Bologna; d) esenzioni daziarie dovevano facilitare lo smercio dei filati fabbricati negli edifici da orsogli alla bolognese; e) tutte le cause fossero affidate inappellabilmente alla magistratura dei cinque savi alla mercanzia (32).
Sulla base di questa risposta i savi alla mercanzia proposero la delibera che regolò per l’avvenire l’impianto dei filatoi. Essi la sostennero con un argomento che non era stato messo in campo fino ad allora: il costo elevato degli orsogli bolognesi metteva fuori mercato le pannine veneziane a vantaggio di quelle fabbricate a Firenze che i mercanti turchi andavano a procurarsi in Ancona.
Vedendosi che nella Turchia vi sia così grande concorso delle pannine forestiere et in particolare de rasi di Fiorenza, abbiamo voluto penetrare perché li turchi non capitano più qui come facevano e troviamo che il prezzo è così eccessivo che non convien ad alcuno venire a comprarli qui. E mentre si pensava a regolazione di prezzi di maestranze e si tentavano alcuni esperimenti per ridurli a segno, troviamo l’inconveniente nascer dalla strettezza degli orsogli di Bologna e dagli eccessivi prezzi che vengono pagati, senza i quali orsogli non si possono far li rasi di parangone che è la pannina tanto stimata. Il rimedio è far fabbricare orsogli nello stato. I filatogi riferiscono la ragione alla mancanza di operai e maestri che non fanno come già anni si faceva li orsogli in tutta perfezione, ma i mercanti si servono di orsogli di Bologna con impiego di molte centinaia di migliara di ducati all’anno (33).
In effetti circa sessantamila libbre d’orsogli erano mandate da Bologna ogni anno a Venezia per un valore di 300.000 ducati (34). Anche allo scopo di non lasciar che tanto denaro uscisse dallo stato, i savi vollero elaborare le condizioni per far fabbricare gli orsogli alla bolognese nello stato con l’esempio dei filatoi feltrino e padovano e grazie all’iniziativa di «un mercante di poderosa condizione» che si offriva di «dar animo agli altri» col fabbricare a Padova o a Treviso o altrove un edificio purché venissero approvate le agevolazioni da lui domandate. Il senato rispose favorevolmente il 5 gennaio 1635 e approvò i «capitoli» presentati dalle magistrature incaricate (35).
Essi erano di due tipi: i primi dedicati ai tessitori veneziani Giovan Battista Bon e fratelli, i quali disponevano ormai dell’edificio fondato da Ottavio Malpigli che, però, era in condizione di lavorare solo «per la terza parte delli molini che in esso edificio s’attrovano»; gli altri generali e riguardanti tutti coloro che avessero voluto intraprendere la produzione degli orsogli alla bolognese. I sette capitoli generali assumevano tutte le richieste avanzate nella proposta di Alberto Gozzi, dalla possibilità di disporre liberamente dei corsi d’acqua alla liceità per i mercanti di diventare produttori di filati, dall’esenzione da corvées reali e personali per gli immigrati costruttori di mulini o filatori al permesso di taglio dei roveri necessari alla costruzione e alla manutenzione degli edifici, dall’esenzione da imposte per cinque anni fino all’attribuzione della giurisdizione per i conflitti nel settore ai savi alla mercanzia. Essi, inoltre, vietavano l’esportazione degli orsogli veneti per riservarli alla tessitura veneziana (36).
I capitoli espressamente destinati per il molino da seta gestito dai fratelli Bon rendevano esenti le sete lavorate nel loro filatoio e gli orsogli prodotti. In più concedevano che per un anno potessero far apprestare le sete a Venezia senza che la Corporazione dei filatori veneziani potesse impedire alle maestre addette di collaborare. Ciò avrebbe permesso di «far ammaestrare in Padova gente per questo servizio». Infine ai fratelli Bon era consentito di continuare la loro professione di tessitori di panni poiché erano dispensati dal rispettare «li ordini delle loro arti che proibiscono alli testori di esser filatogi e alli filatogi esser testor». I fratelli Bon avevano ottenuto le concessioni speciali grazie alla promessa di perfezionare il mulino in modo da «cavarne grandissimo profitto» (37).
Le agevolazioni decretate non contraddicevano le regole corporative le quali valevano solo nella struttura urbana. Erano, invece, il risultato della concorde visione dei magistrati, dei mercanti e dei tessitori veneziani. Esse colpivano gli interessi della Corporazione dei filatori veneziani che nel 1640 tenteranno l’ultima difesa contro l’affermarsi degli orsogli sia veneti che stranieri (38). L’incoraggiamento alla costruzione di impianti trovava dei punti di riferimento nella presenza dei mulini da seta avviati dal Malpigli e tuttavia segnava una discontinuità rispetto al periodo precedente. Infatti i due filatoi di Padova e Feltre non avevano avuto uno sviluppo significativo. Avevano vivacchiato senza rappresentare mai un’alternativa alla produzione bolognese. Non avevano creato neanche le condizioni per l’accumulazione di competenze professionali e di attitudini lavorative. Dopo trent’anni di attività del filatoio mancavano nel Padovano le maestre che potessero predisporre i fili e bisognava rivolgersi alle maestre veneziane. Per le altre fasi del lavoro occorreva far immigrare specialisti da fuori, da Bologna in primo luogo. Tutto sommato l’esempio del Malpigli giocava in modo negativo. I mercanti e i tessitori veneziani non apparivano incoraggiati dalla scarsa fortuna incontrata dall’innovatore. Ma il decreto del 1635 rappresentava una rottura anche per un altro aspetto: mentre l’innovazione era stata riservata ad un singolo innovatore e non era stata favorita con misure fiscali che permettessero di battere la concorrenza bolognese, ora si tentava di promuovere un interesse generale alla produzione di filati con esenzioni fiscali che alleggerivano tutte le fasi della circolazione della seta. In nome della tutela degli interessi veneziani alla salvezza e alla ripresa del commercio della pannina di seta, si favoriva un’attività nelle province di Terraferma mettendo in remora la propensione dei governanti alla salvaguardia delle imposizioni daziarie. Le esenzioni e le facilitazioni furono assecondate dall’emergere di disposizioni ad investire capitali nel settore. Ma la consequenzialità tra agevolazioni e investimenti non era automatica, come si potrebbe ritenere. Infatti non era facile mettere in moto un processo di investimenti. Abbiamo visto che don Cechini non aveva potuto realizzare presto la sua buona intuizione e la decisa volontà di sfruttare il filatoio padovano per mancanza di capitali.
Un mulino alla bolognese era una macchina complessa azionata da energia idraulica. Esso permetteva un processo produttivo meccanizzato allo scopo di torcere la seta grezza in modo da ottenere rapidamente grandi quantità di filati molto sottili, uniformi e resistenti. Per le loro qualità essi erano adatti a comporre l’ordito dei tessuti di gran pregio come i drappi e i rasi veneziani. Un mulino aveva bisogno di un numero minimo di lavoratori addetti alle varie funzioni interne: ad esempio, nel 1700 nel territorio di Bassano c’erano una dozzina di filatoi alla bolognese il più piccolo dei quali dava lavoro a ventitré tra uomini, donne e bambini di entrambi i sessi, mentre il più grande ne impiegava centonovanta (39). In più ciascun filatoio aveva bisogno del lavoro delle donne che doppiavano i fili: dodici erano le doppiatrici al servizio del primo mulino, cinquantaquattro erano nel secondo.
Dunque, avviare la nuova attività richiedeva la spesa di almeno 6.000 ducati (secondo la scrittura dei consoli del 1636, ma nel 1640 i Lazzari sostenevano di averne spesi 10.000) per la costruzione del mulino e dei meccanismi del filatoio, altro denaro per far arrivare le maestranze esperte sia nella costruzione dell’edificio sia nella lavorazione della seta, per procurarsi seta grezza di buona qualità e in quantità adeguata, incettandola in molte province. Il successo durevole dipendeva dalla capacità di organizzare e gestire il processo di produzione e di sottrarre quote di mercato ai più sperimentati orsogli provenienti dai territori emiliani. Ma poiché le esenzioni daziarie erano stabilite per la durata di un quinquennio, l’investitore doveva correre il rischio anche di una possibile revisione di politica fiscale.
Insomma, il potere politico aveva fatto la sua parte scegliendo di rinunciare alle entrate daziarie almeno per cinque anni e dando vantaggi agli investimenti in Terraferma. Ma le agevolazioni da sole non crearono subito l’attrattiva sperata, poiché c’erano diversi ostacoli. Nel 1636 — secondo i consoli dei mercanti — il filatoio di Padova stentava «per non esservi mercanti che diano da lavorare», a Treviso era la mancanza di maestre che rendeva inoperoso un filatoio appena costruito e riuscito «perfetto», a Bassano, invece, era scoraggiante la deficienza di canali:
I mercanti di quel luoco inclinatissimi a questa professione vi ammaestrano le donne del territorio e ben presto accresceranno il negozio e se potesser condur l’acque superiore fabricarebbero degli edifici e lavorarebbero da libbre 100 mila, punto da osservarsi da Provveditori ai beni inculti (40).
La preferenza dei mercanti per gli orsogli provenienti da Bologna aveva buoni fondamenti nel profitto che ne potevano ricavare nella lavorazione in panni. Mettevano in evidenza tale aspetto della questione i consoli dei mercanti. Secondo la loro denuncia un terzo degli orsogli importati erano impiegati nella tessitura dei rasi. Ma solo alcuni «mercanti degni» usavano organzini della migliore qualità ottenendo pannine bellissime. Gli altri preferivano orsogli male lavorati e sottilissimi con i quali facevano fabbricare rasi scadenti, il cui peso era inferiore di oltre il 40% rispetto a quello dei rasi perfetti. I mercanti lucravano bene su questa differenza e perciò trovavano gli orsogli importati più convenienti di quelli filati nello stato, nonostante costassero alcune lire in più. Con tale argomento i consoli giustificavano la sollecitazione a proibire l’importazione degli orsogli per incoraggiare i filatori veneziani i quali, altrimenti, si vedevano costretti a lavorare per gli Ebrei con la conseguenza che le sete migliori erano esportate dallo stato con danno per la fabbrica dei tessuti.
I filatori hanno introdotto di lavorar con la rasera alla bolognese e li lavori riescono alla perfezione con spesa di lire 9 per libbra, il cui costo essendo lire 9 forma il valore di lire 30. Quelli di terre aliene costano lire 33 in 37 e pure giova a mercanti et a testori valersi de forestieri essendo questi molto più sottili. Di tal qualità di orsogli per rasi, quando abbiano da lavorar offeriscono li filatori di fabricar libbre 20 mila all’anno scegliendo dal n. di 10 mila donne che attendono al rocchello n. 500 delle migliori, che bastano al lavoro di 60 valighi. [I consoli concludevano con accuse velenose contro i mercanti:] Gran parte de marcanti pensa al solo proprio interesse, niente alla reputazione della pannina, purché in breve tempo s’arricchiscono come giornalmente segue. Niente pensando al sostentamento de testori, alcuni fanno venir quantità di pannina forestiera, spazzandola per il Levante, quale per la mala qualità ha dato causa alle lamentazioni [...] (41).
Pure i savi alla mercanzia esprimevano un giudizio negativo sugli orsogli forestieri:
stimiamo perniciosissimi li orsogli forestieri con i quali si fabricano pannine bensì di bella e vaga veduta ma ad ogni modo di poca durata (42).
Si scremi pure la rappresentazione dei consoli delle falsità o inesattezze suggerite dall’umore polemico del loro intervento, tuttavia resta l’impressione di una consolidata e interessata affezione agli orsogli forestieri che non incoraggiava i mercanti a cambiare rapidamente i loro orientamenti merceologici. Occorreva che agli stimoli dei governanti rispondessero persone disposte a rischiare notevoli somme di danaro per la costruzione e la manutenzione dei mulini e dei numerosi congegni e più ancora per alimentare i processi lavorativi assicurando sufficienti quantità di seta greggia e i salari per i numerosi lavoratori. Inoltre bisognava saper modificare le abitudini dei mercanti offrendo orsogli di qualità non inferiori a quelli esteri e più convenienti per il prezzo.
Furono i Veneziani che per primi rilanciarono il settore ed il loro esempio fu seguito da sudditi di Terraferma che legarono anch’essi le loro fortune alla tessitura e al commercio della Dominante.
L’iniziativa dei privati
Sia per capire le difficoltà delle imprese, sia per mettere in rilievo i processi e i tempi dello sviluppo del settore, abbiamo la possibilità di seguire per il primo periodo le vicende del mulino di Padova. Esso fu gestito fino al 1637 dai fratelli Bon. Erano dei mercanti che si erano ritirati dalla mercatura e sotto pretesto di dote e fedecommessi avevano messo al sicuro i loro beni pur avendo debiti per grosse somme di danaro (43). Il 20 ottobre 1637 don Cechini cedette il filatoio in affitto a Paolo Molinetto per due anni, prorogabili per un altro biennio, per un canone di 200 ducati annui. L’esame dei termini del contratto conferma che rapido era il deterioramento subito dal filatoio in due cicli produttivi. Il locatore, infatti, doveva
acconciare di tavelle dove fa bisogno, poner le spiere di tela ai balconi dell’incannatoio; far gli scuri di legno ai balconi dell’edificio nel solaro di mezzo. Nella casa grande far accomodar li veri e telleri. Far tramezzare la soffitta dell’incannatoio stesso per mezzo di tavole, far ponere una scala in portego per andar nell’incannatoio. Far stroppare le porte che sono state aperte di nuovo. Consegni in acconcio 3 valeghi che lavorino alla bolognese tutti e tre nell’ordine di mezzo e 2 che torzino nell’ordine di sotto alla bolognese con i suoi naspi.
Ma il contratto sorprende, anche perché rivela che in un edificio vantato come un gioiello tecnico e restaurato a perfezione l’energia idraulica era male sfruttata: infatti l’affittuale pretendeva che il Cechini facesse una ruota nuova e accomodasse
la palificata in modo che la ruota vadi con forza tale che meni il molino senz’altro aiuto di uomini (44).
Il filatoio fu di nuovo restaurato e migliorato nel 1643. Impiegava allora anche operai bolognesi sotto la direzione di un nuovo affittuale, il mercante di seta Iseppo dall’Abbaco il quale, però, dovette essere richiamato dai savi al suo obbligo contrattuale con don Cechini (45). Nel 1644 di nuovo si fece vivo Marchiò Cechini per chiedere un prestito di 4.000 ducati, da restituirsi a rate di 500 ducati all’anno, con lo scopo di poter
in tutte le sue parti perfezionar et incamminar questo primo esemplar et utilissimo edificio di Padova insieme con un altro per torzer la seda che intendo aggionger appresso di quello, quali incaminati con il molto loro approvato lavoriero di orsogli bolognesi non solo saranno di meraviglia a tutta Italia, ma serviranno [...] stabilir la mia povera famiglia con l’incammino di quelli redota per tanti danni patiti si può dire da quel molto che era al niente in che ora si attrova [...] (46).
Le vicende del filatoio padovano mostrano la difficoltà di far decollare l’attività da parte dei mercanti. Quelle del filatoio di Feltre fanno emergere le difficoltà che incontravano gli artigiani gestori senza capitali. Nel 1635 esso apparteneva a Benedetto Fontana, uno dei filatori bolognesi trasferiti nello stato veneziano durante la prima emigrazione di fine Cinquecento (47). Aveva appena «due valghi da filatoio e tre da trazer». Benedetto lo cedette al figlio Domenico all’inizio del 1636, ma allora il mulino era ipotecato a favore di Bortolo Viatis e Martin Perler, provenienti da Norimberga ma attivi come mercanti a Venezia (48). Domenico, nel frattempo, si indebitò con Tomaso Sandi e Gerolamo Poleni. Tentò di uscire dalle sue strettezze stringendo società nel 1638 con Andrea Cristini, mercante di Bardies (Mel) che metteva il capitale di giro e provvedeva all’acquisto di materia prima e alla vendita del filato. Ma nel 1642 il Fontana risultava debitore verso il Cristini per 5.555 lire (49) e nel 1644 il filatoio era descritto come pressoché distrutto (50).
Insomma, l’andamento degli affari dei gestori dei due mulini da seta dimostrava che l’investimento nel settore appariva come un’avventura nella quale i risultati erano estremamente aleatori. Infatti nel primo quinquennio probabilmente ci furono pochissimi investitori disposti ad arrischiare. Forse fu in quel periodo che i veneziani Tomaso Sandi e Gerolamo Poleni fondarono un mulino a Feltre facendo arrivare famiglie intere da Bologna (51). Sembra che l’interesse si facesse più vivo nel 1639. Infatti allora si costituì la compagnia di Cristini, Simon Toffolato e Agostino Norcen per far lavorare la seta e ridurla in orsoglio alla bolognese (52) e i fratelli Fontana, Vittore e Antonio, figli di Benedetto, chiesero trent’anni di privativa per la costruzione di un filatoio alla bolognese in Venezia (53). Allora i bassanesi fratelli Zambelli sollecitarono la concessione della proroga delle agevolazioni con l’intenzione di profittarne. Essi facevano lavorare filatoi ordinari ed ora si dichiaravano pronti a costruirne tre o quattro alla bolognese a condizione che le esenzioni fossero prorogate e che il governo concedesse i terreni adatti (54).
Tuttavia fino al 1640 non dovevano essersi verificate modificaziorti significative nel numero dei mulini da seta attivi. Gli Zambelli sostenevano che era spirato il tempo delle esenzioni senza che lo stato ne provasse alcun beneficio «non avendovi trovato alcuno che vogli impiegar grossi capitali dovuti per fondarli e sostentarli» (55). Del resto i savi alla mercanzia non tenevano in nessun conto la produzione interna di orsogli alla bolognese nella risposta alla supplica dei filatori veneziani che chiedevano il bando degli orsogli sia forestieri che dello stato (56). Ancora nel 1643, nella supplica di Iseppo dall’Abbaco — che pretendeva, anche lui come i Fontana, di aver trovato la maniera di far funzionare filatoi proprio a Venezia — si metteva l’accento sulla possibilità di deviare il negozio ben incamminato di Bologna, senza riferimento alla presenza significativa di mulini da seta nello stato veneziano (57). Insomma i fatti decisivi sembrano essere stati la proroga delle esenzioni per sette anni nel luglio del 1640 e una congiuntura «bolognese» nel 1643, che, secondo i savi alla mercanzia, rendeva facile far emigrare le maestranze da Bologna (58).
Lo slancio si verificò dal 1643, quando il prolungamento della durata delle esenzioni e l’esempio positivo dei pionieri stimolarono un flusso di investimenti più deciso. All’inizio del 1644 il filatoio padovano era descritto come restaurato e migliorato e, nella supplica del giugno 1644, il Cechini vantava che quello era stato di esempio ad altri edifici che si erano fabbricati e rivendicava il godimento dei medesimi privilegi riconosciuti ai filatoi costruiti dopo il suo. Nel 1644 i soci Sandi e Poleni presentarono programmi di espansione offrendo di restaurare i due filatoi dei Fontana e di costruirne un quarto (59). Nel 1644 anche a Vicenza fu avviata la filatura alla bolognese dai fratelli Lazzari che acquistarono «con grave spesa alcune case e ruote sopra il Bacchiglione» e affrontarono spese per liti e per superare molte difficoltà allo scopo di mettere in funzione il loro filatoio costato circa 10.000 ducati (60).
Nel 1646 il decollo del settore poteva dirsi un fatto compiuto. Si contavano ormai quindici mulini, dove maestranze emigrate da Bologna producevano filati di tale qualità che contribuivano a far raggiungere la perfezione alla pannina di seta veneziana:
tutti questi professori concorrono nell’affermare la perfezione delli lavori che ogni giorno più s’avanzi facendo l’uso più atti li operarij et li lavori più perfetti vedendosi, come s’è sopraddetto, per la marzaria le pannine di vaghezza, bellezza, bontà che di vantaggio non si può desiderare […].È anche vero che da pochi anni in qua si fabbricano in questa città pannine di seta di tal bellezza e perfezione che non vi è chi le superi e tutto viene attribuito alla qualità delle sede lavorate sopra li molini introdotti [...] (61).
Le importazioni da Bologna erano notevolmente ridotte. Ormai la concorrenza rendeva più difficile il rifornimento di seta grezza e nelle cattive annate c’era il pericolo che la scarsità della materia prima provocasse l’inattività degli impianti e la disoccupazione dei filatori immigrati. I proprietari dei mulini tentarono allora di conseguire anche il privilegio del monopsonio per le sete grezze prodotte nello stato. Erano sete «di condizione perfettissima» che Fiamminghi e Bolognesi esportavano «per esser delle migliori d’Italia più atte al loro servizio», contendendole, appunto, alle manifatture venete. I proprietari dei mulini chiesero il divieto della loro esportazione, che il governo però non concesse (62).
Seguì un ventennio di intensificazione degli investimenti, di moltiplicazione degli impianti e di sviluppo della produzione. Nel 1654 si era raggiunta quasi la sufficienza delle forniture al setificio veneziano. I filatoi che lavoravano alla bolognese insieme con quelli «alla rasera» e con quelli «ordinari» producevano tanto filato da rendere pressoché superflui gli orsogli esteri. L’ufficio della seta non celava la sua soddisfazione:
Fra li negozi di Venezia quello della pannina d’oro e seta tiene il primo loco facendosi in ogni parte del mondo bramare, mediante la sua finezza e perfezione di lavoro, che con splendore si contraddistingue da qualsivoglia pannina forestiera. Materia unica et necessaria per questa fabbrica riesse la seta nostrana che nasce e viene lavorata nel Stato [...] [e richiedeva di nuovo il divieto di esportazione delle sete grezze con l’intento di colpire le tessiture concorrenti di Rovereto, Bologna, Firenze, Lucca, Genova, Fiandra e Francia] ove per la loro finezza si lavorano e si riducono in pannina di perfezione e bellezza conforme a quella si fabbrica in Venezia (63).
La libertà di esportare. Capitalisti dei filatoi contro capitalisti di pannine
La filatura meccanica si sviluppò sottraendo man mano quote di mercato agli orsogli provenienti da Bologna: nel 1668 erano appena seimila le libbre importate (64). La crescita della filatura meccanica in Terraferma aveva favorito la ripresa della tessitura veneziana e ne aveva reso possibile l’espansione, ma da tale espansione erano stati stimolati di rimbalzo la ricerca di profitti nella filatura e gli investimenti negli impianti. Anche l’andamento dei prezzi degli orsogli fu un fattore di promozione: segnalati a 33-36 lire nel 1636 arrivarono a 36 e fino a 40 lire prima del 1665 (65). L’intreccio ebbe un segno positivo finché non arrivarono le crisi congiunturali della tessitura che si tradussero in crisi di sovrapproduzione per i filatoi. Le fonti ci fanno cogliere le prime manifestazioni della divaricazione verso il 1665.
Nel 1665 la quantità di orsogli fabbricata nello stato era talmente cresciuta da non poter essere più assorbita totalmente dalla tessitura veneziana.
Essendosi molti applicati a construir edifizi per fabricar orsogli, sono ora a tal punto moltiplicati che maggiore è la fabbrica dello smaltimento, onde alcuni di detti edifizi hanno sospeso a fatto il lavoriero, come quelli di Thiene, Valdobiadene, Feltre et altri pocco lavorano per non trovar modi di esitare li fabricati [...] e considerando il poco esito di tali orsogli per consumo della Dominante et dello Stato.
Con tale argomento tre mercanti veneziani — due dei quali avevano in affitto filatoi di proprietà dei patrizi Gerolamo Capello e Lugrezia Molin Memo — aprirono il fronte della liberalizzazione del commercio degli orsogli, che la legge del 1635 riservava esclusivamente al mercato veneziano. Essi chiesero la concessione di esportare dieci balle di seta per ognuno dei filatoi senza pagamento dei dazi d’uscita (66).
Alla proposta si opposero i mercanti di pannine e la questione restò aperta davanti alle magistrature veneziane per cinque anni. I provveditori e aggiunti dell’ufficio della seta riconoscevano che la congiuntura era sfavorevole:
Se al presente pare che vi sia qualche soprabbondanza delli predetti orsogli, ciò deriva dalla scarsezza del lavoriero per mancanza de compratori e commissioni di pannine di seta, scarsezza di lavoriero che si ritrova anco nelle altre città estere da che ne deriva che anco a Bologna al presente si ritrova soprabbondanza di orsogli (67).
Ma si opposero alla proposta di ammettere l’esportazione degli orsogli con argomenti d’obbligo a tutela del commercio delle pannine. In primo luogo, dichiararono che in congiunture normali non c’era eccedenza di orsogli:
La produzione può supplire alla fabbrica della pannina di seta in questa città con qualche aggiunta però di quelli di Bologna, che non sono sì pochi come si crede. [Infatti] gli orsogli nostrani servono per ogni qualità di pannina, benché quelli di Bologna rieschino migliori al far la tessitura della pannina et a far quella riuscire di maggior bellezza e bontà et particolarmente alli rasi lisci schieti che è pannina che ricerca la più perfetta e fina qualità di orsogli che si trova.
Inoltre bisognava ricorrere anche ad orsogli di Bassano e Venezia non lavorati alla bolognese «che in tutto non è somma di non poca considerazione». In secondo luogo, asserirono che la fabbrica di pannine concorrenti era stata introdotta in molti altri luoghi esteri ed essa era competitiva a causa dei costi alti della produzione veneziana (68).
Contro tali argomenti nel 1667 si mossero non alcuni fabbricanti ma tutti i circa sessanta proprietari degli edifici da orsogli alla bolognese. Essi rappresentarono una situazione di crisi della filatura:
Essendo nel Stato tenue il consumo e grande la quantità de medesimi orsogli, sia fabricati nel Stato sia importati, e non essendoci smaltimento molti edifizi hanno arrestato affatto il proseguimento dell’opera e gli altri hanno rallentato la medesima.
Citavano i casi dei filatoi di Thiene, Mutinello, Feltre, Caltran, Treviso e Vicenza (69).
Dovettero insistere nel 1668 e nel 1670 e dimostrare che la produzione potenziale dei loro edifici (circa duecentosettantamila libbre) non poteva far scarseggiare gli orsogli per le pannine veneziane e che i loro prezzi erano scesi a 20-21 lire, mentre i prezzi delle pannine erano rimasti pressoché invariati, con grandi profitti dei mercanti. Finalmente conseguirono la licenza di esportare con un aggravio daziario di 4 grossi per libbra (70). Ma i fabbricanti di orsogli riuscirono ad ottenere presto — dopo due anni — anche l’eliminazione di questo onere, continuando a lamentarsi della crisi di sovrapproduzione e della difficoltà di esportare a causa dell’aumento dei prezzi dovuto all’imposta. La gratuità, concessa all’inizio per due anni, fu poi man mano rinnovata e prolungata. Essa fu riaffermata dal governo anche quando si verificò, in occasione delle proroghe del 1698 e del 1714, un disparere di tre savi alla mercanzia contro il mantenimento dell’esenzione (71). Grazie alle nuove possibilità esportative la correlazione tra l’attività dei filatoi di Terraferma e la tessitura veneziana divenne meno esclusiva (72). Perciò l’esportazione divenne uno dei fattori importanti di crescita ulteriore del settore. Infatti la quota di organzini assorbita dall’esportazione divenne presto consistente oscillando attorno alle ventimila libbre medie tra 1673 e 1677, poi attorno alle ventottomila libbre fino al 1681, per salire alle quarantaduemila libbre medie fino al 1690 e alle cinquantottomila dal 1691 al 1697 (73).
Nel 1706 gli interessati al commercio degli orsogli ne esaltavano i vantaggi sia per l’erario (poiché ad esso era connesso l’andamento del dazio sulla seta grezza che rendeva circa 150.000 ducati), sia per le città della Terraferma e sia per il traffico di Venezia e ne esageravano l’importanza considerandolo come il solo negozio capace di attirare «il danaro dagli esteri [...] che circolando poi fra i sudditi serve a vivificare il commercio»: insomma lo reputavano una sorta di carburante della vita commerciale veneziana (74).
Dominante e Terraferma
La geografia dei filatoi alla bolognese riguardò in primo luogo i territori padovano, feltrino, trevigiano, bassanese, vicentino. Poi si estese anche a territori occidentali (75). Ma gli orsogli fabbricati nella Bergamasca erano lavorati in modo tale da non corrispondere alle esigenze della tessitura veneziana. Nel 1695-1696 la scarsità congiunturale di seta grezza aveva indotto a «far dar punti di meno alla fabbrica di orsogli» e a far introdurre qualche partita di orsogli da Bergamo, ma risultò un poco difficile tesserli (76).
Tale distribuzione è strettamente dipendente sia dal fatto che lo sbocco primario era Venezia sia dal fatto che la dislocazione dipese dalle scelte degli investitori veneziani. Si formarono piccoli distretti serici a Bassano, a Marostica, a Feltre, a Vicenza. Ad esempio, a Feltre nel 1685 sette filatoi davano lavoro a millecinquecento operai (77). Secondo i cronisti citati dal Brentari, nel territorio di Bassano la produzione annua di organzini era passata in un secolo (fine Cinquecento - fine Seicento) da quindicimila a centocinquantamila libbre, lavorate da «dieci edifici di seta detti alla bolognese e mossi dall’acqua e molti altri di diverso genere» (78). Nel 1700 nel Bassanese si elencavano diciassette edifici di cui tre manuali e quattordici idraulici che davano lavoro a oltre millecentosettantacinque persone, per la maggior parte donne e fanciulli. Di essi uno apparteneva al nobile veneziano Orazio Dolce ed un altro era tenuto in affitto dagli eredi del veneziano Ventura Carrara (79). Nel 1709 il rettore di Bassano scriveva che il
principal negozio è quello delle sete che vengono lavorate in orsogli alla bolognese che poi si spediscono in Olanda, Inghilterra, Francia come pure in Venezia (80).
Per le aree interessate la presenza di filatoi si tradusse dapprima in incentivo alla produzione di bachi e di seta grezza, poi in stimoli all’avvio di altre attività manifatturiere. In tutti i territori veneti l’attività dei filatoi promosse l’incremento della bachicoltura e della trattura della seta, specialmente della seta sottile pregiata che si produceva con una media di quattro libbre al giorno per fornello contro le dodici-sedici libbre della seta grossa (81). Ad esempio i cinque o sei mercanti bassanesi incettavano seimila libbre nella propria area, ma ne compravano anche in Polesine, in Friuli, nel Trevigiano, nel Padovano e nel Veronese (82). In taluni casi la tendenza era ad integrare la trattura con la filatura come vollero fare i Fontana a Feltre e Giovanni Passalacqua a Cartigliano, dove nel 1676 portò da due a dieci i fornelli esistenti nel recinto del suo filatoio (83). La crescente domanda di seta dei filatoi alla bolognese stimolò la ricerca di innovazioni dal lato della prima lavorazione del filo grezzo. La trattura fu perfezionata verso il 1714 grazie a nuovi metodi e «la perfezione del lavoro» fu esaltata come superiore ad ogni altra (84).
La filatura meccanica creò una rete di cointeressenze e di solidarietà fra le province venete e fra esse e la Dominante. I legami con Venezia si tramarono su un fitto intreccio di scambi di merci e di persone. Una parte della seta grezza lavorata in orsogli passava da Venezia per raggiungere i filatoi (85). Dalla Terraferma gli orsogli erano inviati a Venezia sia per la loro lavorazione sui telai dei tessitori veneziani sia per l’esportazione. Inoltre i capitalisti di Terraferma saldarono i loro interessi con i capitalisti veneziani. Ad esempio, nel 1726 il podestà di Vicenza metteva in rilievo che i mercanti di Venezia Pomer, Bacmaier e altri mandavano le proprie commissioni ai negozianti vicentini Fadinelli, Guerra e Conti per la spedizione di sete semilavorate in trame e in orsogli alle fiere di Bolzano (86). Con scandalo delle Corporazioni veneziane nella Terraferma presero piede le produzioni seriche alle quali erano imputate le difficoltà congiunturali veneziane nel 1672:
quasi sugli occhi avemo le contraffazioni et multiplici et infinitamente dannose. Fabbrica la Terraferma tutta e Vicenza più d’ogni altro luogo, damaschi, terzanelle, cendalli et ogni altro drappo anche con oro con nostro inevitabil eccidio perché non possiamo star saldi al confronto né vender con loro in concorso. Non pagano essi il dazio per le sede d’entrata, non pagano i drappi nell’andarsene quello d’uscita, non han scuola, galiotti, né tanse, non affiti di bottega, non pesi estraordinari [...] e le maestranze tutte lavorano per mercede minore oltre che non han obligo né d’altezza né di portade; per questo quella terzanella, che a noi costa lire 7 al bracio viene da loro venduta lire cinque, onde dall’Alemagna ricevono e d’altrove tutte le commissioni e noi siamo preteriti e quel ch’è peggio in abondanza anche ne mandano in questa serenissima città [...] (87).
Il governo non poté fare altro che prendere atto della integrazione tra le diverse zone economiche e — ad onta delle richieste corporative di filatori e tessitori e mercanti veneziani — riconobbe alla Terraferma il diritto alla costituzione di attività manifatturiere in altri tempi ritenute concorrenziali con quelle di Venezia (88).
Correlata allo sviluppo delle manifatture seriche fu la crescita dell’importanza del reddito prodotto dalla bachicoltura e dalla trattura del filo sottile adatto ad esser trasformato in organzini durante la seconda metà del Seicento: ciò forse costituì la compensazione rispetto alla perdita provocata dallo svilimento dei prezzi cerealicoli per i proprietari fondiari veneziani e per i loro contadini. Nel 1634 nel suo parere Alberto Gozzi era attento a raccomandare di agevolare l’importazione delle «sete grezze attissime a far detti orsogli» dallo stato estense e da quello della Chiesa come se nello stato veneziano non se ne producesse abbastanza. Nel 1640 i savi, tra i generi di seta fabbricata nello stato, annoveravano quella «sottile» (adatta agli orsogli) che era in massima parte esportata verso il Bolognese ed il Ferrarese. Nel 1644 Sandi e Poleni e Marchiò Cechini legavano alla richiesta di blocco delle esportazioni delle sete «più esquisite» i loro progetti di ampliamento della produzione di filati. Nel 1646 furono i mercanti da seta di Venezia a proporre il divieto di esportazione della seta greggia reputata tra le migliori d’Italia. Insomma nello stesso decennio si verificarono il decollo delle manifatture alla bolognese e lo sviluppo della produzione di seta greggia e della trattura del filo sottile ad esse necessario.
Per i proprietari fondiari si stabilì un circuito di interessi tra la trattura e il commercio della seta grezza e la filatura e il commercio degli orsogli. Ad esempio, nel 1654 era il daziere di Treviso a rivelare il nesso che i patrizi avevano stabilito tra l’interesse alla filatura e quello di proprietari terrieri interessati alla produzione e al commercio dei bozzoli e del filo grezzo, in una protesta che metteva in evidenza il subitaneo aumento del numero dei fornelli per la trattura passato da venti nel 1653 a settantacinque nel 1654 (89). Ma nel 1717 erano i proprietari a fare dell’intreccio tra filatura e interessi agricoli l’argomento forte per difendere il privilegio delle esenzioni daziarie per gli orsogli. In una petizione intitolata Ragioni e motivi per non aggravare gli orsogli si metteva in evidenza che le «case patrizie nelle quali consiste il sforzo di questo negozio» vi si erano dedicate volentieri «perché gli orsogli serve in parte di consumo alle loro entrate, che in pagamento degli operari, che s’impiegano nel lavoro di giorno in giorno contribuiscono». Il cambiamento di regime fiscale avrebbe scoraggiato dagli investimenti
da che poi ne deriverà pur anco che quel misero avanzo di negotio che si ritrova nella nobiltà venghi annientato, quando all’incontro sarebbe desiderabile che tutta s’impiegasse ad imitazione di quella di Fiorenza e Genova nella negoziazione (90).
Da parte loro i governanti furono attenti a non turbare l’equilibrio che si stabilì fra interessi alla gelsibachicoltura, alla trattura e al commercio della seta greggia, gli interessi alla filatura e al commercio degli organzini, gli interessi alla tessitura e al commercio delle pannine.
Significativa, a questo proposito, fu la loro riluttanza ad accettare le proposte, più volte avanzate, di divieto di esportazione della seta greggia. Le respinsero prima nel 1644 e nel 1646 — quando il divieto avrebbe dovuto incoraggiare e premiare gli investitori nella manifattura alla bolognese —, poi nella congiuntura sfavorevole degli anni 1653-1657 — quando l’ufficio della seta si lagnava che le sete «ammassate» venissero condotte a Rovereto, a Bologna, a Firenze, a Lucca, a Genova e altrove e in Fiandra e in Francia, ove per la loro finezza si lavoravano e si riducevano «in pannina di perfezione e bellezza conforme a quella» fabbricata in Venezia, mentre l’Arte veneziana era depressa per la «strettezza di negozi e Piazza» (91) — e ancora nell’altra congiuntura difficile, quella del 1670, quando erano i fabbricanti di orsogli di Bassano ad angustiarsi per la crisi dei loro opifici e la disoccupazione delle maestranze a causa della «quantità di sete grezze sopraffine» che passavano all’estero e
della nuova introduzione di simil negozio in Baviera ove quel Duca dicesi abbia impiegato capitali per 2 milioni et ivi viene espedita la maggiore e migliore parte delle sete che si fabbricano nel Trevigiano e nel Bassanese et le maestranze più perfette sono colà passate, com’è seguito questi ultimi giorni di quelli di Bassano, che in numero di 20 e più sono andati in Baviera [...] (92).
Le tentazioni imprenditoriali dei Veneziani. I Veneziani e i filatoi
Gli impulsi all’espansione della filatura alla bolognese erano partiti da Venezia. Governanti e cittadini li avevano impressi per primi. Li avevano raccolti nel periodo iniziale anche capitalisti delle province di Terraferma. Le decisioni dei governanti assecondarono in ogni fase le esigenze delle nuove intraprese produttive. A far decollare il settore e ad assicurarne lo sviluppo contribuirono fortemente i capitali dei patrizi.
I governanti seppero desistere dalla pressione fiscale sulla seta filata in orsogli, fecero resistenza alle pressioni corporative verso il divieto di esportazione di seta grezza o di orsogli, respinsero le richieste tendenti a distruggere il setificio in Terraferma (prima i filatoi, poi le tessiture di Terraferma), furono pronti a fare concessioni di terreni, di acque, di legname agli investitori, finirono per accettare le ragioni dei capitalisti interessati ai profitti della filatura contro i mercanti di seta veneziani e concessero la libertà piena all’esportazione. Protessero i fabbricanti contro le pretese dei dazieri (93). Insomma in ogni occasione seppero prendere le decisioni convenienti a dare nuove spinte agli investimenti nella filatura meccanica in Terraferma.
Il quadro legislativo da loro a mano a mano costruito rese meno avventurosi gli investimenti e parecchi Veneziani, detentori di capitali, profittarono delle agevolazioni. All’inizio del Settecento su circa cinquantacinque mulini alla bolognese individuati nel Vicentino, nel Bassanese, a Feltre e nel Trevisano, ventisette appartenevano a famiglie riconoscibili come veneziane (94). Di esse tredici erano quelle patrizie, alcune delle quali ne affidavano la gestione ad agenti: ad esempio Giacomo Angaran e Lugrezia Molin Memo ad Angaran (Vicenza) (95). Tuttavia, anche nel caso di proprietari che cedevano in affitto il filatoio, l’investimento iniziale necessario alla costruzione del mulino era la condizione indispensabile per l’avvio di una nuova impresa. I loro mulini erano tra i più grandi: ad esempio quello di Orazio Dolce a Rossano (Bassano) nel 1700 richiedeva il lavoro di cinquantatré persone fra operai, garzoni e fanciulli; ad Angaran quello di Giacomo Angaran mobilitava settantasei persone e in quello di Lugrezia Molin erano ottantacinque i lavoratori. In un elenco del 1726 su trentaquattro mulini da orsogli attivi nel Vicentino (escluso il territorio di Bassano) i Veneziani ne possedevano una decina e di essi otto erano qualificati «grandi» (96).
Ai patrizi si affiancavano i mercanti veneziani o residenti a Venezia. I mercanti di pannine Marco Stroppari, Nicolò Passalacqua, Giovanni Collalto, Giovanni Benzon divennero proprietari di mulini (97). Altri mercanti divennero gestori di mulini appartenenti a patrizi. A Feltre i due mulini da seta rimasti attivi nel 1700, quelli degli annobiliti Tomaso Sandi e Francesco Bergonzi, erano tenuti in affitto da due mercanti di Venezia, Serafino Monticano e Agostino Cefis, che davano lavoro rispettivamente a novanta e quarantacinque lavoratori tra uomini e donne (98). Nel 1702 Vincenzo da Riva, rettore a Feltre, metteva in rilievo il ruolo dei mercanti veneziani in tutto il ciclo di produzione: i due edifici
lavorano per conto de mercanti più opulenti di questa Dominante, li quali trovando colà allettamento maggiore [per il privilegio di esenzione dai dazi di trattura e fornelli] portano colà il denaro, raccolgono quante gallette possono, tirano sede, comprano da particolari quante di queste li vengono, poi le lavorano tutte nelli fillatoij soddetti, dando con ciò da vivere a quella poca gente minuta che l’edificio ricerca (99).
Il Cefis fondò nel 1706 un terzo mulino con tre ruote a Feltre (100).
Nelle mani di capitalisti operanti a Venezia fu quasi tutta l’esportazione degli organzini per oltramonti, specie dopo che il decreto del 22 marzo 1691 obbligò gli orsogli a passare dal fontico dei Tedeschi. Tra loro si distinsero per la frequenza e la grandezza delle partite il Passalacqua, il Roberti, il Golin, lo Zambelli, Pietro Vettorelli — che erano proprietari e gestori di mulini — e Giovanni Cristoforo Pomer insieme con numerosi altri Tedeschi o Olandesi. Parecchi patrizi segnalavano la loro presenza nel settore anche con la diretta partecipazione alle attività esportative (Marco Contarini, Lugrezia Molin Memo, Giacomo Angaran, Giovanni Capello, Giovanni Benzon, Marco Andrea Zambelli, Gabriel Contarini, Pietro e Andrea Capello Morosini, Pietro Emo) (101).
Qualunque fosse il modo di interessarsi alla produzione e al commercio degli orsogli, i proprietari dei mulini vedevano remunerati bene i loro investimenti. «I padroni degli edifici [...] resi in questo negotio per la maggiorparte facultosi et opulenti»: li descrivevano così nel 1714 i revisori del denaro pubblico in zecca che tentarono, inutilmente, di strappare al senato l’assenso a imporre 10 soldi per libbra sugli orsogli commerciati (102).
Possiamo immaginare che all’opulenza prodotta in parte dal setificio si debba la possibilità di sostenere i costi dell’acquisto della nobiltà e del mecenatismo da parte di famiglie come i Sandi, che nel 1724 si fecero decorare il salone del palazzo da Nicolò Bambini e Giambattista Tiepolo (103).
Anche il primo filatoio alla torinese fu impiantato con capitali veneziani a Vicenza. Esso realizzava un progresso nella lavorazione degli organzini rispetto a quelli lavorati alla bolognese. Il nome del gestore era Santo Battistella che chiese la licenza per costruirlo nel 1723 (104). Egli aveva il merito di aver introdotto anche la lavorazione delle sete di Persia e Turchia in trame. Il suo edificio dava da vivere a «molte centinaia di persone». Quando fallì nel 1728 si scoprì, però, che i grandi capitali (più di 87.000 ducati) con i quali egli lavorava erano di residenti a Venezia: tra di essi oltre la nd Barbarigo Vitturi Nievo, esposta per 16.000 ducati, vi erano anche degli Ebrei («per somma ragguardevole») e un misterioso personaggio per conto del quale Isac Treves aveva investito addirittura 40.000 ducati (105).
Insomma dal 1635 in poi, per tutta la durata della congiuntura secolare, la manifattura degli organzini attirò capitali di Veneziani. Il setificio era un settore che produceva buoni profitti grazie al commercio dei panni serici nel Levante ed era collegato all’interesse agricolo, e questo può apparire la ragione che rende ovvio l’orientamento dei Veneziani ad investire nella torcitura della seta in Terraferma. Inoltre le esenzioni daziarie e le agevolazioni di vario genere concesse dal governo avevano il potere di incoraggiare anche i più titubanti. S’è visto, tuttavia, che la manifestazione e il consolidamento di tale propensione non erano una scontata conseguenza di tali condizioni favorevoli e che la decisione di investire in intraprese manifatturiere costituiva un atto di calcoli aleatori anche in un caso che appare favorevole come questo.
La controprova possiamo trovarla nell’orientamento di alcuni degli stessi soggetti e di altri Veneziani ad investire in un settore come quello cartario che non dava profitti altrettanto seducenti di quello della seta, che non era legato all’interesse agricolo, che non godeva di privilegi fiscali e che era più colpito dalla recessione del dopopeste.
Gli investimenti veneziani e la manifattura cartaria
Nel settore cartario la presenza di capitali veneziani era già segnalata prima della peste secentesca. Ad esempio nel Padovano e nel Trevigiano si trovavano cartiere di proprietà di patrizi o di cittadini già da molto tempo. Ma erano stati i due decenni precedenti la peste il periodo in cui più significativamente si era manifestato l’interesse ad investire per stimolare la produzione della carta in vista dei profitti da ricavare col suo commercio. Il territorio di Ceneda allora era diventato un polo di attrazione di capitali veneziani. Un gruppo di patrizi aveva fondato nel 1618-1619 una «compagnia della carta» con grandi progetti di espansione produttiva e di sviluppo commerciale (106). La peste aveva bloccato il fervore di iniziative. Nella congiuntura sfavorevole che cosa ci si attenderebbe? Che si verificassero solo dismissioni. Invece nel periodo 1633-1720 ci furono investimenti per far sopravvivere le cartiere e investimenti per farne sorgere di nuove. Per renderci conto della continuità delle attività finanziarie che le riguardarono può bastare ricostruire la serie degli investimenti di tre famiglie.
La prima è quella dei Mocenigo di S. Stae. Troviamo un suo membro come socio nella compagnia della carta che acquisì le cartiere di Ceneda nel 1619. I Mocenigo continuarono a tenere cartiere dopo lo scioglimento della compagnia nel 1622. All’inizio del periodo critico erano proprietari di una cartiera. Nel 1634 furono loro a far risorgere la cartiera già Correr distrutta da un incendio. Poi, nel 1644, ricostruirono ancora una cartiera di sette ruote anch’essa distrutta da un incendio (107). Non era però un periodo in cui un proprietario di cartiera potesse limitarsi a godere della rendita. Senza il finanziamento della produzione era probabile la rovina della cartiera, poiché diventava impossibile trovare chi volesse assumere la gestione e gli oneri dell’impresa. I Mocenigo dovettero finanziare i conduttori con migliaia di ducati e coinvolgersi nel commercio della carta. Nei contratti del 1634, 1640, 1643, 1665 finanziavano i produttori con esborsi di denaro cospicui, «per darli modo di poter far lavorare meglio l’edificio» (108). Nel 1677 erano creditori del maestro affittuale e nel 1678 in saldo del suo debito ricevettero da lui una cartiera sita a Toscolano (distretto di Salò). La cedettero in affitto al mercante veneziano Giuseppe Maria Zuanelli che la subaffittò al maestro Bartolomeo Sgrafignoli.
Il nuovo contratto per la cartiera cenedese di sei ruote con i maestri Bartolomeo e Benedetto Bontempi chiarisce quale era la grandezza dell’esposizione finanziaria e il modo di coinvolgimento dei Mocenigo. L’affitto valeva 630 ducati annui da pagarsi in carta «ottima e perfetta»; il proprietario aveva l’obbligo di comprare in contanti metà della carta prodotta a lire 50 la balla e di anticipare il costo del frumento e del vino per gli operai; il proprietario prestava 2.000 ducati in stracci e strumenti per l’avvio del ciclo produttivo. L’interesse alla commercializzazione traspare da due clausole: 1) «a fine che il negozio non perda reputazione» all’affittuale è proibito di dare carta ai lavoranti che la svenderebbero; 2) ai maestri cartai è concesso di condurre a proprie spese la carta a Venezia anche sotto nome dei Mocenigo per maggior vantaggio «acciò s’inanimischino al buon servizio di esse eccellenze». Nel 1686 Alvise Mocenigo qm. Marco Antonio perse per un incendio la cartiera di Toscolano.
Ponderato però [...] il stato delle cose, la distanza del luoco e fatto riflesso alle molte spese del restauro, [...] per non perdere totalmente detto capitale e per non privarsi affatto del dominio dell’edificio
si mise d’accordo con lo Zuanelli per un affitto di venticinque anni a 50 ducati annui (o 1.500 anticipati) in cambio dell’impegno alla ricostruzione. Nel corso del Seicento i Mocenigo fecero costruire un’altra cartiera nel contiguo territorio di Serravalle alla Negrisola con quattro ruote e due tini. Nel 1665-1666 la fecero ingrandire con l’aggiunta di altre due ruote e di un altro tino (109).
Nella stessa area simile persistenza d’interesse e d’impegno dimostrarono i Contarini della famiglia del doge del 1655, Carlo. Proprio Carlo, che possedeva a Battaglia nel Padovano dei molini, una pila da riso e una quota della cartiera privilegiata (110), era stato l’antesignano nella fondazione della compagnia della carta e dopo lo scioglimento della società aveva costruito una grande cartiera di sei ruote a S. Giacomo di Veglia, forse nel 1622 (111). Egli nel 1637 fece costruire una seconda cartiera di tre ruote. Nello stesso anno per la conduzione della cartiera grande — data in affitto ad un maestro cartaio per 500 ducati annui — dovette finanziare la produzione con un anticipo di 1.100 ducati da essere restituiti in quattro rate semestrali. Era obbligato anche alle spese necessarie a rendere più efficienti le infrastrutture e le macchine. Non era interessato a ricevere carta, se non una piccola quantità in regalìa (112). Invece il figlio Andrea appare di nuovo percettore di canoni in carta e ancora finanziatore degli affittuali dei due impianti (113). Nel 1664 la cartiera minore era affidata in conduzione ai Pasini di Ceneda sostenuti da un prestito di 300 ducati al 6% in cambio di un canone di 285 ducati pagati in carta. Con un contratto analogo era gestita la cartiera maggiore dal nobile cenedese Vincenzo Bonaldi che aveva avuto un finanziamento di 1.000 ducati e pagava un canone di 500 ducati. Nel 1677 il figlio di Andrea, Carlo Contarini, risultava creditore sia dei Bonaldi sia dei Serravalle, gli affittuali subentrati ai Pasini nel 1671 (114). Allora egli stipulò un nuovo contratto con i Bressanin per la cartiera piccola: contemplava un abbassamento del canone a 200 ducati e clausole analoghe a quelle dei contratti Mocenigo per la fornitura di carta a prezzi definiti (115).
In altra area, invece, fu la famiglia Capello a dimostrare un interesse non episodico per le cartiere. Dalla metà del Seicento Andrea era proprietario di una cartiera di media capacità produttiva (con due tini) ad Oliero nel Vicentino (116). Nel 1680 egli chiese la concessione dell’acqua necessaria a mettere in moto un nuovo impianto che intendeva costruire a Galliera nel territorio di Cittadella. Il progetto riguardava una cartiera di medie dimensioni (quattro ruote e due tini). Pur di ottenere la concessione Andrea affrontò liti e opposizioni davanti al consiglio di 40 civil novo e solo nel 1685, composte le vertenze, fu autorizzato ad eseguire i lavori. Ma a quel punto insorsero le opposizioni del nobile Contarini e degli altri comproprietari della cartiera della Battaglia (vicino Padova). Essi accampavano i diritti derivanti dal privilegio di monopolio provinciale di vendita della carta e di esclusiva nell’acquisto degli stracci, che era connesso con il possesso della cartiera facente parte originariamente dei beni carraresi. La costruzione fu ritardata per 4 anni, finché il Capello non si adattò a situarla sull’altra riva della Seriola nella podestaria di Castelfranco. Per l’investitura d’acqua pér il follo da carta e per altri usi (un maglio di ferro e l’irrigazione di centotré campi) Andrea dovette sborsare al fisco 1.840 ducati correnti (117). Nel 1719 i figli di Andrea, Lorenzo, Girolamo e Vincenzo, sfruttarono la concessione dell’acqua per animare un’altra cartiera a Fontaniva, più grande delle altre due (tre tini e sei ruote). Essa sostituiva un edificio per la fabbricazione di polvere da sparo incendiato nel 1717 e richiese l’abbattimento di una macina da olio di lino e l’uso di un pezzo di prato. Per poterla far funzionare e per assicurarsi la provvigione di stracci i Capello dovettero sobbarcarsi ad un altro onere: prendere in affitto la cartiera della Battaglia, i cui comproprietari avevano ostacolato l’iniziativa di Andrea. Il canone era di 880 ducati, probabilmente gonfiato dal valore delle privative. Nel 1720, dunque, i Capello erano proprietari di tre cartiere e ne avevano un’altra in affitto perpetuo (118).
Le notizie relative ai Mocenigo, ai Contarini, ai Capello si prestano a tre costatazioni: 1) alcune famiglie aristocratiche avevano interesse a investire nel settore della manifattura cartaria una parte non piccola della rendita; 2) la continuità di tale interesse attraversa la congiuntura secentesca; 3) la congiuntura depressiva costringe gli investitori a farsi carico non solo della costruzione degli impianti ma anche del finanziamento delle attività necessarie al ciclo produttivo e, a volte, alla commercializzazione. Sono tre rilievi che contraddicono lo schema che ha stabilito la corrispondenza tra depressione secentesca e rifugio di tutti gli aristocratici nella rendita parassitaria, tra depressione e disinvestimento dalle manifatture. Il terzo rilievo riguarda invece il fatto che proprio in un tempo di difficoltà i detentori di capitali interessati alla produzione manifatturiera dovevano accrescere l’esposizione finanziaria. Gli esempi ci fanno ben percepire il ruolo del capitale nobiliare nella costruzione e nel funzionamento della manifattura cartaria.
Le tre famiglie citate sono un campione della ventina di famiglie aristocratiche che, durante il secolo XVII, legarono il loro nome ad una o più imprese cartarie. Nel 1725 nel Trevigiano le famiglie patrizie implicate nel settore cartario erano quelle dei Dolfin (Girolamo di S. Sofia), dei Gradenigo (Giuseppe), dei Tiepolo (Domenico), dei Gritti (Ottaviano), dei Priuli (Andrea); a Vas c’erano i Gradenigo (di Campiello degli Squellini). Su diciannove cartiere essi ne possedevano dieci. Nel Bellunese erano i Sagredo (Gerardo) a gestire l’unica cartiera del territorio. Nel Pordenonese Contarina Contarini, la famiglia Rota, il procuratore Vincenzo Gradenigo. Nel Vicentino oltre i Capello, i Priuli, un altro ramo Mocenigo, Alvise Zusto. Alcune delle famiglie patrizie avevano attraversato il Seicento sostenendo la proprietà di cartiere fondate precedentemente e intervenendo per restaurarle o ingrandirle; altre, invece, si erano inserite nel corso del secolo fondandole o comprandole (119). Ai patrizi si affiancarono anche investitori borghesi, come Gasparo Righi di Venezia, che aveva una cartiera di una ruota a Bibano di Carbonera (Treviso) (confinante con quella dei Dolfin e con un’altra dei Priuli (120)), e come la famiglia cittadinesca Aronzio. Alcuni suoi membri acquistarono nel 1659 una cartiera posta a Campese nel Vicentino e un loro discendente trasformò nel 1719 una ruota da molino in un edificio da orsogli alla bolognese (121). A Ceneda alle vicende dei patrizi Mocenigo e Contarini si intrecciarono quelle dei mercanti Giovan Maria Rizzardi, Urbano Urbani e Giuseppe Maria Zuanelli. Il Rizzardi insieme con l’Urbani prese in affitto la cartiera Contarini nel 1633. Nel 1635 l’Urbani comprò la cartiera del Bertella, che era un fabbricante incapace di far fronte ai costi della produzione. Nello stesso anno Rizzardi se ne fece costruire una con tre ruote (122). Nel 1640 Rizzardi, rimasto unico proprietario delle due cartiere, seguitò ad investire per spostarne una sulla riva opposta e per costruirne una terza di due ruote. Anche l’Urbani e il Rizzardi si esposero finanziariamente impegnandosi a fornire ai cartai gli stracci, la colla, le paghe degli operai (123). Nel 1650 il testamento del Rizzardi lo fa apparire come legato a Venezia ma radicato anche a Ceneda: ha casa presso la cartiera e vicino fa costruire una chiesuola, vuole farsi seppellire nella sua arca ai Frari di Venezia e raccomanda alla moglie Margherita e agli altri due tutori dei figli «di dover far continuare le cartere che saranno il [loro] sostentamento» (124).
Giuseppe Maria Zuanelli prese in affitto la cartiera Mocenigo di Toscolano nel 1677 assicurandone l’attività produttiva. Fu lui a provvedere alla sua ricostruzione nel 1686 dopo l’incendio. Egli era uno dei mercanti di carta che, trapiantati a Venezia da parecchie generazioni provenendo dalla valle del Toscolano, svolsero la funzione di finanziatori della produzione cartaria. Due esempi: nel 1702 il discendente Giovan Maria Zuanelli subaffittava la cartiera ad un maestro cartaio e si impegnava a sovvenzionarlo con un capitale di 500 lire veneziane in denari, stracci e altri generi e ad accettare la fornitura della carta di volta in volta richiesta ai prezzi determinati per il valore di 1.800 ducati annui, che dovevano essere saldati con versamenti mensili di 150 Ducati (125). Nel 1731 troviamo notizia che il veneziano Gian Andrea Comincioli finanziava il produttore operante a Toscolano con migliaia di lire di piccoli (126).
I patrizi e i cittadini preferivano dirigere i loro investimenti nelle aree orientali dello stato concentrandosi in particolare attorno a Treviso. Nel caso dei mercanti il maggior flusso di investimenti si diresse verso le cartiere della valle del Toscolano nella Riviera di Salò. Ma i due flussi furono tra i fattori determinanti, da una parte, per rendere più numerosi gli impianti dei territori orientali e, dall’altra, per arrestare e limitare la crisi delle cartiere salodiane colpite dagli effetti della peste. Essi contribuirono di conseguenza a rendere meno grave la depressione di alcuni settori dell’economia veneziana come quello dell’esportazione della carta e quello dell’attività editoriale.
Per quanto riguarda la carta, nel primo trentennio del secolo a Venezia le importazioni avevano raggiunto punte di sedicimilacinquecento balle. Dopo la peste, per tutto il decennio 1630-1640 ammontavano annualmente in media a tremilanovecentotrentasette balle, mentre prima del 1630 superavano largamente il triplo. Nel 1640 erano scese a tremilacento balle. Ma quindici o venti anni dopo esse erano tornate al livello di circa diecimila balle, che rappresentavano, comunque, l’uscita dal collasso. La maggior parte era destinata all’esportazione. Il consumo interno veneziano di carta da scrivere e da stampa rappresentava ormai appena un terzo della carta che entrava a Venezia (127). Avevano ragione i mercanti veneziani che nel 1683 riconoscevano:
è prodigiosa fortuna che nello stato delle cose presenti vi sia in questa città tanta estrazione di carta per mare che ascenda a risme 60.000 all’anno, mentre dalla fede de negozianti cospicui di questa piazza, prodotta, risulta che nello stato del Papa, de Genovesi e di Marsiglia la carta vaglia molto meno di quello si paga [qui] (128).
L’attività editoriale veneziana subì una decadenza lunga dal 1630 alla fine del secolo. Si assestò a livelli di pura sopravvivenza negli anni Settanta. Ma l’arresto della decadenza sembra essere iniziato dal 1680 circa fino a tramutarsi in ripresa e slancio nei primi decenni del Settecento. Alla inversione della tendenza contribuì la carta da stampa a prezzi meno cari messa a disposizione dalle cartiere nel frattempo impiantate nei territori trevigiani e vicentini, per la maggior parte, con i capitali di Veneziani (129).
Altre intraprese
La filatura alla bolognese e la produzione cartaria avevano in comune il carattere di imprese che assorbivano capitali di grande entità e influenzavano direttamente il commercio ad ampio raggio o alcune attività indotte veneziane. Tale caratteristica è riscontrabile anche in altre attività quali le estrazioni minerarie e il commercio del legname, contrassegnate dal bisogno di immobilizzi di capitali ampi. Anche in tali settori troviamo documentate le inclinazioni dei Veneziani all’investimento. Ad esempio, nelle miniere della valle Imperina a partire dal 1669 si avviò una impresa gestita direttamente dalla Repubblica veneta, che nel giro di un cinquantennio assunse dimensioni e importanza analoghe a quelle dell’azienda della famiglia Crotta, che continuò a occuparsi dell’impresa mineraria anche dopo l’aggregazione al patriziato veneziano comprata nel 1649 (130). Le miniere suscitavano l’interesse di Bernardo Moro nel 1683 ma erano quelle situate a Primiero in territorio imperiale. Egli spese 3.000 ducati per comprare la miniera da ferro, il forno, la fucina con casa e carbonile dal barone Piero Castagna (131). Il commercio del legname a vasto raggio continuò ad essere il grande affare della famiglia Sagredo per tutto il secolo (132).
Ma anche in altri settori in cui le singole imprese non necessitavano di grandi capitali gli investimenti dei Veneziani furono un fattore essenziale per la loro resistenza o per la loro espansione. Abbiamo un caso di investimento praticato in un’impresa commerciale udinese da parte di Lodovico Ferro che aveva una bottega di spezierie nella parrocchia di S. Marina. Nel 1680 strinse compagnia con Gasparo Spiera per un negozio di merci da esercitarsi nella bottega appositamente presa a Udine. Il contratto lo impegnava a conferire 1.500 ducati al capitale sociale e a provvedere da Venezia delle mercanzie ordinate dallo Spiera. La società restò attiva con profitto fino al 1701 (133). Ma i casi più interessanti riguardano i patrizi e i borghesi veneziani il cui nome è facile trovare tra i proprietari della miriade degli opifici idraulici (mulini da grano, battirame, battiferro, folli da panni, mulini da polvere da sparo, segherie...) che costituivano delle nebulose di attività produttive caratteristiche di economie più localizzate. Ad esempio, a Campolongo Nicolò Contarini e i due fratelli qm. Francesco possedevano «un loco posto sulla riva del Brenta» dove funzionavano «un edificio con 4 mele da sega, 3 ruote da molin, una ruota da maglio per il favro, doi edifici da cartiera e doi edifici da seda»: segheria, mulino da cereali, officina fabbrile, cartiera e filatoio meccanico costituivano un piccolo distretto manifatturiero che la famiglia aveva man mano costruito con ripetuti investimenti (134).
Lungo il Seicento ci sono molti patrizi che appaiono insistenti nella loro ricerca di costituire in fonti di reddito le intraprese produttive in Terraferma. Esemplari sono le iniziative ripetute di due proprietari di cartiere. Andrea Capello nel 1661 aveva — oltre la cartiera — altri edifici tra i quali un mulino a tre ruote (135). Nel 1676 provò ad ottenere nuove diramazioni d’acqua dal Brenta per le segherie di Carpené. Suscitò le reazioni negative degli zattieri della confraternita di S. Nicolò di Valstagna (136). Ancora più pervicace l’interesse di Domenico Gritti fu Alessandro. Nel 1669 chiese l’investitura d’acqua per una cartiera a Roncadelle (Treviso) e l’ottenne nel 1689 (137); nel 1676 la chiese ancora per una seconda cartiera a Fontane (138); nel 1677 volle aggiungere due ruote ad un mulino in Villorba e costruire una cartiera per «carta strazza» e un «edificio per frangere vallonia per accomodar pelle e cuoiami sopra la Piavesella» (139); nel medesimo anno chiese ancora investiture per un altro edificio per fare carta straccia, un altro di battirame, un altro da sega sopra la Piavesella in Visnadello, Villorba e Fontane e l’ottenne nel 1678 (140). Infine nel 1686, «provando nell’esecuzione poca riuscita nell’edificio da sega e sperando render più profittevole la pratica del battiferro in sua vece», domandò facoltà di cambiamento d’uso (141); l’anno successivo presentò supplica per una quinta cartiera di tre ruote sulla Piavesella, in pertinenze di Spresian, e conseguì la concessione nel 1691 (142). Insomma tra il 1669 ed il 1691 Domenico Gritti ripetutamente provò a ricavare redditi da una decina di impianti idraulici, ora costruendoli, ora potenziandoli, ora commutandone l’uso ed il fratello Ottaviano ne continuò l’opera dopo la sua morte (143).
Sono attività generalmente trascurate nella storiografia sull’economia veneta e su quella veneziana. Però la presenza della proprietà veneziana degli impianti che le rendevano possibili era molto forte nelle province orientali. Tale proprietà sembra intensificarsi durante il Seicento con la conseguenza di rafforzare i poteri economici derivanti dal possesso fondiario (144).
Il ruolo degli investimenti veneziani nelle intraprese produttive in Terraferma
L’attenzione alle intraprese produttive di Terraferma dona visibilità al ruolo che in esse svolsero gli investitori veneziani, in primo luogo aristocratici. L’evidenziazione del loro ruolo spinge a mettere in discussione gli schemi interpretativi generali che sono stati largamente applicati nell’interpretazione della storia economica veneta del Seicento e Settecento. Essi si possono sintetizzare in due enunciati: 1) i valori sociali inibivano l’aristocrazia dallo svolgere una qualsiasi delle funzioni imprenditoriali e la disponevano a rifugiarsi nella confortevole nicchia della rendita agraria; 2) in forza di questo atteggiamento aristocratico l’agricoltura e il consumo drenavano i capitali potenzialmente destinati all’investimento nel settore secondario che restò, perciò, asfittico e incapace di espansione. Quelle interpretazioni negano all’aristocrazia la capacità di assumere un ruolo positivo qualsiasi nello sviluppo del settore manifatturiero e all’agricoltura di poter avere una parte complementare ad esso. Secondo la caratterizzazione che è ricorrente nella letteratura storiografica, i redditieri erano infingardi e inetti a concepire altri impieghi dei loro capitali se non sotto forma di piazzamento nel possesso fondiario o nel debito pubblico. Tali argomenti sono diventati dei punti di forza delle spiegazioni della crisi secentesca e dell’«arretratezza» del Veneto settecentesco (145).
La presenza non episodica di capitali veneziani svela come abusiva la tesi che la depressione secentesca e il sistema di valori ostassero all’investimento nel settore manifatturiero. La propensione ad investire nella manifattura serica e in quella cartaria si manifestò nelle province orientali attraverso le alterne congiunture del Seicento. Le iniziative furono prese durante il periodo considerato come il più deprimente per le attività produttive e commerciali dell’economia veneta. Per apprezzare il ruolo di tali investimenti occorre tener conto delle specificità delle manifatture interessate. Sia i mulini da seta sia quelli da carta appartenevano a quel tipo di manifatture che nell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert erano classificate come riunite. Esse richiedevano,
sia per il primo impianto, sia per le altre operazioni che vi si fanno, investimenti considerevoli [...]. Una manifattura riunita può essere impiantata e sviluppata solo con grandi spese di costruzione degli opifici, di manutenzione di questi edifici, di direzione, di soprastanti, contabili, cassieri, preposti, inservienti e simili e, infine, con grandi approvvigionamenti (146).
Infatti sia i mulini da seta sia le cartiere richiedevano un capitale fisso rappresentato da infrastrutture (rogge, ponti, strade...), da edifici, da macchine utensili e strumenti semplici, il cui costo incideva in misura rilevante nell’organizzazione dell’attività produttiva; il capitale circolante necessario per l’approvvigionamento delle materie prime e per il pagamento dei costi del lavoro era anch’esso notevole. Inoltre occorrevano riserve di capitali per far fronte alla lunghezza della rotazione dei capitali circolanti.
La grandezza delle spese di impianto non era alla portata delle maestranze che potevano assumere il carico della gestione della fase produttiva. Nella situazione d’impotenza dei manifattori diventava essenziale che i capitali dei redditieri contribuissero ad espandere le risorse produttive. I redditieri veneziani non si tirarono indietro e con la costruzione di impianti misero i loro capitali a disposizione dei manifattori.
La morfologia dei contratti d’affitto dimostra che il proprietario non poteva considerare l’investimento immobiliare come un impiego senza impegni, un semplice cespite di rendita fissa. Essi dovevano intervenire ancora con i propri capitali se volevano preservare o aumentare la redditività dell’investimento, provvedendo ora alla riparazione delle opere murarie, ora a quella delle canalizzazioni danneggiate dalle piene, ora ai restauri e alle migliorìe (147). Si trattava anche di investimenti rischiosi: bastava una piena o un incendio per mandare in fumo centinaia di ducati e i danni di una recessione prolungata ricadevano anche sui proprietari per l’impossibilità di affittare la cartiera e di assicurare la remunerazione dell’investimento.
Ma era fuori della portata dei manifattori anche la possibilità di finanziare i costi di esercizio. Essi dipendevano generalmente dagli anticipi dei mercanti (di seta, di carta, oppure degli stampatori, o dal buon volere degli incettatori di stracci) (148). Nella depressione secentesca tale dipendenza si aggravò. Perciò proprio nelle fasi congiunturali secentesche gli investimenti dei patrizi non potevano limitarsi alla costituzione del capitale fisso, dovevano pervadere la fase produttiva in parecchi casi e per lunghi periodi e a volte dovevano sostenere persino la fase commerciale. Nel caso dei borghesi era in genere proprio l’interesse diretto al commercio a dare impulso agli investimenti manifatturieri. Nella maggior parte dei casi la proprietà degli «edifici idraulici» obbligava i proprietari anche ad un’attività creditizia. Mi sembra lampante l’ulteriore esempio della famiglia di Alvise Mocenigo IV, procuratore di S. Marco, che nel 1683 ottenne l’investitura di acqua per un mulino da seta a Pieve sotto Torrebelvicino. Sullo stesso torrente Leogra nel 1692 la famiglia aveva anche due magli da rame, un maglio da ferro ed una cartiera e riceveva 570 ducati per il loro affitto e in più 361 ducati a conto di interessi al 5% per il prestito di 7.230 ducati consegnati all’unico affittuale «per far andare detti edifici» (149).
Erano investimenti fatti con prudenza, tenendo conto dei riflessi della redditività dell’intrapresa produttiva sulla rendita. Possiamo inferirlo leggendo un incartamento — presumibilmente appartenuto alla famiglia Corner (150) — che si trova ora nell’archivio privato Morosini-Grimani. Lo compongono anche numerose annotazioni, degli anni Settanta e Ottanta del Seicento, riguardanti eventuali destinazioni di investimenti, progetti di imprese, notizie sui commerci... che rivelano la vigilanza della famiglia circa le potenzialità di imprese in Terraferma.
Nel 1675 il ragionamento riguardava l’idea di mettere su una bottega di ferramenta alle Sarasine «distante pochissimo dai nostri campi di Lendinara»; nel 1681 tre lettere di un affittuale da Treviso davano informazioni sul commercio delle scodelle e i loro prezzi; nel 1685 si trattava di avviare un negozio in Castelfranco e si raccoglievano notizie su ferramenta e carni salate; nel 1689 si dava conto del parere di un produttore di olio di lino fatto arrivare dal Dolo a Mirano a «vedere il nostro edificio per trovar uomini da poterlo far lavorare con regola migliore della presente [...]». Il documento più eloquente è la relazione dell’inizio del 1689 su un abboccamento con un uomo d’affari in vista di investimenti in miniere e in negozi di ferramenta. L’anonimo estensore scriveva da un luogo di Terraferma, forse non lontano dalla miniera di Caneva nel Pordenonese, ad un corrispondente veneziano col quale condivideva la proprietà di stabili nei pressi di S. Basso in Venezia. Probabilmente erano patrizi in fraterna. Il facoltoso uomo d’affari era Giulio Delai comproprietario di miniere e fucine, negoziante di ferramenta e proprietario di sette o otto cartiere a Toscolano e di un negozio di carta a Venezia che rendeva 1.000 ducati al mese. Egli era stato «fatto venire [...] e interrogato» dallo scrivente. Informava circa la fabbricazione e la fornitura di attrezzi di ferro, dava il suo giudizio sulla qualità ottima del ferro prodotto nella miniera di Caneva, informava sulle proprie attività minerarie e su un investimento sbagliato di 14 o 15.000 ducati nell’acquisto di una miniera di ferro infruttuosa nella valle di Progno nel Veronese. Con lui lo scrivente meditava di mettersi in società, sia per far fare ricerche sulle origini della presenza di pagliuzze d’oro presenti in una fontana scorrente nella proprietà Delai nella valle del Toscolano, sia per la miniera abbandonata in val di Progno. Ma principalmente lo scrivente aveva intenzione di chiedergli di procurare gli operai e i direttori per rendere attiva la miniera di Caneva senza dover affrontare spese inopportune e intempestive. In un’altra missiva il medesimo corrispondente riferiva del parere di un altro esperto di estrazioni minerarie e di lavorazioni del ferro che credeva che si potesse far un edificio idraulico per muovere tre magli da battiferro e battirame. Il legno da carbone poteva essere fatto arrivare dall’Istria e lo si poteva trasportare via Piave. Calcolava che un maglio che lavorasse sessanta miara di ferro all’anno produrrebbe un guadagno di 1.000 ducati. Lo scrivente pensava di fabbricare chiodi, di dar lavoro a quindici o venti uomini e di mantenerli con le entrate delle proprie campagne. Progettava di aprire una bottega negli stabili di S. Basso, ma l’esperto considerava migliore la soluzione di aprirla a Murano «in luoco più secreto» (151). Si può intendere che i protagonisti veneziani erano alla ricerca di profitti mediante la costituzione di un’intrapresa che realizzasse un circuito completo di sfruttamento di giacimenti di ferro, di lavorazione del metallo e di commercializzazione dei prodotti finiti mediante investimenti mirati ad avviare l’attività estrattiva, a costruire magli e metterli in produzione e a impiantare una bottega a Venezia.
Non sappiamo se gli atteggiamenti mentali che queste carte ci danno la possibilità di spiare fossero condivisi da tutti gli investitori aristocratici o borghesi di Venezia. Fatto sta che di fronte alle difficoltà dei manifattori che avevano più diretto interesse per la produzione, l’iniziativa dei redditieri veneziani, la loro prontezza a stanziare fondi accumulati al di fuori del settore industriale per cambiare destinazione d’uso agli edifici idraulici o per costruirne di nuovi, risultò importante per promuovere la crescita delle intraprese produttive in qualche settore manifatturiero o in alcuni territori o per rendere meno gravi le ripercussioni della crisi sulle intraprese di settori colpiti dal cambiamento congiunturale.
Alla vigilia di un’espansione: bilancio di un secolo di resistenza
Gli studi dell’economia veneziana nel XVII secolo si sono polarizzati sui movimenti di importazione ed esportazione via mare e sul contributo dell’economia urbana al commercio internazionale. Nel modello che da essi sarebbe possibile derivare il suo rapporto con l’economia manifatturiera di Terraferma non trova né posto né ruolo (152). Anzi, l’incapacità di Venezia di raccordare la propria economia a quella delle province è stata considerata un parametro importante della sua «innegabile decadenza». Si è così collegata la «fragilità di Venezia» al fatto che essa fosse «mal unita a quell’arcipelago di città e campagne che è la Terraferma» e che
la campagna non ha costituito il riparo dell’industria in difficoltà. Venezia non ha avuto questa possibilità. Essa non ha avuto la saggezza di tentare di impiantare le sue industrie fuori della città. Ha lottato sempre per conservare tutti i monopoli e i privilegi. Senso del privilegio: questo può essere la più grande debolezza della Venezia secentesca. [...] Venezia non ha accettato i sacrifici necessari per lottare e sopravvivere. Essa è morta nel lusso delle sue classi dirigenti, nell’egoismo candido delle sue Arti, nell’incomprensione delle rivoluzioni necessarie.
Alla luce di tale interpretazione si sono messe a carico della depressione veneziana persino la difficoltà di provvista della seta siciliana e la scarsità degli acquisti di seta levantina, che in effetti non erano essenziali per i manufatti veneziani e furono sostituite, invece, nelle tessiture prima da altre sete italiane poi da quelle venete (153). La suggestione di tali formule valutative si appanna di fronte agli esiti delle ricerche sui nessi tra economie veneziana e di Terraferma. Infatti per il periodo fra la metà del Cinquecento e i primi decenni del Seicento Michael Knapton ha evidenziato
sia la fondamentale complementarità di interessi nel rapporto commerciale fra la capitale e lo stato di terra — Venezia che forniva alla Terraferma materie prime ed esportava la sua produzione manifatturiera — sia l’elemento conflittuale, laddove la signoria insisteva per convogliare tramite il porto e i dazi della capitale soprattutto gli scambi interessanti la Terraferma centrale e occidentale, sia la tensione fra la complementarità e il conflitto di interessi economici [...] che riguardò pure
l’attività manifatturiera, manifestandosi nella tutela veneziana — più esplicita ed estesa nel Cinquecento — del diritto prioritario o esclusivo della capitale a produrre determinate merci di lusso. [Knapton ha pure dato significato] al graduale sviluppo di una produzione manifatturiera decentrata generalmente meno qualificata di quella dei grandi capoluoghi urbani ma anche meno affetta — soprattutto nel lungo periodo — dal crollo del primo Seicento. [Insediatasi nella] lunga fascia di vallate montane e di zone di pedemonte e pianura alta dall’ovest all’est della Terraferma, favorita da fattori geografici — la presenza diffusa di energia idrica, carbone e legna, la lana dei greggi transumanti, i depositi minerari... — come pure dalla pressione esercitata sulla popolazione da suoli aspri più che fertili, [che invogliava ad] integrare i raccolti e proventi di un’agricoltura povera con altre attività lavorative, la produzione manifatturiera costituì una parte cospicua dei centri minori delle province di Terraferma [...] chiaramente caratterizzati da attività economiche di rilevanza non meramente locale. [In tale contesto la novità principale fu rappresentata] dal setificio come attività di trasformazione dominata da interessi mercantili e disponibile ad accogliere innovazioni tecniche associate all’impiego di mezzi meccanici, come, per esempio, i filatoi ad acqua segnalati nel Vicentino e nel Bergamasco ancor prima della diffusione seicentesca del mulino alla bolognese. Fu proprio nel setificio che si verificò nel Cinquecento lo scontro più diretto fra gli interessi produttivi della capitale e quelli delle province. Questo riguardò in un primo tempo anche la filatura: robuste proteste soprattutto di Vicenza e Verona — le due principali protagoniste del setificio di Terraferma nel Cinquecento — valsero a far rientrare l’ordine di chiusura dei filatoi di Terraferma chiesto dall’arte della seta di Venezia e decretato dal senato nel 1542. Il consenso poi dato dalla signoria alle prime richieste di avviare la tessitura in Terraferma diede inizio a scontri durevoli dal 1558 in poi [...] (154).
In che modo il quadro profilato dal Knapton fu modificato nel corso del secolo seguente per le iniziative di investimenti dei detentori veneziani di capitali, sia patrizi sia borghesi, nelle imprese manifatturiere di Terraferma? Già Domenico Sella aveva intuito che un processo di sfruttamento di nuove risorse della Terraferma veneta aveva avuto luogo nel Seicento ed era stato «reso possibile in larga misura dal capitale veneziano», però molti aspetti del processo gli «rimanevano oscuri» e considerava la seta solo come una voce della «valorizzazione delle risorse agricole» (155). Lo studio dei settori manifatturieri ha messo in luce che le iniziative imprenditoriali a cui parteciparono i Veneziani contribuirono a dotare le province orientali di un apparato produttivo che all’inizio del Settecento era molto più esteso rispetto ad un secolo prima. La novità era costituita dalle manifatture accentrate. La loro diffusione propiziò durante il Seicento l’espansione, nel caso del setificio, o la resistenza, nel caso della manifattura cartaria, e la tenuta di altri settori dell’economia veneta e, di conseguenza, di settori dell’economia veneziana ad essi legati. Si affermò con maggiore continuità la tendenza alla complementarità tra l’economia della Dominante e quella dei territori soggetti. Si consideri, ad esempio, il comparto della seta. Venezia si trovò al centro della rete di scambi riguardante i prodotti serici. Dalla Terraferma una parte di seta grezza passava per Venezia per essere avviata ai mulini alla bolognese (156). La seta trasformata in orsogli era mandata in gran quantità a Venezia. Qui una parte veniva esportata verso i paesi europei senza altre lavorazioni; un’altra quota era usata nella fabbricazione delle pannine. Le pannine di seta erano inviate da Venezia in Levante. In ogni punto del circuito della produzione e della commercializzazione dei prodotti serici nei loro diversi stati c’erano operatori veneziani, ma nel circuito erano implicati anche contadini, mercanti, fabbricanti, artigiani, manovalanza e proprietari di Terraferma. Uno schema analogo potrebbe rappresentare i rapporti di Venezia con le province orientali nel settore cartario.
La proiezione di una parte dei detentori veneziani di capitali verso le intraprese produttive di Terraferma, intensificando i rapporti economici tra Venezia e le province soggette, da una parte determinò la costituzione della base produttiva che fu investita dai vistosi incrementi economici delineatisi dal 1725-1730 in poi, dall’altra diede fondamenti economici alla tendenza alla «simbiosi tra la Terraferma di qua dal Mincio e la città lagunare» che Gaetano Cozzi ha individuato sul piano culturale (157).
1. A.S.V., Senato, Rettori, filza 6, 24 marzo 1634, inserta relazione dei savi alla mercanzia del 31 dicembre 1632.
2. Girolamo Priuli, Cronaca, in Wien, Oesterreichische Nationalbibliothek, cod. 6229, in copia presso microfilmoteca della Fondazione Cini.
3. A.S.V., Senato, Terra, filza 234, 7 maggio 1619, scrittura dei conduttori del dazio del 6% del 22 giugno 1617. Il dazio del 6% era stato appaltato per 64.201 ducati all’anno. Le dieci navi erano arrivate con i loro carichi tra il dicembre 1616 ed il maggio 1617 ed erano state già tutte noleggiate per viaggi di Cipro, Siria, Alessandria e Costantinopoli.
4. Ivi, V Savi alla Mercanzia, I ser., Risposte, reg. 142, 21 aprile 1610. Per due fallimenti che «facevano tremare tutta la Piazza» nel 1609, cf. ivi, Senato, Terra, filza 192, 27 novembre 1609.
5. Ivi, Collegio, Risposte di dentro, filza 13, 12 giugno 1611. Nel 1608 si annotavano centoquarantuno mercanti all’Officio della seta, i maestri tessitori di panni di seta erano duecentottantatré, i maestri filatori settantuno: ivi, Arte Seta, b. 104, fasc. 119, c. 1, 15 settembre 1608. Nel 1612 i mercanti erano diventati centocinquantadue, nel 1623 erano novantatré, nel 1627 erano ottantuno e nel 1630 erano risaliti al numero di centotrenta ma è presumibile che tra essi si fossero inseriti molti tessitori indotti a commerciare in proprio dalla disperazione di ricevere commissioni dai mercanti.
6. Ivi, Provveditori all’olio, b. 14, reg. 2, cc. 1-6 e 80v.
7. Cf. Domenico Sella, Commerci e industrie a Venezia nel secolo XVII, Venezia-Roma 1961. Il processo di regionalizzazione dell’economia veneziana all’inizio del secolo è sintetizzato in Michael Knapton, Tra dominante e dominio (1517-1630), in Gaetano Cozzi-Michael Knapton-Giovanni Scarabello, La Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, Torino 1992, pp. 230-234 (pp. 203-549), dove è messa in rilievo la crescita degli scambi con l’area germanica.
8. Cf. Paolo Ulvioni, Il gran castigo di Dio. Carestie ed epidemie a Venezia e nella Terraferma. 1628-1632, Milano 1989, pp. 77-87 96-105.
9. A.S.V., Senato, Rettori, filza 6, 24 marzo 1634, inserta scrittura dei savi alla mercanzia del 31 dicembre 1632.
10. Ivi, V Savi alla Mercanzia, I ser., reg. 149, 29 aprile 1633.
11. Ibid., b. 477, t. II, fasc. 14, scrittura dei consoli dei mercanti del 29 settembre 1636. In effetti ivi, Senato, Terra, filza 322, 11 febbraio 1630 m.v., tratta della questione di un prestito in soccorso dell’Arte dei testori «i quali in n. di 10 mila per le correnti influenze di mal contagioso languiscono e periscono dalla fame, rispetto che l’è cessato il lavoriero».
12. Cf. Renzo Paci, La «scala» di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani fra Cinque e Seicento, Venezia 1971.
13. A.S.V., Senato, Rettori, filza 6, 24 marzo 1634, inserta relazione dei savi alla mercanzia del 31 dicembre 1632.
14. Ivi, V Savi alla Mercanzia, I ser., reg. 150, 21 maggio 1636.
15. Ivi, Senato, Rettori, filza 6, 24 marzo 1634, inserta relazione dei savi alla mercanzia del 31 dicembre 1632. Da essa sono tratte le citazioni.
16. Cf. Ivo Mattozzi, Il distretto cartario dello Stato veneziano, in Cartai e stampatori a Toscolano. Vicende, uomini, paesaggi di una tradizione produttiva, a cura di Carlo Simoni, Brescia 1995, pp. 35-36 (pp. 23-65).
17. A.S.V., Senato, Rettori, filza 6, 24 marzo 1634, relazione dei savi alla mercanzia del 31 dicembre 1632.
18. Ivi, V Savi alla Mercanzia, I ser., reg. 150, 8 giugno 1635.
19. Per i non addetti c’erano difficoltà a distinguere gli orsogli alla bolognese dagli altri. Lo confessava l’inquisitore sopra i dazi, Vettor Contarini, a proposito del sequestro di due balle di seta lavorata: «dalle deposizioni in processo de mercanti da seta come dei filatogli, constando che siano orsogli, non s’è potuto ricavare da medemi questa cognizione, se si sano fabricati alla bolognese o no. Parendomi impossibile in periti dell’arte questa ignoranza ho voluto con informazioni a parte procurar qualche saggio a mia soddisfazione. Dicono questi esser l’orsoglio 2 cai di seda filata assieme torti. La manifattura di questa tortura farsi o con 2 rode sopra l’acqua e questi si dicono orsogli alla bolognese o con rode menate a mano e questi si dicono li orosogli ordinari che si facevano avanti l’introduzione delli edifici sopra l’acqua chiamati alla bolognese. L’orsoglio alla bolognese [...] sicome nel lavoriero il corso di quella [acqua] è continuatamente lo stesso così parimenti continuata, qualiva et seguente è la tortura dello stesso orsoglio. Dove l’orsoglio torto con le rode a mano talvolta dal moto della stessa mano più o meno veloce, può ricevere nella tortura in qualche parte alterazione, et perciò dificilissimo per non dir impossibile la cognizione di questa differenza»: ivi, Arte Seta, b. 99, fasc. 39, c. 19, 1669. In effetti, contrariamente alla descrizione dell’inquisitore, nel 1700 era elencato tra i filatoi alla bolognese l’«edificio da mano, fato già alquanti anni, condotto a forza d’uomini di Antonio Todesco» che a Valstagna dava «lavoro a un maestro oltre la sua persona; 4 putti per torcere; 3 putti che girano l’edificio; 14 putelle nell’incannatoio; 14 donne che doppiano la seda fuori dell’edificio alle loro case»: ivi, V Savi alla Mercanzia, I ser., b. 594, lettera del Capitano di Vicenza del 21 settembre 1700. Ancora nel 1731 Giuseppe e Antonio Remondini vedevano catalogato come edificio alla bolognese il filatoio da loro fatto costruire in contrada del Bastion a Bassano, «condotto a forza di bracci; di albori 2 a filar con valeghi 6 a cadaun alboro in tuti valeghi 12 con bachetti 18 per valeghi. Sono bachetti 216 e due albori da torcer sono valeghi 4 con naspi 68, con canatoggio (incannatoio) giusto il solito bisogno e tavelle 830 il tutto fabbricato a perfezion di poter lavorar e far orosogli alla bolognese»: ibid., b. 478, 25 maggio 1731.
20. Ibid., n. ser., b. 117, memoria nr. 18, pt. I, c. 18, 31 marzo 1640: «furono il 14 giugno 1578 con parte del senato permessi per due anni e nel 1583 prorogata fino a nuovo ordine. Essa ha provocato l’esterminio dell’arte dei filatori ridotti a poco numero di maestri che vanno diminuendo di giorno in giorno. Circa alli filatogi avanti il decreto 1578, 14 giugno non poteva adoperarsi altri orsogli che quelli lavorati in Venezia, né per proprio conto potevano lavorare i maestri filatogi onde li mercanti davano ad essi da lavorare. Come questa parte nacque in occasion del contagio permettendo che per anni due potessero esser introdotte sede lavorate tanto nello stato che in estero con dazio ducato per cento. E con tale decreto fu permesso agli operari il poter lavorare per proprio conto, qual facoltà fu prorogata con altra parte 1583, 3 novembre, li filatogi per godere il privilegio non fecero alcuna istanza e li mercanti traendo da ciò profitto lo lassiarono correre. Tali deliberazioni causarono che que’ filatogi che non avevano modo di lavorare per proprio conto partirono da Venezia, passando in Padova, Vicenza, Verona, Bassano, con danno de dazi quali non sono risarciti dal dazio che si ricava per intrata delli orsogli forestieri per ducati 2561». Dunque un valore degli orsogli di 85.367 ducati circa, se il dazio era ancora del 3%, e una quantità di 56.911 libbre di sete, se la stima fiscale del valore di ogni libbra era ancora di 1,5 ducati come era stato stabilito col decreto del 14 giugno 1578: ibid., I ser., b. 477, t. II, scrittura dei consoli dei mercanti del 29 settembre 1636. Il decreto del 14 giugno 1578 concedeva l’importazione di «peli filadi e sede torte» in considerazione della mancanza di molte maestre abili a trarre le sete: ivi, Senato, Terra, filza 74. Prima del 1578 esistevano a Venezia circa cinquecento mulini a mano. Tra 1578 e 1584, dopo l’ammissione degli organzini forestieri, essi si erano ridotti della metà: Carlo Poni, Piccole innovazioni e filatoi a mano: Venezia (1550-1600), in AA.VV., Studi in memoria di Luigi Dal Pane, Bologna 1982, p. 373 (pp. 371-389), che cita da A.S.V., Arte Seta, Officio della seta, filza 98, fasc. 34, 26 marzo 1584. «Acciò li orsogli di Bologna tanto necessari in questa città per la fabbrica dei panni non siano portati fuori» le sete lavorate furono aggravate di un dazio del 70% circa: A.S.V., Senato, Terra, filza 288, 17 settembre 1627, relazione dei savi del 30 giugno.
21. A.S.V., Senato, Terra, filza 836, 18 ottobre 1670 e inserte del 16 settembre 1670, scrittura dei provveditori e aggiunti alla seta Pietro Surian, Zorzi di Contenti, Piero Berlendis, Carlo Martinelli, Tomaso Mazzocco, Gian Battista Negroni, Giovan Francesco Scarpetta, Giovanni Moscheni.
22. Ivi, Arte Seta, b. 152, fasc. 208, c. 8r-v, s.d., ma scritta presumibilmente attorno al 1674, quando si dibatteva la questione del valore degli zecchini che i mercanti levantini preferivano esportare al posto delle pannine di seta.
23. Secondo le tabelle pubblicate da Richard T. Rapp, Industria e decadenza economica a Venezia nel XVII secolo, Roma 1986, pp. 86-90, i tessitori di seta nel 1672 erano millecentocinquantanove, ma secondo i dirigenti dell’ufficio della seta molto numerosi erano coloro che lavoravano in mansioni subordinate senza essere inclusi nella Corporazione. Il dato del 1673 in A.S.V., V Savi alla Mercanzia, I ser., b. 477, t. II, fasc. 18, 18 febbraio 1672 m.v., supplica testori in collegio.
24. A.S.V., Senato, Terra, filza 801, inserta del 12 settembre 1667: nella relazione degli interessati si diceva che quelli che avevano «con gravi dipendi costrutto edifici» erano cinquantasei.
25. La storia del Malpigli è nota per gli studi di Domenico Sella, Contributo alla storia delle fonti di energia: i filatoi idraulici della Valle Padana durante il sec. XVII, in AA.VV., Studi in onore di Amintore Fanfani, V, Evi moderno e contemporaneo, Milano 1962, pp. 619-631; e di Carlo Poni, Archéologie de la fabrique: la diffusion des moulins à soie «alla bolognese» dans les États vénitiens du XVIème au XVIIIème siècle, «Annales E.S.C.», 27, 1972, nr. 6, pp. 1475-1496.
26. A.S.V., Arte Seta, b. 99/99, fasc. 39, c. 16, 1654, risposta da Verona all’inchiesta dei revisori e regolatori dei dazi: «Verona può aver circa 40 padroni di filatoi la maggior parte lavorano a mercede e tutti uniti possono aver 100 molini, ma per il più vanno voti senza lavorar per mancamento di negozi e di sete. Se lavorasero di continuo fabricariano l’anno circa 100.000 libbre di seta di più di quella che nasce in questa città e territorio che può esser libbre 70-80 mila all’anno. Il territorio non ha filatoi di sorte alcuna né maestranze di seta».
27. Sulle differenze tra filatoi manuali e mulini alla bolognese cf. Carlo Poni, All’origine del sistema di fabbrica: tecnologia e organizzazione produttiva dei mulini da seta nell’Italia settentrionale (sec. XVII-XVIII), «Rivista Storica Italiana», 88, 1976, nr. 3, pp. 444-497, e Id., Piccole innovazioni e filatoi a mano. Contrariamente alla contrapposizione di due soli tipi di filatoi fatta dall’anonimo mercante inglese di seta citato da Poni nel primo saggio, la descrizione dei consoli dei mercanti rende chiaro che l’energia idraulica non era l’elemento distintivo dei filatoi alla bolognese, poiché poteva essere impiegata anche per filare in modo ordinario. Del resto negli elenchi di filatoi veneti alla bolognese del 1700 erano presenti anche filatoi manuali: cf. n. 18.
28. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, n. ser., b. 117, memoria nr. 18, pt. I, c. 28, 28 settembre 1646 su scrittura dei mercanti da seta di Venezia che propone di vietare estrazione di seta grezza.
29. Ibid., c. 2, 3 settembre 1700. Nell’elenco generale non sono registrati sette dei diciassette mulini elencati in una lettera del podestà di Vicenza tra i quali quelli dei veneziani Roberto Roberti a Le Nove, Lorenzo Grapiglia a Marostica, eredi Nicolò Contarini a Oliero e il secondo mulino degli Stroppari a Marostica: ibid., I ser., b. 594, 6 settembre 1700.
30. Ivi, Arte Seta, b. 99, fasc. 43, 20 luglio 1634, scrittura di prete Marchiò Cechini.
31. Ivi, V Savi alla Mercanzia, n. ser., b. 117. Approvarono la risposta negativa diciannove su venti. L’unico che votò contro forse fu Alberto Gozzi.
32. Ivi, Arte Seta, b. 99, fasc. 43, scrittura di Alberto Gozzi non datata.
33. Ivi, V Savi alla Mercanzia, n. ser., b. 117 e I ser., reg. 150, 27 settembre 1634, scrittura dei savi alla mercanzia per proporre misure favorevoli all’introduzione dei filatoi.
34. Cf. C. Poni, Archéologie de la fabrique, p. 1485.
35. A.S.V., Senato, Terra, filza 369, 5 gennaio 1634 m.v.
36. Ibid.
37. Ibid.
38. Ivi, V Savi alla Mercanzia, n. ser., b. 117, memoria nr. 18, pt. I, c. 18, 31 marzo 1640. Alla richiesta dei filatori di vietare l’importazione di orsogli forestieri, i savi rispondevano prudentemente che era vero che con «li orsogli forestieri» si fabbricavano «pannine bensì di bella e vaga veduta ma ad ogni modo di poca durata», ma che era pericoloso metterli al bando prima che si fosse incamminata la fabbrica degli orsogli a Venezia. Proponevano di obbligare i mercanti a dare ogni mese duemila libbre di seta all’Arte dei filatori per farne orsogli da rasi e per altre pannine. I filatori avrebbero dovuto avere nelle proprie botteghe valichi adatti a filar sia sete sottili sia sete grosse. Alla scarsità di maestre capaci di trarre le sete come in altri tempi adatte alla fabbrica degli orsogli di tipo bolognese si poteva rimediare assegnando tal sorte di lavoro alle donne ospitate nei luoghi pii.
39. Ibid., I ser., b. 575.
40. Ibid., b. 477, t. II, fasc. 14, copia di scrittura dei consoli dei mercanti del 29 settembre 1636.
41. Ibid., fasc. 2, scrittura dei consoli del 29 settembre 1636.
42. Ibid., n. ser., b. 117, memoria nr. 18, pt. I, c. 18, 31 marzo 1640.
43. I1 5 settembre 1636 G.B. Bon d’Astori s’appellava contro una sentenza dei rettori di Padova a favore dei dazieri della seta. Ibid., I ser., b. 150, 23 giugno 1635: «G.B. Bon e fratelli mercanti si sono ritirati e sottopretesto di dote e fideicommessi hanno coperto tutti li suoi beni avendo un debito di 7.888 reali con un mercante turco».
44. Ibid., n. ser., b. 117, 20 ottobre 1637, copia di contratto rogato da Claudio Paolini qm. Nicola, notaio veneto, in solido con Benedetto Lurano, Alvise Balbi e Francesco Bollani giudici dell’esaminador.
45. Ibid., memoria nr. 18, pt. I: a c. 25, 19 gennaio 1643 m.v., ingiunzione ai rettori di Padova di far godere al filatoio in contrà Pellatieri di Padova i privilegi stabiliti nel 1634, tanto più che era stato anche migliorato e restaurato, e in esso si fabbricavano orsogli anche con operai bolognesi; a c. 26, 18 marzo 1644, i savi alla mercanzia intimano a Iseppo dall’Abbaco che «atteso l’accordato in scrittura e contratto tra lui e mons. Marchiò Cechini, dobiate in 3 giorni incamminar l’edificio da seta in Padova in contrà Pellatieri con la necessaria maestranza» come nella scrittura del 25 febbraio 1643 m.v.
46. Ivi, Collegio, Risposte di dentro, filza 35, 22 giugno 1644. Il Cechini si arrogava il merito di aver fatto edificare da Ottavio Malpigli a Padova nel 1604 il primo mulino alla bolognese e in riguardo «delli danni e spese immense» da lui patite «per l’introduzione di questo primo esemplar», «vedendosi sino il giorno di oggi l’effigie di chi l’ha fabbricato appesa con un piede in su nella piazza pubblica di Bologna», chiedeva una provvigione mensile a favore della sua povera e numerosa famiglia.
47. Cf. Antonio Cambruzzi, Storia di Feltre, III, Feltre 1886, p. 304: «Fu quest’arte trasportata molti anni orsono da Bologna in Feltre e ne’ primi anni gli artefici di questa erano tutti bolognesi». Gigi Corazzol ha messo in luce che la tradizione a cui si richiamava nel 1681 il Cambruzzi è esatta. Devo alla sua amichevole generosità tutte le informazioni e i riferimenti archivistici relativi alla famiglia Fontana e alle vicende dei loro mulini feltrini. Gliene sono grato cordialmente. Le ricerche del Corazzol hanno appurato la sicura presenza del bolognese Benedetto Fontana a Feltre già dal 1597: tale data porterebbe a riscrivere la storia dell’introduzione del segreto tecnologico dei mulini da seta alla bolognese nello stato veneziano finora legata al solo nome del Malpigli e alla data del 1604. Ciò pretendevano di fare i discendenti Fontana: A.S.V., Collegio, Risposte di dentro, filza 30, 16 marzo 1639.
48. Belluno, Archivio di Stato, Notarile, Atti, b. 1873, cc. 4v-5, 30 gennaio 1636.
49. Ibid., b. 6650, cc. 58-59v, 24 maggio 1642.
50. A.S.V., Collegio, Risposte di dentro, filza 35, 12 aprile 1644.
51. Ibid.
52. Belluno, Archivio di Stato, Notarile, Atti, b. 6650, cc. 72-74v.
53. A.S.V., Collegio, Risposte di dentro, filza 30, 16 marzo 1639.
54. Ivi, Senato, Terra, filza 435, proroga del 7 luglio 1640 e 15 ottobre 1647.
55. Ibid., 7 luglio 1640.
56. Ivi, V Savi alla Mercanzia, n. ser., b. 117, memoria nr. 18, pt. I, c. 18, 31 marzo 1640. I savi rilevavano che erano tre i tipi di seta tratta nello stato: la prima, sottile, serviva per gli orsogli ed essi erano per la maggior parte esportati verso il Bolognese ed il Ferrarese; le mezzane si lavoravano in gran quantità a Rovereto dove si erano introdotti moltissimi molini a danno della filatura veronese; le sete grosse servivano per la passamaneria. Secondo tale informazione era, dunque, scarsa la quantità di seta lavorata nello stato veneziano.
57. Ibid., c. 23, 14 settembre 1643.
58. Ibid.: alla «opportunità» della «congiuntura dei presenti tempi» faceva riferimento, secondo il parere dei savi, anche il progetto dall’Abbaco di impiantare mulini da seta a Venezia «con l’aiuto di un compagno di stato alieno» previa la concessione di due fondi o case, le esenzioni fiscali, e un prestito di 10.000 ducati di banco da restituire in undici anni.
59. Ivi, Collegio, Risposte di dentro, filza 35, 12 aprile 1644.
6o. Ibid., 18 marzo 1644. Furono anche esentati dal pagamento delle gravezze «de mandato domini», secondo la loro richiesta: ivi, V Savi alla Mercanzia, n. ser., b. 117, memoria nr. 18, pt. I, c. 27, 18 giugno 1644.
61. Ibid., c. 28, 28 settembre 1646.
62. Già il Cechini e i soci Sandi e Poleni avevano proposto il divieto nel 1644 con lo scopo di aggiungere anche il vantaggio della riserva del mercato della seta greggia a quelli della congiuntura e delle agevolazioni già decretate.
63. A.S.V., Arte Seta, b. 99, fasc. 39, cc. 10 e 14, 1654, memoriale dell’officio della seta ai savi alla mercanzia sopra le sede nostrane; e fasc. 40, c. 2, 29 aprile 1654, supplica dell’officio per chiedere divieto esportazione di seta grezza nostrana. Ibid., fasc. 39, c. 15, copia di parte del senato del 18 luglio 1654 in risposta alla supplica dell’officio della seta: conteneva commissioni ai savi alla mercanzia e ai revisori, ai regolatori dei dazi e ai provveditori di comun, affinché informassero circa la riuscita degli edifici per orsogli e se «proibir l’estrazione delle sede nostrane o almeno accrescer il dazio sia utile».
64. Ibid., fasc. 44, 14 settembre 1668: risposta ai savi alla mercanzia circa la richiesta di licenza di esportazione.
65. Per il primo prezzo: ivi, V Savi alla Mercanzia, I ser., b. 477, t. II, fasc. 2, scrittura dei consoli, 29 settembre 1636; per il secondo: ivi, Senato, Terra, filza 836, 18 ottobre 1670 e inserte.
66. Ivi, Arte Seta, b. 99, fasc. 44, 23 settembre 1665, copia della supplica di Roberto Roberti, Giacomo Zanchetta e Giovanni Passalacqua per ottenere permesso di esportare annualmente dieci balle di orsogli: «tra quelli che hanno costruiti simil edifici vi è il nh Gerolamo Capello che ne ha affittato uno a me Roberto Roberti, un altro ne possede il nh Pietro Memo per le ragioni della nd Lugrezia da Molin sua moglie, tenuto ad affitto da me Giacomo Zanchetta et uno di ragione di me Z. Passalacqua».
67. Ivi, Senato, Terra, filza 801, 14 novembre 1668, risposta inserta del 26 marzo 1666.
68. Ibid. e 20 maggio 1667: «la fabbrica di ogni qualità di pannine è stata introdotta nel Levante in Scio, Salonicco, Bursia, Aleppo, Damasco e altrove. In Ponente nella Spagna, nella Fiandra, nell’Inghilterra e fino con le flotte dell’Indie vien portata drapperia di seta. La Francia ancor essa ne fabbrica grandissima quantità ove una volta questa città serviva tutti li suddetti paesi. In Italia in Fiorenza, Bologna, Lucca, Genova, Milano, Napoli, Rovere di Trento et altri lochi se ne fabrica quantità infinita. In Terraferma contro i decreti del senato, a Padova, Verona, Vicenza, Brescia, Bergamo ed altri lochi. Tutti li sudetti lochi ponno vender le loro pannine a molto minor prezzo di quello possiamo far noi, non tanto per il costo della seta, quanto per li prezzi più rigorosi che pratichiamo con le maestranze per le cause benissimo note all’Eccellenze Vostre, non potendosi ridurre un panno a perfezione che non passi per 16 mani, da che ne deriva che non possiamo noi concorrere con li prezzi delle pannine loro».
69. Ibid., inserte 31 marzo e 12 settembre 1667.
70. Ibid., filza 836, 18 ottobre 1670 e inserte. Concessione dell’esportazione il 20 agosto 1670: scrittura degli interessati negli edifici degli orsogli alla bolognese. In effetti in quegli anni tirava brutta aria per i produttori di pannine. Già dal 1666 si segnalava che le pannine veneziane di qualità erano insidiate dalla concorrenza di cattive pannine fabbricate in Terraferma specie a Vicenza, dalle pannine fabbricate con oro e argento falsi, dall’esportazione furtiva di orsogli e dalla preferenza che i mercanti levantini avevano ormai a portar via gli zecchini piuttosto che comprar pannine: ivi, Arte Seta, b. 152, fasc. 219, c. 21, 21 gennaio 1666 m.v., e fasc. 209, settembre 1673 con riferimenti a denunce del 1666. Negli anni seguenti la congiuntura si appesantì per i panni di seta: «Essendo benissimo nota a tutti la scarsezza grande del negozio, come del lavoriero che a’ tempi presenti si pratica nell’arte nostra della seda [...]», scrivevano i mercanti nel gennaio 1672. Ibid., c. 34, 9 gennaio 1672. Dalla crisi il settore uscì quando furono adottati tipi di tessuti più leggeri e senza cimosa, diversi da quelli della regolamentazione corporativa che risaliva al 1612. Nel 1681 i tessitori erano contenti della ripresa: ibid., c. 51r-v, 19 giugno 1681. A parere dei tessitori detti «mezadi» (dotati di sei telai e capaci di lavorare con due di essi per conto proprio) «l’arte notabilmente migliorò dopo il giudizio 1677 mentre nell’anno 1681 i mercanti fabbricarono tele n. 8.302 e li testori n. 2.335, potendo vantar d’aver pareggiati li mercanti negli anni 1690, 1691, 1692»: ivi, V Savi alla Mercanzia, I ser., b. 477, t. III, fasc. 2, scrittura 4 giugno 1703.
71. Ibid., n. ser., b. 117, memoria nr. 18, pt. II, 24 maggio e 11 giugno 1698, e b. 118, 20 dicembre 1714: prima due savi alla mercanzia, poi i regolatori delle entrate pubbliche tentarono di modificare il regime di esenzione di cui beneficiavano gli orsogli esportati, ma tali tentativi furono avversati dal senato.
72. Nel 1698 si calcolava che per la fabbrica di circa cinquemila panni di seta (comprendenti «lavori piani e lavori alti») si consumassero circa venticinquemila libbre di orsogli: ivi, Senato, Terra, filza 1239, 21 giugno 1698. Negli ultimi anni la media annua di orsogli esportati ammontava a cinquantamila libbre. Poiché la capacità produttiva della cinquantina di mulini delle aree orientali era molto maggiore di ottantacinquemila libbre, si deve presumere che una parte degli organzini era esportata senza le licenze dei savi e un’altra parte era usata nelle manifatture di Terraferma. Nel 1700 la quindicina di mulini del Vicentino smerciava quarantamila libbre di seta mediamente: ivi, V Savi alla Mercanzia, I ser., b. 594, lettera del capitano di Vicenza del 6 settembre 1700.
73. Ibid., b. 478, registro terminazioni delle licenze rilasciate agli esportatori.
74. Ibid., n. ser., b. 117, memoria nr. 18, pt. II, c. 8, 16 gennaio 1705 m.v., contro le pretese dei dazieri.
75. Nel 1651 Andrea Tasca fondò il primo filatoio nel Bergamasco: cf. Carlo Poni, Misura contro misura: come il filo di seta divenne sottile e rotondo, «Quaderni Storici», n. ser., 16, 1981, p. 416 (pp. 385-422). Ma nel Bergamasco diffusione e concentrazione dei mulini a ruota idraulica che lavoravano alla bolognese (mancanti, però, dell’incannatoio) avvennero a partire dal 1670: cf. Id., All’origine del sistema di fabbrica, p. 472. Nel 1654 nel Veronese non esistevano filatoi di nessuna sorte e quelli presenti a Verona erano un centinaio di molini ordinari che appartenevano a una quarantina di padroni usi a lavorare «a mercede», ma quasi sempre mancanti di commissioni e di sete. La seta grezza prodotta nel territorio ammontava a settanta-ottantamila libbre all’anno: A.S.V., Arte Seta, b. 99, fasc. 39, c. 16.
76. Ibid., b. 152, fasc. 220, c. 17, 4 settembre 1711.
77. Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, a cura di Amelio Tagliaferri, II, Podestaria e Capitanato di Feltre, Milano 1974, relazione di Vincenzo da Riva del 15 maggio 1702, p. 446. Il Cambruzzi da testimone oculare così li esaltava descrivendo la Feltre del 1677: sulla rosta derivante dal Colmeda «vi sono alcuni filatoi di seta, edifici belli e sontuosi. [...] Si fanno sete squisitissime in grandissima quantità, essendovi molti nobili e sontuosi edifici per il lavoro delle medesime, che in tutta copia si fanno e agevolmente si trasmettono in Francia, in Inghilterra e in altre principali città dell’Europa. [...] Ed è tanto accresciuta questa professione di artefici e di edifici, che ne è ripiena tutta la città» (Storia di Feltre, pp. 300 e 304).
78. Cf. Ottone Brentari, Storia di Bassano e del suo territorio, Bassano 1884, pp. 514-515.
79. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, I ser., b. 575, notifiche inserte in lettera del 15 settembre 1700. Nel mulino da seta di Orazio Dolce, sito a Rossano, lavoravano nove specializzati nella filatura, due garzoni, ventidue fanciulli e fanciulle, venti maestri doppiatori; in quello gestito dagli eredi Carrara sedici erano i filatori, ventisette i fanciulli e fanciulle, trentadue i maestri doppiatori.
80. Ibid., 19 febbraio 1708 m.v.
81. Ibid., n. ser., b. 117, memoria nr. 18, pt. II, 16 dicembre 1670.
82. Ibid., I ser., b. 575, lettera del podestà di Bassano, Girolamo Barbaro, del 19 febbraio 1708 m.v.
83. Ivi, Senato, Terra, filza 932, 18 luglio 1676, citato da C. Poni, All’origine del sistema di fabbrica, p. 459.
84. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, n. ser., b. 118, scrittura dei Revisori e regolatori delle entrate pubbliche in zecca del 20 dicembre 1714.
85. «S’estraggono da Venezia le sede per ridurle negli edifici in orsogli»: ibid., b. 117, memoria nr. 18, pt. II c. 8, 16 gennaio 1705.
86. Ibid., I ser., b. 594, lettera del podestà di Vicenza Antonio Michiel del 7 aprile 1726. Riferisce sulla produzione di seta grezza nel Vicentino in risposta a richieste dei savi alla mercanzia del 30 marzo.
87. Ivi, Arte Seta, b. 152, fasc. 202, C. 40, 13 maggio 1675. La lamentela contro i lavori di Terraferma era stata elaborata già nel 1668: «S’è andato introducendo il lavoro de panni nelle città suddite e particolar in Vicenza, a segno tale che al presente lavorano anco delle più principali qualità di pannine che sono tabini alti e bassi da parangon, damaschi e veludi d’ogni qualità e sino delli lavori con orsogli onde che lavorano summa rilevante di telleri, si ché ha fatto e va facendo molto accrescere in detti lochi il detto lavoriero et all’incontro molto scemare in Venezia»: ibid., fasc. 209, allegato del 18 ottobre 1668 a risposte del settembre 1673.
88. Nel 1714 fu data libertà di lavori con i telai per seta: ivi, V Savi alla Mercanzia, Diversorum, b. 348.
89. Ivi, Arte Seta, b. 99, fasc. 39, c. 17, 8 giugno 1654: supplica del daziere di Treviso contro i «nobili veneti» e «altri che spendono il loro nome nel far trazer seda». Sollecitava provvedimenti punitivi contro coloro che non denunciavano l’esatta quantità di seta lavorata.
90. Ivi, V Savi alla Mercanzia, n. ser., b. 117, memoria nr. 18, pt. II, c. 70, 1717. La memoria sostiene che a differenza che per altre manifatture venete ormai andate in disuso, per gli orsogli «a motivo della loro perfezione si va sostenendo il loro credito presso degli esteri» pure se in quel momento la congiuntura è poco favorevole. Una supplica della città di Verona, che nel 1650 lamentava come l’appesantimento fiscale avesse rovinato il setificio veronese, metteva in rilievo che «il contadino [...] volentieri impiegava le sue fatiche per cavar seta, primo raccolto che poteva giovarli ne’ mesi più difficoltosi al proprio vitto»: ivi, Senato, Terra, filza 554, 7 giugno 1650, supplica inserta.
91. Ivi, Arte Seta, b. 99, fasc. 39, c. 14; fasc. 40, c. 2, 29 aprile 1654 e fasc. 45, c. 14, 12 novembre 1655.
92. Ibid., c. 24. Alla supplica si oppose il nunzio della comunità di Bassano. Cf. Gabriele Lombardini, Pane e denaro a Bassano tra il 1501 e il 1799, Vicenza 1963, p. 16. Circa il divieto di esportazione sia nella supplica dei Bassanesi sia in altre è ricorrente il riferimento al divieto di esportazione che il governo aveva comminato alle sete grezze del Vicentino e del Veronese il 19 aprile 1651 (A.S.V., Senato, Terra, filza 654). In effetti il provvedimento aveva prodotto effetti perversi, denunciava il rettore di Vicenza, Tommaso Pisani, nel 1656: «Rimirò la pubblica provvidenza a divertir l’ampliato negotio di Roveredo. Asseriscono che l’evento non abbi corrisposto a sì provido fine, mentre sin allora di gran lunga abbondava più il concorso delle sede a Vicenza etiandio della stessa terra di Roveredo, che mercanti forestieri di Germania volevano grezze per lavorarle ne’ propri paesi [...] non punto essendosi accresciuti li fillatoi di Vicenza». Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, a cura di Amelio Tagliaferri, VII, Podestaria e Capitano di Vicenza, Milano 1976, p. 424.
93. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, n. ser., b. 117, memoria nr. 18, pt. I, c. 44, 16 giugno e 7 luglio 1665: i savi annullarono la sentenza e il proclama del podestà di Treviso favorevole al governatore del dazio contro i padroni di edifici da orsogli alla bolognese; ibid., pt. II, c. 8, 16 gennaio 1705 m.v. e 16 dicembre 1710: i savi si opposero alle pretese dei dazieri di Vicenza.
94. Ibid., pt. II, c. 2, 3 settembre 1700.
95. Ibid., I ser., b. 594, lettera del capitano di Vicenza del 21 settembre 1700. Anche il nobile Contarini aveva affidato la direzione dei suoi mulini a Piazzola al direttore Giuseppe Zanoni: cf. C. Poni, All’origine del sistema di fabbrica, p. 468.
96. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, I ser., b. 594, allegato a lettera del podestà di Vicenza del 7 aprile 1726.
97. I loro nomi compaiono tra i ventitré mercanti registrati ivi, Arte Seta, b. 152, reg. 2 10, 1666. Giovanni Passalacqua era fra i tre postulanti che chiesero nel 1665 la licenza di esportare orsogli; Marco Stroppari ottenne l’investitura per un edificio idraulico a Marostica nel 1676 (ivi, Provveditori sopra beni inculti, b. 274, 20 dicembre 1676) e ne costruì un secondo entro il 1700 (ivi, V Savi alla Mercanzia, I ser., b. 594, lettera del capitano di Vicenza del 6 settembre 1700).
98. Ibid., b. 581, lettera del podestà di Feltre del 10 settembre 1700. Solo metà del mulino Bergonzi era tenuto in esercizio dal Cefis.
99. Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, II, Podestaria e Capitanato di Feltre, relazione di Vincenzo da Riva del 15 maggio 1702, p. 446. Il relatore rimarcava che negli ultimi diciassette anni i filatoi feltrini s’erano ridotti a due e ne ipotizzava la ragione nella moltiplicazione di filatoi nel Trevigiano che avevano attirato le maestranze feltrine.
100. A.S.V., Provveditori sopra beni inculti, Relazioni dei periti, b. 279, c. 90. La quantità di acqua necessaria era di 4 quadretti.
101. Ivi, V Savi alla Mercanzia, I ser., b. 478, registro terminazioni di concessioni di esportazioni. La prima apparizione è quella di Marco Contarini nel 1673, primo anno dopo le esenzioni daziarie, quando esportò millecinquecentocinquanta libbre a Londra e oltremonti. Altre attività di esportazioni di patrizi si segnalano dal 1680 in poi. Dapprima fu Lugrezia Molin per quattro partite di trecentocinquanta libbre ciascuna, poi Giacomo Angaran per millequattrocento libbre nel 1681. Nel 1684 si inserì Giovanni Capello con una partita di millequattrocento libbre, portate a duemila l’anno seguente. Nel 1686 a loro si affiancò Giovanni Benzon con una partita di tremilacinquecento libbre, mentre Marco Andrea Zambelli continuava l’attività esportativa importante anche dopo l’aggregazione alla nobiltà. Poi nel 1691 parteciparono al profitto dell’esportazione Pietro Emo con duemila libbre e Pietro e Andrea Capello Morosini che negli anni 1691, 1692, 1693, 1695 chiesero concessioni per partite di diecimila libbre ogni anno. Che Venezia fosse il centro delle operazioni mercantili si evince anche dalla lettera del podestà di Bassano che nel 1700 dichiarava di non poter dare informazioni sulle sete immagazzinate «essendo la maggior parte di questi mercanti fuori del Paese e respettivamente in Venezia»: ibid., b. 575, 19 gennaio 1699 m.v.
102. Ibid., n. ser., b. 118, 20 dicembre 1714.
103. Cf. Bernard Aikema, Nicolò Bambini e Giambattista Tiepolo nel salone di palazzo Sandi a Venezia, «Arte Veneta», 41, 1987, pp. 147-154.
104. A.S.V., Provveditori sopra beni inculti, Investiture, b. 396.
105. Ivi, V Savi alla Mercanzia, I ser., b. 594.
106. Cf. Ivo Mattozzi, Un processo di accumulazione manifatturiero: le cartiere di Ceneda nel primo Seicento, «Studi Trevisani», 7, 1988, pp. 105-129.
107. A.S.V., Collegio, Risposte di dentro, filza 35, 2 settembre 1644. Alvise Mocenigo I e II fu Tomà chiedevano la licenza di taglio per «200 tolpi e 25 roveri per far mazzi, stanghe, banchette, passi, cadene, fusi, carieghe, ripade, setoli, mari et parte delli torcoli» necessari alla ricostruzione.
108. Treviso, Archivio di Stato, Notarile, I, Atti, b. 1468, 17 ottobre 1643: la «sovenzione» al maestro cartaio consisteva di 2.000 ducati. Ibid., b. 1783, 30 maggio 1665: contratto con Giacomo Bressanin, da cui è tratta la citazione.
109. Nel 1652 gestiva l’attività V. Bertoli di Ceneda: Venezia, Museo Correr, P.D.C. 2486/XIII, 30 maggio 1665. Dal 1666 era affittata per 10 anni a Francesco Bozzon originario di Riva di Trento e proveniente da Segusino, precedentemente era stata gestita dalla famiglia ebraica Isach Grassini di Ceneda: Treviso, Archivio di Stato, Notarile, I, Atti, b. 1783, prot. 2, cc. 152-157v.
110. Cf. Gino Benzoni, Contarini, Carlo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XXVIII, Roma 1983, p. 131 (pp. 129-132).
111. Cf. I. Mattozzi, Un processo di accumulazione manifatturiero, specie pp. 119-120.
112. Treviso, Archivio di Stato, Notarile, I, Atti, b. 1463, prot. 38, cc. 122v-123v, 14 luglio 1637.
113. Nel 1665 egli finanziò la costruzione di un ponte sul Meschio insieme con Margherita Rizzardi, proprietaria di un’altra cartiera: ibid., b. 1783, prot. 2, c. 22, 20 luglio 1665.
114. Ibid., b. 1795, prot. 1, 12 maggio 1677.
115. Ibid.
116. La cartiera era data in locazione a Paolo Chemin, cartaro di Campese, il 18 marzo 1649: A.S.V., Provveditori sopra beni inculti, Investiture, b. 400; cf. Franco Signori, Campese e il monastero di S. Croce, Cittadella 1981, p. 183.
117. A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 26, inserta nella supplica di F. Martini del 10 novembre 1790, e Provveditori sopra beni inculti, b. 390.
118. Ivi, Dieci Savi alle decime, Condizioni di S. Croce, filza 326, nr. 375; Provveditori sopra beni inculti, Investiture, b. 396; Aggiunti alla provvisione del denaro pubblico in Zecca, b. 684: stampe in causa.
119. Ecco alcuni esempi: nel 1649 Alvise Sagredo stipulava un nuovo contratto per la sua cartiera sul Rai (Belluno) con il cartaro salodiano Vincenzo Bertoli, che lasciava la cartiera Mocenigo. Per attirarlo egli si impegnò sia a mettere a punto l’edificio, sostenendo le spese di vari lavori, sia a prestare al fabbricante 600 ducati da restituire alla fine dell’affittanza; tale contratto fu prolungato con i fratelli Bressanin fino al 1668, quando Alvise avviò una lite per ottenere il pagamento dei debiti dai maestri cartai: Venezia, Museo Correr, P.D.C. 2486/XIII. Nel 1644 e 1646 i fratelli Giambattista e Alessandro Beregan chiesero investitura per due cartiere a Sarcedo (A.S.V., Provveditori sopra beni inculti, Catastico Vicenza, cc. 148v e 161). La cartiera effettivamente fondata con tre ruote passò ai Giusto nel 1654 (ibid., Investiture, b. 397) che la ingrandirono di una ruota nel 1694: ivi, Patroni e provveditori all’Arsenale, Catastico, c. 97v, e Provveditori sopra beni inculti, Catastico Treviso, c. 444v. Nel 1708 Marco Gradenigo qm. Piero volle aggiungere una ruota alla cartiera di tre ruote a Carbonera e pagò la concessione 50 ducati (ibid., c. 489).
120. Ibid., Processi, b. 69, fasc. 53.
121. Ibid., b. 4. La cartiera fu acquistata all’incanto per 2.770 ducati.
122. Treviso, Archivio di Stato, Notarile, I, Atti, b. 1492, prot. 35, c. 94, 9 giugno 1635.
123. Ibid., b. 1463, prot. 38, cc. 85, 11 maggio 1637, e 164v, 2 ottobre 1637; prot. 40, cc. 60 ss., 3 aprile 1639; b. 1467, prot. 42, cc. 108-111v, 29 giugno 1640.
124. Ibid., b. 1466, prot. 52, cc. 92-93, 4 maggio 1650.
125. Brescia, Archivio di Stato, Notarile, Atti, filza 852, 9 maggio 1702.
126. Ibid., filza 1498, 19 settembre 1731.
127. Nella Valle del Toscolano nei due o tre decenni seguenti alla peste si verificò una smobilitazione consistente di impianti. Ma nel secondo Seicento si mise in moto una ripresa progressiva: non furono ripristinate le centocinquanta/centosessanta ruote dei primi decenni del secolo (pari a sessanta/settanta cartiere e settanta/ottanta tini) ma fu recuperata oltre la metà degli impianti. Inoltre il rapporto tra numero di ruote e numero di cartiere fa pensare che una delle reazioni alla crisi fosse consistita nel potenziamento delle singole cartiere, sicché è probabile che la capacità produttiva fosse recuperata più di quanto faccia supporre il solo raffronto del numero delle ruote. Possiamo dunque immaginare una curva della capacità produttiva, che dopo essersi infossata dal 1631 agli anni Cinquanta riprende quota progressivamente per raggiungere livelli che rimarranno costanti fino al terzo decennio del Settecento.
128. Verona, Archivio di Stato, Comune, Processi, b. 154, nr. 1470.
129. Cf. Ivo Mattozzi, «Mondo del libro» e decadenza a Venezia (1570-1730), «Quaderni Storici», n. ser., 24, 1989, pp. 743-786; Tiziana Pesenti, Stampatori e letterati nell’industria editoriale a Venezia e in Terraferma, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 4/I, Il Seicento, Vicenza 1983, pp. 93-129; sulla ripresa vigorosa dell’editoria veneziana nei primi decenni del Settecento, cf. Mario Infelise, L’editoria veneziana nel Settecento, Milano 1989.
130. Cf. Raffaello Vergani, Tecnologia e organizzazione del lavoro nell’industria veneta del rame (secoli XVI-XVIII), in Forme ed evoluzione del lavoro in Europa: XIII-XVIII secc., a cura di Annalisa Guarducci, Firenze 1984, p. 616 (pp. 615-632).
131. A.S.V., Notarile, Atti, b. 8809, nr. 27.
132. Fin dal Cinquecento i Sagredo si erano segnalati per le loro attività di affitto di boschi, di costruzione di segherie, di commercio del legname del Cadore dove era attiva anche la famiglia Pasqualigo: cf. M. Knapton, Tra dominante e dominio (1517-1630), p. 454. Alvise Sagredo prima di essere nominato come ambasciatore a Torino (1662) e a Parigi (1665) s’era trasferito per una dozzina d’anni in Cadore a sovraintendere allo sfruttamento della tratta dei legnami che scendevano dalle Alpi tedesche nel Friuli: Relazione dell’anonimo (1659-1665), in Pompeo G. Molmenti, Curiosità veneziane, Bologna 1919, p. 440.
133. Venezia, Museo Correr, P.D.C. 2451/2, cc. 1-3, 26 ottobre 1680 e 23 settembre 1701.
134. A.S.V., Provveditori sopra beni inculti, b. 661, 11 febbraio 1682 m.v.
135. Cf. Franco Signori, Valstagna e la destra del Brenta, Cittadella 1981, p. 173.
136. Cf. Id., Campese e il monastero di S. Croce, p. 183.
137. A.S.V., Provveditori sopra beni inculti, Processi, b. 44, riferimento al decreto del senato del 23 giugno 1689. La cartiera era progettata con quattro ruote.
138. Ibid., Investiture, b. 690, 26 settembre 1739: fa riferimento alla concessione del 1676.
139. Ibid., Catastico Treviso, c. 444.
140. Ibid., Investiture, b. 386; furono richiesti 200 ducati dal fisco.
141. Ibid., b. 390.
142. Ibid., c. 465; furono richiesti 118 ducati dal fisco.
143. Domenico ed Ottaviano, tra cinque figli di Alessandro, si distinguono per il loro appassionato orientamento verso l’investimento manifatturiero ed Ottaviano lo rivendica contro le pretese spartitorie degli eredi del fratello Lorenzo: «Quanto poi alla cartera nova fatta da me in loco del battirame stato per tanti e tanti anni inutile, e ciò con gran mio dispendio, cura et applicazione, li dico che quando mi risarciranno delle dette spese [...]»: Treviso, Biblioteca Civica «Bailo», Stampe in causa, 26 marzo 1709, p. 10.
144. Un indizio della estensione degli interessi di Veneziani, aristocratici e borghesi, nelle intraprese produttive in Terraferma è il numero di ottocentocinquantadue «botteghe» (termine generico comprensivo, oltre che di case con botteghe, di opifici idraulici e di ogni altro edificio da lavoro) registrato da Giuseppe Gullino grazie allo spoglio delle condizioni di decima del 1661 per i soli tre sestieri di S. Marco, Cannaregio e S. Croce: cf. Giuseppe Gullino, Quando il mercante costruì la villa: le proprietà dei Veneziani nella Terraferma, in Storia di Venezia, VI, Dal Rinascimento al Barocco, a cura di Gaetano Cozzi - Paolo Prodi, Roma 1994, pp. 875-924, specie le tabelle a pp. 920-921.
145. La tendenza interpretativa è riassunta da Peter Burke, Venice and Amsterdam. A Study of Seventeenth Centufy Elites, London 1974 (trad. it. Venezia e Amsterdam. Una storia comparata delle élites del XVII secolo, Ancona-Bologna 1988), pp. 101-112. Le revisioni di tali interpretazioni sono in corso specie per quel che riguarda l’aristocrazia e le sue attività imprenditoriali nella gestione della terra e dei suoi prodotti e nella mercatura: cf. Giuseppe Gullino, I patrizi veneziani e la mercatura negli ultimi tre secoli della Repubblica, in Mercanti e vita economica nella Repubblica veneta, a cura di Giorgio Borelli, Verona 1985, pp. 403-451; Salvatore Ciriacono, Acque e agricoltura. Venezia, l’Olanda e la bonifica europea in età moderna, Milano 1994, specie alle pp. 89-117: le tre tabelle sulle investiture d’acque alle pp. 96-98 contengono anche utili dati sulle concessioni d’acqua per edifici idraulici, che però sono carenti specie per il Padovano, il Trevigiano e il Friulano, territori per i quali dal 1605 al 1700 compaiono rare concessioni per cartiere, filatoi e altri opifici contrariamente ai risultati delle ricerche qui sfruttate. Per il settore manifatturiero cf. I. Mattozzi, Un processo di accumulazione manifatturiero e Id., Investimenti aristocratici nelle cartiere venete: che ruolo nella espansione produttiva?, in Produzione e commercio della carta e del libro. Secc. XIII-XVIII, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze 1992, pp. 269-278.
146. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, a cura di Denis Diderot, Paris 1751-1787.
147. Le cartiere erano più soggette di altri edifici idraulici a riparazioni periodiche. Lo mettevano in evidenza spesso i proprietari. Ad esempio, Giovan Battista Grossi, proprietario di cartiere nel Vicentino, confrontando cartiere e seghe asseriva: nelle cartiere «ci va gran ferramenti e legnami e ogn’anno bisogna farli accomodare due volte all’anno e li van circa 60 ducati per ogni volta e per ogni cartiera. Si avverte che le seghe si acconciano una volta all’anno e li va ducati 15 in 20 per volta»: Vicenza, Archivio di Stato, Estimo, b. 2458, 1640, citato da Liliana Contin in Angelo Colla e collaboratori, Tipografi, editori e librai, in Storia di Vicenza, III/2, L’età della Repubblica veneta (1404-1797), a cura di Franco Barbieri - Paolo Preto, Vicenza 1990, p. 134 (pp. 109-162). Un preventivo su «quello vi vole a far lavorare una cartera con 2 ruode per la carta bianca e nera» calcolava che «per fruo dell’edificio di ferramenta e legname» occorressero 2 lire e mezzo al giorno, cioè 147 ducati all’anno: Venezia, Museo Correr, P.D.C. 2539, reg. 14, carta sciolta s.d., ma presumo seicentesca.
148. Ad esempio, nella società tra il mercante Andrea Cristini e Domenico Fontana per la produzione di orsogli, il primo, il capitalista, forniva la seta grezza o i bozzoli e dava, inoltre, 1 ducato per ogni libbra di seta da lavorare a conto delle spese per l’edificio e di salari delle maestranze: Belluno, Archivio di Stato, Notarile, Atti, b. 6650, cc. 60v-65v, 19 agosto 1638. Dunque, se il mulino lavorava tremila libbre di seta, occorrevano 3.000 ducati solo per le spese correnti di fabbricazione a cui doveva aggiungersi il costo per la seta grezza o per i bozzoli.
149. A.S.V., Provveditori sopra beni inculti, Processi, b. 58, copia della contabilità relativa all’affittuale Iseppo Abbondio per gli anni 1692-1695 allegata al dossier del 22 agosto 1804. I canoni di affitto erano così distinti: 300 ducati per i due magli da rame, 70 ducati per il maglio da ferro e 200 ducati per la cartiera. C. Poni ha notato «che il capitale (nella forma del capitale commerciale) non è più in rapporto estrinseco con il modo di produzione, ma tende a impadronirsene, ingigantendo con forti investimenti le dimensioni delle aziende» (All’origine del sistema di fabbrica, p. 469). Lo studio delle manifatture venete permette di aggiungere che a tale risultato concorrevano il capitale investito negli immobili e quello creditizio sia di aristocratici sia di borghesi.
150. I conti riguardano Giorgio Corner e Gerolamo Corner di S. Tomà, che aveva un mulino di 4 ruote a Casier (Treviso), per il quale il mugnaio pagava 500 ducati: Venezia, Museo Correr, Morosini Grimani, 513/V/fasc. 21, 15 dicembre 1685.
151. Ibid., fasc. 11, 9, 13 e 19 gennaio 1688 m.v.
152. Cf. Carlo Livi - Domenico Sella - Ugo Tucci, Un problème d’histoire: la décadence économique de Venise, in AA.VV., Aspetti e cause della decadenza economica veneziana del secolo XVII, Venezia-Roma 1961, pp. 289-317.
153. Cf. Fernand Braudel - Pierre Jeannin - Jean Meuvret - Ruggiero Romano, Le déclin de Venise au XVIIème siècle, ibid., le citazioni alle pp. 80-85 (pp. 23-85). Già nel 1627 i savi alla mercanzia riconoscevano che le sete di Siria «non si lavorano in questa città rispetto al suo peso e gran valore et la più parte esser grosse, lavorando questi mercanti le sede paesane, messinesi et di Morea, di manco prezzo, più sotili et proporzionate et utili al loro negozio»: A.S.V., Senato, Terra, filza 288, 15 settembre 1627, relazione dei savi Paolo Basadonna, Pietro Foscari, Andrea Dolfin del 30 giugno. Georgelin ha periodizzato l’andamento del traffico commerciale sulla base dei dati delle cinque dogane veneziane ed ha messo in rilievo la contrazione mercantile dei cinque decenni dopo il 1625 e la ripresa dell’ultimo quarto del secolo. Ma bisogna fare la tara ai dati della «entrata da terra» e della «uscita» poiché le due dogane non registravano più, dopo le esenzioni del 1635, né le sete destinate ai mulini da seta alla bolognese, né gli orsogli alla bolognese. Cf. Jean Georgelin, Venise au siècle des lumières, Paris-La Haye 1978, pp. 57-72.
154. Sul rapporto tra economia della Dominante ed economie delle province si sofferma il saggio di M. Knapton, Tra dominante e dominio (1517-1630), specie pp. 449-458.
155. Cf. D. Sella, Commerci e industrie, pp. 86-90. Nel 1636 i consoli dei mercanti delineavano il seguente andamento: «Circa la qualità delle sete dello stato se ne fabbricavano 30 anni prima del 1617 [dunque nel 1587 circa] libbre 500 mila ma postovi il dazio di lire i per ogni libbra di seta si danno in presente in nota circa libbre 350 mila, sicché diminuita si è la rendita, non perché sia diminuito il genere ma perché importando il cumulo de dazi lire 4 per ogni libbra vengono commesse delle occultazioni. Lo che porta anche un accrescimento di prezzi alle manifatture. Perfette sono quelle di Feltre, del Bassanese, d’alcuni luochi del Bresiano e Bergamasco, a segno che sono comprate da Bolognesi per ridurle in orsogli»: A.S.V., V Savi alla Mercanzia, I ser., b. 477, t. II, fasc. 14, 1636, copia di scrittura dei consoli del 29 settembre 1636. Secondo un documento citato dal Sella all’inizio del Seicento la produzione annua di seta grezza doveva aggirarsi attorno alle quattrocentocinquantamila libbre destinate ai setifici italiani e francesi. L’espansione della domanda straniera fu probabilmente l’incentivo alla produzione: nel secondo quarto comparve accanto alla Francia lo sbocco olandese e nel 1670 la seta veniva esportata anche verso l’Inghilterra e la Baviera. Ma nel frattempo lo sviluppo della torcitura alla bolognese aveva stimolato anche dall’interno la bachicoltura, malgrado gli oneri fiscali fossero sempre più gravosi.
156. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, I ser., b. 478: il registro delle terminazioni delle licenze di estrazione di sete grezze da lavorare in orsogli per il 1696-1697 registra circa cinquantamila libbre di seta grezza passante per Venezia. Mentre una «nota delle sede grezze che sono state condotte in Bassano da 1 maggio 1700 sino al presente 22 novembre 1700» dà l’idea di quante fossero le diramazioni del commercio della seta greggia diretta ai mulini da organzini: ibid., b. 575, inserta in lettera del 5 dicembre 1700.
157. Cf. Gaetano Cozzi, Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 4/II, Il Seicento, Vicenza 1984, p. 518 (pp. 495-539).