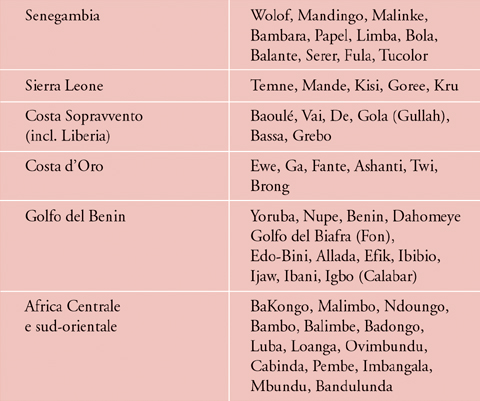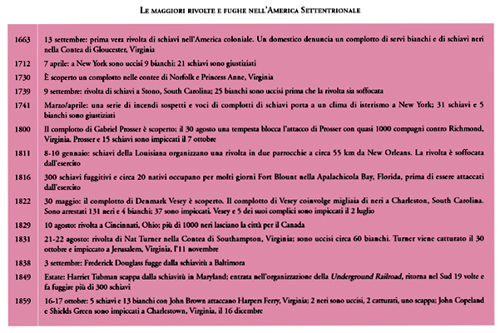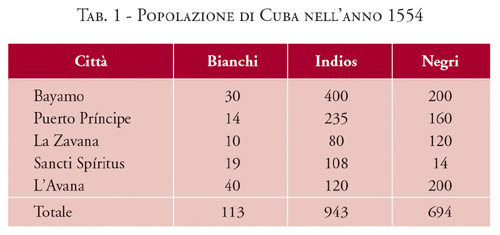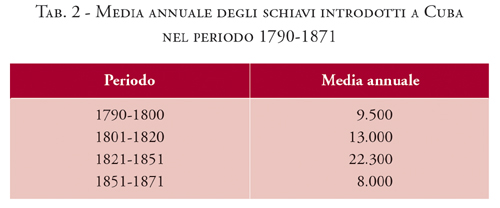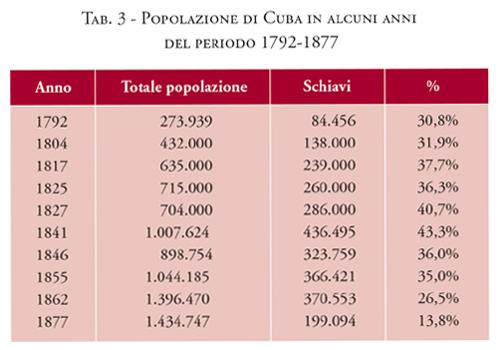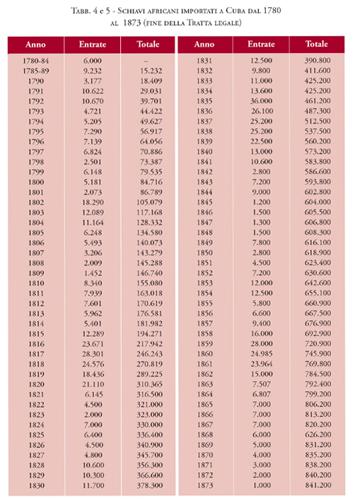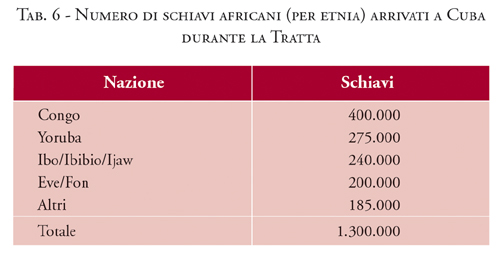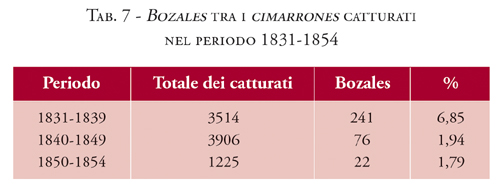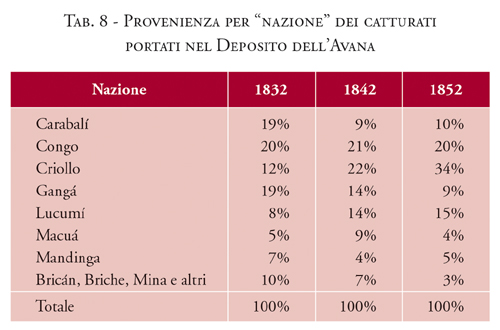L'Africa oltre l'Africa
L'Africa oltre l'Africa
La schiavitù in america settentrionale
di Alessandro Campus
Jamestown, 1619: nell'allora capitale della Virginia, arriva la prima nave di schiavi proveniente dall'Africa Occidentale. Comincia così la lunga storia del popolo afroamericano che, dalla deportazione dalla terra di origine, ha portato attraverso secoli di lotte all'affermazione dei pieni diritti civili.
È questa la data che solitamente si dà come inizio della schiavitù in America Settentrionale; è invece probabile che i 20 Africani portati in America nel 1619 non fossero schiavi nel vero senso della parola, ma servi che avrebbero potuto tornare liberi dopo un periodo di tempo determinato dal contratto. Comunque sia, l'importazione di schiavi dall'Africa e il loro commercio in America Settentrionale non conobbero soste dagli inizi del Seicento sino al 1808, anno in cui ne fu vietato l'arrivo dall'Africa, ma ‒ è bene ricordarlo ‒ non la schiavitù. Quest'ultima venne definitivamente abolita in tutti gli Stati Uniti nel 1863; nel 1865, alla fine della guerra di secessione, il Tredicesimo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti mise fuori legge la schiavitù: "Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction" ("Né la schiavitù né la servitù coatta, eccetto che come punizione per un crimine di cui la parte sarà stata riconosciuta colpevole nelle forme dovute, potranno esistere negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo sottoposto alla loro giurisdizione"). Tre anni dopo, nel 1868, il Quattordicesimo Emendamento garantì la cittadinanza a tutti gli Afroamericani, mentre due anni dopo il Quindicesimo Emendamento stabilì che il diritto al voto non poteva essere negato a causa della razza. Tra l'altro, la legge che nel 1808 vietò l'importazione di schiavi dall'Africa ebbe come effetto quello di farne aumentare il prezzo; confrontando i prezzi degli schiavi nel South Carolina, si può notare che nel periodo tra il 1790 e il 1799 uno schiavo costava poco meno di 200 dollari, tra il 1800 e il 1809 il prezzo era salito a quasi 400 dollari, per scendere poi a quasi 350 dollari tra il 1810 e il 1815. Per gli stessi periodi, può esser fatto un confronto con il prezzo del riso: nel 1790-1799 il riso costava 2,73 cents per libbra, nel 1800-1809 3,81 cents per libbra.
Tra il 1710 e il 1810 l'attività degli schiavisti si svolse nel continente africano con la cattura di milioni di individui; le percentuali degli schiavi catturati sono le seguenti:
In particolare, poi, sono state interessate dalla tratta degli schiavi le seguenti popolazioni:
Tra il 1740 e il 1865 sono state pubblicate negli Stati Uniti una cinquantina di autobiografie di ex schiavi, le cosiddette slave narratives; alcune di queste furono scritte da individui catturati in Africa, che fornirono sia la descrizione della propria vita in Africa, sia delle vicende che avevano portato alla loro cattura. È questo il caso, ad esempio, di The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African, Written by Himself (London 1789). L'autore inizia descrivendo la zona dell'Africa da cui proviene: "Quella parte dell'Africa, conosciuta col nome di Guinea, nella quale si continua il commercio degli schiavi, si estende lungo la costa per circa 3400 miglia, dal Senegal all'Angola, e include molti regni. Tra questi il più importante è il regno del Benen, sia per estensione che per ricchezza, l'abbondanza e la coltivazione del terreno, il potere dei suoi re, il numero e il carattere guerriero degli abitanti. (...) Questo regno è diviso in molte province o distretti: in uno tra quelli più lontani e fertili, chiamato Eboe, sono nato io, nell'anno 1745, in una incantevole fertile valle chiamata Essaka. La distanza di questa provincia dalla capitale Benin e la costa deve essere molto notevole; per questo non avevo mai sentito parlare di uomini bianchi o di Europei, né del mare, e la nostra dipendenza dal re di Benin era poco più che nominale; ogni relazione del governo, per quanto poco potevo vedere, era condotta dai capi o dai vecchi del luogo. Le usanze e il governo di un popolo che ha pochi rapporti con altri Paesi sono generalmente molto semplici e la storia di ciò che succede in una famiglia o un villaggio serve come esempio di una nazione" (pp. 4-5). Dopo aver parlato del proprio padre ‒ uno dei capi del villaggio in cui abitava ‒ e della propria cultura (amministrazione della giustizia, matrimoni, musica, abitazioni, religione, ecc.), descrive le vicende della cattura: "Un giorno, quando tutta la nostra gente era uscita per il lavoro come sempre e solo io e la mia cara sorella eravamo rimasti a badare alla casa, due uomini e una donna scavalcarono il muro e in un attimo ci presero e, senza che ci lasciassero il tempo di gridare o di fare resistenza, ci chiusero la bocca e fuggirono portandoci nel più vicino bosco. Ci legarono le mani e continuarono a portarci il più lontano possibile, sino alla notte, quando raggiungemmo una piccola casa, dove i ladri si fermarono per riposarsi e passare la notte. Fummo quindi slegati, ma non riuscimmo a mangiare" (pp. 48-49).
A questo punto comincia l'odissea di Olaudah Equiano, che, separato dalla sorella e dopo molti giorni di viaggio, viene venduto a un capo tribù; inizia così a lavorare per il suo primo padrone, che lo usa per muovere il mantice per la fusione del metallo che questi lavorava. Ma dopo qualche tempo venne venduto ancora e portato in una città che egli chiama Tinmah; questa è la descrizione che ne fa: "Era una città molto ricca e vi erano molti canali che scorrevano attraverso di essa e formavano un grande lago al centro della città, dove la gente si lavava. Qui per la prima volta vidi e assaggiai noci di cocco, che pensai migliori di qualsiasi altra non avessi mai assaggiato prima; gli alberi, carichi di questi frutti, erano disseminati tra le case, che erano così piacevolmente ombreggiate ed erano simili alle nostre, con gli interni accuratamente intonacati e dipinti di bianco. (...) Il loro denaro consisteva in piccole conchiglie bianche, delle dimensioni di un'unghia. Qui fui venduto per 172 di queste conchiglie da un mercante che viveva lì e mi aveva portato" (pp. 62-63).
Olaudah Equiano rimase con la famiglia che lo aveva comprato per qualche mese, sino a che non fu venduto ancora. Fu portato via dalla città in cui stava e condotto sulla costa, dove fu imbarcato su una nave di schiavi che, attraverso l'Atlantico, l'avrebbe condotto in America: il cosiddetto middle passage. "La ristrettezza dello spazio e il clima caldissimo, aggiunti al numero di persone nella nave, che era così affollata che ciascuno aveva appena lo spazio per girarsi, quasi ci soffocavano. Questo produceva una traspirazione così abbondante che l'aria presto divenne irrespirabile per la varietà di odori disgustosi e fece ammalare molti degli schiavi, dei quali parecchi morirono, cadendo così vittime dell'imprevidente avidità, per chiamarla così, dei loro compratori. Questa spaventosa situazione era ancor più aggravata dall'irritazione prodotta sulla pelle dalle catene, ora divenuta insopportabile, e dalla sporcizia dei secchi che servivano da latrina, nei quali spesso i bambini cadevano ed erano quasi soffocati. Le grida delle donne e i lamenti dei moribondi rendevano l'intera scena di un orrore quasi inimmaginabile" (p. 79).
Arrivati alle Barbados, gli schiavi furono venduti: "Non eravamo da molti giorni sotto la custodia del mercante che fummo venduti nella loro solita maniera, che è la seguente: dato un segnale (come il rullo di un tamburo) i compratori si precipitano tutti insieme nel cortile dove sono rinchiusi gli schiavi e scelgono la merce che preferiscono. Il rumore e il chiasso tra cui ciò avviene e l'impazienza visibile nel comportamento dei compratori contribuiscono non poco ad aumentare lo spavento dei terrorizzati Africani, i quali con molta probabilità li considerano quelli che portano quella distruzione alla quale pensano di esser destinati. In questo modo, senza scrupoli, sono separati parenti e amici, molti dei quali non si vedranno mai più. Ricordo che nella nave nella quale fui portato, nella zona degli uomini, c'erano parecchi fratelli, che furono venduti in lotti diversi; ed era molto commovente in questa occasione vedere e sentire i loro lamenti alla separazione" (pp. 86-87). Il viaggio non era però ancora concluso; rimasto pochi giorni alle Barbados, Olaudah Equiano fu nuovamente imbarcato su una nave e portato in Virginia, alla volta della piantagione del suo padrone.
Simile è la descrizione di una nave di schiavi nella biografia dell'ex schiavo Zamba raccolta da P. Neilson nel volume The Life and Adventures of Zamba, an African Negro King; and His Experience of Slavery in South Carolina. Written by Himself. Corrected and Arranged by Peter Neilson (London 1847). Zamba, nato sulle rive del Congo a circa 200 miglia dal mare, era figlio del re Zembola, egli stesso mercante di schiavi. Zamba all'arrivo a Charleston fu reso schiavo dal capitano della nave con la quale egli stesso aveva portato schiavi da vendere.
Queste sono le sue parole: "Il Capitano Winton mi fece entrare in un bel salone e lasciammo il Congo il primo giorno del mese di ottobre del 1800. Seppi che in tutto c'erano a bordo 422 schiavi: ma poiché il vascello aveva una stazza di 500 t, non era tanto affollato quanto quelli che ho visto spesso con emigranti dall'Europa all'America; comunque, la loro sistemazione era molto penosa. Il ponte inferiore della nave era diviso da poppa a prua in scompartimenti di circa 6 piedi quadrati con tavole alte circa sei pollici; in ognuna di queste divisioni erano messi quattro schiavi, sdraiati o in piedi, come volevano. Le tavole servivano a non farli rotolare quando il mare era agitato. Ovviamente, non avevano altro se non il duro ponte su cui sdraiarsi. Per quanto riguarda i vestiti, ne erano a malapena forniti: in generale, sia gli uomini che le donne avevano una iarda o una iarda e mezzo [0,9-1,3 m ca.] di Osnaburghs [un tipo di lino] messo intorno ai fianchi; alcuni di loro avevano un pezzo di stoffa, o un fazzoletto, arrotolato intorno alla testa. Gli uomini erano legati due a due con una piccola catena alla caviglia. Relativamente al cibo, stavano meglio di quanto solitamente capita nelle navi di schiavi, e questo, per quanto possa sembrare strano, era dovuto più alla avidità che all'umanità del capitano. I motivi, comunque, erano di poca importanza per i poveri schiavi, a patto che il risultato fosse a loro vantaggio. Gli schiavi avevano per colazione una razione sufficiente di granturco bollito, con un cucchiaio di melassa ciascuno; per pranzo di solito avevano riso bollito, la cena era la stessa della colazione. Qualche volta a pranzo ricevevano circa mezza libra [2 hg ca.] di gallette con un pezzetto di manzo o di maiale; troppo di quest'ultimo senza dubbio avrebbe portato sete. (...) Il capitano mi raccontò, nel corso del nostro viaggio, che all'inizio della sua esperienza di trasporto di schiavi aveva visto lo stesso numero di schiavi che aveva a bordo su una nave di 200 t, dove erano letteralmente stipati uno sull'altro; di conseguenza, per l'aria malsana, la strettezza e il cibo scarso o guasto, le malattie che si ebbero furono talmente diffuse che in molti casi il capitano seppe che solo la metà era sopravvissuta al viaggio; e questi, come disse, in condizioni tali da non poter essere venduti. Egli trovava, quindi, che concedendo loro quello che egli chiamava alloggi sufficienti e buoni pasti, con un trattamento clemente, il suo investimento gli avrebbe fruttato molti più dollari; e questo è quello che gli interessava" (pp. 86-88).
A testimoniare la insensibilità dei comandanti delle navi negriere, questo è l'epitaffio di uno di essi:
Sotto questa pietra giace
il corpo
del
Capitano Thomas Hughes
che lasciò questa vita
il 2 giugno 1777
nel suo 45° anno di età
--
Fu per molti anni Comandante
nella tratta degli schiavi,
ufficio che ricoprì
con laboriosità e integrità estreme.
Marito affettuoso
Tenero Padre
Uomo retto
--
Con animo sereno percorse un duro cammino
e obbedì amabilmente
alla chiamata del Signore
(cit. in Spiegl 1971)
Tali fonti documentarie, per quanto abbondanti e circostanziate, non sempre sono state ritenute pienamente attendibili; era cioè dubbio se rappresentassero reali racconti di ex schiavi oppure opere di scrittori bianchi antischiavisti. Le indagini archeologiche intraprese a partire dalla metà del XX secolo costituiscono dunque un prezioso riscontro, soprattutto di elementi di cultura materiale, oltre che delle condizioni di trasporto, di vita e delle pratiche funerarie. Dal punto di vista topografico, poi, l'archeologia ha consentito di appurare quanto non altrimenti noto in merito alla diffusione del fenomeno schiavista: è questo il caso ad esempio della vasta necropoli per soli Afroamericani rinvenuta a New York (il cosiddetto African Burial Ground), in una zona cioè che non aveva ancora dato riscontro materiale del fenomeno. In questo caso, il rinvenimento della necropoli ha stimolato la rilettura e la diffusione di documentazione scritta, che ha integrato il dato materiale.
In questa ottica di integrazione tra fonti testuali e fonti archeologiche, di particolare interesse è lo scavo subacqueo del relitto di una nave affondata a 35 miglia al largo di Key West, in Florida; il riconoscimento di questo relitto come quello della Henrietta Marie è dovuto al ritrovamento della campana di bronzo della nave con la scritta "Henrietta Marie 1699". Grazie a questa identificazione, è stato possibile ripercorrerne la storia: costruito durante il XVII secolo in Francia, questo veliero fu catturato dagli Inglesi nel 1697 e quindi venduto a mercanti inglesi. Lungo 18,3 m circa e con una stazza di 120 t, probabilmente nel novembre del 1697 esso fece il suo primo viaggio verso l'Africa e, di lì, verso l'America. Tornato in Inghilterra alla fine del 1698, nel settembre del 1699 ripartì alla volta dell'Africa dove approdò nel dicembre dello stesso anno, per arrivare in Giamaica, dove vendette il proprio carico di 190 schiavi africani, nel maggio dell'anno successivo. Durante il viaggio di ritorno verso l'Inghilterra, il veliero affondò al largo delle coste della Florida. Lo scavo della nave ha consentito di recuperare una grande quantità di materiali, tra cui una ottantina di ceppi con i quali gli schiavi erano imprigionati a due a due. Durante lo scavo sono stati recuperati sia l'equipaggiamento di bordo ‒ cannoni, ancore, pompe, ecc. ‒ sia gli oggetti appartenenti all'equipaggio ‒ piatti, bottiglie, vassoi, cucchiai, tutti di peltro ‒ sia parte del carico; in particolare, è stata trovata una grande quantità di perline di vetro di produzione veneziana, lingotti di ferro, una zanna di elefante. Dallo studio del relitto, si è potuto stabilire che lo spazio riservato a ogni schiavo era di 0,4 × 1,7 m circa; la distanza tra un ponte e l'altro era di 90 cm circa e gli schiavi non avevano lo spazio sufficiente per rimane seduti con la schiena diritta. Quando qualcuno, date le condizioni, moriva, veniva gettato fuori bordo dall'equipaggio.
Alla Library of Congress di Washington sono conservate immagini che illustrano in che modo sistemare gli schiavi africani sulle navi: lo schema della nave inglese Brookes, del 1780, ad esempio, mostra come ogni spazio disponibile fosse occupato; gli schiavi erano sistemati su due ponti, ognuno dei quali aveva un soppalco. Di fatto, c'era solo lo spazio per stare sdraiati, a contatto col proprio vicino. Questa nave era autorizzata a trasportare 454 schiavi, più o meno il numero di persone che si vede nell'illustrazione; comunque, nei suoi primi quattro viaggi, tra il 1781 e il 1786, essa portò tra 609 e 740 Africani. Una volta arrivati nella piantagione, gli schiavi incontravano condizioni di vita terribili. Sono le autobiografie di ex schiavi che, ancora una volta, ci descrivono la quotidianità.
La situazione degli schiavi nati in America era invece segnata sin dall'infanzia. Ecco quello che scrive F. Douglass nella sua Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. Written by Himself (Boston 1845): "Mia madre si chiamava Harriet Bailey. Era figlia di Isaac e Betsey Bailey; entrambi neri, e neri assai (quite dark). Ma era di carnagione più scura dei miei nonni. Mio padre era un bianco ‒ secondo tutti coloro che ho sentito parlare della mia parentela. Correva pure voce, o almeno si sussurrava, che fosse il mio padrone; ma dell'esattezza di questa storia io non so nulla, essendomi stato precluso il modo di saperlo. Infatti, mia madre e io fummo separati ch'ero piccolissimo ‒ prima che la conoscessi come mia madre. È abitudine corrente, nella parte del Maryland dalla quale son fuggito, strappare i figli alle loro madri in età tenerissima. Sovente, prima che il piccolo abbia raggiunto i 12 mesi, sua madre viene prestata a una fattoria distante un buon tratto di cammino e lui affidato a una vecchia troppo carica di anni per poter lavorare la terra. Perché questa separazione venga imposta lo ignoro, se non è per impedire che il bimbo si affezioni alla madre e smorzare e distruggere il naturale affetto della madre per il bimbo. Comunque, è questo il risultato inevitabile" (pp. 1-2; trad. it. p. 1).
Non era infrequente che in una piantagione il padrone avesse figli con alcune delle schiave che possedeva; in questi casi, di solito i bambini venivano venduti subito dopo la nascita. L'intera vita di Harriet A. Jacobs è segnata dai tentativi di violenza del suo padrone, tanto che, alla fine, dopo aver dato alla luce due figli con un altro bianco, fugge dalla piantagione del suo padrone per rifugiarsi prima in casa della nonna ‒ una nera libera ‒ e poi nel Nord; le sue avventure, raccontate nel volume Incidents in the Life of a Slave Girl. Written by Herself (Boston 1861), sono talmente incredibili che per molti anni sono state ritenute un semplice romanzo. Solo nel 1987 l'edizione critica di J. Fagan Yellin pubblicata a Boston ha dimostrato la veridicità del racconto. Addirittura, la stessa autrice inizia così la prefazione: "Lettore, ti assicuro che questa storia non è un romanzo. So che alcune delle mie avventure potrebbero sembrare incredibili; invece sono, nonostante tutto, strettamente vere. Non ho esagerato gli orrori inflitti dalla schiavitù; al contrario, le mie descrizioni sono inferiori ai fatti" (p. 5). Pur non dovendo lavorare nei campi, la donna era sottoposta a continue umiliazioni: "Mi diceva che ero sua proprietà, che dovevo essere soggetta ai suoi voleri in ogni cosa. La mia anima si rivoltava contro la crudele tirannia. Ma dove potevo trovare protezione? Non importa se una schiava è nera come ebano o bianca come la sua padrona. In entrambi i casi non c'è ombra di legge che la protegga dall'insulto, dalla violenza o persino dalla morte; tutto questo è inflitto da demoni che hanno sembianza umana" (p. 45).
È ancora Douglass che ci descrive una tipica situazione: "Mr. Covey (scil. il padrone di Douglass) era un uomo povero. Stava appena cominciando la sua fortuna; era in grado di comprare una sola schiava e, per quanto sia scioccante, la comprò, come egli disse, come animale da riproduzione. Questa donna si chiamava Carolina. (...) Lei era una grossa donna sana, di circa vent'anni. Aveva già dato alla luce un bambino, fatto che provava ciò che egli voleva. Dopo averla comprata, affittò un uomo sposato da Mr. Samuel Harrison, che vivesse con lui per un anno, e lo chiudeva con lei ogni notte! Il risultato fu che, alla fine dell'anno, la povera donna diede alla luce due gemelli (pp. 63-64)".
Le sopraffazioni, le violenze cominciavano sin dall'infanzia; ecco che cosa racconta l'ex schiavo Levi Branham nel suo My Life and Travels (Dalton 1929): nato nel 1852 nella Contea di Murray in Georgia, dove visse fino all'età di 11 anni, ricorda quasi con affetto la propria vecchia padrona: "La mia vecchia padrona, 'Miss Beckie', era molto buona con noi. Si dava da fare per noi neri più di quanto facessero i nostri genitori, semplicemente perché aveva più possibilità di prendersi cura di noi, e perché ci voleva bene" (p. 3). Una immagine idilliaca, certo, ma dopo poche righe la rivelazione: "Un giorno chiesi a 'Miss Beckie': 'Perché noi piccoli bambini negri (we little negro children) dobbiamo lavorare per lei?' Lei rispose: 'Questo è il modo che i nostri avi hanno stabilito'. Le dissi: 'Quando sarò cresciuto cambierò le cose in qualche modo'" (pp. 3-4). Questa situazione era addirittura legalizzata: nel 1852 il giudice Nash, della Suprema Corte di Giustizia della Carolina del Nord, decretò che "è impossibile stabilire quali siano gli atti che possono definirsi insolenza verso un bianco; può essere uno sguardo, l'accennare con un dito, il rifiuto o la negligenza nello scostarsi quando si avvicina un bianco. Ma ognuno di questi atti viola le regole della proprietà e se tollerato potrebbe distruggere quella subordinazione sulla quale poggia il nostro sistema sociale" (cit. in Johnson 1937, p. 619).
La presenza afroamericana in America Settentrionale non poteva non lasciare una grande eredità: da diversi anni i ricercatori statunitensi hanno chiarito la portata dei cosiddetti africanisms, "elementi culturali trovati nel Nuovo Mondo che possono risalire a un'origine africana" (Holloway 1991, p. IX). Tali africanismi sono stati individuati sia a livello linguistico che come emergenze materiali. Per quanto attiene alla lingua, è diventato un esempio classico, dopo il lavoro di L. Turner, il dialetto Gullah parlato nelle isole al largo della Georgia. In questo dialetto Turner ha ritrovato circa 4000 parole che derivano direttamente dalle lingue parlate in Africa dagli schiavi importati. Il relativo isolamento in cui questa comunità è vissuta nel corso degli anni ha portato a un grande conservatorismo nella lingua, mantenendo quindi termini che, in altre comunità nere, si sono persi nel tempo.
Un esempio della persistenza del dialetto Gullah è la seguente trascrizione del Padre Nostro:
Ow-uh farruh, hu aht in heh-wm, hallow-ed be dy name, dy kingdom come, dy will be done on ut as it done in heh-wn. Jih-w us dis day ow-uh daylih bread, an fejih-w dohz truspuss ajens us. Lead us not into temptation, but dihlih-wuh us fum all ting like e-wull. Dyne dih kingdom, pahwuh, an dy glorih.
Questa è invece la stessa preghiera in inglese:
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it done in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive those trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all thing like evil. Thine the kingdom, power and Thy glory.
Nell'inglese parlato oggi negli Stati Uniti una parola di origine africana è bambi, dal Bantu mubambi, che indica una persona che si sdraia per terra per nascondersi; anche bamboula, che in inglese indica un tipo di tamburo, viene da una parola africana: bambula, battere su una superficie; allo stesso modo, africana è l'origine del termine banjo ‒ che è ugualmente uno strumento di diretta origine africana: deriva dal Kimbundu mbanza, parola che designa uno strumento a corde. Nell'inglese moderno degli Stati Uniti viene usato il verbo dig per dire "guardare" o "capire", probabilmente dal Wolof dega, "capire"; un esempio in Wolof è dega nga olof, "capisci il Wolof?". Anche nella toponomastica negli Stati del Sud degli Stati Uniti si possono rintracciare ascendenze africane. È il caso, ad esempio, del toponimo Angola, in Florida, luogo in cui un pescatore cubano nel 1821 riferisce che "la popolazione consiste di centinaia di uomini, donne e bambini neri" (Brown 1991); ancora, il nome della Coosaw Island, nelle Isole Gullah, deriva dalla parola Germa per "polvere". Ugualmente nelle isole Gullah è la Wassaw Island, dal nome Twi di un distretto, una tribù e un dialetto della Costa d'Oro. Anche la città di LaVilla, in Florida, nonostante la grafia occidentale, denuncia una derivazione dall'Africa: in Congo, infatti, significa "relazione, famiglia, clan"; in questo caso la derivazione da un termine africano è anche semantica, in quanto la città di LaVilla è stata tra il 1866 e il 1887 abitata solo da neri liberi, prima di essere assorbita dalla vicina Jacksonville, abitata in prevalenza da bianchi. Non derivano da parole africane, ma hanno una chiara matrice culturale, toponimi come African Bar e Nigger Heaven in California, Freemanville e Negro Point in Florida, North Fork Colored e Canadian Colored in Oklahoma.
Per quanto riguarda le ricerche archeologiche, il National Register of Historic Places si occupa di censire "distretti, siti, edifici, strutture e oggetti significativi per la storia, l'architettura, l'archeologia, la tecnica e la cultura americane a livello nazionale, statale e locale" (Joyner 2003, p. 24). In questo ambito, sono stati identificati diversi siti di particolare interesse per la cultura afroamericana. Uno di questi è la Congo Square a New Orleans, dove la domenica si riunivano gli schiavi di questa città. Una vivida descrizione di quanto accadeva in Congo Square ci viene data da B.H. Latrobe nel 1819: "Un anziano nero si siede a cavalcioni su un grande tamburo cilindrico. Usando le dita e il taglio delle mani colpisce ripetutamente la parte superiore del tamburo ‒ che è di circa un piede di diametro e fatto probabilmente con pelle animale ‒ provocando una vibrazione con rapidi secchi colpi. Un secondo percussionista, che tiene il proprio strumento tra le ginocchia, lo segue, suonando con lo stesso attacco staccato. Un terzo nero, seduto per terra, pizzica uno strumento a corde, la cui cassa è rozzamente ricavata da una zucca. Un'altra zucca è servita per costruire un tamburo e una donna la colpisce con corti bastoncini. Una voce, poi altre voci si uniscono. Accompagnano questo scambio musicale una danza apparentemente incompatibile e una figura in movimento che sembra da una parte informale e spontanea, dall'altra, a una osservazione più attenta, ritualizzata e precisa. È una danza di grandi proporzioni. Una folta folla di corpi scuri divisa in gruppi circolari ‒ forse 500 o 600 persone che si muovono al ritmo della musica, qualcuno dondolando dolcemente, altri battendo i piedi in modo energico. Alcune donne del gruppo cantano" (cit. in Vlach 1990). È significativo il fatto che nel Settecento tutti gli schiavi dell'area provenissero dalla zona del Senegal e del Gambia, avendo così una relativa omogeneità culturale. Oggi, la piazza è pavimentata con mattoni disposti in cerchio, per ricordare le danze che vi si svolgevano.
Un aspetto interessante messo in evidenza dalla archeologia è quello delle conchiglie cauri; tali conchiglie, di origine indo-pacifica, erano ampiamente usate in Africa come mezzo di scambio. In tutti gli Stati Uniti ne sono stati trovati pochissimi esemplari: una in Virginia, a Monticello nella Contea di Albemarle; una nel North Carolina, nella piantagione Stagville vicino a Durham; una in Louisiana, nella piantagione Ashland-Belle. Di recente, cauri sono stati rinvenuti anche in una tomba dell'African Burial Ground a New York. Ebbene: vista la estrema esiguità dei ritrovamenti, è stato ipotizzato che queste conchiglie fossero in possesso degli Africani al momento della loro cattura in Africa e che quindi essi le avessero portate con sé. Il confronto con sette altre conchiglie cauri ritrovate in una sepoltura di uno schiavo alle Barbados ha permesso di ipotizzare anche il modo in cui esse erano indossate: erano probabilmente montate con altri oggetti ritrovati nella stessa tomba, quali vaghi di vetro di fabbricazione europea, denti di cane forati e un vago di corniola, formando così una collana che aveva anche caratteristiche africane. Si può forse immaginare che un oggetto di questo tipo sia quello descritto nel volume di Th.L. Johnson Africa for Christ. Twenty-Eight Years a Slave (London 18926), un ex schiavo che andò in Africa come missionario; alla fine del volume, Johnson riporta in appendice un articolo di The Herald: "Johnson porta dall'Africa una rara collezione di curiosità, che mostra al giornalista di The Herald alla conclusione della sua conferenza. Una grande collana è intrecciata con conchiglie marine, che sono le monete di alcune tribù, una conchiglia comune grande più o meno come un fagiolo del valore di 8 cents" (pp. 89-90). Ugualmente di origine africana è un anello fatto di legno di ebano, materiale che si trova solo nelle aree tropicali dell'Africa e dell'Asia, rinvenuto nella piantagione Portici nel Manassas National Battlefield Park in Virginia; insieme a questo anello ligneo ne è stato rinvenuto un altro esemplare di osso di animale. Questi oggetti, interpretati come "ricordi di famiglia", sono stati recuperati in contesti della metà del XIX secolo, quando erano ancora in vita alcuni schiavi nati in Africa.
Alcuni oggetti fabbricati da schiavi nelle piantagioni della Virginia rivelano un indubbio influsso africano: ad esempio, M.C. Emerson (1988) ha ipotizzato che le pipe fabbricate da schiavi alla metà del XVII secolo abbiano forma e materiale di tipo europeo, ma la decorazione ‒ a motivi impressi e incisi bianchi ‒ sia da confrontare con coevi e simili disegni del Ghana, della Nigeria, del Senegal e del Mali. Se questa ipotesi fosse vera, si tratterebbe dei più antichi esempi di identità culturale africana in America Settentrionale. Anche alcune produzioni ceramiche sono state attribuite a manifattura afroamericana. Questo tipo di ceramica, nota negli Stati Uniti come colonoware, è di argilla cotta in forni a bassa temperatura, non rivestita e non decorata; le forme sono quelle di basse ciotole e piccole olle globulari. Se da una parte si riteneva che questi vasi fossero prodotti da nativi americani e frutto della interazione culturale tra questi e gli Europei, alcuni anni fa sono stati invece attribuiti alla produzione degli schiavi per proprio uso, visto, inoltre, che questo tipo di ceramica è stato ritrovato anche in siti nei quali era ormai da tempo finita l'occupazione da parte di nativi americani (Garrow-Wheaton 1989). L'importanza dello studio di questo tipo di ceramica risiede nel fatto che si possono ricavare informazioni non desumibili da altre fonti; ad esempio, è possibile ipotizzare che il cibo fosse preparato autonomamente da ciascun gruppo famigliare, forse per conservare un gusto di tradizione africana (Singleton 1991). I resti di cibo ritrovati durante gli scavi confermano la pratica di cucinare pasti per gruppi numericamente ridotti: gli animali da cuocere erano tagliati in piccoli pezzi e i segni sulle ossa attestano che di solito tali pezzi erano stati bolliti e non arrostiti.
Alcuni oggetti trovati nella piantagione Jordan nella Contea di Brazoria, a sud di Houston in Texas, sono stati ricondotti alla attività di un guaritore; nella baracca denominata dagli scavatori Conjurer / Midwife's Cabin (Baracca del Mago / della Levatrice) sono stati rinvenuti materiali che per la loro associazione sono stati interpretati come strumenti per attività magiche. Si tratta di fondi di bollitori di ferro, un termometro, pezzi di gesso molto usurati, crani di uccelli, frammenti di un piccolo peso, una zampa di animale, medicinali, conchiglie, bottiglie, parti di bambole, cucchiai, chiodi, coltelli, grattatoi di selce, vaghi di collana di vetro blu (Brown 2001). Tale insieme di oggetti è stato confrontato con le statuette nkisi attestate presso i BaKongo dell'Africa Centrale; questo tipo di statuette aveva un ruolo importante nei rituali di guarigione delle popolazioni di quella zona dell'Africa. Se questa ipotesi trovasse conferma, si tratterebbe dell'unica attestazione di materiali del genere in America Settentrionale. Vicino a questi oggetti, sono stati trovati altri depositi di materiale, che contenevano oggetti simili; un ulteriore ripostiglio scavato all'esterno della baracca, vicino alle fondamenta, presentava altri manufatti ‒ quasi tutti di ferro ‒ ricollegati anche questi a una nkisi. Altri oggetti sono sette monete di ferro ‒ con date che vanno dal 1853 al 1858 ‒, una delle quali forata, bottoni di divise di soldati confederati, frammenti di ossa, conchiglie, una baionetta, cenere. La posizione degli oggetti nei depositi e la disposizione dei depositi tra loro hanno fatto pensare a una sorta di cosmogramma, una rappresentazione simbolica dell'universo, da ricondurre alla religione BaKongo (Brown 2001).
Una situazione simile è stata trovata nello scavo della piantagione Frogmore Manor: anche qui è stata identificata una baracca ugualmente chiamata Conjurer / Midwife's Cabin, sotto le pareti della quale sono stati ritrovati quattro depositi. Uno conteneva un pollo con le ali leggermente aperte posto in un piccolo buco e rivolto verso est; al di sopra era stato messo il fondo di una bottiglia di vetro. Un altro consisteva in una giovane mucca quasi completamente articolata, sdraiata su un fianco; come il pollo del primo deposito, anche la mucca, cui mancava la coda, era rivolta verso est. Anche al di sopra di questo animale era stato posto il fondo di una bottiglia di vetro, oltre a una bottiglia intera. Il terzo deposito presentava una grande quantità di conchiglie, una bottiglia di vetro, un lungo ago di ferro, diversi pezzi di specchio, frammenti di ossa levigate, un vago di collana di vetro blu, frammenti di ceramica colonoware. Il quarto deposito, infine, conteneva cenere calcarea, con piccolissimi frammenti di conchiglie bruciate, alcuni piccoli chiodi; l'analisi del terreno ha mostrato che questi oggetti furono bruciati in situ. Anche in questo caso, si è ipotizzato che questi quattro depositi formassero un cosmogramma.
Sono ancora le slave narratives che ci illuminano sugli oggetti ritrovati in contesti schiavili. Charles Ball (1837) è esplicito, per quanto riguarda la religione degli schiavi: "c'è, in generale, un senso di obbligo religioso molto ridotto, o di dovere, tra gli schiavi delle piantagioni di cotone; e il cristianesimo non può essere propriamente detto la religione di queste persone. Esse sono universalmente soggette alla superstizione più rozza e abbietta; credono tutte nella stregoneria, negli incantesimi e nell'intervento di spiriti cattivi nelle vicende della vita umana. La maggior parte è nativa dell'Africa o discendente di quelli che, di generazione in generazione, vissero nel Sud, dal tempo in cui i loro antenati sbarcarono in questo continente; e la loro superstizione, che non merita il nome di religione, non è migliore, né meno feroce, di quella che opprime gli abitanti delle regioni più selvagge di Negro-land" (p. 165).
Scrive Henry Bibb (1849) che "c'è molta superstizione tra gli schiavi. Molti di loro credono in ciò che chiamano 'incantesimo', trucco e stregoneria ('conjuration', tricking, and witchcraft); e alcuni di essi asseriscono di possedere l'arte e dicono che attraverso di essa possono evitare che i loro padroni esercitino il loro volere sui loro schiavi. Questi incantesimi sono fatti per dare il potere di impedire che i loro padroni li fustighino. L'ingrediente (remedy) è più generalmente un tipo di radice amara; la devono masticare e sputare verso i loro padroni quando sono adirati con i loro schiavi. Altre volte preparano certi tipi di polvere da cospargere intorno alle abitazioni dei loro padroni. Tutto questo è fatto per difendersi in un qualche modo pacifico, sebbene io sia convinto che non c'è nessuna virtù in tutto questo" (pp. 25-26). Nonostante fosse scettico, Bibb provò a usare questi sistemi magici, ma venne comunque punito; si rivolse allora a un altro schiavo: "Ma c'era un altro vecchio schiavo nelle vicinanze che sosteneva di sapere tutto sugli incantesimi e pensai di provare la sua abilità. Mi disse che il primo era solo un ciarlatano e che se gli avessi dato una certa somma in contanti egli mi avrebbe detto come evitare che chiunque mi colpisse. Dopo che gli ebbi pagato il prezzo, mi disse di andare nel recinto delle mucche la notte seguente e prendere un po' di letame fresco e mischiarlo con pepe rosso e capelli di un bianco, mettere tutto in una pentola sul fuoco e bruciare sino a che fosse macinato in polvere. Poi dovevo spargerlo intorno alla camera da letto del mio padrone, nel suo cappello e negli stivali e ciò avrebbe evitato che abusasse di me in qualsiasi modo" (p. 28). Ma purtroppo anche questo sistema non va a buon fine, tanto che l'autore conclude che "running away was the most effectual way by which a slave could escape cruel punishment ‒ scappar via era per uno schiavo il miglior sistema per evitare una punizione crudele" (ibid.).
Un sistema simile ci è raccontato da F. Douglass (1855): "Ho trovato in Sandy un buon consigliere. Non era solo un uomo religioso, ma diceva di credere in un sistema per cui io non ho un nome. Era un vero Africano e aveva ereditato alcuni dei cosiddetti "poteri magici" che si dice abbiano gli Africani e le nazioni orientali. Mi disse che mi avrebbe potuto aiutare, che proprio in quei boschi c'era un'erba, che può essere trovata la mattina, che ha tutti i poteri che servivano per la mia protezione (...) e che, se avessi seguito i suoi consigli, mi avrebbe procurato la radice di quell'erba di cui mi aveva parlato. Mi disse inoltre che se avessi preso quella radice e l'avessi indossata a destra sarebbe stato impossibile per Covey colpirmi, che con questa radice su di me nessun bianco mi avrebbe potuto frustare. Mi disse che egli l'aveva portata per anni e che ne aveva provato le virtù. Non era stato colpito da nessun padrone di schiavi finché l'aveva portata e non si aspettava di essere mai colpito perché aveva intenzione di portare quella radice come protezione" (p. 238).
D'altro canto, ecco che cosa dice Jenny Proctor, una ex schiava dell'Alabama nata nel 1850: "Non c'era chiesa per gli schiavi, ma la domenica mattina si andava sotto il pergolato dei padroni e un predicatore bianco veniva a farci il discorso. Ecco cosa diceva: 'Ora prendo il testo che dice: negro obbedisci al padrone (nigger obey your master and your mistress), perché tutto quello che avrai da loro su questa terra è tutto quello che puoi avere, voi siete come i porci e gli altri animali, quando morite avete finito di esistere, dopo che vi hanno buttato in quella fossa'. Penso che per un po' di tempo gli abbiamo creduto perché non c'era modo di trovare qualcosa di diverso. La Bibbia non l'abbiamo mai vista" (p. 213 del dattiloscritto Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers' Project, 1936-1938 Texas Narratives, Volume XVI, Part 3 Ex-slave autobiography, Library of Congress, Washington; trad. it. in Armellin 1975, p. 184).
Per quanto riguarda l'architettura, sia le fonti archeologiche sia le narrazioni di ex schiavi ci danno un'idea delle condizioni di vita. Il racconto di Jenny Proctor è piuttosto preciso: "Avevamo delle vecchie baracche malridotte, fatte di tronchi d'albero, e alcune fenditure erano tappate col fango e col muschio e altre no: non avevamo letti per dormire: c'erano delle impalcature inchiodate al muro e appoggiate sui pali, e sopra ci stava una branda da pezzenti; non era davvero un gran bel dormire, ma alle nostre ossa stanche dopo una giornata di lavoro pesante nei campi andava bene tutto" (p. 20, dal dattiloscritto Born in Slavery, cit.; trad. it. in Armellin 1975, p. 181). È più precisa la descrizione che M.S. Fayman fa nel 1937 delle baracche. "Erano costruzioni di pietra, ciascuna larga circa 20 piedi e lunga 50 [6 × 15,2 m ca.], dell'altezza di 9 piedi [2,75 m ca.] sul retro e davanti 12 [3,65 m ca.], con un tetto inclinato di tavole di legno di noce e una porta scorrevole; sia davanti che dietro fra le porte c'erano due finestre di 3 × 4 piedi [0,91 × 1,22 m ca.], e al capo della fila di casupole c'erano pure una finestra e una porta simili a quelle che stavano sul davanti e sul retro. Queste costruzioni erano 12, ognuna aveva annessa una baracca di 12 × 15 piedi [3,65 × 4,6 m ca.] che serviva da cucina. Ogni edificio aveva un focolare che era usato per scaldare le stanze, e sul davanti c'era un barile pieno d'acqua che veniva portata attraverso delle tubature da una grossa sorgente situata a 300 iarde [275 m ca.] di distanza sul fianco di una collina molto rocciosa, dove era estratta la pietra per le costruzioni della fattoria. All'esterno di ogni porta e finestra stavano ben fissati al muro degli anelli di ferro attraverso i quali ogni sera veniva fatta passare una sbarra di ferro che era poi bloccata col lucchetto, in modo da rendere impossibile la fuga di quelli che stavano dentro" (p. 12 del dattiloscritto Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers' Project, 1936-1938 Maryland Narratives, Volume VIII, Library of Congress, Washington; trad. it. in Armellin 1975, pp. 221-22).
Le costruzioni della tenuta di Solitude sono piuttosto significative per quando riguarda le slave cabins (Pulice 2000). Solitude, oggi parte integrante del campus della Virginia Polytechnic Institute and State University, fu costruita ‒ come risulta dalle analisi dendrocronologiche su travi della casa principale ‒ tra il 1798 e il 1801. La sua eccezionalità consiste in particolare nel fatto che una delle costruzioni di travi di legno per gli schiavi è ancora in elevato e si è potuto procedere con analisi di dettaglio; questa baracca risulta databile ‒ anch'essa mediante la dendrocronologia ‒ al 1843 circa. L'abitazione misura 4,26 × 4,87 m, ha un piano e mezzo, con la scala che conduce alla soffitta in un angolo opposto al caminetto. Questo tipo di abitazione poteva essere eretto velocemente e facilmente, con un costo molto basso e, se necessario, poteva essere smontato e riposizionato.
Nel 1991 è stata scoperta a New York una vasta necropoli (2-2,5 ha), della quale sono state scavate più di 400 tombe di Afroamericani; è stato calcolato che dovevano esservi sepolte tra le 10.000 e le 20.000 persone. I materiali ritrovati nelle sepolture forniscono una datazione dell'uso dell'area a scopo funerario tra gli inizi e la fine del XVIII secolo. Una descrizione di quest'area risale al 1847: D.T. Valentine parla di una zona che "nel primo insediamento della città è stata assegnata come luogo di sepoltura per i negri, schiavi e liberi. (...) Molti di loro erano nativi dell'Africa, importati qui in navi schiavili, che conservavano le loro superstizioni e le loro usanze funebri, tra le quali c'era quella di seppellire di notte, con molte pantomime e grandi schiamazzi (mummeries and outcries)" (History of Broadway, New York 1865, p. 567). Anche nel caso delle sepolture, i racconti degli ex schiavi ci aiutano. "Quando moriva un negro (nigger) facevamo una veglia funebre ed era diverso da come è oggi. Non lasciavano mai un negro morto in casa, ma andavano tutti i vicini e aiutavano. Giravano tutti gli specchi della casa perché dicevano che una volta molto tempo fa un negro morì e tre giorni dopo la sua famiglia guardando in uno specchio lo vide chiaramente. Durante la veglia funebre battevamo il tempo con le mani e i piedi ‒ lo chiamano Walking Egypt ‒ e cantavamo e cantavamo a bocca chiusa tutta la notte sino a che non si faceva il funerale (Hamp Kennedy, p. 86 del dattiloscritto Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers' Project, 1936-1938 Mississippi Narratives, Volume IX, Library of Congress, Washington).
Molto simile è il racconto fatto da Arrie Binns nel 1937: "Quando un negro moriva facevano la veglia funebre tutta la notte e il giorno dopo si faceva il funerale e quando si avviavano verso il cimitero col corpo ognuno nell'intera processione voleva cantare inni. Li ho sentiti abbastanza volte chiaramente attraverso i campi cantare e gemere quando andavano" (Arrie Binns, p. 77 del dattiloscritto Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers' Project, 1936-1938 Georgia Narratives, Volume IV, Part 1, Library of Congress, Washington).
Altri racconti, tra le biografie pubblicate nell'Ottocento, confermano l'uso di seppellire i morti durante la notte. Il costume di celebrare il funerale di notte è attestato anche nei racconti di Harriet Tubman raccolti e pubblicati da Sarah H. Bradford (1869). "Descrisse un funerale notturno al quale partecipò; gli schiavi, non essendo mai stato loro concesso di seppellire i loro morti di giorno, hanno continuato l'usanza dei funerali notturni per abitudine. Il corpo era deposto sulla terra e la gente sedeva intorno, il gruppo illuminato con torce di pino. Il vecchio predicatore negro cominciò col cantare un inno, che fu cantato da tutti. 'Oh, spero che lei lo possa sentire, signora', disse Harriet. 'Quelle voci sono così dolci, e possono cantare qualsiasi cosa cantiamo e poi possono cantare molti inni che non potremo mai imparare'. Il vecchio predicatore cominciò il suo sermone indicando il morto, che giaceva in una rozza cassa davanti a lui. 'Shum? Ded-a-de-dah! Shum, David? Ded-a-de-dah! Ora voglio che tutti riflettiate (flec') per un momento. Chi di tutta questa congregazione non è prossimo a giacere morto (ded-a-de-dah)? Potete andare ovunque, miei amici e fratelli, ma Morte (Deff) vi troverà. Potete scavare una buca così profonda e sotterrarvi, ma Dio Onnipotente che vede lontano vi troverà, e Morte vi raggiungerà. Non potete andare in quella costruzione (...) e chiudervi dentro; quella fortezza che Sesh Buckner dice che il diavolo non può prendere, ma Morte vi troverà. Tutti i vostri amici vi possono dimenticare, ma Morte non vi dimenticherà. Ora, amici miei, preparatevi a giacere morti'. Questo era un sermone molto lungo, dopo il quale tutta la congregazione si mosse in cerchio in una sorta di ballo solenne, chiamato spiritual shuffle, stringendosi le mani l'un l'altro e chiamandosi per nome mentre cantavano
My sis'r Mary's boun' to go;
My sis'r Nanny's boun' to go;
My brudder Tony's boun' to go;
My brudder July's boun' to go.
(Mia sorella Mary deve andare
Mia sorella Nanny deve andare
Mio fratello Tony deve andare
Mio fratello July deve andare)
Questo con la stessa melodia, finché ogni mano fu stretta da ognuno. Quando arrivarono a Harriet, che era straniera, cantarono
Eberybody's boun' to go!
(Ognuno deve andare)
Quindi il corpo fu messo nel carro funebre e, alla luce delle torce, la strana, oscura processione si mosse, cantando un rozzo inno funebre, finché non raggiunsero il luogo della sepoltura" (pp. 43-44). Il testo completo del canto intonato durante il funerale ci è dato da Th.W. Higginson (1867, p. 686), che lo intitola Bound to go:
Jordan River, I'm bound to go,
Bound to go, bound to go, -
Jordan River, I'm bound to go,
And bid 'em fare ye well.
My Brudder Robert, I'm bound to go,
Bound to go, ecc.
My Sister Lucy, I'm bound to go,
Bound to go, ecc.
È, per inciso, da sottolineare il fatto che il testo di questo canto può avere due interpretazioni: da una parte quella religiosa in una prospettiva escatologica, dall'altra il verso I'm bound to go, "devo andare", si potrebbe riferire a una speranza di fuga dello schiavo verso la libertà, il Nord. Questo procedimento di cantare inni sacri per significare invece una richiesta di libertà immediata ‒ il cosiddetto double talk ‒ era molto presente. Un'altra testimonianza di questo canto è contenuta nel volume di W.F. Allen - Ch.P. Ware - L. McKim Garrison, Slave Songs of the United States (New York 1867, p. 1):
My brudder sittin' on de tree of life,
An' he yearde when Jordan roll;
Roll, Jordan, Roll, Jordan, Roll, Jordan, roll!
O march de angel march,
O march de angel march;
O my soul arise in Heaven, Lord,
For to yearde when Jordan roll.
Little chil'en, learn to fear de Lord,
And let your days be long;
Roll, Jordan, ecc.
O, let no false nor spiteful word
Be found upon your tongue;
Roll, Jordan, ecc.
Mio fratello è seduto sull'albero della vita,
E ascolta quando il Giordano scorre;
Scorri, Giordano, scorri, Giordano, scorri, Giordano, scorri!
Marcia la marcia dell'angelo,
Marcia la marcia dell'angelo;
La mia anima arriva in Paradiso, Signore,
Per ascoltare quando il Giordano scorre.
Piccoli bambini, imparate ad aver paura del Signore,
Fate che i vostri giorni siano lunghi;
Scorri, Giordano, ecc.
O, fate che nessuna parola falsa o maligna
Sia trovata sulla vostra lingua;
Scorri, Giordano, ecc.
Sono piuttosto evidenti in questo testo almeno due diversi punti nei quali poter individuare il double talk. Il quarto, quinto e sesto verso di ogni strofa recitano: "marcia la marcia degli angeli / marcia la marcia degli angeli / la mia anima salirà in Paradiso". Il cantante, quindi, non soltanto spera in una rinascita in Paradiso, ma anche in una salita (arise) verso il Nord, dove non c'è la schiavitù. La seconda strofa inizia così: "Piccoli bambini, imparate ad aver paura del Signore". Ma il Signore può essere sia Dio, sia il padrone, e assume così un ben più pregnante significato il secondo verso "Fate che i vostri giorni siano lunghi".
Lettura simile può esser data di un altro canto, tratto sempre dalla raccolta su citata (p. 8), dal titolo There's a Meeting here To-Night:
I take my text in Mattew, and by de Revelation,
I know you by your garment,
Dere's a meeting here to-night.
Dere's a meeting here to-night,
Oh! / (Brudder Tony,) Dere's a meeting here to-night,
Oh! / (Sister Rina,) Dere's a meeting here to-night,
I hope to meet again.
Prendo il mio testo in Matteo, e dall'Apocalisse,
Ti riconosco da ciò che indossi,
C'è una riunione qui stanotte.
C'è una riunione qui stanotte,
Oh! / (Fratello Tony,) c'è una riunione qui stanotte,
Oh! / (Sorella Rina,) c'è una riunione qui stanotte,
Speriamo di incontrarci ancora.
Leggendo questo testo non si può non pensare alla cosiddetta Underground Railroad, la "ferrovia sotterranea", un'organizzazione fondata nel Nord sia da bianchi abolizionisti sia da neri fuggitivi che riuscì a far scappare tra i 60.000 e i 100.000 schiavi. Una figura di spicco nella organizzazione fu la già citata Harriet Tubman; nata schiava nel Maryland intorno al 1820 e sposata con un nero libero di nome John Tubman, nel 1849 fuggì assieme ad altri schiavi per paura di essere venduta e andò a Philadelphia. Nel corso di 10 anni compì 19 viaggi nel Sud e fece fuggire almeno 300 schiavi. Durante la guerra di secessione lavorò con l'esercito unionista facendo la cuoca, l'infermiera e la spia; dopo la guerra si stabilì a Auburn, New York. Morì nel 1913.
Il brano sicuramente più studiato in questo senso è Follow the Drinking Gourd, "Segui la Stella Polare". Dice il ritornello, piuttosto esplicito:
Follow the Drinking Gourd
Follow the Drinking Gourd
For the old man is waitin'
To carry you to freedom
Follow the Drinking Gourd.
Segui la Stella Polare
Segui la Stella Polare
Perché un vecchio ti sta aspettando
Per portarti verso la libertà
Segui la Stella Polare.
È ancora Charles Ball (1837) che ci dà un'altra preziosa testimonianza di un funerale. "Pochi giorni prima di Natale il suo bambino morì, dopo una malattia di soli tre giorni. Ho aiutato lei [scil. la madre] e suo marito a seppellire il bimbo ‒ che era piccolo ‒ e suo padre ha sepolto con lui un piccolo arco e numerose frecce; una piccola borsa con un pasto, una canoa in miniatura lunga circa un piede [28 cm ca.], un piccolo remo (col quale il padre diceva che il piccolo avrebbe attraversato l'oceano sino alla sua patria), un piccolo bastone con un chiodo di ferro appuntito e fissato a una estremità, e un pezzo di mussola bianca, con molte figure curiose e strane dipinte in rosso e blu tramite le quali, disse, i suoi parenti e connazionali avrebbero saputo che il bambino era suo figlio e l'avrebbero accolto di conseguenza, al suo arrivo tra loro" (pp. 264-65).
L'eccezionalità della scoperta di New York ha consentito ‒ e consentirà, dato che sono ancora in corso gli studi ‒ di analizzare la vita di una comunità afroamericana nel corso di circa un secolo. Le analisi sulle ossa dell'African Burial Ground hanno permesso di stabilire che il 59% degli inumati era di età adulta, il 2% al di sotto dei due anni, il 32% di età puberale. Di particolare interesse è la tomba 335-356, nella quale sono stati trovati i resti scheletrici di una donna di età compresa tra i 25 e i 35 anni, sepolta in una cassa; i resti di un bambino in tenera età nella piegatura del braccio destro hanno fatto pensare a una madre col proprio figlio, entrambi morti al momento del parto. Inoltre, intorno ai resti del bambino è stata trovata una ventina di spilli, probabilmente usati per fermare una veste con la quale era stato sepolto. Anche la tomba 226 conteneva i resti di una donna sepolta col proprio bambino di meno di 2 mesi; in corrispondenza del collo del bambino sono stati trovati 8 vaghi di collana, prodotti con una tecnica caratteristica dell'Africa Occidentale. Il vetro era prima sbriciolato, poi messo in un contenitore di argilla e bruciato; i vaghi erano quindi modellati e molati. Di grande interesse è anche la tomba 340, nella quale la donna deposta ‒ di un'età compresa tra i 39 e i 65 anni ‒ indossava un ornamento alla vita formato da conchiglie cauri e vaghi di vetro, di probabile produzione veneziana, e uno di ambra. La tomba 101 apparteneva a un uomo, morto in età relativamente giovane; è stato supposto che egli fosse stato probabilmente portato dall'Africa poiché i denti erano stati limati, un uso questo attestato in Africa Occidentale (Handler 1994). Sul coperchio della cassa che conteneva i resti dell'uomo è stato trovato un disegno formato da una novantina di chiodi che, secondo gli studiosi, è confrontabile con il Sankofa, simbolo Akan dell'uccello col capo rivolto all'indietro. L'estrema stilizzazione del disegno sarebbe dovuta alla volontà di mascherare il simbolo agli occhi dei bianchi, mantenendolo comprensibile ai propri connazionali. Il disegno della tomba 101 è stato scelto come simbolo dell'African Burial Ground, proprio per la caratteristica di guardare indietro; e proprio per questo il motto scelto per l'African Burial Ground è "Return to the past in order to built the future", ritornare al passato per costruire il futuro.
Bibliografia
Olaudah Equiano, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, the African, Written by Himself, London 1789; Ch. Ball, Slavery in the United States. A Narrative of the Life and Adventures of Charles Ball, a Black Man, Who Lived Forty Years in Maryland, South Carolina and Georgia, as a Slave under Various Masters, and Was One Year in the Navy with Commodore Barney, during the Late War, New York 1837; F. Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. Written by Himself, Boston 1845 (trad. it. Roma 1992); P. Neilson, The Life and Adventures of Zamba, an African Negro King; and His Experience of Slavery in South Carolina. Written by Himself. Corrected and Arranged by Peter Neilson, London 1847; H. Bibb, Narrative of the Life and Adventures of Henry Bibb, an American Slave, Written by Himself, New York 1849; F. Douglass, My Bondage and My Freedom, New York - Auburn 1855; H.A. Jacobs, Incidents in the Life of a Slave Girl. Written by Herself, Boston 1861; W.F. Allen - Ch.P. Ware - L. McKim Garrison, Slave Songs of the United States, New York 1867; Th.W. Higginson, Negro Spirituals, in Atlantic Monthly, 19 (June 1867), pp. 685-94; S.H. Bradford, Scenes in the Life of Harriet Tubman, Auburn 1869; Th.L. Johnson, Africa for Christ. Twenty-Eight Years a Slave, London 18926; G.G. Johnson, Ante-Bellum North Carolina: a Social History, Chapel Hill 1937; L. Turner, Africanisms in the Gullah Dialect, Chicago 1949; F. Spiegl, A Small Book of Grave Humour, London 1971; B. Armellin (ed.), La condizione dello schiavo. Autobiografie degli schiavi neri negli Stati Uniti, Torino 1975; M.C. Emerson, Decorated Clay Tobacco Pipes from Chesapeake, Ann Arbor 1988; P. Garrow - Th. Wheaton, Colonoware Ceramics: the Evidence from Yaughan and Curriboo Plantations, in A. Goodyear III - G.T. Hanson (edd.), Studies in South Carolina Archaeology. Essays in Honor of Robert L. Stephenson, Columbia 1989, pp. 175-84; J.M. Vlach, The Afro-American Tradition in Decorative Arts, Athens - London 1990; E.C. Brown, Florida's Peace River Frontier, Gainesville 1991; J.E. Holloway (ed.), Africanisms in American Culture, Bloomington - Indianapolis 1991; Th.A. Singleton, The Archaeology of Slave Life, in D.C. Campbell (ed.), Before Freedom Came: African-American Life in Antebellum South, Charlottesville 1991, pp. 155-75; J.S. Handler, Determining African Birth from Skeletal Remains: a Note on Tooth Mutilation, in Historical Archaeology, 28, 3 (1994), pp. 113-19; K.L. Brown, Material Culture and Community Structure: the Slave and Tenant Community at Levi Jordan's Plantation, 1848-1892, in Jr.L.E. Hudson (ed.), Working Toward Freedom: Slave Society and Domestic Economy in the American South, Rochester 1995, pp. 95-118; M.L. Blakey, The New York African Burial Ground Project: an Examination of Enslaved Lives, a Construction of Ancestral Ties, in Transforming Anthropology, 7, 1 (1998), pp. 53-58; M.H. Cottman, The Wreck of the Henrietta Marie: an African American's Spiritual Journey to Uncover a Sunken Slave Ship's Past, New York 1999; D. Eltis, The Rise of African Slavery in the Americas, Cambridge - New York 2000; S.A. Kallen, Life on the Underground Railroad, San Diego 2000; M.P. Leone, L'archeologia storica nelle terre dei colonizzatori, in N. Terrenato (ed.), Archeologia teorica. X ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia (Certosa di Pontignano, Siena, 9-14 agosto 1999), Firenze 2000, pp. 267-80; M.J. Pulice, The Log Outbuilding at Solitude: an Architectural and Archaeological Investigation of Virginia Tech's Second Oldest Building (Master of Sciences in Architecture Thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University), Blacksburg 2000; K.L. Brown, Interwoven Traditions: Archaeology of the Conjurer's Cabin and the African American Cemetery at the Jordan and Frogmore Manor Plantations, in Place of Cultural Memory: African Reflections on the American Landscape. Conference Proceedings (Atlanta, May 9-12, 2001), Washington (D.C.) 2001, pp. 99-114; A. Heinrichs, The Underground Railroad, Minneapolis 2001; A.I. Kashif, Africanisms upon the Land: a Study of African Influenced Place Names of the USA, in Place of Cultural Memory: African Reflections on the American Landscape. Conference Proceedings (Atlanta, May 9-12, 2001), Washington (D.C.) 2001, pp. 15-34; B.D. Joyner, African Reflections on the American Landscape. Identifying and Interpreting Africanisms, Washington (D.C.) 2003; D. Eltis - D. Richardson, Prices of African Slaves newly Arrived in the Americas: 1673-1865. New Evidences of Long-Run and Regional Differences, in D. Eltis - F.D. Lewis - K.L. Sokoloff (edd.), Slavery in the Development of the Americas, Cambridge 2004, pp. 181-218; J.C. Monroe - S. Mallios - Q. Emmet, A Dating Formula for Colono Tobacco Pipes in the Chesapeake, in The Journal of the Jamestown Rediscovery Center, 2 (2004), pp. 1-5.
La musica afroamericana: tre esempi
di Alessandro Campus
Solitamente si dà come data di nascita del blues il 1903, secondo la testimonianza di William Christopher Handy: una notte di quell'anno, mentre si trovava nella stazione di Tutwiler, nel Mississippi, egli sentì un cantante che suonava una canzone in uno stile mai sentito prima. Il brano si intitolava Going where the Southern Crosses the Yellow Dog, "Andando dove il Southern incrocia lo Yellow Dog" (il Southern e lo Yellow Dog sono due linee ferroviarie). Il musicista suonava la chitarra senza premere le corde sulla tastiera, ma sfregandole con la lama di un coltello. Handy rimase stupito e trascrisse il brano, che poi pubblicò a proprio nome. Da allora, è stato definito come blues uno stile musicale del popolo afroamericano che, come caratteristiche musicali, ha "una progressione armonica in cui la prima frase era alla tonica, la seconda alla sottodominante e la terza alla dominante, con la formula seguente: I-I-I-I7-IV-IV-I-I-V7-V7-I-I" (Venturini 1984, p. 159).
Ma prima del blues il popolo afroamericano aveva altre forme musicali. Sin dalla metà del XIX secolo si è cominciato a raccogliere i canti degli schiavi afroamericani. Nel 1856 F.L. Olmsted pubblicava la sua opera A Journey in the Seaboard Slave States; with Remarks on their Economy, nella quale parlava anche dei canti che gli schiavi del Sud degli Stati Uniti intonavano, sia quando lavoravano, sia quando pregavano, sia durante le feste. Addirittura, in una parte del suo volume, intitolata The Musical Talent of Negroes, Olmsted scrive: "L'amore per la musica che caratterizza il negro, la prontezza con la quale acquisisce l'abilità in questa arte, la sua capacità di memorizzare e improvvisare la musica sono molto marcati e costanti. (...) I negri delle piantagioni, o i marinai delle navi a vapore ‒ le cui menti sono così poco istruite che non sanno contare sino a venti ‒ spesso, caricando balle di cotone, o trasportando legname a bordo, iniziano a cantare, ognuno con una parte diversa, e la portano avanti con grande energia e indipendenza e in perfetta armonia come non ho mai sentito da parte di cantanti, che non sono stati particolarmente educati, al Nord " (pp. 552-53). Qualche anno dopo, nel 1867, W.F. Allen, Ch.P. Ware e L. McKim Garrison pubblicarono una raccolta di canti: Slave Songs of the United States. Come aveva fatto Olmsted, anche Allen, Ware e McKim Garrison attribuirono la capacità di cantare dei neri a una caratteristica "razziale"; così comincia la loro opera: "La capacità musicale della razza negra è stata riconosciuta da così tanti anni che è difficile spiegare perché fino a oggi non è stato fatto alcun tentativo sistematico di raccogliere e conservare le loro melodie. Più di trent'anni fa hanno fatto la loro comparsa quelle plantation songs" (p. I).
Bisogna però attendere gli anni Trenta del Novecento per sentire direttamente dalla voce di un cantante questi brani. Nel 1934 John Lomax e Alan Lomax fecero un viaggio nel Sud degli Stati Uniti, allo scopo di documentare la musica afroamericana; durante questo viaggio registrarono circa 25 ore di musica e più di 300 musicisti, tra i quali Huddie Ledbetter, noto col soprannome di Leadbelly.
Leadbelly
Leadbelly nacque intorno al 1885 nella zona di Caddo Lake, vicino a Mooringsport, in Louisiana. Nel 1901 fuggì di casa, per sottrarsi alla rigida educazione del padre, e si trasferì a Dallas, in Texas, dove incontrò il bluesman Blind Lemon Jefferson, uno dei più famosi musicisti texani. Rimase con Blind Lemon Jefferson fino al 1917, quando fu condannato a trent'anni di lavori forzati per omicidio e rinchiuso nel penitenziario di Huntsville; nel 1924 il governatore del Texas Pat Neff si recò in visita proprio nella prigione in cui era rinchiuso Leadbelly, il quale cantò durante il pranzo del governatore; grazie alle sue abilità di cantante e chitarrista, il governatore gli concesse la grazia e fu così liberato il 15 gennaio 1925. Ma cinque anni dopo, Leadbelly fu nuovamente condannato per tentato omicidio e rinchiuso nel Louisiana State Penitentiary di Angola, forse la prigione più dura di tutti gli Stati Uniti. Proprio ad Angola i Lomax incontrarono Leadbelly, che raccontò loro la propria vita. Tra le molte canzoni che i Lomax registrarono, vi era anche Governor O.K. Allen, con la quale il cantante chiedeva la grazia al governatore della Louisiana del tempo. I Lomax mandarono questa registrazione al governatore: arrivò così la seconda grazia e da quell'anno visse da uomo libero ‒ fatto salvo un anno di carcere per rissa; si trasferì a New York, dove morì il 6 dicembre 1949.
Sia nelle registrazioni che i Lomax fecero nella prigione di Angola, sia in quelle successive, Leadbelly ci offre un panorama della musica afroamericana che sino a quel momento era nota solamente attraverso descrizioni: blues, work songs, gospels, ballate, nessuno stile musicale gli era ignoto; il suo immenso repertorio ‒ comprendente più di 600 brani ‒ ci offre uno spaccato della musica nera americana come nessun altro cantante è mai riuscito a dare. Di particolare interesse sono le work songs che egli ha inciso: nato durante il periodo della schiavitù, questo tipo di brani aveva vari scopi, il principale dei quali era quello di sincronizzare il lavoro dei vari componenti della squadra. Un esempio di work song è Lining Track, cantata durante la messa in opera dei binari:
Good morning, Eloise,
Go linin' track
All I hate about linin' track
These ol' bars 'bout to break my back
Oh boy, can't you line 'em
Oh boy, can't you line 'em
Oh boy, can't you line 'em
See Eloise goin' linin' track
If I could I surely would
Stand on rock where Moses stood
Oh boy, can't you line 'em
Oh boy, can't you line 'em
Oh boy, can't you line 'em
See Eloise goin' linin' track
Moses stood on the Red Sea shore
He was battin' at the waves with a two-by-four
Oh boy, can't you line 'em
Oh boy, can't you line 'em
Oh boy, can't you line 'em
See Eloise goin' linin' track.
Buon giorno, Eloise, vai ad allineare il binario
Tutto quello che odio dell'allineare il binario
È che queste sbarre stanno per rompermi la schiena
Oh ragazzo, non puoi allinearle?
Oh ragazzo, non puoi allinearle?
Oh ragazzo, non puoi allinearle?
Guarda Eloise che sta per allinearle
Se potessi sicuramente vorrei
Stare sulla roccia su cui stava Mosè
Oh ragazzo, non puoi allinearle?
Oh ragazzo, non puoi allinearle?
Oh ragazzo, non puoi allinearle?
Guarda Eloise che sta per allinearle
Mosè stava sulle rive del Mar Rosso
Stava colpendo le onde con un bastone
Oh ragazzo, non puoi allinearle?
Oh ragazzo, non puoi allinearle?
Oh ragazzo, non puoi allinearle?
Guarda Eloise che sta per allinearle.
In questo brano si trovano le caratteristiche delle work songs: il leader canta il primo verso (Good morning, Eloise) e il gruppo risponde col secondo (Go linin' track); ricomincia il leader che canta i due versi successivi (All I hate about linin' track / These ol' bars 'bout to break my back), i compagni rispondono con il ritornello (Oh boy, can't you line 'em, ecc.).
Un'altra caratteristica dei canti afroamericani è la costante identificazione della propria vicenda con quella del popolo di Israele, sia durante il periodo in Egitto che con quello della "cattività babilonese". Nel brano appena riportato il cantante vuole essere come Mosè, che conduce attraverso il Mar Rosso gli Ebrei verso la libertà, la Terra Promessa. Ma l'identificazione del bluesman è anche con alcuni animali, considerati dall'uomo (il "bianco") come prede, ma che invece riescono sempre a salvarsi. Si veda, ad esempio, The Grey Goose, interpretata da Leadbelly con il Golden Gate Jubilee Quartet nel 1940 (testo e trad. in Venturini 1984, pp. 64-65):
It was one Sunday mornin',
Lawd, Lawd, Lawd,
The preacher went a-huntin'.
He carried along his shotgun.
Well, along come a grey goose
Well, he throwed it to his shoulder,
The gun went off: boo lum!
And down come a grey goose.
He was six weeks a-fallin'
He was six weeks a-findin'
And my wife and yo' wife,
They give him feather pickin'
They was six weeks a-pickin'
An' they put him on to parboil
He was six months a-parboil',
And they put him on the table,
And the knife couldn't cut him
And the fork couldn' stick him,
An' they throwed him in the hog-pen,
And the hog couldn't eat him
Aw, he broke the hog's teeth out
They tak'n him to the saw mill,
And the saw wouldn't cut him
An' de last time I seed him,
Well, he was flyin' cross the ocean,
With a long string o' goslin's,
An' they all goin' "quack quack".
Era una domenica mattina
Signore, Signore, Signore
Il predicatore se ne andò a caccia,
Col fucile
Arrivò un'oca grigia
se lo mise sulla spalla
e il fucile fece boo lum!
cadde un'oca grigia
E ci mise sei settimane a cadere
e ci mise sei settimane a trovarla
Mia moglie e tua moglie
Si misero a spennarla
E impiegarono sei settimane
La misero a bollire
E bollì per sei settimane
La portarono a tavola
E il coltello non la tagliava
La forchetta non si conficcava
E allora la buttarono ai porci
Ma il maiale non poté mangiarla
Perché gli ruppe i denti
La portarono alla segheria
Ma la sega non la tagliava
Perché ruppe i denti alla sega
E l'ultima volta che l'ho vista
Volava sull'oceano
Con una lunga fila di ochette
Che facevano "quack quack".
È facile leggere in questo brano l'identificazione del nero con l'oca che il predicatore (il "bianco") non riesce comunque a sconfiggere. Allo stesso modo vanno letti i racconti del folklore afroamericano, che riportano le storie di Brer Rabbit, il Fratel Coniglietto di disneyana memoria, che lotta costantemente con Brer Fox (Comare Volpe) e Brer Bear (Compare Orso): il coniglio, più piccolo e meno forte degli altri due, è comunque più furbo e con le proprie astuzie riesce non solo a sconfiggerli, ma anche a metterli in ridicolo.
Un altro tipo di brani nel repertorio di Leadbelly sono i cosiddetti field hollers, i richiami che i lavoratori dei campi intonavano per comunicare tra loro. È ancora Douglass (1845) che ci dà una idea dei canti degli schiavi nelle piantagioni: ‟Gli schiavi scelti per andare alla Great Farm House per la assegnazione mensile loro e dei loro compagni erano particolarmente entusiasti. Mentre andavano, facevano riverberare i boschi, per miglia, con i loro canti selvaggi, che rivelavano la più grande gioia e la più profonda tristezza. Componevano le canzoni mentre camminavano, senza mettersi d'accordo né sul tempo né sulla melodia. I loro pensieri erano espressi se non con la parola col suono, e frequentemente sia nell'una che nell'altro. A volte cantavano il sentimento più toccante nella melodia più entusiastica e il sentimento più entusiastico nella melodia più toccante. In tutte le loro canzoni riuscivano a parlare delle Great House Farm, specialmente quando partivano. Cantavano allora in maniera molto allegra le seguenti parole: 'Sto andando alla Great House Farm!' (I am going away to the Great House Farm!). (...) Quando ero schiavo, non capivo il profondo significato di quelle canzoni rozze e apparentemente incoerenti. Io stesso ero nell'ambiente; (...) Raccontavano una storia di dolore che a quel tempo era al di là della mia scarsa comprensione; mormoravano la preghiera e il lamento degli animi che traboccavano della più dolorosa angoscia. Erano melodie alte, lunghe e profonde. Ogni melodia era una testimonianza contro la schiavitù. (...) Se qualcuno vuole essere colpito dagli effetti che uccidono l'anima della schiavitù, vada alla piantagione del Colonnello Lloyd il giorno della assegnazione, vada nel bosco di pini e lì ascolti in silenzio i suoni che arriveranno nel profondo della sua anima, e se non rimarrà impressionato, sarà perché 'non c'è carne nel suo cuore indurito'" (pp. 13-14).
Leggendo queste descrizioni, non si può non pensare a brani di Leadbelly quali Cotton Fields, "Campi di cotone":
Oh when the cotton bolls get rotten
You can't pick very much cotton
In them old cotton fields at home
Quando la capsula di cotone marcisce
non puoi raccogliere molto cotone
in quei campi di cotone a casa.
A una melodia apparentemente allegra, si abbina un testo che nasconde una tragicità profonda. Se la pianta del cotone era rovinata, i braccianti avrebbero raccolto una minore quantità di prodotto, per essere quindi pagati meno. Questo problema è descritto in un blues di Leadbelly, The Boll Weevil. Boll weevil è un termine prettamente afroamericano che indica un curculionide, che, annidandosi nelle gemme della pianta del cotone, rovina irrimediabilmente il raccolto.
You can talk about the latest, the latest of your home,
These devilish boll weevils, they gonna rob you of a home,
They're a-looking for a home, they're a-looking for a home.
The first time I seen him, he was sitting on the square,
Next time I seen him, he was spreadin' ev'rywhere,
He was looking for a home, He was looking for a home.
Farmer taken the boll weevil, put him in the sand,
Boll weevil said to the farmer, "This is treating me like a man.
I have a home, I have a home".
Farmer taken the boll weevil, put him on the ice,
Boll weevil said to the farmer, "You is treating me mighty nice.
I'll have a home, I'll have a home".
The farmer and his went out 'cross the field,
The farmer said to the old lady "I found a lotta meat and meal,
I'll have a home, I'll have a home".
Ol' lady said to the ol' man "I'm tryin' my level best
To keep these devilish boll weevils outa my ol' cotton dress
It's full of holes, and it's full of holes".
Farmer said to the ol' lady, "What do you think of that?
I got some devilish boll weevils out of ol' Stetson hat
And it's full of holes, and it's full of holes".
Farmer told to the merchant, "I didn't make but one bale,
Before I'll let you have that last one, I'll suffer and die in jail,
I will have a home, I will have a home".
Puoi parlare dell'ultima, l'ultima novità di casa,
Questi boll weevils infernali, ti deruberanno della casa,
Stanno cercando casa, stanno cercando casa.
La prima volta in cui lo vidi, era seduto nella gemma del cotone,
La volta successiva in cui lo vidi si stava espandendo ovunque
Stava cercando casa, stava cercando casa.
L'agricoltore prese il boll weevil, e lo mise nella sabbia,
Il boll weevil disse all'agricoltore "Questo è trattarmi come un uomo.
Ho una casa, ho una casa".
L'agricoltore prese il boll weevil, e lo mise nel ghiaccio,
Il boll weevil disse all'agricoltore "Mi stai trattando proprio bene
Avrò una casa, avrò una casa".
L'agricoltore e il boll weevil uscirono nel campo,
L'agricoltore disse alla moglie "Ho trovato molta carne e cibo,
Avrò una casa, avrò una casa".
La moglie disse al marito "Sto facendo del mio meglio
Per mandar via questo boll weevil infernale dal mio vestito di cotone
È pieno di buchi, è pieno di buchi".
L'agricoltore disse alla moglie "Cosa pensi di questo?
Ho alcuni boll weevils infernali sul mio cappello
Ed è pieno di buchi, è pieno di buchi".
L'agricoltore disse al mercante "Ho fatto solo una balla,
Prima che ti lasci questa ultima, soffrirò e morirò in prigione,
Avrò una casa, avrò una casa".
Al di là della prima interpretazione ‒ la cattiveria del boll weevil che rovina il raccolto dell'agricoltore ‒ è possibile anche un'altra chiave di lettura: a ben vedere, il boll weevil non fa altro che cercare una casa ‒ condizione classica del nero povero ‒ e cerca in ogni modo un luogo in cui vivere, ma anche l'agricoltore è rovinato dalla situazione. Alla fine, sia il boll weevil che l'agricoltore sono sconfitti di fronte al mercante: "Prima che ti lasci questa ultima, soffrirò e morirò in prigione" dice il secondo verso dell'ultima strofa. Alla fine, la prigione è l'unico luogo in cui il contadino potrà andare.
La sofferenza del nero afroamericano trova la sua massima espressione nel blues. Cosa sia il blues lo spiega Leadbelly nella introduzione parlata al suo Good Morning Blues:
Now, this is Good Morning Blues. And I'll tell you about the blues. All negroes like blues. Why? Because they are born with the blues. And now, everybody has the blues. Sometimes they don't know what it is, but when you lay down at night, turning from one side to the bed all night to the other and can't sleep, what's the matter? Blues got you. (...) You say "Lord, have mercy. I can't eat and I can't sleep". What's the matter? Blues still got you. They want to talk to you. You got to tell them something.
Bene, questa è Good Morning Blues. Vi parlerò dei blues. A tutti i negri piace il blues. Perché? Perché sono nati con i blues. E ora, tutti hanno i blues. Talvolta non sanno che cosa sia, ma quando di notte sei coricato, e ti giri tutta la notte da una parte all'altra del letto e non puoi dormire, che cosa succede? I blues ti hanno preso. (...) Dici: "Signore, abbi pietà. Non posso mangiare e non posso dormire". Che cosa succede? I blues ti hanno preso ancora. Vogliono parlare con te. Devi dir loro qualcosa.
È evidente, in questo testo, la polivalenza semantica della parola "blues": Leadbelly si riferisce sia allo stile musicale, sia al sentimento di profonda tristezza sia alla personificazione di tale sentimento. Da una parte il cantante dice all negroes like blues, dall'altra dice everybody has the blues. Ma, ancora, alla fine della lunga introduzione, si dice They want to talk to you. You got to tell them something: i blues sono personificati, sono esseri con i quali ognuno deve fare i conti. L'angoscia che prende il nero arriva a essere definita come qualcosa di altro da sé, qualcosa di ineludibile, che lo prende quando nasce e lo abbandona quando muore. D'altronde, dice sempre Leadbelly in una strofa di De Kalb Blues ("Blues di De Kalb"):
Blues was whisky stay drunk all time
Blues was whisky stay drunk all time
Stay drunk, baby, got you off my mind.
Se il blues fosse stato whisky sarei stato ubriaco tutto il tempo
Se il blues fosse stato whisky sarei stato ubriaco tutto il tempo
Ubriaco, ragazza, saresti stata fuori dai miei pensieri.
Ma se da una parte Leadbelly fu il più grande testimone non solo di una musica, ma anche di una cultura che ormai andavano tramontando, suo contemporaneo fu uno dei maggiori bluesmen della storia, colui che ha definitivamente cambiato la storia della musica nera: Robert Johnson.
Robert johnson
La storia di Robert Johnson è avvolta nel mistero: le sue origini, le date della sua vita, tutto è incerto e dubbio, fatta salva la sua musica. Tra il 1936 e il 1937 in due sedute di incisione registrò appena 29 canzoni; ma tra queste c'erano brani come Dust my Broom, Sweet Home Chicago, Preaching Blues, If I Had Possession over Judgment Day. Da quei giorni degli anni Trenta, il blues sarebbe stato completamente diverso.
Le ricerche degli studiosi di musica afroamericana sono riuscite a ricostruire alcune tappe della vita di questo bluesman; nacque, illegittimo, forse l'8 maggio 1911 da Julia Major Dodds. Il suo nome completo era Robert Leroy Dodds Spencer (quest'ultimo cognome era stato adottato dal marito della madre quando si trasferì da Hazlehusrt, Mississippi, a Memphis), ma prese quello di Johnson quando scoprì chi era il suo vero padre. Negli anni Trenta viaggiò attraverso lo Stato del Mississippi e nel 1936 andò in un negozio di musica a Jackson; era il negozio di H.C. Speir, un bianco che faceva incidere i musicisti della zona. Fu lui, ad esempio, che portò in sala di incisione bluesmen quali Charley Patton, Son House, Skip James. A quel tempo Speir collaborava con la ARC e, dopo l'audizione, passò il nome al talent scout di quella casa discografica. Fu così che Robert Johnson andò a San Antonio, Texas, a registrare, il 23 e il 26 novembre 1936; tra le 16 canzoni incise, ci sono alcuni tra i più importanti brani della musica afroamericana, come Preaching Blues e Cross Road Blues. L'anno successivo, nel 1937, tornò in sala di registrazione, questa volta a Dallas, sempre in Texas: il 19 e il 20 giugno incise le sue ultime 13 canzoni. Morì nella notte tra il 15 e il 16 agosto 1938.
La leggenda di Robert Johnson nacque immediatamente: addirittura, nel 1939 Alan Lomax, durante il suo viaggio di ricerca sulla musica afroamericana, si recò proprio nelle zone frequentate dal musicista chiedendo sue notizie. Proprio gli amici che il musicista frequentava negli anni del vagabondaggio da una città all'altra hanno alimentato l'alone di leggenda intorno a lui. Ad esempio, Son House, che fu anche uno dei maestri di Johnson, raccontò che il giovane Robert voleva imparare a suonare, ma non ci riusciva. Nonostante ciò, seguiva Son House e Willie Brown ovunque suonassero; durante le pause delle esibizioni prendeva la chitarra e cercava di suonare, ma veniva fermato subito perché suonava malissimo; dopo un po', sparì per ricomparire circa un anno dopo. Ecco le parole di Son House: "Io e Will [scil. Brown] stavamo suonando in un paesino chiamato Banks, a est di Robinsonville. Era un sabato sera e a un tratto entrò qualcuno. Era proprio lui, e con una chitarra che gli pendeva dalla spalla! Io dissi: 'Bill! Hai visto chi c'è?' Lui alzò lo sguardo: 'Ah sì, il piccolo Robert'. E io: 'Ha una chitarra!' La cosa ci fece ridere. Poi Robert riuscì a farsi largo tra la gente e ad arrivare tra noi. Disse qualcosa e io gli risposi: 'Be' ragazzo, ancora con la chitarra? E che cosa vuoi fare? È inutile, non sei capace'. E lui: 'Aspetta e vedrai. Lasciami il tuo posto solo per un minuto'. 'Va bene,' gli dissi 'ma cerca di combinare qualcosa di buono' e schiacciai l'occhio in direzione di Willie. Robert si sedette e iniziò a suonare. Diavolo se era diventato bravo! Quando ebbe finito eravamo tutti a bocca aperta. Io pensai: 'Ce l'ha fatta. E anche in fretta'" (cit. in Guralnick 1991, pp. 26-27). Son House ‒ e non solo lui, ma anche molti altri bluesmen del Mississippi ‒ pensava che Johnson, per riuscire a imparare a suonare la chitarra in così breve tempo avesse venduto l'anima al diavolo. D'altro canto, sono gli stessi testi delle canzoni di Robert Johnson che trattano argomenti del genere. Questo è il testo di Me and the Devil Blues ("Blues di me e del diavolo"):
Early this mornin' when you knocked upon my door
Early this mornin', ooh, when you knocked upon my door
And I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go".
Me and the Devil was walkin' side by side
Me and the Devil, ooh, was walkin' side by side
And I'm goin' to beat my woman until I get satisfied.
She say you don't see why that you will dog me 'round
(spoken) Now, babe, you know you ain't doin' me right, don'cha
She say you don't see why, ooh, that you will dog me 'round
It must-a be that old evil spirit so deep down in the ground.
You may bury my body down by the highway side
(spoken) Baby, I don't care where you bury my body when I'm dead and gone
You may bury my body, ooh, down by the highway side
So my old evil spirit can catch a Greyhound bus and ride.
Questa mattina presto quando hai bussato alla mia porta
Questa mattina presto, ooh, quando hai bussato alla mia porta
E io ho detto "Ciao, Satana, credo che sia il momento di andare".
Io e il Diavolo stavamo camminando fianco a fianco
Io e il Diavolo, ooh, stavamo camminando fianco a fianco
E picchierò la mia donna sino a che non sarò soddisfatto.
Lei dice "Non vedi che mi stai picchiando qua e là"
(parlato) Lo sai, bambina, che mi stai trattando male, vero?
Lei dice "Non vedi che mi stai picchiando qua e là"
Deve essere quel vecchio spirito cattivo che abita nella terra profonda.
Mi puoi seppellire al lato dell'autostrada
(parlato) Bambina, non mi importa dove seppellisci il mio corpo quando sono morto
Mi puoi seppellire, ooh, al lato dell'autostrada
Così il mio vecchio spirito cattivo può prendere un pullman e andarsene.
Anche qui, l'angoscia esistenziale del cantante si personifica nel diavolo: è il diavolo che lo va a prendere a casa; è il diavolo, con il quale Robert Johnson cammina fianco a fianco, che lo spinge a picchiare la propria donna. Anche in altri brani Robert Johnson personifica il proprio disagio di vivere; si veda, ad esempio, il testo della prima strofa di Hellhound on my Trail ("Un cerbero sulle mie tracce"):
I got to keep movin', I've got to keep movin'
Blues fallin' down like hail,
Blues fallin' down like hail.
Umm
Blues fallin' down like hail,
Blues fallin' down like hail.
And the days keeps on worryin' me,
There's a hellhound on my trail
hellhound on my trail
hellhound on my trail.
Mi devo muovere, mi devo muovere,
I blues stanno cadendo come grandine,
I blues stanno cadendo come grandine.
Umm
I blues stanno cadendo come grandine,
I blues stanno cadendo come grandine.
I giorni continuano a preoccuparmi,
C'è un cerbero sulle mie tracce
Un cerbero sulle mie tracce
Un cerbero sulle mie tracce.
Ma il brano nel quale si è visto maggiormente il rapporto tra Robert Johnson e il diavolo è Crossroad Blues ("Blues dell'incrocio"). Questo brano rimanda a una tradizione raccontata da un altro bluesman, Tommy Johnson: "Se vuoi imparare a suonare qualunque strumento ti passi per la testa e a scrivere canzoni, devi prendere la chitarra e andare dove c'è un crocicchio. Per essere sicuro, devi arrivarci prima di mezzanotte. Poi prendi la chitarra e ti metti a suonare qualcosa. (...) Allora vedrai arrivare un grande uomo nero che ti prenderà la chitarra, la accorderà, suonerà una canzone e te la restituirà. È così che ho imparato a suonare tutto quello che ti pare" (cit. in Guralnick 1991, p. 28). Canta Robert Johnson:
I went to the crossroad, fell down on my knee
I went to the crossroad, fell down on my knee
Asked the Lord above "Have mercy, save poor Bob, if you please".
Sono andato al crocicchio, sono caduto in ginocchio
Sono andato al crocicchio, sono caduto in ginocchio
Ho chiesto al Signore lassù "Abbi pietà, salva il povero Bob, se vuoi".
È questo il mondo in cui si muoveva Robert Johnson, un mondo cupo, oscuro, nel quale la magia aveva una larga parte. È ancora Hellhound on my Trail che riporta la testimonianza di una fattura:
You sprinkled hot foot powder, mm, around my door
All around my door
You sprinkled hot foot powder, mm, around my door
All around your daddy's door, mm
It keep me with ramblin' mind, rider
Every old place where I go
Every old place where I go.
Hai sparso la "polvere del piede" calda intorno alla mia porta, mm, intorno alla mia porta
Tutto intorno alla mia porta
Hai sparso la "polvere del piede" calda intorno alla mia porta, mm, intorno alla porta del tuo caro, mm
Mi ha fatto uscire di testa, ragazza
In ogni luogo in cui vado
In ogni luogo in cui vado.
Non si può non ricordare, a proposito della hot foot powder, quanto già detto prima a proposito dei riti magici: si tratta di un preparato che doveva servire a far cambiare le persone con le quali veniva usato. Anche le tradizioni sulla sua morte sono legate al soprannaturale: sebbene appaia probabile che egli sia stato avvelenato, alcuni suoi amici dell'epoca raccontano che era stato il diavolo a portarlo via; nel crocicchio in cui egli si era recato aveva venduto l'anima al diavolo in cambio del successo. Una volta raggiuntolo, il diavolo sarebbe andato a prendersi ciò che gli era stato promesso.
Se da una parte Son House fu il maestro di Robert Johnson, dall'altra moltissimi furono i suoi allievi: McKinley Morganfield ‒ poi noto come Muddy Waters ‒, Robert Jr. Lockwood, Elmore James, solo per citare quelli che poi avrebbero avuto un grande successo nel blues dello stile di Chicago.
Elmore james
Elmore James imparò a suonare la chitarra da Robert Johnson; da lui apprese la tecnica cosiddetta slide, o bottleneck, consistente nel suonare la chitarra sfregando sulle corde una barretta metallica o un cilindro di vetro.
Nato il 27 gennaio 1918 a Richland, nel Mississippi, nel 1937, durante i suoi viaggi nel Delta ‒ l'area compresa tra il Mississippi e il suo affluente Yazoo ‒ frequentò i più importanti musicisti del tempo: Sonny Boy Williamson II, Robert Jr. Lockwood e Robert Johnson. Da quest'ultimo Elmore James imparò non soltanto la tecnica della chitarra slide, ma anche parte del repertorio. Dopo la morte del suo maestro, andò via dal Mississippi (pare per paura di subire la stessa fine) e, dopo il servizio militare tra il 1943 e il 1945, si unì con Sonny Boy Williamson e il cugino Homesick James; proprio con Sonny Boy Williamson incise nel 1951 la prima versione postbellica dell'ormai classico brano di Robert Johnson Dust my Broom. Trasferitosi prima a Helena, in Arkansas, poi a Chicago, visse sempre una sorta di scissione: da una parte la paura di morire a causa di un problema cardiaco congenito ‒ e la necessità quindi di evitare fatiche ‒, dall'altra l'incapacità di stare lontano dalle campagne del Sud in cui era nato e vissuto. La morte lo colse a Chicago il 24 maggio 1963, all'età di 45 anni, proprio a causa dei problemi cardiaci che tanto temeva.
Elmore James, seguendo la lezione del maestro, fu forse il musicista che più di tutti seppe approfondire gli aspetti più cupi e introversi della "musica del diavolo", come veniva chiamato il blues. Unendo ai testi delle sue canzoni una insuperata abilità nell'uso della tecnica slide trasposta nelle sonorità della chitarra elettrica, egli rappresenta il punto di unione tra il blues rurale del Mississippi e il nuovo ‒ per i tempi ‒ stile di Chicago. Ecco il testo di It Hurts Me Too ("Fa male anche a me"):
You said you was hurtin', you almost lost your mind
Now, the man you love, he hurt you all the time
But, when things go wrong, ooh, wrong with you,
it hurts me too.
You'll love him more when you should love him less
Why lick up behind him and take his mess
But when things go wrong, whoa, wrong with you,
it hurts me too.
He love another woman, yes, I love you
But, you love him and stick to him like glue
When things go wrong, ooh, wrong with you,
it hurts me too.
Now, he better leave you or you better put him down
No, I won't stand to see you pushed around
But, when things go wrong, ooh, wrong with you,
it hurts me too.
Dicevi che ti faceva male, avevi quasi perso la testa
Ora, l'uomo che ami ti fa male tutto il tempo
Ma quando le cose vanno male, ooh, vanno male con te
Fa male anche a me.
Lo amerai di più quando dovresti amarlo di meno
Perché gli stai appresso e ti fai carico dei suoi problemi?
Ma quando le cose vanno male, ooh, vanno male con te
Fa male anche a me.
Egli ama un'altra donna, sì, io amo te
Ma tu ami lui e gli sei attaccata come la colla
Ma quando le cose vanno male, ooh, vanno male con te
Fa male anche a me.
Ora, è meglio che egli ti lasci o meglio che tu lo pianti
No, non starò a guardarti sbattuta via
Ma quando le cose vanno male, ooh, vanno male con te
Fa male anche a me.
Tutta l'angoscia di una situazione sentimentale irrisolvibile diventa angoscia esistenziale in The Sky is Cryin' ("Il cielo sta piangendo"):
The sky is cryin', look at the tears roll down the street
The sky is cryin', look at the tears roll down the street
I'm wadin' in tears lookin' for my baby,
and I wonder, where can she be?
I saw my baby one mornin', and she was walkin' on down the street
I saw my baby one mornin', and she was walkin' on down the street
Made me feel so good,
until my poor heart would skip a beat.
I got a bad feelin', my baby, my baby don't love me no more
I got a bad feelin', my baby don't love me no more
Now, the sky's been cryin',
the tears rollin' down my nose.
Il cielo sta piangendo, guarda le lacrime che scorrono lungo la strada
Il cielo sta piangendo, guarda le lacrime che scorrono lungo la strada
Sto camminando in lacrime in cerca della mia ragazza
E mi chiedo: "Dove può essere?"
Una mattina ho visto la mia ragazza, stava passeggiando lungo la strada
Una mattina ho visto la mia ragazza, stava passeggiando lungo la strada
Mi ha fatto sentire bene
Sino a che il mio cuore non ha avuto un sobbalzo
Ho un cattivo presentimento, la mia ragazza, la mia ragazza non mi ama più
Ho un cattivo presentimento, la mia ragazza non mi ama più
Ora, il cielo sta piangendo,
Le lacrime stanno scorrendo sul mio naso.
Con l'uso della sua tecnica chitarristica, Elmore James in questo brano è riuscito a far perdere all'ascoltatore le prospettive, confondendo il sé con l'universo: se da una parte il cantante è disperato per la perdita della propria donna, dall'altro il dolore pervade tutto, in una visione totalizzante della realtà. Profondamente superstizioso, incapace di star fermo in un luogo per molto tempo, nella sua versione di Dust my Broom ripropone quasi testualmente i versi di Robert Johnson, ma cambia l'ultima strofa. Johnson cantava:
I believe, I believe I'll go back home
I believe, I believe I'll go back home
You can mistreat me here, babe, but you can't when I go home.
Credo, credo che tornerò a casa
Credo, credo che tornerò a casa
Qui mi puoi trattare male, ma non puoi quando vado a casa.
Significativamente diverso, invece, è ciò che cantava Elmore James:
I believe, I believe my time ain't long
I believe, I believe my time ain't long
I gotta leave my baby and break up my happy home.
Credo, credo che il mio tempo non sia lungo
Credo, credo che il mio tempo non sia lungo
Sto per lasciare la mia ragazza e rovinare la mia casa felice.
Con Elmore James i blues sono cambiati: non sono più (solo) i blues del cotone, i blues della siccità o delle alluvioni, i blues del lavoro nei campi del Sud, sono ormai qualcosa di diverso. Sono i blues della lontananza dalla propria terra, senza aver trovato una nuova terra, i blues della incapacità di vivere nel Nord e della impossibilità di vivere nel Sud. Ormai, sono (soprattutto) i blues della città. Questa è Coming Home ("Tornando a casa"):
Well now, look for me baby, you know I'm comin' home
Well now, look for me baby, because you know I'm comin' home
Well now, the reason why I left you down,
You know you'd done me wrong.
Well now, I'm comin' home to you baby and I ain't gonna leave no more
Yes, I'm comin' home to you baby and I ain't gonna leave no more
Yes, you know I done you wrong, darlin',
The last time I'm walkin' out your door.
Well now, I'll tell you, baby, just before I leave this town
Yes, I'm gonna tell you, baby, just before I leave this town
Well, I'm comin' home to you, baby,
And won't stand no pushin' around.
Bene, ora, cercami, ragazza, lo sai che sto tornando a casa
Bene, ora, cercami, ragazza, lo sai che sto tornando a casa
Bene, ora, la ragione per la quale ti ho lasciato giù
Lo sai che mi hai trattato male.
Bene, ora, sto tornando a casa da te, ragazza, e non ti lascerò più
Sì, sto tornando a casa da te, ragazza, e non ti lascerò più
Sì, lo sai che ti ho trattato male
L'ultima volta che sono uscito dalla tua porta.
Bene, ora, ti dirò, ragazza, appena prima di lasciare questa città
Sì, ti dirò, ragazza, appena prima di lasciare questa città
Bene, sto tornando a casa da te, ragazza,
E smetterò di fare il prepotente.
Per una conclusione
Quanto detto sin qui non può, e non vuole, essere che una presentazione quanto mai generale di un argomento che ha ormai alle spalle almeno un secolo di storia. Anche la scelta di presentare solamente tre esponenti della musica afroamericana è sicuramente riduttiva, ma sono probabilmente i musicisti che hanno maggiormente segnato la storia del blues: Leadbelly ‒ la tradizione; Robert Johnson ‒ l'innovazione; Elmore James ‒ il blues nelle città del Nord.
Il blues, soprattutto a partire dalla metà degli anni Cinquanta, è uscito dai luoghi in cui tradizionalmente veniva suonato; il rock and roll, in fondo, non è stato che una riproposizione da parte di musicisti bianchi per un pubblico di bianchi di schemi e motivi caratteristici del blues. Non è un caso, infatti, che Elvis Presley, all'inizio della propria carriera, incise That's All Right, un brano del bluesman Big Boy Crudup; e lo stesso Presley incise altri brani presi dal repertorio del blues: Mistery Train, Heartbreak Hotel, Hound Dog non sono altro che riprese dall'enorme patrimonio dei bluesmen. Più avanti nel tempo, troviamo i Rolling Stones, che presero il loro nome proprio da un blues e che incisero Love in Vain, una versione di un omonimo pezzo di Robert Johnson; i Beatles, d'altro canto, non hanno mai nascosto la loro ammirazione per Chuck Berry, del quale hanno inciso brani come Roll over Beethoven, o Johnny B. Goode.
Il movimento del cosiddetto blues revival, poi, durante gli anni Sessanta ha avuto il grande merito di riportare all'attenzione del grande pubblico musicisti come Lightnin' Hopkins, Sonny Boy Williamson II, Muddy Waters, Fred McDowell. In quegli anni si sono avute anche collaborazioni ‒ non sempre con risultati felici ‒ tra bluesmen neri e artisti rock bianchi. Ma una volta, durante una intervista, disse Muddy Waters, riferito ai musicisti rock che incidevano pezzi presi dal suo repertorio: "Possono suonare come me, ma non possono cantare come me".
Well, I woke up soon one morning, I had the blues all 'round my bed
Well, I woke up soon one morning, I had the blues all 'round my bed
Well I reach for my baby, and I got these blues instead.
I walked the streets late at night, till my feet turned soaking wet
Yes, I walked the streets late at night, till my feet turned soaking wet
Well, I asked all my friends, haven't heard talk of my baby yet.
Just wrote a letter back home to the boys, asking them "Please pray for my sins"
Yes, I wrote a letter back home to the boys, asking them "Please pray for my sins"
Well, I'm headed down toward the ocean, I believe that this is the end.
Mi sono svegliato presto una mattina, avevo i blues tutto intorno il mio letto
Sì, mi sono svegliato presto una mattina, avevo i blues tutto intorno il mio letto
Bene, cerco la mia ragazza, e invece presi questi blues.
Ho camminato tardi la notte per le strade, sino ad avere i piedi inzuppati
Ho camminato tardi la notte per le strade, sino ad avere i piedi inzuppati
Ho chiesto a tutti i miei amici se avevano sentito parlare della mia ragazza.
Ho appena scritto una lettera a casa ai ragazzi, chiedendo loro "Per piacere, pregate per i miei peccati"
Sì, ho appena scritto una lettera a casa ai ragazzi, chiedendo loro "Per piacere, pregate per i miei peccati"
Bene, mi sono avviato verso l'oceano, credo che questa sia la fine.
(James Reed, The End)
Bibliografia
È praticamente impossibile dare una bibliografia seppur generica sul blues e la musica afroamericana; si indicano di seguito solo alcuni titoli di riferimento, in particolare in italiano, e le opere citate nel testo: F. Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave. Written by Himself, Boston 1845; F.L. Olmsted, A Journey in the Seaboard Slave States; with Remarks on their Economy, New York 1856; W.F. Allen - Ch.P. Ware - L. McKim Garrison, Slave Songs of the United States, New York 1867; A. Roffeni (ed.), Blues, ballate e canti di lavoro afroamericani, Roma 1976; G. Oakley, La musica del diavolo: storia del blues, Milano 1978 (trad. it.); A. Roffeni (ed.), Il blues: saggio critico e raccolta di liriche della più importante forma di canto afro-americana, Milano 19782; A. Portelli (ed.), Saggi sulla cultura afro-americana, Roma 1979; L. Federighi, Blues nel mio animo: temi e poesia del blues, Milano 1981; F. Venturini, Sulle strade del blues, Milano 1984; M.L. Hart - BM. Eagles - L.N. Howorth, The Blues: a Bibliographic Guide, New York - London, 1989; P. Guralnick, Robert Johnson. In cerca del re del blues, Milano 1991 (ed. or. Searching for Robert Johnson, New York 1989); L. Cohn (ed.), Nothing But the Blues: the Music and the Musicians, New York 1993; M. Cotto (ed.), Enciclopedia del blues e della musica nera, Milano 1994; L. Federighi, Blues on my mind: temi e poesie del blues, Palermo 2001. Per la discografia, si vedano: M. Leadbitter - N. Slaven, Blues Records, January 1943 to December 1966, New York 1968; R.M.W. Dixon - J. Godrich, Blues and Gospel Records, 1902-1943, Essex 19823; M. Leadbitter - N. Slaven, Blues Records, 1943-1970: a Selective Discography, I-II, London 1987-94; R.M.W. Dixon - J. Godrich - H. Rye, Blues and Gospel Records, 1890-1943, Essex 19824. Per Leadbelly, sono fondamentali i sei CD The Library of Congress Recordings, Rounder CD 1044-1046, 1097-1099; per Robert Johnson tutte le incisioni sono pubblicate nei CD The Complete Recordings, Columbia 467246 2; per Elmore James le prime incisioni sono pubblicate nei CD Classic Early Recordings, Ace ABOXCD 4-1-3.
L’africa caribeña: cuba
di Carlo Nobili
Yoruba soy, lloro en Yoruba / Lucumí. / Como soy un Yoruba de Cuba, / quiero que hasta Cuba suba / mi llanto Yoruba: / que suba el alegre llanto Yoruba: / que sale de mi. / Yoruba soy, / cantando voy, / llorando estoy, / y cuando no soy Yoruba, / soy Congo, Mandinga, Carabalí (N. Guillén, Son número 6).
È noto quanto le culture nazionali delle Americhe e dei Caraibi debbano, nel loro processo di formazione storica, alle popolazioni africane tratte schiave durante i secoli che vanno dal XVI al XIX. La presenza africana è stata, per quanto riguarda Cuba, molto varia e costante sin dagli albori dell'epoca coloniale. Un proverbio assai diffuso oggi in tutta l'isola dice che "Quien no tiene de Congo, tiene de Carabalí", come a significare che nessuno nell'isola può escludere con estrema sicurezza che nelle sue vene non scorra una parte di sangue africano.
La schiavitù: i precedenti
Già nel XV secolo, al tempo dei loro primi contatti con le popolazioni negre della Guinea, i Portoghesi avevano dato inizio a una forma di tratta per così dire europea, in quanto gli schiavi catturati in Africa andavano a incrementare il mercato del lavoro servile nelle città lusitane. Nel 1441 Antam Gonçalves, spintosi con la sua "piccola nave" fin sulla costa sud dell'attuale Marocco (la colonia spagnola di Río de Oro), per compiacere il suo regale padrone ‒ il principe Enrico del Portogallo, il Navigatore ‒, catturò, con l'aiuto di un altro avventuriero portoghese, Nuño Tristão, 12 abitanti di quella terra e li portò schiavi a Lisbona. Solamente due anni dopo il fenomeno cominciò ad assumere però connotati e proporzioni che ne andarono prefigurando il tragico epilogo: dopo che le Isole Canarie ebbero fatto da trampolino di lancio, nel 1443, grazie alle sistematiche spedizioni dell'italiano Lanzarotto Marocello e dei portoghesi Gil Eannes, Alfonso Gonçalves de Baldaja e Nuño Tristão verso quelle stesse terre, ben 235 Africani furono inviati in Portogallo come schiavi (Davidson 1966) e questa stessa prassi si adottò, da lì in avanti, per soddisfare la necessità di manodopera interna.
Da allora fino alle soglie della scoperta dell'America la Tratta portò dall'Africa in Europa circa 800 neri ogni anno (Rojas Mix 1988). Nel 1452 la bolla di Papa Niccolò V, Dum diversas, concedeva al re del Portogallo, Alfonso V, di ridurre in schiavitù tutti i musulmani dell'Africa (Ferro 1984); nel 1455 (8 gennaio) lo stesso papa indirizzava al principe portoghese Enrico il Navigatore e al re Alfonso una bolla, la Romanus Pontifex, che, autorizzandoli a insediarsi sulle coste africane fino alla Guinea, di fatto garantiva loro il monopolio della rotta verso le Indie, ma soprattutto gettava le basi dei moderni sistemi di dominazione schiavisti e razzisti (Surdich 1991). La bolla, i cui principi verranno poi ribaditi con la successiva Aeterni Regis Clementia del 21 giugno 1481, proclamava: "Immensa è la nostra gioia nell'apprendere che il nostro caro figlio, Principe di Portogallo [...] ha recato il Nome di Dio nelle terre più remote e sconosciute e ha condotto fra le braccia della Chiesa Cattolica perfidi nemici di Dio e di Cristo, quali i Saraceni e gli Infedeli [...] Noi, dopo cauta deliberazione [...] abbiamo concesso al Re Alfonso il diritto, totale e assoluto, di invadere, conquistare e soggiogare tutti i paesi dominati dai nemici di Cristo, Saraceni o Pagani [...] Desideriamo [...] che lo stesso Re Alfonso, il Principe e tutti i loro successori, occupino e posseggano in diritto esclusivo le isole suddette [dell'Oceano], i porti ed i mari che diremo in seguito, e vietiamo a tutti i fedeli Cristiani di violare [...] la sovranità del detto Alfonso e dei suoi successori. Fra le conquiste già fatte, o che si faranno, tutte quelle che si estendono fino al Capo Bojador e al Capo Non, alla costa di Guinea ed a tutto l'Oriente sono in perpetuo ed in avvenire sotto la sovranità del Re Alfonso" (Surdich 1991, p. 14).
Come conseguenza diretta di queste "investiture" vennero a intensificarsi i viaggi di esplorazione e, intorno a quegli anni, sorse e divenne fiorente a Lisbona un emporio di schiavi neri provenienti dall'Africa. L'arcipelago di Madeira, al largo della costa occidentale dell'Africa, colonizzato subito dopo la sua scoperta ‒ avvenuta a opera di Enrico il Navigatore nel 1425 ‒, contava già alla fine del XV secolo ben 2000 schiavi adibiti al lavoro nelle piantagioni di zucchero, su una popolazione totale di circa 17.000-20.000 abitanti (Crosby 1986). Malgrado questi precedenti, che comunque non andarono al di là della soglia atlantica, costituita dalle isole al largo della costa occidentale dell'Africa, la Tratta canonica, quella atlantica, sembra essere iniziata, a opera degli Spagnoli, sin dal 1510, anche se già nel 1505 (13 anni dopo la prima traversata di Colombo) gli archivi parlano di una caravella salpata da Siviglia con alcune attrezzature minerarie e 17 schiavi negri destinati al lavoro nel Nuovo Mondo (Davidson 1966, 1990; Sauer 1966). Alcuni studiosi, tra i quali J. Ferrer y Couto, sostengono che i 17 negri schiavi siano giunti a Hispaniola (attuali Haiti e Repubblica Dominicana) nel 1501; nel 1510 la cifra passò a 100 (Ferrer y Couto 1864). Nel 1502 arrivarono alcuni schiavi nell'isola di Hispaniola con la flotta di Nicolás de Ovando; si trattava di schiavi domestici ladinos che viaggiavano accompagnando i propri padroni; erano perlopiù aiutanti, mozzi, servi, buffoni. Uno di questi (non si conosce il suo nome), alla prima opportunità che ebbe fuggì nella selva e si unì ai nativi, diventando così il primo cimarrón (schiavo fuggiasco) di tutto il continente americano.
Secondo C. Coll y Toste è del 1517 la prima autorizzazione concessa da Ferdinando II d'Aragona a Lorenzo R. Garrebad, barone di Montinay. Certo è che nel 1518 lo stesso sovrano spagnolo autorizzò il trasporto di 4000 Africani, presi schiavi sulla costa della Guinea. Un'ulteriore licenza (asiento) venne concessa il 12 febbraio 1528 per l'introduzione di schiavi africani nei possedimenti d'America a due commercianti tedeschi, Henri Ehinger e Jérome Sayler, agenti dei Welser, banchieri che, insieme ai Fugger, dominavano le finanze spagnole dell'epoca (Coll y Toste 1977). Dopo questa data il commercio divenne sempre più un'istituzione e un aspetto essenziale dell'impresa ispano-americana. Il sistema cominciò a mostrare tutto il suo rilievo già intorno al 1592, quando per cercare di soddisfare una domanda di schiavi resa praticamente inesauribile dall'olocausto di quelli che morivano durante la traversata atlantica o stremati dalle fatiche del lavoro nelle miniere e nelle piantagioni, la corte spagnola concesse a Pedro Gómes Reynal, per circa un milione di ducati, una licenza della durata di nove anni per il trasporto di 4250 schiavi l'anno, per un totale di 38.250 schiavi. Nella concessione era stipulato che almeno 3500 dei 4250 schiavi dovessero sbarcare vivi; in caso contrario vi era una penale di 10 ducati per ogni schiavo in meno dei 3500 (Davidson 1966). Era soltanto l'inizio: tra il XVII e il XVIII secolo 3,5-4 milioni di Africani furono trasportati come schiavi attraverso l'Atlantico; tra il 1600 e il 1870 si arrivò a un totale di 9.250.000; il 60% di essi fu destinato alle piantagioni di zucchero dei Caraibi; qui nel 1750 circa 9 uomini su 10 erano schiavi e dal 1790 avrebbero continuato ad arrivare sulle isole 50.000 schiavi ogni anno per far fronte alla sempre più elevata richiesta di manodopera da utilizzare nel "campo".
La schiavitù a cuba: i numeri
La prima menzione di negri schiavi a Cuba si ha già dai tempi del conquistador e primo governatore dell'isola, Diego Velázquez de Cuellar: lo storico santiaguero R. Duharte Jiménez, grazie a cronache del tempo rimaste finora nascoste negli archivi, ha recentemente annunciato che i nomi dei primi Africani portati schiavi a Cuba potrebbero essere Juan Cortés, servo personale di Hernán Cortés, il futuro conquistatore del Messico, e Juan Garrido (Zamora Suárez 2005).
Già nel 1512 un documento ufficiale autorizzava l'introduzione nell'isola di 300 schiavi africani (Dirección Politica de las Far 1983, p. 34); durante il secondo governo di Gonzalo de Guzmán (1535-1538), si ha invece notizia di negros horros (schiavi che avevano riscattato a pagamento la propria libertà) in rivolta assieme agli indios contro gli Spagnoli nel Jobabo. Fermo restando che le espressioni di rivolta per la libertà raggiungono una connotazione più rilevante nella formazione della nazione cubana nella seconda metà del secolo XIX durante le lotte per l'indipendenza dal colonialismo spagnolo, dopo quella del 1533, altre rivolte negre vengono segnalate nel 1538 a Santiago de Cuba, nel 1540 a Bayamo, nel 1606 a Sancti Spíritus e Trinidad, nel 1669 e nel 1726 a L'Avana, nel 1677-1731 a El Cobre, nel 1748 a Cabo Cruz, nel 1791 a Quiebra Hacha, nel 1795 a Puerto Príncipe e nel 1798 a Trinidad. Nel 1554 la popolazione negra già superava quella bianca (Tab. 1), risultando inferiore però a quella indigena (La Rosa Corzo 1988).
Ancora nel XIX secolo i censimenti mettono in risalto una maggioranza di popolazione negra e mulatta su quella bianca, nel 1827 (393.436 contro 311.051, ossia il 55,85% contro il 44,15%) e nel 1841 (589.333 contro 418.291, ossia il 58,49% contro il 41,51%), mentre la tendenza opposta comincia a rivelarsi sin dal censimento del 1861 (793.484 bianchi contro 603.046 negri e mulatti, ossia il 56,82% contro il 43,18%). Nei successivi censimenti si ha questa situazione: 1877, popolazione bianca (B) = 988.624 pari al 64,97%, mulatta e negra (MN) = 489.249 pari al 32,41%; 1887 B = 1.102.889 pari al 67,59%, MN = 528.598 pari al 32,41%; 1899 B = 1.052.397 pari al 66,91%, MN = 505.543 pari al 32,14%; 1907 B = 1.428.176 pari al 69,70, MN = 608.967 pari al 29,72%; 1919 B = 2.088.047 pari al 72,28%, MN = 748.811 pari al 27,16%; 1931 B = 2.856.956 pari al 72,10, MN = 1.079.106 pari al 27,23%; 1943 B = 3.553.312 pari al 74,37%, MN = 1.206.342 pari al 25,24%; 1953 B = 4.243.956 pari al 72,81%, MN = 1.568.416 pari al 26,90% (Casal 1979, p. 15). I dati per il 1825 sono quelli forniti nel Saggio politico sull'isola di Cuba da A. von Humboldt, che indica anche in 455.000 il numero delle persone libere (64%), 325.000 bianchi e 130.000 tra negri e mulatti. Per il precedente censimento del 1817 lo studioso indica invece in 630.980 l'intera popolazione dell'isola, 290.021 bianchi, 115.691 negri e mulatti liberi e 225.268 schiavi (von Humboldt 1986, III, p. 75).
La tabella che segue (Tab. 2) mostra la media annuale degli Africani introdotti a Cuba come schiavi tra il 1790 e il 1871 (La Rosa Corzo 1988, p. 93).
Interessante è pure leggere i dati che si riferiscono ad alcuni anni dello stesso periodo (Tab. 3), perché essi mostrano come a partire dall'ultimo decennio del XVIII secolo vi sia stato un aumento delle entrate di genti africane, fino a raggiungere la cifra più alta tra gli anni che vanno dal 1820 al 1840, per poi decrescere a partire dagli anni Cinquanta (La Rosa Corzo 1988, p. 93).
Sul numero di schiavi importati a Cuba dall'Africa molto si è scritto e ipotizzato in cifre; si vedano, ad esempio gli studi di K.F. Kiple (Kiple 1970, 1976) e J. Pérez de la Riva (Pérez de la Riva 1970, 1979), al quale si devono le due successive tabelle. La Tab. 4 è relativa al numero di entrate dall'anno 1780 al 1820, anno in cui (30 maggio) viene dichiarata illegale la Tratta di schiavi, secondo il Trattato Anglo-Spagnolo del 1817. La Tab. 5 è invece relativa al periodo che va dal 1821 al 1873, anno in cui sbarca, presso la costa nord di Pinar del Río, l'ultima nave negriera di cui si ha notizia.
Dovranno passare ancora 7 anni perché la schiavitù venga ufficialmente abolita (1880). Ancora nel 1855 la corte spagnola, ignorando le pressioni internazionali, aveva dichiarato ufficialmente che la schiavitù, questa forma speciale della proprietà nell'isola di Cuba, era considerata essenziale, per cui "sarà rispettata così come deve esserlo" (Pérez de la Riva 1961), ossia alimentando il suo mercato con l'arrivo di nuovi bozales, così come venivano chiamati gli schiavi che ancora non parlavano lo spagnolo, in quanto appena importati dall'Africa (Del Valle Hernández 1814). La Tab. 6 dà infine conto del numero totale di Africani, distinti per etnia, entrati a Cuba dall'inizio della Tratta fino al 1873.
bozales
Bozal (o bozalón) è a Cuba sinonimo di "selvaggio" e gli Africani appena giunti sull'isola erano chiamati con disprezzo in questo modo poiché parlavano come se avessero una museruola (spagn. bozal, "museruola"). Nelle Ordenanzas de la Española del 1528 si legge: "È bozal lo schiavo arrivato a Cuba da Capo Verde o dalla Guinea da meno di un anno, salvo che tale schiavo fosse già ladino quando da lì è partito, che fosse conosciuto da tempo a Capo Verde e a São Tomé: non sono bozales coloro che, stando sull'isola da più di un anno, sono ritenuti ladini" (Rojas Mix 1988, p. 8).
I bozales non potevano acquistare la libertà o iscriversi fra i coartados, se non dopo otto anni dal loro arrivo a Cuba. Bisogna ricordare che la coartación era il diritto legale che gli schiavi avevano di pagare una somma di denaro al loro padrone, garantendosi così di non essere più venduti tranne che a un determinato prezzo, ma soprattutto la possibilità di riscattare la propria libertà, dopo aver pagato, a rate, la differenza fra il versamento iniziale depositato e il prezzo fisso convenuto (Thomas 1973). Esteban Montejo, ex schiavo e cimarrón del periodo della colonia diventato noto al grande pubblico intorno agli anni Sessanta del Novecento, quando lo scrittore ed etnologo cubano M. Barnet raccolse la sua testimonianza in un libro ormai considerato un classico della novellistica testimoniale, Biografía de un Cimarrón (1966), dice di loro: "Li chiamavano bozales, tanto per dirgli qualcosa e perché parlavano nella lingua del loro paese. Parlavano in modo diverso, questo era tutto. Io non li consideravo così, come dei bozales. Al contrario, li rispettavo. Un negro Congo o un Lucumí ne sapeva di medicina più di un medico. Persino più di un medico cinese! Sapevano anche quando una persona stava per morire. Questa parola, bozal, era sbagliata. Ora non si sente più perché, a poco a poco, i negri africani sono scomparsi tutti. Se ce n'è ancora qualcuno, deve essere venti volte più vecchio di me".
Molti bozales diventavano cimarrones e nel periodo dal 1831 al 1854 ne furono catturati 339 su un totale di 8645 (Tab. 7). In particolare, e limitatamente agli anni 1832, 1842 e 1852, questa (Tab. 8) è la provenienza per "nazione" dei catturati portati nel Deposito dell'Avana (González Moreno 1986, p. 193).
Il fenomeno del cimarronaje
Il termine cimarrón (maroon in inglese, marron in francese) indicava originariamente gli animali, come il maiale, che da domestici ridiventano selvatici; lo stesso termine viene usato la prima volta per indicare gli indiani rivoltosi, in una Carta che Gonzalo de Guzmán e altri funzionari scrivono da Santiago de Cuba il 16 settembre del 1530 alla regina di Spagna (Arrom 1983). Solo più tardi il termine andrà a indicare gli schiavi negri in fuga dalle piantagioni delle colonie spagnole d'America.
Il cimarronaje fu infatti essenzialmente legato a quel modello politico ed economico inventato dal capitalismo europeo, dapprima sperimentato dai Portoghesi a São Tomé sin dal 1485 e quindi trasferito e sviluppato, per rendere sempre più complesso il sistema di sfruttamento, da Spagnoli, Inglesi, Francesi e dagli stessi Portoghesi nel continente americano: il sistema schiavistico della piantagione, il cui antro, ha detto È. Glissant, insieme al ventre della nave dei negrieri, ha rappresentato "la vera genesi dei popoli dei Caraibi" (Glissant 1998, p. 29). Il fenomeno del cimarronaje fu presente in tutte le Americhe ‒ dalla costa occidentale degli Stati Uniti ai Caraibi, dall'America Centrale a quella Meridionale ‒ e molto spesso, nonostante la loro doppia marginalità (Tardieu 1980), le comunità di cimarrones costrinsero i governi coloniali a firmare trattati e patti che garantirono loro la libertà, la terra e l'autonomia politica, così come accadde a Santo Domingo nel 1782, quando le autorità francesi riconobbero ai cimarrones, dopo circa 80 anni di lotte contro gli orrori della schiavitù, la piena libertà.
A Cuba gli studi sul fenomeno hanno distinto tra i cimarrones, oltre al rebelde (lo schiavo che fuggiva dopo una sommossa), il simple e l'apalencado. Il primo era lo schiavo che, fuggito dall'hacienda, viveva a una distanza poco maggiore di tre leghe (oltre 15 km) e si univa in gruppi di non più di sette persone che non avevano un proprio territorio da controllare. Aveva l'appellativo di apalencado lo schiavo che fuggiva con l'obiettivo di rifugiarsi in luoghi appartati per unirsi a gruppi consistenti di cimarrones, fondando comunità, coltivando, procreando figli e organizzando un sistema di vigilanza e difesa della zona in cui ci si riuniva, il palenque appunto, da cui apalencado. Il palenque ‒ conosciuto in altre parti d'America come mocambo (probabilmente dalla voce africana mukambu, "tetto di paglia"), quilombo (da kimboundu o kilombu, "accampamento, villaggio"), cumbe, maniel e cimarronera ‒ fu un elemento fondamentale nella riorganizzazione religiosa dei popoli africani e l'apalencado fu più fieramente perseguitato che non il semplice cimarrón: se, ad esempio, per la cattura di questo si pagavano quattro pesos, per l'apalencado il prezzo poteva essere superiore cinque o sei volte (La Rosa Corzo 1988).
R. Bastide (1970) ha ricordato che, nella maggior parte delle Piccole Antille, i cimarrones non si sono riuniti che in piccole bande, non abbastanza numerose per ricostruire una nuova Africa sull'altra sponda dell'Atlantico. Per la particolare conformazione del territorio, il consolidamento di comunità cimarronas fu in verità a Cuba (e nelle altre isole caribiche) assai più difficile che non in tutto il resto dell'America e se è vero che vi furono palenques che ebbero una vita alquanto lunga, non si registrò nell'isola cubana la stessa stabilità che ebbero queste stesse comunità di schiavi fuggiaschi, ad esempio in Colombia, in Venezuela e soprattutto in Brasile, dove più facile fu per il cimarrón, per i grandi spazi offerti dalle condizioni geografiche di quella nazione, mettere una maggiore distanza tra sé e i persecutori e difendere in modo più efficace il proprio territorio. Va ricordato, ad esempio, che il Quilombo dos Palmares (nei pressi di Recife, Stato di Pernambuco) durò circa 100 anni (dal 1600 al 1695) ed era costituito da 20.000 persone (il 15% dell'intera popolazione brasiliana) e 13 comunità coordinate fra loro, tra queste: Macaco, nella Serra da Barriga (Stato di Bahía), con 8000 abitanti; Amaro, a nord-est di Serinhaém (Stato di Bahía), con 5000 abitanti; Sucupira, a 80 km da Macaco; Osenga, a 20 km da Macaco; Zumbi ‒ a nord-est di Porto Calvo (Stato di Bahía).
Negli studi sul fenomeno del cimarronaje cubano vengono riconosciute cinque distinte fasi cronologiche, assai diversamente caratterizzate tra esse. Nella prima, che va dagli inizi del XV secolo alla metà del XVIII, non è possibile operare una differenziazione tra simple, rebelde e apalencado; l'unione tra cimarrones africani e indios mostra il carattere originariamente transculturativo della cultura cubana. In una lettera spedita nel 1503 al governatore spagnolo, Nicolás de Ovando chiedeva di sospendere l'invio di schiavi africani per la colonia, poiché questi fuggivano e si univano ai nativi (Tardieu 1980); qualche anno più tardi, nel 1554, il vescovo Diego Sarmiento così scriveva all'imperatore: "Nel secondo anno dal mio arrivo mi trovavo a Bayamo, trenta leghe da qui, con il proposito di passare in altre città e rendermi conto di una rivolta di alcuni indios che si erano uniti a dei negri e che avevano rubato e ucciso delle persone, portandosi via le donne e incendiando il villaggio" (Sarmiento 1965, pp. 161-62). La fase successiva è quella che va dal 1750 fino al 1786; maggiori sono le informazioni sugli schiavi fuggiaschi; non si notano differenziazioni tra la figura del ribelle e dell'apalencado, ma entrambi vengono considerati cimarrones.
La terza fase, che va dal 1796 al 1820, è quella in cui si registrano le cifre più alte di cimarrones catturati. Pubblicato nel 1796 il Reglamento de cimarrones (Nuevo reglamento…, 1796), viene avviato un vasto piano di persecuzione e cattura degli schiavi fuggiaschi. Oltre alla creazione di Depositi ufficiali dove sono portati i cimarrones catturati, in questa fase vengono a differenziarsi maggiormente i concetti di rebelde, simple e apalencado. La quarta fase va dal 1820 al 1854; si registrano pressappoco le stesse cifre dei catturati della fase precedente; dal 1854 il Deposito dell'Avana non accoglie più cimarrones catturati ma chinos contratados. L'ultima fase, la quinta, va dal 1854 al 1886; come conseguenza del grande sviluppo delle industrie dello zucchero, il fenomeno del cimarronaje si concentra perlopiù nelle zone di Cárdenas e di Matanzas. È la fase che chiude il triste capitolo della schiavitù a Cuba; il fenomeno del cimarronaje va a scemare e la guerra di indipendenza (o guerra ispano-americana) unirà ben presto schiavi neri e padroni bianchi in un ideale comune di libertà.
Tra i più famosi cimarrones cubani vanno ricordati: Yara, Pedro José, Juan Manco, Mariano Gangá, Domingo Macuá, Diós Dá, Felipe Macuá, Antonio José, Mayimbe José Dolores, Ventura Sánchez (Coba), Manuel Griñan (Gallo), Trimi, Pascual Betancourt, Ambrosio Congo, Agustín Madre de Agua, Felipe Gangá, Lorenzo Gangá, Patricio Sabicú, Caoba, Miguel Vientos, José Antonio e Joaquín. Un posto speciale nella grande costellazione di cimarrones cubani è occupato dalla figura di Madre Malchora, che fu a capo di un gruppo apalencado di 40 persone e che operò nelle montagne di Pinar del Río; da Pancho Mina (noto come Capitán de Palenque), il quale tenne in scacco per oltre 20 anni rancheadores (cacciatori di cimarrones) e soldati spagnoli, fino a quando cadde, nell'agosto del 1835, in un'imboscata preparatagli dal capitano Francisco Rubio Campos nel cafetal (piantagione di caffè) Teresa; da Sebastián, capo del Palenque El Frijol, il più grande di cui si abbia notizia a Cuba; da Diego Grillo, altrimenti detto Capitán Dieguillo, cimarrón marinaio che, imbarcatosi su una nave pirata, diventò secondo di Francis Drake e successivamente luogotenente dell'olandese Cornelius Jo Jolls (Palo de Pata), insieme al quale partecipò a numerose scorribande nel mare dei Caraibi. Nelle grandi sommosse del 1843, figure di grande spicco nella storia del cimarronaje furono Feliciano, Eduardo, Fermina, Gregorio, Evaristo, Carlota, Carmita Juliana, María Filomena, Lucía, Felipe, Manuel, Cristóbal, Zoilo, Cirilo, Adán e Nicolás.
Al di fuori di Cuba, figure di spicco furono: nel Suriname, Baron, Boni e Jolie Coeur, che animarono le sollevazioni di schiavi tra il 1772 e il 1778; in Giamaica, Grandy Nanny, leader donna che intorno al XVIII secolo fondò in un luogo inaccessibile sulle Blue Mountains la città fortificata di Nanny Town, che difese dagli attacchi dei soldati inglesi, e Cudjoe, organizzatore della prima guerra cimarrona (1729-39); in Venezuela, Miguel, che fondò nel 1552 nella miniera di Buría un cumbe inespugnabile unendo indiani e cimarrones africani, Guillermo "El Cimarrón", Pedro Quiroga "El Fundidor", distintosi nella sollevazione di Andresote (1732) e Manuel Espinoza, che organizzò una rivolta assai importante nel 1794; ad Haiti, Michel, che nel 1719 diresse la comunità del Bahoruco, Aymouth che sempre intorno agli stessi anni diresse quella di Nippes, Polydor, che nel 1734 fu a capo di una comunità cimarrona nel distretto di Trou, Noël, che nel 1775 organizzò la resistenza armata di un gruppo di fuggitivi nel Fort-Dauphin, successivamente capeggiati da Telémaque Canga, Isaac e Pyrrhus Candide, e infine François Macandal, giustiziato nel 1758 e diventato in seguito uno dei personaggi del romanzo Il regno di questo mondo di A. Carpentier.
A parte il cimarronaje vero e proprio, vi furono nella Cuba coloniale diverse altre forme di resistenza e di opposizione frontale al sistema schiavista: dal boicottaggio nei lavori nei campi (gli schiavi ostacolavano gli interessi dei padroni rallentando, ad esempio, il ritmo del lavoro, anche producendosi "ferite per rendere inutilizzabili braccia e gambe e non dover più lavorare per il padrone", Le Riverend Brusone 1997, p. 18) allo scontro armato, dal rifiuto delle donne a partorire schiavi per i loro padroni a forme di ribellione individuale o di rivolta violenta da parte di gruppi talora alquanto numerosi. In Mujer y esclavitud la studiosa dominicana C. Albert Batista ha recentemente elaborato un nuovo concetto di cimarronaje: il cimarronaje doméstico, alludendo a tutte quelle azioni fatte dalle schiave di casa di nascosto o in modo palese per burlarsi o "debilitare" il potere del padrone. La schiava che esercitava il suo lavoro come jornalera e che comprava e vendeva per il padrone imponeva abilmente, ad esempio, le sue proprie regole, sia convincendo il padrone della necessità di rimanere ella stessa lontano dalle fatiche imposte dalla piantagione, sia risparmiando per comprare la libertà dei suoi figli, la propria e anche quella del marito (Hernández 1998).
In questo senso, piace pensare come cimarrona doméstica Ma' Dolores Iznaga, la schiava cubana di origine Gangá, guaritrice e rivoluzionaria, che nel secolo scorso fu condannata a morte (e quindi graziata) perché nascondeva nella sua baracca i patrioti feriti e li curava con le sue doti e con i suoi efficaci rimedi africani (saliva, acqua di pozza e preghiere). Su questa figura, che doveva il cognome al suo ex padrone, Don Pedro Iznaga, esiste a Cuba molta letteratura orale, perlopiù raccolta dallo storico E. Sánchez y Sánchez (1916) e dal grande etnografo e folklorista cubano S. Feijóo (1986). Nel suo racconto Rumba di donne a Cuba D. Manera scrive: "Sulla parete di fondo, tra le riproduzioni di quadri di Amelia Peláez, ce n'è uno di Ariadna dedicato a Ma Dolores, la schiava guaritrice che nel secolo scorso nascondeva nella sua baracca i patrioti cubani feriti e li curava. Ma Dolores è ritratta serena di fronte al plotone d'esecuzione, mentre arriva al galoppo un ufficiale con la spada in alto e una busta con la grazia sulla punta. La folla radunata sul pianoro piange a un estremo ed esulta all'altro, a seconda che si trovi vicino al luogo della fucilazione o lungo il sentiero percorso dal cavaliere. In basso, a destra, appoggiato a un albero, si vede il tenente del picchetto, che si è fratturato una gamba cadendo da cavallo ed è stato guarito all'istante da Ma Dolores, con tabacco impastato di saliva prodigiosa. A sinistra c'è invece la sorgente presso Cabarnao dove si dice che lei sia scomparsa e dove ancora va la gente ad attingere acqua medicamentosa o immergersi vestita il Venerdì Santo" (1996, pp. 87-88).
Gli schiavi domestici
Il negro di casa (cuciniere, domestico, cocchiere, balia), ricevendo direttamente l'influenza del bianco, poteva godere di una vita quotidiana e sociale certamente ben diversa da quella riservata a coloro che lavoravano nell'ingenio (zuccherificio) o nel cafetal. Questo stato di cose lo portava ad assumere atteggiamenti da bianco, in altre parole si blanqueaba, cominciava ad apprendere i comportamenti più consoni alle occasioni e la sua capacità camaleontica completava poi il processo di blanqueamento, facendolo ancora più esigente, in fatto di cortesia ed educazione, dello stesso padrone bianco. Ricevendo un trattamento migliore, non era raro che coloro che servivano in casa potessero provare addirittura lealtà e affetto per i padroni e i loro figli. L'ex schiavo e cimarrón Montejo nella sua autobiografia li considera adulones de amos y apapipios, ossia leccapiedi e spie del padrone, anche se riconosce loro un certo grado di raffinatezza: "Eran como decir los señoritos de color" ("Erano, per così dire, i signorini di colore") (Barnet 1966, p. 18).
Questo è invece ciò che scrive sulla negra domestica lo studioso cubano J.L. Franco Ferrán (1990, p. 63): "Quando il negro passa a vivere in città, il padrone bianco ha già introdotto, soprattutto nel servizio domestico urbano, le schiave, alla cui attrazione non sa resistere. La donna negra, in età matura, si convertirà in istitutrice e padrona, in governante della famiglia ed educatrice dei bambini bianchi. Possedendo una intelligenza aperta e liberatasi da ogni complesso di inferiorità culturale, con grande permeabilità, adotta la cultura spagnola, parla in modo eccellente il castigliano, è cattolica, conosce ninna-nanne e leggende fantastiche, è abile nell'arte culinaria, precisa e risparmiatrice, un magnifico esemplare di dirigente domestico. A lei vengono delegati tutti i poteri della padrona, l'insegnamento religioso di questa e dei suoi figli, in altre parole, è una matrona che tutti rispettano e onorano".
Gli schiavi domestici erano dotati del massimo grado di mobilità e del minimo controllo fra tutti gli schiavi, avevano condizioni di vita che consentivano loro tempi di riposo, di riflessione e attività autonome maggiori, erano esentati dai lavori più pesanti, erano nutriti e vestiti in modo migliore rispetto agli altri. Ha scritto S. Marconi (1996, pp. 32-33): "In città (e a Cuba, essenzialmente all'Avana, il più grande porto di tutta l'America coloniale spagnola), vi erano schiavi neri che svolgevano ruoli molto differenti: domestici, cocchieri, artigiani, prostitute (che versavano la gran parte del proprio guadagno ai loro padroni), fattorini, scaricatori di porto, manovali impegnati alla lastricatura delle strade o alla costruzione delle fortificazioni, ecc.; molti di questi ruoli si svolgevano a diretto contatto con i propri padroni, dunque anche con gli oggetti della vita quotidiana e con quelli di culto degli stessi, mentre altri si svolgevano in un tessuto urbano ricco di riferimenti iconografici potenzialmente utili per i processi sincretici. […] In molti casi, gli schiavi urbani potevano guadagnare somme di denaro, sia in accordo coi propri padroni (era il caso delle prostitute), sia esercitando attività autonome, ad esempio artigianali, nel proprio tempo libero; questo fatto consentiva loro di migliorare ulteriormente le proprie possibilità di alimentazione e di vita, talvolta di imparare a leggere e scrivere, talaltra di comperare la propria libertà; vi era poi la possibilità di contatti ben più numerosi sia con i neri liberti e liberi, sia con coloro, come i marinai della flotta, che erano portatori di elementi culturali relativi alle altre terre (e talvolta alla stessa Africa)".
La schiavitù e le donne
All'inizio del XIX secolo nelle piantagioni cubane il rapporto tra donne (hembras) e uomini (varones) era di 1 a 4, poiché gli schiavisti importavano perlopiù uomini. Secondo lo storico M. Moreno Fraginals erano pochissimi gli ingenios che avevano negre; nella logica economica dell'hacendado dell'inizio del secolo XIX raramente si compravano donne, in quanto considerate di basso rendimento. La giustificazione offerta però per spiegare il profondo disequilibrio numerico tra uomini e donne schiavi era spesso religiosa: non si compravano negre per evitare il peccato e il contatto sessuale tra persone non sposate (Moreno Fraginals 1964).
Nel 1811 Francisco de Arango y Parreño, nella sua difesa a favore della Tratta (Documentos de que hasta ahora se compone el expediente que principiaron las Cortes Extraordinarias sobre el tráfico y la esclavitud de los negros) così scriveva: "Non c'è hacienda che abbia donne in numero pari agli uomini. In più dirò che sono pochissime quelle che hanno donne, perché siamo fatti così; perché finora è stato assai difficile far recepire ai nostri moralisti di avere schiavi di entrambi i sessi nei nostri poderi rustici senza che fossero sposati e non era considerato peccaminoso condannare al celibato perpetuo coloro che erano nati e cresciuti nella più assoluta poligamia" (Pérez de la Riva 1979, p. 31).
Quando A. von Humboldt visita l'isola, le donne tra gli schiavi impiegati nelle piantagioni sono in relazione di 1 a 4, mentre nel resto del Paese si ha un rapporto di 1 a 1,7, ossia 170 uomini per 100 donne; nelle città dove gli schiavi sono impiegati come domestici la relazione è di 1 a 1,2, ossia 120 uomini per 100 donne. José García de Arboleya, nel suo Manual de la Isla de Cuba, offre invece questi dati: su un totale di 283.625 schiavi dei campi gli uomini rappresentano ben il 63,44% e le donne il 36,56%; nelle città, su un totale di 16.121 schiavi urbani il 47,57 è rappresentato dagli uomini e il 52,46% dalle donne (García de Arboleya 1852, pp. 116-17). Nel 1899, a causa delle perdite dovute alla guerra d'indipendenza la situazione vede invece un rapporto di 93 uomini per 100 donne; il censimento del 1907 indica 96 uomini per 100 donne; nel 1919, finalmente, si arriva a una situazione più equilibrata: 99,4 uomini per 100 donne (Pérez de la Riva 1979, pp. 32-33).
Schiavitù e archeologia
Come ha ben messo in evidenza L. Domínguez, la possibilità di utilizzare il contributo delle fonti archeologiche nello studio della schiavitù a Cuba ha contribuito, pur nella novità della disciplina, ad arricchire lo studio sulla schiavitù e sul fenomeno della fuga di schiavi di nuovi e sorprendenti elementi di indagine (Domínguez 1986). Grazie a una archeologia sempre più attenta verso tutte quelle fasi che hanno contraddistinto il processo di formazione dell'identità nazionale dell'isola, sappiamo oggi, ad esempio, qualcosa in più rispetto anche alla dieta dei primi fuggiaschi africani del XVI secolo, i quali unendosi a gruppi di indios appresero la loro cucina e iniziarono a cibarsi di specie animali a loro una volta sconosciute: molto spesso sono stati trovati resti di jutía ‒ il tipico roditore di Cuba (Capromys pilorides), la cui carne era assai apprezzata dagli indigeni cubani ‒ tra i rifiuti che si accumulavano all'esterno delle capanne usate come rifugio dai cimarrones.
Nelle ricerche sul campo realizzate nelle montagne e nelle zone rurali dell'isola gli archeologi dell'Accademia delle Scienze di Cuba hanno potuto localizzare grotte e altri rifugi naturali abitati dai cimarrones, nei quali si sono trovate innumerevoli evidenze materiali: pentole di ferro tipiche della prima metà del XIX secolo, frammenti di pipe di terracotta, alcune delle quali decorate con motivi "negroidi", e altre testimonianze assai rivelatrici di quella che doveva essere la vita quotidiana di un palenque. Grazie al lavoro archeologico oggi alcuni di questi siti sono visitabili, come nel caso del Palenque de los Cimarrones nella valle de Viñales (prov. di Pinar del Río). Qui, dove è stato installato il Museo Etnográfico Cimarrón, E. Alonso, responsabile del gruppo di archeologi della Sierra de los Órganos, ha individuato 57 grotte abitate da cimarrones e oltre 600 evidenze archeologiche della loro presenza: oltre a pipe di terracotta, pettini intagliati in legno di jócuma amarilla (Mastichodendron foetidissimum) e altri manufatti artigianali.
Anche se l'apporto africano non si limitò all'economia azucarera e cafetalera, ma fu ben presente anche nella produzione tabacalera e in quella dell'allevamento, nella costruzione di vie di comunicazione, di fortificazioni e dei grandi edifici urbani, gli archeologi cubani negli ultimi decenni hanno concentrato i loro sforzi nello studio attento e sistematico dei vari elementi che componevano ingenios e cafetales dell'epoca della colonia: cimiteri, infermerie, torri campanarie ma soprattutto quell'elemento presente sin dal 1830 in entrambe le realtà, il barracón, ossia l'edificio in cui trovavano ricovero notturno gli schiavi della piantagione. Esso, come ha detto lo storico Moreno Fraginals (1978), ha rappresentato il "massimo baluardo della barbarie schiavista". Costruito con legno, e successivamente in muratura, il barracón era in genere dotato di una sola porta; ogni cuarto, in cui era diviso all'interno, era a sua volta dotato di una piccola porta e di una piccola finestra entrambe sbarrate affinché gli schiavi di una parte non potessero comunicare con gli altri (Pérez de la Riva 1975). A partire dalla fine degli anni Sessanta del Novecento ‒ quando il barracón dell'ingenio Taoro (nella Provincia dell'Avana), in attività già dal 1791, fu oggetto di scavi da parte del Dipartimento di Archeologia dell'Accademia delle Scienze di Cuba e si dette inizio al restauro del cafetal La Isabelica nella Gran Piedra, nei pressi di Santiago ‒ il lavoro degli archeologi cubani ha cominciato a costituirsi come un ideale e opportuno strumento per addentrarsi in nuovi interstizi. Questi, andando ben al di là di interpretazioni generalizzate sull'origine, lo sviluppo, la crisi e la decadenza del sistema schiavistico cubano, non hanno mancato di gettare nuova luce sulla conoscenza di costumi, abitudini, quotidianità, livello di vita e altri indicatori socioculturali riguardanti gli schiavi della piantagione.
C'è poi da dire che un ulteriore sviluppo è stato dato dall'azione svolta fin qui dal progetto interdisciplinare La Ruta de Los Esclavos, che ‒ auspicato dal settembre del 1994 (quando fu presentato a Cotonou, nel Benin) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e l'Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO) e appoggiato dalla Fondazione Fernando Ortiz, il Consiglio Nazionale del Patrimonio Culturale e la Commissione Cubana per l'UNESCO ‒ attraverso la ricerca archeologica intende inventariare, mantenendone un controllo sistematico e preservandone la memoria storica, tutte le evidenze materiali legate alla pratica schiavistica.
L’eredità africana a cuba
Lo studioso cubano J. Guanche (1996) ha identificato, per ciò che riguarda le componenti africane presenti a Cuba, otto denominazioni metaetniche: Arará, Carabalí, Congo, Gangá, Lucumí, Macuá, Mandingo e Mina. Ogni gruppo, a sua volta, comprende diverse denominazioni etniche ed etnonimi. In Africa, rispetto a ciascuna denominazione generica vengono classificati circa 30 etnonimi principali; a Cuba, le circa 230 denominazioni conosciute si relazionano principalmente con toponimi e idronomi che designano e identificano i territori e le aree fluviali e marittime di provenienza. La possibilità di identificare e classificare la maggioranza delle denominazioni degli schiavi africani esistenti a Cuba si deve soprattutto all'alta capacità di resistenza e sopravvivenza dei popoli subsahariani coinvolti nel grande olocausto transatlantico, cosa questa che ha permesso di tracciare le vicende legate alla cosiddetta "rotta degli schiavi", così come l'estrema complessità e la ricchezza dell'eredità che queste popolazioni hanno lasciato a quelli dell'America e del Caribe.
Si deve al massimo pensatore cubano, F. Ortiz (1916, 1920, 1950, 1951, 1954), e successivamente a L. Cabrera (1940, 1954) e R. Lachatañeré (1961a, 1961b), il merito indiscutibile di avere posto l'attenzione sui valori espressi dalla cultura di origine africana e sull'importanza che questa ha avuto nella storia e nella formazione di Cuba come nazione. L'apporto africano a Cuba, ricco e vitale, risulta oggi di estrema importanza non solo per la grande complessità degli esiti biologici a cui ha dato seguito, ma anche e soprattutto per la densa trama di manifestazioni culturali, dalla musica alla letteratura e all'arte, dalle religioni alla forma stessa del vivere e del sentire del cubano. Le ricche tradizioni della terra d'Africa si sono perpetuate a Cuba alla stessa maniera in cui si perpetua l'archivio della sua ancestrale mitologia, con i suoi Pantheon popolati da divinità dalla pelle scura.
Un elemento importante nel processo di conservazione fu l'istituzione dei cabildos, associazioni di carattere religioso-mutualistico che raggruppavano gli schiavi africani e loro discendenti, creoli, schiavi o liberti, appartenenti a una stessa nazione. I cabildos ‒ che cominciano ad apparire a Cuba intorno al XVII secolo (alcuni di essi resisteranno fino all'epoca repubblicana) ‒ contribuirono significativamente a preservare le molteplici espressioni culturali, soprattutto, mantennero vivi e attuanti i sistemi religiosi africani, poiché, attraverso un complesso lavoro di mimetizzazione, dietro le immagini dei santi cattolici si occultarono le vere divinità africane, così come accadde nella santería o regla de ocha, quel sistema che ha origine nel culto agli orishas, divinità del Pantheon Yoruba sincretizzate con santi dell'agiografia cattolica o nel palo monte o regla conga (e sue varianti: mayombe, brillumba e regla kimbisa), sistema religioso di origine Bantu che si incentra sulle forze soprannaturali degli elementi della natura e sugli spiriti dei morti e il cui depositario è quel ricettacolo, carico di energia, chiamato nganga o prenda. Queste pratiche religiose, insieme ad altre ‒ come ad esempio la Sociedad Secreta Abakuá dei Carabalí, ossia dei gruppi Efik ed Efor provenienti da una vasta regione africana comprendente l'odierna Nigeria meridionale, il Calabar e il Camerun, i cui adepti sono conosciuti a Cuba come ñañigos, o come il culto Arará dei gruppi Ewé-Fon del Dahomey (oggi Benin), che entrarono a Cuba, sin dal secolo XVII, sotto le più diverse denominazioni: arará adobá, arará agicón, arará cuatro ojos, arará cuévano, arará magino, arará nezeve, carará sabalú o sabalauno, dajome e mina ‒ svilupparono una funzione importante nella preservazione di altre manifestazioni culturali come i canti, la musica e le danze, il cui archivio, insieme al sacro linguaggio dei tamburi, rappresenta di fatto lo strumento di una complessa comunicazione.
Si dice che Cuba sia mulatta come la poesia di N. Guillen, il quale spiegava che i suoi versi fanno parte degli stessi elementi che entrano nella composizione etnica di Cuba, "... dove tutti siamo mischiati" ed essendo Cuba meticcia "... dallo spirito della pelle vi verrà il colore definitivo. Un giorno si dirà color cubano". Si dice che Cuba sia mulatta e questo non è solo un modo di dire, in quanto proprio il mulatto seppe ristabilire un equilibrio dinamico tra il bianco e il negro, liberando l'uno e l'altro in modo che davanti a lui il Cubano bianco venne ad avvertirsi meno assoluto e il negro meno inferiore. Inserito il negro in un processo di "bianchizzazione" e il bianco in uno di "negrizzazione", "spagnolizzato" l'Africano e "africanizzato" lo Spagnolo, diluiti tutti questi elementi in un'unica provetta, quella della transculturazione, il prodotto che ne risultò, con caratteri differenziali propri, la mulatidad, liberò il bianco dalla sua avidità, dalla sua antica ira e dalla sua nuova superbia e il negro dalla sua miseria, dal suo antico rancore e dal suo nuovo risentimento. E non solo, il mulatto ha rappresentato a Cuba l'equilibrata storicità nel sentimento di patria e di nazione, sentimento che determinò la liberazione etnica cubana non solo dal punto di vista razziale, ma anche nazionale (Entralgo 1990).
Il sentimento di libertà e la voglia di indipendenza furono svegliati grazie al gesto risolutorio di un convinto abolizionista, il ricco proprietario terriero Carlos Manuel de Céspedes (considerato il "Padre della Patria"), il quale lanciò il 10 ottobre 1868, presso la fattoria La Demajagua, lo storico Grito de Yara, liberando, al suono della campana dell'ingenio, tutti i suoi schiavi e chiamando a raccolta tutti coloro che come lui credevano nell'indipendenza dalla Spagna. Gli ex schiavi vennero così a trovarsi fianco a fianco dei bianchi e insieme a loro vi erano i creoli; per i cubani ancora oggi il vero eroe di quella epopea, colui che sapientemente seppe guidare l'Ejercito Libertador de Cuba, fatto di mambises (sing. mambí, probabilmente dalla voce africana mbi, che sta a indicare il rivoluzionario) armati di solo machete, fu un mulatto, il generale Antonio Maceo, il quale, caduto in battaglia nei pressi di Punta Brava il 7 dicembre 1896, è per tutti il Titano di Bronzo, così da ricordare la sua forza ma soprattutto il colore della sua pelle e un tratto distintivo della stessa cubanía, ossia quell'infinita mescolanza che a Cuba può a ragione essere rappresentata dalla donna mulatta, la quale, prodotto che cominciò a formarsi nel ventre della schiava negra negli ingenios della Colonia spagnola, porta con sé intere generazioni di cultura nel processo di formazione del "criollismo" cubano.
Bibliografia
Nuevo reglamento y arancel que debe gobernar en la captura de esclavos cimarrones aprobado por S.M. en Real Orden expedida en San Lorenzo con fecha veinte de diciembre de 1796, La Habana 1796; A. Del Valle Hernández, Nota sobre la introdución de negros bozales en la isla de Cuba y estado actual de la distribución de las gentes de color, libres y esclavos en ellas, in Documentos de que hasta ahora se compone el expediente que principiaron las Corte Extraordinarias sobre el tráfico y la esclavitud de los negros, Madrid 1814, pp. 116-26; J. García de Arboleya, Manual de la Isla de Cuba, La Habana 1852; J. Ferrer y Couto, Los negros en sus diversos estados y condiciones; tales como son; como se supone que son y como deben ser, Nueva York 1864; F. Ortiz, Hampa afrocubana. Los negros esclavos (Estudio sociológico y de derecho público), La Habana 1916; E. Sánchez y Sánchez, Recuerdos del tiempo viejo. Tradiciones trinitarias, Cienfuegos 1916; F. Ortiz, La fiesta afrocubana del Día de Reyes, La Habana 1920; L. Cabrera, Cuentos negros de Cuba, La Habana 1940 (ed. or. Contes nègres de Cuba, Paris 1936); F. Ortiz, La africanía de la música folklórica de Cuba, La Habana 1950; Id., Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba, La Habana 1951; L. Cabrera, El monte (Igbo. Finda. Ewe Orisha. Vititi Nfinda), La Habana 1954 (trad. it. Piante e magia. Religioni, medicina e folklore delle culture afrocubane, Milano 1984); F. Ortiz, Los instrumentos de la música afrocubana, I-IV, La Habana 1954; R. Lachatañeré, El sistema religioso de los lucumis y otras influencias africanas en Cuba, in Actas del Folklore, 1, 7 (1961), pp. 9-20; Id., Tipos étnicos africanos que concurrieron en la amalgama cubana, ibid., 1, 3 (1961), pp. 5-12; J. Pérez de la Riva, Cuadro sinóptico de la esclavitud en Cuba y de la cultura occidental, estratto da Actas del Folklore, 5 (1961); M. Moreno Fraginals, El Ingenio. El complejo económico social cubano del azúcar, I. 1760-1860, La Habana 1964; Diego Sarmiento, Carta del Obispo al Emperador. Documentos para la historia de Cuba (época colonial) (ed. de Hortensia Pichardo Viñals), La Habana 1965; M. Barnet, Biografía de un Cimarrón, La Habana 1966 (trad. it. Torino 1968); B. Davidson, Madre Africa. L'Africa nera e il commercio degli schiavi, Torino 1966 (ed. or. London 1961); C.O. Sauer, The Early Spanish Main, Berkeley - Los Angeles 1966; R. Bastide, Les Amériques Noires, Paris 1967 (trad. it. Milano 1970); K.F. Kiple, The Cuban Slaves Trades, 1820-1862. The Demographic Implications for Comparative Studies, Gainesville 1970; J. Pérez de la Riva, ¿Cuantos africanos fueron traídos a Cuba?, in Economia y Desarrollo, 3 (1970), pp. 135-42; H. Thomas, Storia di Cuba. 1762-1970, Torino 1973 (ed. or. Cuba: the Pursuit of Freedom, New York 1971); J. Pérez de la Riva, El barracón y otros ensayos, La Habana 1975; K.F. Kiple, Blacks in Colonial Cuba, 1774-1889, Gainesville 1976; C. Coll y Toste, Historia de la esclavitud en Puerto Rico, San Juan 1977; M. Moreno Fraginals, El Ingenio, I, La Habana 1978; L. Casal, Race Relations in Contemporary Cuba, in A. Dzidzienyo - L. Casal, The Position of Black in Brazilian and Cuban Society, London 1979, pp. 11-27; J. Pérez de la Riva, El monto de la immigración forzada en el siglo XIX, La Habana 1979; J.-P. Tardieu, La double marginalité du nègre marron, in BIFAN, 142, 4 (1980), pp. 693-721; J.J. Arrom, Cimarrón: apuntes sobre las primeras documentaciones y su probable orígen, in REspAntrAm, 13 (1983), pp. 47-58; Dirección Politica de las Far, Historia de Cuba, La Habana 1983; G. Ferro, Le navigazioni lusitane nell'Atlantico e Cristoforo Colombo in Portogallo, Milano 1984; A.W. Crosby, Ecological Imperialism. The Biological Expansion of Europe 900-1900, Cambridge (Mass.) 1986 (trad. it. Bari 1986); L.S. Domínguez, Fuentes arqueológicas en el estudio de la esclavitud en Cuba, in La esclavitud en Cuba, La Habana 1986, pp. 267-79; S. Feijóo, Mitología cubana, La Habana 1986 (trad. it. Misteri e leggende di Cuba, Padova 1998); M. González Moreno, Breve estudio de una fuente documental. Los libros de registros de entrada y salida del Depósito de cimarrones de La Habana, in La esclavitud en Cuba, La Habana 1986, pp. 190-95; A. von Humboldt, Viaggio alle regioni equinoziali del Nuovo Continente. Fatto negli anni 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 e 1804 da Alexander von Humboldt e Aimé Bonpland, I-III, Roma 1986 (ed. or. Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804, I-III, par Al. De Humboldt et A. Bonpland, Paris 1814-25); G. La Rosa Corzo, Los cimarrones de Cuba, La Habana 1988; M. Rojas Mix, Cultura afroamericana: de esclavos a ciudadanos, Madrid 1988; B. Davidson, Storia dell'Africa, Torino 1990 (ed. or. London 1984); E. Entralgo, La mulatización cubana, in L. Menéndez Vázquez (ed.), Estudios afro-cubanos. Selección de lecturas, La Habana 1990, I, pp. 174-83; J.L. Franco Ferrán, La presencia negra en el Nuevo Mundo, ibid., II, pp. 53-87; L. Menéndez Vázquez, Estudios afro-cubanos. Selección de lecturas, I-IV, La Habana 1990; F. Surdich, Verso il Nuovo Mondo. La dimensione e la coscienza delle scoperte, Firenze 1991; J. Guanche, Componentes étnicos de la nación cubana, La Habana 1996; D. Manera (ed.), Rumba senza palme, né carezze. Narratrici cubane contemporanee, Lecce 1996, pp. 87-111; S. Marconi, Congo Lucumí. Appunti per un approccio sincretico al sincretismo culturale, Roma 1996; J. Le Riverend Brusone, Piccola storia di Cuba, Milano 1997 (ed. or. La Habana 1971); A. Hernández, Cimarronaje doméstico: Santa Marta y Yemalla, in Revista Especial / Fempress, Santiago 1998, web-url http://www.fempress.cl/base/especialespecialmjrd-cimarrn.htm; É. Glissant, Poetica del diverso, Roma 2004 (ed. or. Introduction à une poétique du divers, Paris 1996); I. Zamora Suárez, Los dos Juanes en Cuba: primeros negros esclavos de América, in Cuba. Una identità in movimento, 2005, web-url: http://freeweb. supereva.com/archivocubano/juanes.html.
L'africa in brasile
di Donatella Saviola
Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil / Quand la frénésie de l'or draîna au marché la dernière goutte de sang indien / De sort qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or / On se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique / Pour assurer la relève du désespoir… (R. Depestre).
Premessa
"Ciò che ritorna in modo brutale, nelle strade di Los Angeles, come in tutta Haiti la dimenticata, è l'Africa, questo terzo escluso delle nostre cerimonie; e con essa il volto notturno dell'America. Allora il nostro stesso inconscio d'ombra si illumina, in quanto Europei: il traffico di schiavi, primo fondamento della nostra opulenza" (R. Debray, in Haiti. 500 años de historia, Roma 1997, p. 14).
Forte è stata ed è la presenza dei neri nelle Americhe; ancora più forte essa è stata nel Brasile, e in particolar modo in alcune regioni, che hanno visto arrivare milioni di individui deportati. Per quanto valore possano avere le stime in una simile circostanza, il numero delle persone strappate da tutte le regioni africane ‒ nessuna esclusa (Davidson 1990) ‒ è stato tanto enorme da lasciare in quel continente profonde lacerazioni. Forse non si saprà mai quanti siano morti durante la traversata, eufemisticamente nota come middle passage. Ma da quell'olocausto, che in qualche modo l'Occidente ha rimosso, nasce storicamente la nostra "modernità". Per le comunità afroamericane, la tratta degli schiavi rappresenta invece l'inizio di quella condizione esistenziale che W.E.B. Du Bois ha chiamato "doppia coscienza", ripresa come privilegiato ambito speculativo da P. Gilroy nell'opera The Black Atlantic (2003), vale a dire l'essere, nello stesso tempo, dentro e fuori le regole e i diritti della società moderna, dentro e fuori gli Stati in cui si veniva deportati, ma pienamente investiti da un sentimento di sofferenza e dal conseguente desiderio di riscatto, derivanti da quella che Gilroy definisce come "permanente condizione ontologica di dolore", comune denominatore di tutte le espressioni culturali, politiche ed estetiche della diaspora africana (Gilroy 2003, p. 333).
È quanto afferma anche B. Davidson, quando sottolinea la differenza tra l'antico sistema di schiavitù diffuso in molti regni africani e il nuovo che stava nascendo, diverso non solo per le dimensioni raggiunte: "Il potere del regno dello zucchero e del regno del cotone... dette vita a un processo di migrazione forzata, il più vasto che la storia avesse mai conosciuto. Gettò le fondamenta dello sviluppo del sistema americano. Alimentò la crescita economica inglese e francese, favorendo un notevole progresso tecnologico e scientifico. La storia dell'umanità non ha mai riscontrato una combinazione più lugubre e più contraddittoria: da un lato, l'accumulazione della ricchezza ma, dall'altro, la miseria della schiavitù in massa" (1990, p. 157). Un altro aspetto che lo storico inglese pone in evidenza, tra i diversi contraccolpi che la tratta ha lasciato in Africa (oltre allo spopolamento e all'annientamento di intere comunità), è quello della massiccia esportazione di capacità e qualità umane. Dell'immenso contributo degli Africani al Nuovo Mondo, il cui apprezzamento e riconoscimento si sono avuti esclusivamente nel campo artistico ‒ difficile peraltro da ignorare ‒, non si è dato giusto rilievo all'apporto fondamentale che ha fornito all'America e al mondo intero: un corpus di saperi e tecniche concernenti soprattutto l'agricoltura tropicale che risultò ancor più prezioso non potendo disporre di manodopera indigena. "Sotto questo aspetto, non fu soltanto la loro capacità di sopportare il clima e le febbri tropicali che rese preziosa e insostituibile la loro opera. Ancor più fu la loro capacità, acquisita in Africa, a lavorare la terra in condizioni totalmente diverse rispetto all'esperienza europea" (Davidson 1990, p. 168).
Il Brasile è un paese afro-luso-americano. Americano, evidentemente, per la sua posizione geografica e per la sua popolazione indigena; lusitano, come effetto della colonizzazione portoghese; africano non solo perché la nazione brasiliana si è formata sul lavoro degli schiavi, ma anche perché questi costituirono storicamente l'elemento di popolazione più denso nelle grandi e piccole città, nelle piantagioni e nei settori di estrazione mineraria, elemento base a partire dal quale la popolazione del Brasile si moltiplicò, profondamente segnata dai loro costumi, dalle loro religioni e dalle loro tradizioni. La distruzione nel 1890 degli archivi relativi al traffico negriero, voluta dal ministro delle Finanze Rui Barbosa ed eseguita all'indomani dell'emanazione della legge che aboliva la schiavitù (13 maggio 1888), e l'interdizione nei censimenti ufficiali della discriminazione in base al colore della pelle hanno reso particolarmente ardua una valutazione dell'impatto che la popolazione di ascendenza africana ha avuto in Brasile. Nondimeno, le indagini effettuate nel 1967, in particolare nel settore di geografia umana, dal Gabinete de Estudos Regionais e de Geomorfologia dell'Università di Bahia, hanno permesso di accertare che il 35% della popolazione totale del Brasile (di circa 90 milioni di abitanti) era di origine africana; percentuale che saliva all'85% nella città di Salvador e del suo Recôncavo (una vasta cinta verde che circonda l'ex capitale dell'antica colonia luso-americana, oggi capitale dello Stato). Si dice di Salvador da Bahia che sia la città più africana del Brasile e, al di là delle percentuali demografiche, che moltissimi abbiano il proverbiale pê na cozinha ("piede in cucina", ossia un antenato schiavo africano).
Come è noto, le culture africane approdarono in terra brasiliana con gli schiavi che i colonizzatori portoghesi portarono con sé fin dal loro arrivo, come parte dei loro beni e che, in seguito, importarono direttamente dall'Africa, soprattutto dalla cosiddetta Costa degli Schiavi. Sottomesso alla potenza coloniale che controllava la maggior parte del commercio atlantico degli Africani, il Brasile fu il maggiore importatore di manodopera forzata durante i tre secoli e mezzo di traffico negriero verso il Nuovo Mondo. Strumento indispensabile per lo sviluppo dell'economia agricola e mineraria, la schiavitù ha assunto nella colonia portoghese caratteristiche particolari rispetto al resto dell'America. Essa si diffuse in tutto il subcontinente e, in quest'immenso territorio, mantenne la sua struttura sempre più radicata. Durante tutto il periodo coloniale e imperiale fino al 1888 (anno dell'abolizione della schiavitù), ossia alla vigilia della Proclamazione della Repubblica, fu la manodopera africana che sostituì quella indigena, meno adatta al lavoro forzato.
Diversamente da altre regioni dell'America Meridionale, come il Perù, la Colombia o l'Ecuador, dove la presenza di schiavi rimase comunque circoscritta in aree determinate, nel Brasile non solo la quantità di schiavi importati fino al 1850 (anno dell'abolizione dei viaggi di tratta) ma la stessa continuità di questa importazione mostrano come la società schiavista della nascente nazione sia riuscita a stabilirsi e a svilupparsi mediante meccanismi regolatori che permettevano un costante rinnovamento della forza lavoro coatta.
Africani in brasile: aspetti demografici
L'esiguità dei dati esistenti non permette di arrivare a una quantificazione verosimile del numero degli schiavi che, per tre secoli e mezzo, giunsero nei diversi porti brasiliani. Le stime vanno da 3 a 18 milioni di individui. Si sa, tuttavia, che, in funzione del carattere ciclico dell'economia brasiliana, la massa di schiavi fu trasferita più volte per tutto il territorio, arrivando a stabilire un modello di concentrazione della popolazione nera, soprattutto in certe aree del paese, che perdura ancora oggi. Questa concentrazione è più elevata negli attuali Stati nord-orientali, da Bahia fino al Ceará e, escludendo Rio de Janeiro, meno accentuata negli Stati sud-orientali, come Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul: le stesse aree verso cui affluirono i grandi contingenti di immigranti stranieri a partire dalla fine del XIX secolo, voluti fortemente dalle autorità per avviare un processo di "sbiancamento" che potesse fronteggiare la predominanza dei neri.
Secondo A. Ramos, la popolazione schiava fu distribuita in tutto il territorio nel modo seguente: Bahia (con irradiazione verso il Sergipe), da dove era smistata nelle piantagioni di canna da zucchero, di tabacco e di cacao, nelle zone urbane per i servizi domestici e, in seguito, nelle zone minerarie; Rio de Janeiro e São Paulo, nelle numerose fazendas per la lavorazione di zucchero e caffè della Baixada Fluminense; Pernambuco, Alagoas e Paraíba, centri di irradiazione di un'enorme quantità di piantagioni di canna da zucchero e di cotone del Nordeste; Maranhão (con irradiazione verso il Pará), zona di produzione del cotone; Minas Gerais (con irradiazione verso il Mato Grosso e Goiás) in cui lo schiavo fu destinato, per tutto il XVIII secolo, al lavoro nelle miniere. La consistenza numerica di questa popolazione e la sua distribuzione per tutto l'immenso territorio nazionale sono i due fattori che hanno determinato la specificità dello schiavismo brasiliano rispetto a quello degli altri Paesi sudamericani e degli stessi Stati Uniti.
Gli effetti demografici e culturali della migrazione forzata degli Africani erano nitidi fin dalla fine del Cinquecento. Nei Diálogos das grandezas do Brasil (1618), Ambrósio Fernandes Brandão afferma che i costumi e la natura degli Africani erano parte costitutiva del dibattito circa le cose dell'America portoghese, "poiché nel nostro Brasile si è creata una Nuova Guinea con la grande moltitudine di schiavi provenienti da quel paese (...) C'è qui tanta gente dal colore nero e dai capelli crespi che non ci farà abbandonare la nostra consuetudine di riflettere su di essi" (Brandão 1943). Della massa di schiavi sbarcati nelle Americhe, dai primi decenni del Cinquecento fino a oltre la metà dell'Ottocento, il Brasile ne ricevette il 38%; l'America spagnola, le Antille Francesi (compresa la Louisiana) e quelle Britanniche ne ebbero ciascuna il 17%; alle Antille Olandesi e agli Stati Uniti andò il 6%. A ogni nuovo ciclo economico brasiliano l'aumento delle importazioni di Africani nel Brasile era più accelerato rispetto alla totalità delle altre regioni schiaviste. Tale fu il caso che si verificò tra il 1575 e il 1650, periodo di massimo sviluppo del ciclo zuccheriero, o tra il 1701 e il 1720, con l'inizio del ciclo delle miniere d'oro e tra il 1780 e il 1810, ciclo della rinascita agricola improntato sulla cultura del cacao, del riso, del cotone e soprattutto del caffè. Da allora fino al 1850, quattro quinti degli Africani deportati sbarcarono nelle spiagge brasiliane.
Tali furono l'estensione e l'intensità del traffico negriero che si creò, paradossalmente, il terreno adatto alla formulazione delle concessioni di libertà agli schiavi al punto che i colonizzatori portoghesi e luso-brasiliani godevano della fama di essere i signori schiavisti più generosi del Nuovo Mondo. D'altro canto, la migrazione forzata di Africani diede luogo fin da subito a un gran numero di fughe, ribellioni e tumulti. Tra le leggi emanate al fine di ridurre il rischio costante delle rivolte e che, al contempo, avrebbero dovuto stemperare la disumanità della condizione in cui viveva lo schiavo vi fu la famosa Legge del Ventre Libero, del 1871, secondo la quale il figlio della schiava sarebbe nato libero cittadino, con tutti i diritti che ne conseguivano; ma mantenendo la madre in schiavitù, l'unica realtà che si prospettava per il neonato era quella dell'abbandono e della solitudine, mentre i padroni, gli unici a ricavarne vantaggi da questa legge, non avevano più obblighi assistenziali se non nei confronti di chi era realmente produttivo. A questa legge seguì quella del Sessagenario ‒ un altro dispositivo che permetteva di liberarsi di forze ormai inermi ‒ che decretava l'ottenimento della libertà allo schiavo che avesse compiuto sessant'anni, un'età a dir poco venerabile a cui ben pochi giungevano.
Le rivolte degli schiavi e le comunità quilombolas brasiliane
In tutte le regioni americane coinvolte nella diaspora, la ribellione degli schiavi alla loro condizione si verificò fin dai primi sbarchi e assunse nel tempo le caratteristiche di un fenomeno costante, che in molti casi raggiunse notevoli proporzioni. Essa costituì una continua minaccia per il sistema schiavista, minandone le basi a diversi livelli ‒ economico, sociale e militare. Fu un movimento emancipazionista che precedette, di molto, quello liberale abolizionista e che si differenziava da quest'ultimo per la sua visione radicale, senza alcun elemento di mediazione con gli interessi della classe schiavista: da un lato gli schiavi ribelli, dall'altro i padroni e l'apparato repressivo di quella ribellione. Solo la violenza, quindi, poteva consolidarlo o distruggerlo. Esso stabiliva una frontiera sociale, culturale e militare contro il sistema di oppressione, costituendosi in un'unità permanente, autonoma e stabile nella misura in cui riusciva a controllare e arginare gli attacchi degli eserciti governativi.
Soprattutto ad Haiti il fenomeno ha assunto connotazioni molto particolari. L'isola era famosa alle potenze coloniali per la perenne condizione di rivolta dei neri. Questi, rafforzati nella loro consapevolezza anche grazie ai loa del vodun, trasformarono i nuclei di rifugiati nelle foreste in un fermento continuo, poi nella rivolta generale degli schiavi guidati da Toussant Louverture che, nel 1796, proclamò l'indipendenza e l'istituzione della prima Repubblica Nera del mondo, indipendente e sovrana.
In Brasile le comunità di schiavi fuggiaschi erano denominate quilombos e mocambos, due termini derivanti da quelli di lingua Kimbundu (del ramo Bantu) kilombo e mu'kambu, che significano rispettivamente "villaggio" e "sommità". Nella misura in cui il flusso di Africani verso l'America portoghese era regolare e corposo, anche le "perdite" erano di considerevoli proporzioni. Quando uno di questi rifugi cresceva al punto di trasformarsi in polo d'attrazione e stimolo alla ribellione degli altri schiavi, le autorità tentavano di distruggerlo. Questa situazione generò una pratica repressiva che criminalizzava le concentrazioni autonome di neri in territorio brasiliano. Così, l'Ordine Reale del 2 aprile 1699 esentava da ogni punizione legale coloro che avessero ucciso i fuggitivi o quilombolas. I cosiddetti capitães-de-mato ("capitani delle foreste"), quasi sempre meticci e specializzati nella persecuzione e nella cattura dei ribelli, ottennero nel 1724 l'ufficializzazione e la regolamentazione della loro professione. Le misure repressive si moltiplicarono durante la prima metà del XVIII secolo, quando la domanda simultanea di schiavi nelle miniere aurifere dell'interno e nei latifondi del litorale stimolava la crescita dell'offerta negriera.
In Brasile il quilombo ha segnato, con la sua presenza nell'intero territorio, tutto il periodo della schiavitù. E. Carneiro caratterizza le forme di lotta degli schiavi brasiliani nel seguente modo: a) rivolta organizzata, con la presa del potere politico, che ha avuto come sua espressione più visibile la serie dei tumulti dei neri Malê (di religione islamica) a Bahia, tra il 1807 e il 1835; b) l'insurrezione armata nel Maranhão come quella messa in atto da Manuel Balaio nel 1839; c) la fuga in foresta con la costituzione di comunità indipendenti ‒ i quilombos appunto ‒ come quella di Palmares, dell'eroe Zumbi (Carneiro 1966). Tra le caratteristiche del fenomeno del quilombagem va segnalata la sua continuità storica: dal secolo XVI (il primo quilombo fu organizzato nel 1575 nello Stato di Bahia) se ne registrano continuamente fino alla vigilia dell'abolizione della schiavitù; e la sua diffusione territoriale anche laddove la concentrazione di schiavi era numericamente esigua. Tra tutti va ricordato il famoso Quilombo di Palmares, nella Serra da Barriga, che darà vita all'omonima Repubblica degli uomini liberi istituita, intorno al 1630 circa, in una delle zone più fertili del Paese e che sarà sanguinosamente distrutta nel 1695. Esso costituì la più grande manifestazione di ribellione antischiavista dell'America Latina e la sua durata di quasi un secolo diede un forte contraccolpo al sistema economico regionale dell'antica capitania di Pernambuco. Furono organizzate numerose spedizioni contro Palmares, che resistette con coraggio e cadde solo quando entrarono massicciamente in gioco le forze federali. Zumbi de Palmares fu la sintesi della capacità di organizzazione, mobilitazione e resistenza della Repubblica, il suo eroe-simbolo, poiché con il sacrificio della sua vita rappresentò l'esistenza del suo popolo. Ancora oggi gli abitanti dell'União dos Palmares "sentono" nelle notti silenziose il suono degli antichi tamburi di quella comunità.
L'articolo 68 dell'attuale Costituzione Federale del Brasile, del 1988, riconosce ai discendenti dei quilombolas, noti ormai come remanescentes nei numerosi dibattiti giuridico-antropologici che si sono intensificati negli ultimi venti anni, il diritto alla proprietà delle terre da essi occupate.
Le aree di provenienza degli schiavi
Individuare le regioni di appartenenza degli Africani destinati al Brasile e, in generale all'America, è compito molto arduo per diverse ragioni, prima fra tutte la conseguenza derivante dalla mentalità colonialista che, nel negare la condizione umana all'Africano, di fatto non dava importanza alcuna alla provenienza degli individui catturati, attribuendo stessi nomi a popolazioni diverse.
La tradizione storiografica distingue, per l'area africana, due grandi gruppi etnico-linguistici: le popolazioni di lingua Bantu dell'Africa equatoriale e tropicale (un'immensa area che comprende il Golfo di Guinea, il Congo, l'Angola, gli altopiani orientali e quelli della costa sud-orientale); e quelle sudanesi dell'Africa Occidentale. Non si hanno prove decisive della predominanza di uno dei due gruppi sull'altro, per quanto si ammetta normalmente che la maggioranza fosse Bantu ma che le tradizioni culturali di alcuni gruppi sudanesi, come gli Yoruba, siano state notevolmente predominanti nell'eredità africana del Brasile. Gli studi intrapresi da R. Nina Rodrigues e A. Ramos nei primi decenni del XX secolo hanno evidenziato una forte concentrazione nello Stato di Bahia di Yoruba-Nago della Nigeria sud-occidentale, degli Ewe (in Brasile noti come Jejé) dell'ex Dahomey, dei Mina della costa settentrionale della Guinea, oltre alla presenza degli Hausa della Nigeria nord-occidentale, di religione islamica come i Fulani e i Mandingo, questi ultimi molto temuti dai Portoghesi.
Durante il lungo periodo di schiavitù le diverse "nazioni" dell'Africa Occidentale, Equatoriale e Orientale andavano imprimendo segni profondi alla formazione della società brasiliana. Disarticolati dallo schiavismo gli antichi legami di sangue, l'appartenenza alla "nazione" di origine si è ricostituita attraverso la creazione di confraternite (cabildos), trasformatesi poi in associazioni di mutuo soccorso. Mentre gli Africani di origine Bantu, del Congo e dell'Angola, deportati in Brasile per primi durante il duro periodo della conquista, furono distribuiti nell'immenso territorio delle piantagioni della zona litoranea centrale, tra gli Stati di Rio de Janeiro, São Paulo, Espirito Santo e Minas Gerais ‒ in un'epoca in cui le comunicazioni con i centri urbani erano molto difficili ‒, quelli di origine sudanese, soprattutto i Jejé e i Nago, giunti nell'ultima fase del periodo schiavistico, furono concentrati nelle zone urbane delle ricche regioni degli Stati del Nordeste, Bahia e Pernambuco, e principalmente nelle loro capitali, Salvador e Recife.
Tra le dinamiche storiche che diedero luogo a rapporti "privilegiati" tra alcune regioni americane e africane, nel caso dello Stato di Bahia, questi contatti furono particolarmente intensi con l'Angola e il Congo fino alla fine del XVIII secolo per rivolgersi, in seguito, verso la Costa do Castelo São Jorge de Mina, nel Golfo del Benin, tra i fiumi Volta e Lagos. L'attenzione fu rivolta, più tardi, alla zona centrale di questa regione ‒ tristemente nota come Costa degli Schiavi ‒ e in particolar modo nel suo porto più importante, Ouidah, denominato Glehué dai Dahomeani, Igelefé dagli Yoruba, Ajuda dai Portoghesi, Judá o Grégoy dai Francesi, Whydah dagli Inglesi e Fidá dagli Olandesi. L'etnia Nago-Yoruba fu l'ultima a stabilirsi in quelle terre, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo.
Sul versante africano, i continui attacchi che il regno del Dahomey sferrò contro i suoi vicini e la pressione dei Fulani sulla città di Oyo (capitale politica dei regni Yoruba), che indebolì la difesa delle regioni più remote dell'impero, ebbero come risultato la cattura e la vendita di numerosi sottogruppi Yoruba come gli Egba, Egbado, Sabe e, particolarmente i Ketu, imbarcati a Ouidah e a Cotonou. In seguito alla caduta di Oyo e alle spietate lotte intestine che culminarono con la rivolta e la perdita della città di Ilorin, a quei contingenti si aggiunsero altri gruppi provenienti dallo stesso territorio di Oyo, gli Ijesha e gli Ijebu. I Ketu furono quelli maggiormente colpiti dai Dahomeani di Abomey e, in tal senso, la storia di questo sottogruppo è preziosa fonte diretta di quella che è l'eredità afrobahiana. Furono i Ketu a impiantare con maggiore intensità la loro cultura a Bahia, ricostituendo le loro istituzioni e adattandole al nuovo ambiente, con così grande fedeltà verso i valori più peculiari della loro cultura d'origine che ancora oggi quelle costituiscono il baluardo dinamico dell'identità afrobrasiliana.
Questi diversi gruppi provenienti dalle regioni meridionali e centrali dell'ex Dahomey, del Togo e dalla Nigeria sud-occidentale, ossia quel vasto territorio convenzionalmente definito Yorubaland, sono conosciuti in Brasile con la designazione generica di Nago, portatori di una tradizione la cui ricchezza deriva dalle specifiche tradizioni culturali dei diversi regni in cui esse fiorirono, che si riconoscono tutti discendenti da un unico progenitore mitico, Oduduwa, fondatore di Ile Ife, il centro spirituale da cui ebbero origine i diversi regni Yoruba. I Ketu, Sebe, Oyo, Egba, Egbado, Ijesha e Ijebu portarono con sé i loro costumi, le loro strutture gerarchiche, la loro visione del mondo insieme alla lingua, alla musica, alla letteratura orale e alla mitologia. E, soprattutto, portarono in Brasile la loro religione politeista.
Flusso e riflusso tra africa e bahia
Si deve a P.F. Verger il merito di avere indagato su un aspetto poco noto della diaspora in Brasile, nella sua opera Fluxo e refluxo do tráfico de escravos del 1968. Esistono innumerevoli connessioni e reciproche influenze, sottili o manifestamente dichiarate, tra la regione del Golfo del Benin e la città di Salvador.
Gli Africani deportati nel Brasile e, in particolare, nello Stato di Bahia, seppero conservare e trasmettere ai loro discendenti costumi, tradizioni culturali e alimentari a tal punto da ricostituire in terra brasiliana un ambiente africano. Tra i discendenti della prima generazione ce ne furono molti che, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, intrapresero il viaggio in direzione opposta a quello della tratta che li portò a Lagos, in Nigeria, per avviare un apprendistato che, di ritorno a Bahia, avrebbe permesso loro la riorganizzazione dei culti tradizionali. Non tutti gli Africani liberati che giunsero in Africa per completare l'apprendistato religioso ripresero poi la strada per Bahia. Molti di loro tornarono nella terra d'origine per rimanervi definitivamente; ma, fatto curioso tra le tante conseguenze storiche della Diaspora Nera, una volta giunti nella loro terra, quegli individui risultavano ormai "brasiliani" e "deafricanizzati". Apparentemente cattolici, essi preservarono il modo di vita dei loro parenti d'oltremare, vestendo all'occidentale, costruendo case a due piani secondo lo stile brasiliano e commemorando in Africa la festa del Senhor do Bonfim, versione sincretica di Oshalá, l'orisha preposto alla creazione. Mantennero rapporti costanti con Bahia, con frequenti viaggi da una sponda all'altra dell'Atlantico a bordo di quegli stessi velieri che navigavano fra i due continenti con i loro carichi di uomini.
Dall'Africa così potevano giungere tutti i prodotti essenziali ai suoi figli d'oltreoceano: olio di palma, noto in Brasile come dendê; le noci obí e orobó, indispensabili per i rituali e per le offerte di culto; tessuti della Costa e quant'altro poteva servire alla realizzazione delle pratiche cultuali legate agli orishas, compresi i condimenti per la preparazione dei cibi rituali alle divinità e dei manicaretti della piccante cucina afrobahiana, che tanta enfasi ha avuto nell'opera letteraria di J. Amado. Benché queste due comunità abbiano praticamente perso i contatti a partire dall'inizio del secolo scorso, i loro discendenti sono divenuti ‒ in termini culturali ‒ Africani del Brasile e Brasiliani dell'Africa; questa, come ha ben evidenziato Verger (1968), è stata la conseguenza imprevista del flusso del traffico degli schiavi e del riflusso tra il Golfo di Benin e Bahia de Todos os Santos o, in termini Yoruba, "la spiaggia di tutti gli orishas".
L’eredità africana nel brasile meticcio
"Da noi le frontiere sono chiazzate e mutevoli; (...) il nostro sistema di classificazione razziale riconosce non solo bianchi e neri, ma anche loiros, morenos, memelucos, pardos, mulatos, preos e sararás; bianchi e neri si gettano insieme nel samba; assaporiamo hamburger e patatine fritte, ma il cibo degli schiavi è il nostro piatto nazionale; qualcuno è protestante, quasi tutti sono cattolici, ma chi di noi non è anche macumbeiro?" (P. Fry, prefazione a Dantas 1988, p. 14).
Nel corso di circa quattro secoli di convivenza interrazziale, e come risultato di un intenso e continuato processo di mescolanza, si andò formando in seno alla nazione brasiliana un notevole segmento meticcio ‒ quello dei mulatti. Questa popolazione, che ora si confonde con i neri, ora con i bianchi, venne inclusa nei censimenti sotto la categoria dei pardos, al fianco dei brancos e dei negros. Il pardo può essere meticcio del bianco-nero (mulatto), del bianco-indio (mameluco), del nero-indio (cafuso) o anche lo stesso indigeno integrato nella società brasiliana.
Considerando che il sospetto di essere uno schiavo fuggitivo pesava su ogni nero o mulatto incapace di fornire prove della sua effettiva condizione di libero o liberto, nelle zone rurali interne ogni attività economica indipendente e ogni riunione di uomini di colore si presentavano come altamente rischiose. Implicito durante il periodo coloniale, dopo il 1822 l'atto di considerare gli uomini di colore come sospetti di latitanza finì per essere incorporato nella legislazione poliziesca brasiliana. In queste circostanze, i discendenti di schiavi che avevano riscattato la propria libertà preferivano vivere sotto la protezione degli antichi padroni; integrati in tal modo nella fascia più bassa della società coloniale luso-brasiliana, neri e mulatti risultavano maggiormente permeabili all'acculturazione e al meticciamento. Atrofizzata nelle colonie portoghesi dell'Africa, sull'altra sponda dell'Atlantico l'ibridazione si sviluppa e si presenta come uno dei fenomeni centrali dell'influenza lusitana nel Brasile, che dà origine a una fascia intermedia di mulatti che si distingue dai bianchi e dai neri. L'interiorizzazione, da parte della sfera subalterna, dei valori culturali dominanti dà luogo all'elaborazione di una gerarchia sociale fondata sul colore della pelle, sulla forma del viso, sulla morfologia dei capelli. Si tratta del processo che F. Fanon ha definito come "epidermizzazione dell'inferiorità" (Fanon 1940).
Culti afrobrasiliani: il candomblé
Il candomblé - Candomblé è il nome dato in Brasile alla religione (oggi ufficialmente riconosciuta come tale dalla Chiesa Cattolica) degli orishas, divinità portate dagli schiavi di etnia Yoruba. L'origine etimologica del termine candomblé pare rinviare al Bantu kà-n-dómb-íd-è / kà-n-dómb-éd-è, derivato da kù-lòmb-à che significa "lodare, pregare, invocare" (Castro 1983, p. 83).
Nei contesti religiosi Yoruba-Fon si possono ravvisare diverse analogie che rimandano a un medesimo impianto mitico-sociale: gli orishas Yoruba come i vodun dei Fon dell'ex Dahomey (che ad Haiti corrispondono ai loa) sono entità divine o antenati umani divinizzati mediante i quali si definiscono i rapporti che l'individuo intrattiene con la società e con le forze della natura. Essi svolgono diverse funzioni: cosmologica, quando si identificano con gli elementi naturali ‒ Ossayin per i vegetali, Oya-Iansan per il vento (e in Africa anche per il fiume Niger), Shango per il fulmine, Ogun, divinità tra le più arcaiche, per il ferro, Yemanjá per il mare, ecc. ‒; sociale, poiché regolano le pratiche della vita collettiva (Ogun per la guerra e l'agricoltura, Shango per la giustizia); personale, nella misura in cui l'iniziato attualizza in sé una combinazione particolare dei loro molteplici aspetti o manifestazioni.
Ogni divinità inoltre presenta una dimensione universale, in cui si può definire il suo archetipo, e una singolarità accentuata, facilmente riconoscibile anche da un profano. Così ogni orisha è, a un tempo, totalità del divino che riunisce la pluralità delle sue caratteristiche e parte che si distingue da tutti gli altri aspetti. Ciascuna divinità media una rete di rapporti che contribuisce a definirla: nel proprio altare, ilê orishá, ogni figura divina è attorniata dal suo Pantheon di relazioni con il mondo; ad esempio, il dio della caccia, Oshossi, sarà affiancato da Ogun, il dio fabbro responsabile della confezione degli strumenti agricoli, e da Ossayin, signore della foresta, delle piante e delle loro qualità terapeutiche. Gli orishas sono potenze che si appropriano del corpo umano durante la transe, rendendo l'individuo che ne è posseduto la personificazione della stessa divinità. Voluti e creati dagli uomini, e da questi nutriti con sangue, saliva, piante e quant'altro, l'assemblaggio di materie inerti si trasformerà in una cosa organica e viva nella misura in cui la praxis cultuale umana ne supporta l'esistenza; poiché, senza l'azione rituale, non vi è vita per gli orishas. Lungi dall'essere sostanze assolute e immanenti, queste divinità si pongono come entità relazionali non solo perché il corpo dell'adepto e quello del dio partecipano di una stessa natura, ma perché uomini e dei si generano reciprocamente e sono sempre in processo nuovi aggiustamenti.
Nel mondo della diaspora, queste divinità hanno subito un processo di sincretismo con i santi cattolici che, se da un lato ha permesso ai loro adepti di mantenere intatto il loro Pantheon, oggi è oggetto di un ripensamento critico da parte degli operatori rituali del candomblé che rivendicano il recupero del sistema originario Yoruba, senza alcuna mediazione. La testimonianza di una sacerdotessa è illuminante al riguardo: "il santo e l'orisha sono come acqua e olio in un bicchiere: non si mischiano mai" (riportata nella rivista Nigrizia, novembre 1995, p. 35). Nonostante le somiglianze con i santi, di cui spesso portano il nome, gli orishas non hanno nulla in comune con l'agiografia cattolica. Nell'adattamento alle condizioni sociali del Nuovo Mondo, il Pantheon politeistico Yoruba ha subito notevoli cambiamenti soprattutto in relazione al territorio. In Africa, ogni orisha era in origine legato a una città o a un intero paese e il culto assumeva così una configurazione locale o regionale: Shango a Oyo, Yemanja nel paese degli Egba, Iyewa tra gli Egbado, ecc. A questa distribuzione geografico-mitica fa da contrappunto, in Brasile, la concentrazione di tutte le divinità nell'unico spazio del terreiro. Ma l'intero impianto religioso mantenne nondimeno i suoi tratti fondamentali, ravvisabili nell'importanza attribuita alla danza, alla musica, al sacrificio e all'offerta rituale in quanto strumenti che veicolano la transe di possessione, quest'ultima concepita come condizione privilegiata di comunicazione con le divinità.
I templi del candomblé (terreiros) si differenziano secondo la loro appartenenza alle "nazioni" (comunità etniche risultanti dalla diaspora) Ketu, Angola, Jejé, ecc. che si riferiscono a specificità rituali e idiomatiche. Nondimeno, come ha sottolineato L. Arcella, se da un punto di vista storico-geografico si può riconoscere una concentrazione Jejé-Nago negli Stati del Nordeste e una di origine Bantu nelle zone meridionali del Paese, è pur vero che tale suddivisione non sussiste in ambito sincretico-religioso: se il candomblé è specifico di Bahia, la città è sede anche di terreiros caboclos (ossia amerindiani) e congo-angolani (Bantu). L'intromissione di quest'ultima cultura "... in una tradizione considerata sudanese quale il candomblé, si ripropone nel modo inverso nel sincretismo Bantu che adopera il complesso mitico Nago, ovvero il sistema degli orixàs, come struttura portante del proprio culto" (Arcella 1980, p. 19).
Gli studiosi del candomblé bahiano, fino a due decenni fa, erano unanimi nel dare rilievo alla preminenza dei modelli cosiddetti Nago e Jejé sui candomblé delle "nazioni" Congo, Angola e Caboclo. Lo stesso R. Nina Rodrigues, che svolse la sua ricerca in una casa Nago ‒ il famoso candomblé di Gantois di cui conobbe le due anziane fondatrici ‒, attribuiva a questo culto un'origine unicamente Yoruba-Nago, opinione che in parte rettificò anni dopo quando venne a conoscenza dei testi del colonnello dell'esercito britannico Ellis sugli Yoruba, della Nigeria sud-occidentale, della zona sud-orientale dell'ex Dahomey e del Togo meridionale, e sui Fon dell'ex Dahomey, che rivelavano come le teogonie di questi ultimi fossero influenzate dal Pantheon e dall'organizzazione religiosa dei primi.
Nina Rodrigues (1862-1906) è considerato da molti il precursore degli studi scientifici sui neri del Brasile. Medico legale, il suo interesse per il nero e, in particolare, per le sue religioni si inserisce in un quadro di riferimento più ampio che è quello di pensare la società brasiliana, darle un "certo ordinamento e orientare, partendo da presupposti scientifici", le pratiche di controllo sociale. Sebbene le sue riflessioni risentissero delle teorie evoluzioniste e diffusioniste dell'epoca in cui operava, Nina Rodrigues comprese ed espresse quello che più tardi l'antropologia avrebbe definito come processo acculturativo. L'espressione Jejé-Nago, formulata dallo studioso, illustra molto bene quel processo culturale, e gli autori che hanno proseguito l'indagine, con un impianto metodologico più sicuro, hanno sottolineato il fatto che già in Africa erano presenti dinamiche relazionali tra i Fon e i Nago-Yoruba che potevano essere ricondotte alla categoria del "sincretismo religioso". Ovviamente, questo processo acculturativo tra le due etnie deve essersi accentuato nelle terre della schiavitù, dall'inizio del XIX secolo con la partecipazione di leaders religiosi delle due culture ai movimenti di resistenza antischiavista, per assumere una connotazione diasporica squisitamente brasiliana. In tal senso l'espressione Jejé-Nago deve essere intesa come significativa di sistemi religiosi organizzati, nello Stato di Bahia, sui modelli culturali di origine dei gruppi Nago-Yoruba e Jejé-Fon.
Si deve a E. Carneiro il merito di avere rivolto l'attenzione all'esistenza dei candomblé di origine Bantu, denominati Congo e Angola. Sono significativi i suoi primi lavori sulle "religioni negre" e sui "neri Bantu" (1936), il suo impegno nel secondo Congresso Afro-Brasiliano del 1937 a Salvador e il suo ruolo nella fondazione dell'Unione delle Sette Afrobrasiliane, infine il suo coinvolgimento nel movimento nero degli anni Cinquanta. Contemporaneo di Carneiro, lo studioso statunitense M. Herskovits diede legittimità teorica alla tesi del candomblé etnico e aprì la strada allo studio scientifico dei neri dell'Atlantico. Etnologo dell'antico Dahomey, egli vedeva nel Nuovo Mondo sopravvivenze e reinterpretazioni africane in contesti sia profani sia sacri. Per Herskovits, il mondo afrobrasiliano formava una subcultura che doveva essere analizzata con il riferimento alla terra africana di origine e come un universo totale. Nello stesso quadro teorico generale si situano le ricerche di R. Bastide e di P. Verger.
Altri culti afrobrasiliani - Il candomblé è solo uno dei culti di possessione afrobrasiliani. I suoi adepti si distinguono, nonostante le dinamiche sincretiche, dai cattolici e dal resto dell'universo "afro" degli umbandistas, degli espíritas, dei crentes, rispettivamente affiliati all'umbanda, ai culti kardecisti (fondati sulla dottrina di Kardec) e alle sette d'origine protestante. Tra gli altri sistemi religiosi nati in seguito alla diaspora nera in Brasile vanno ricordati: lo xangô di Recife (presente anche nell'isola caraibica di Trinidad) e il batuque di Porto Alegre, che condividono con il candomblé la medesima organizzazione religiosa Yoruba, ne onorano le stesse divinità, sincretizzate, però, con figure di santi diverse; di influenza Ewe/Fon (dahomeana) è il Tambor di Mina, o Casa das Minas, di São Luis do Maranhão, i cui fondatori provenivano dall'ex Dahomey; la macumba e l'umbanda (con la variante quimbanda) di Rio de Janeiro, di origine Bantu, in cui il medium può essere posseduto da entità mitiche amerindiane, i caboclos, o di antichi schiavi, i pretos velhos.
L’eredità afro nel mondo brasiliano contemporaneo
Nel Brasile degli anni Trenta del Novecento la cultura fu usata per modellare un nazionalismo culturale, modalità di integrazione verticale, che si sovrappone alle classi come alle etnie, tentando di eliminare le differenze e mettendo in risalto la solidarietà che si esprimerebbe mediante un patrimonio culturale comune. Nella costruzione di questo nazionalismo culturale l'eredità dei neri assume un ruolo rilevante. In tal senso, se l'esaltazione della cultura negra fu usata per creare una cultura nazionale, la glorificazione dell'Africano, più specificamente del Nago-Yoruba, serviva a marcare le differenze regionali poiché gli africanismi considerati come più fedeli all'antica tradizione e meglio conservati si trovavano nel Nordeste, e soprattutto a Bahia.
I neri del Nuovo Mondo hanno creato in modo attivo una propria cultura e una propria "Africa". La deportazione atlantica, la società di plantation, l'abolizione della schiavitù, la libertà e l'adattamento alla modernità furono i contesti nei quali gli Afroamericani dovettero ridefinire, in un lasso di tempo molto breve e sotto un'intensa pressione, la loro visione del mondo e il modo in cui essa si sarebbe manifestata. Queste nuove culture dovevano significare ed essere intelligibili agli stessi discendenti di Africani e, sebbene in altra forma, ai bianchi. Nel processo di diffusione di una nuova cultura "nera" vengono scelti, per poterla rappresentare come un tutto, oggetti e caratteristiche legati al corpo, ai costumi e al comportamento come elementi costitutivi di uno stile peculiare.
Nella storia della cultura afrobrasiliana si possono identificare due varianti principali, ciascuna associata a una città, rispettivamente Rio de Janeiro e Salvador da Bahia. Sia i resoconti scientifici sia i discorsi popolari hanno sempre teso ad associare la prima al meticciamento e alla manipolazione culturale e la seconda all'identità nera e alla purezza culturale. Nella città di Rio de Janeiro il processo di diffusione della cultura nera si è concentrato principalmente intorno a due elementi ben noti e interrelati: il samba e il carnevale. Nel periodo compreso tra il 1920 e il 1960, queste due manifestazioni da una dimensione ghettizzata divennero i pilastri intorno ai quali si è costruita la rappresentazione (spettacolarizzata) della brasilianità. Da un lato, alcuni intellettuali nazionalisti si proposero come figure "organiche" in rapporto alla cultura popolare afrometiccia; dall'altro, diversi "intellettuali popolari" neri (normalmente poeti e autori di testi di samba), come Pixinguinha e Paulo da Portela (Vianna 1995; Farias 1998), ottennero una notevole fama nelle scuole di samba che, da quel momento in poi, furono considerate il cuore dell'autentica cultura popolare moderna. Tramite una complessa interazione tra questi due gruppi, la cultura nera di Rio è assurta a cultura del samba e delle sfilate del carnevale.
Se le espressioni culturali afro di Rio sono diventate essenziali per la rappresentazione pubblica della brasilianità ‒all'interno, ma ancor più all'estero ‒, un complesso di elementi della tradizione afrobahiana ha assunto il ruolo di fonte di ispirazione per la creazione delle culture afrobrasiliane. In queste rappresentazioni la città di Salvador si contrappone a quella di Rio, dove la manipolazione e la mescolanza sono attitudini imprescindibili della creatività culturale nera: la sfilata di carnevale, benché altamente mercificata e gerarchizzata, ancora celebra come buono e ingegnoso il sincretismo inteso come l'atto di "prendere in prestito". Nelle rappresentazioni della cultura afrobahiana, al contrario, ciò che assume rilievo è la capacità di relazionarsi all'Africa e di rimanere fedeli alle tradizioni, mentre il sincretismo è solo uno strumento di quella dinamica di riavvicinamento alla terra d'origine (Capone 1999). Seguendo tale ottica, che vede nel candomblé l'artefice della superiorità che Bahia ha guadagnato nella scala degli africanismi nelle Americhe, si è prodotta una dicotomia secondo la quale, potremmo dire, i portavoce dei neri di Rio guardano Bahia come la principale fonte di purezza africana, mentre quelli di Bahia guardano l'Africa come la principale fonte di ispirazione e legittimazione del ruolo di "Roma Nera delle Americhe" che è di Salvador da Bahia.
La formazione di una coscienza afro consapevolmente alternativa a quella nazionale si è avuta in Brasile anche grazie a una serie di rivendicazioni che hanno trovato lo spazio in diversi ambiti sociali, fra i quali quello dell'editoria, con il fenomeno noto come Imprensa negra. Nel 1915 ha inizio, nella città di São Paulo, una rilevante manifestazione di identità etnica, tra le più importanti nella lotta per la cittadinanza dell'afrobrasiliano, con la circolazione del primo giornale, O Menelick. Il fenomeno prende le mosse dalla necessità di superare le barriere imposte dalla stampa ufficiale, impermeabile alle rivendicazioni della comunità nera, creando una stampa alternativa nella quale dare spazio ai desideri, alla vita associativa culturale e sociale e alle denunce contro il razzismo imperante. Al primo quotidiano fecero seguito le seguenti testate: A rua e O Xauter del 1916; O Alfinete del 1918; O Bandeirante del 1919; A Liberdade del 1919; A Sentinela del 1920; O Kosmos del 1922; O Getulino del 1923; O Clarim da Alvorada e Elite del 1924; Auriverde, O Patrocínio e O Progresso del 1928; Chibata del 1932; A Evolução e A Voz da Raça del 1933; O Clarim, O Estímulo, A Raça e Tribuna Negra del 1935; A Alvorada del 1936; Senzala del 1946; Mundo Novo del 1950; O Novo Horizonte del 1954; Notícias de Ébano del 1957; O Mutirão del 1958; Hífen e Niger del 1960; Nosso Jornal del 1961; Correio d'Ébano del 1963.
Quest'insieme di periodici che si sono susseguiti nell'arco di cinquanta anni, fatto unico in tutto il Brasile, influì significativamente nella formazione di un'ideologia etnica del nero paulista, gettando le basi per la nascita del maggiore movimento politico nero del Brasile: la Frente Negra Brasileira, movimento di carattere nazionale, con ripercussioni internazionali, fondato nel 1931. Nel 1945 fu fondato, nella città di Rio de Janeiro, il Comitê Democrático Afro-Brasileiro e dopo il 1954 si assistette, in diverse città del Brasile meridionale, a una diffusa rinascita della cultura nera grazie a sodalizi come la Associação Cultural do Negro na rua São Bento. La dittatura militare degli anni Sessanta pose fine a ogni forma di dialogo democratico tra le autorità e le comunità afrobrasiliane, che poterono riorganizzarsi solo dopo la fine del regime militare, dando vita nel 1978 a un atto pubblico di protesta e all'istituzione del Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial, abbreviato poi in Movimento Negro Unificado.
Conclusione
La sopravvivenza della coscienza nera lungo i cinque secoli in terra americana è stata possibile solo grazie alla forza con cui i discendenti degli Africani hanno saputo mantenere la loro cultura materiale e simbolica. L'esempio del candomblé refrattario a ogni forma di repressione, tanto della Chiesa Cattolica come dell'apparato poliziesco dello Stato è, in tal senso, chiarificatore.
Anche nell'ambito più propriamente culturale ritroviamo nuove forme aggregative nate con l'intento di favorire il riscatto e l'autostima ‒ secolarmente negata ‒ della loro gente. Possiamo citare le numerose associazioni culturali Olodum, Araketu, Ilê Ayê (denominazioni che rimandano direttamente al mondo sociale e mitico Yoruba) e i vari blocos afros (associazioni per il carnevale), senza dimenticare i gruppi di samba, di pagode, di capoeira e le associazioni di congadas e moçambiques. Inoltre le nuove generazioni, influenzate dal movimento rapper nordamericano, denunciano il razzismo della società brasiliana attraverso la musica, parlando della violenza della polizia, dello sterminio dei ragazzi di strada, dei massacri dei loro compagni neri nelle periferie delle grandi città.
Va ricordato al riguardo quanto sostiene P. Gilroy circa il senso e il valore da attribuire alla musica nera e alla sua storia. Per lo studioso anglo-africano la musica ha assunto un ruolo di primaria importanza nella produzione culturale della diaspora africana. Essa può essere utilizzata per sfidare quelle concezioni dominanti nel pensiero occidentale che considerano la scrittura e il linguaggio come le principali forme d'espressione della coscienza umana. In questo senso, il potere e l'importanza della musica all'interno dell'Atlantico nero sono cresciuti in forma inversamente proporzionale alle limitate capacità di linguaggio con cui dovette misurarsi la popolazione schiava. Come afferma lo stesso autore, esiste nella musica uno stile inconfondibilmente nero, che non è tuttavia l'espressione di qualcosa di innato, di immobile e di puro, intrinseco a una presunta "coscienza black". Per cogliere la peculiarità della blackness egli prende spunto dal concetto di "changing same" di Amiri Baraka (alias Leroi Jones) nell'analisi del blues per affermare che è possibile reperire nella produzione culturale della diaspora africana un "medesimo che cambia", vale a dire qualcosa che persiste nonostante gli effetti disgreganti e destabilizzanti della storia. Non si tratta di un'essenza "trans-storica", ma piuttosto di una condizione sociale che informa tutta la produzione culturale dell'Atlantico nero. È questa condizione esistenziale degli Afroamericani, caratterizzata tanto dall'oppressione quanto dalla resistenza al potere razzista, a produrre un ethos culturale permanente nel tempo, che va visto come una sorta di "tradizione-non-tradizionale", vale a dire come il prodotto dell'esperienza sociale e che, per questo stesso motivo, è ibrido, flessibile e sempre in continua mutazione o rielaborazione. Un ethos culturale dove il "same" va ricercato proprio nel "changing" e dove il "changing", viceversa, si tramuta nel "same".
Oggi non solo la musica e il cibo, le feste, la capoeira e la religione, ma anche elementi meno concreti come un "modo di essere" ereditato dagli Africani sono riconosciuti come valori nazionali ed esportati in tutto il mondo. Il berimbau, il pandeiro, la feijoada, gli orishas sono apertamente valorizzati come elementi della cultura nazionale. Il Brasile ha esportato il samba, il carnevale e le mulheres bahianas in tutto il mondo; il candomblé e l'umbanda in Argentina, Venezuela, Cile, Italia, Svezia, Francia, Germania, Stati Uniti e Giappone. Sono dei nostri giorni non solo la crescita e la partecipazione delle popolazioni più diverse alle scuole di samba, alla capoeira e ai ritmi di origine africana ‒ sia che si tratti del reggae, del samba o del jazz ‒, ma si assiste anche a un forte aumento dell'adesione alle religioni afrobrasiliane che diventano sempre più visibili in tutti gli spazi sociali e nei mass media a stampa ed elettronici apparendo in novelle televisive, mini-serie, film, esposizioni, pitture e sculture e, più recentemente, CD-ROM e siti web. Le scienze sociali, dal canto loro, si dedicano alla comprensione del ruolo del nero nella società nazionale che lo discrimina come individuo, mentre le sue pratiche culturali vengono assorbite con malcelata passione.
Bibliografia
Mondo afrobrasiliano:
R. Nina Rodrigues, Os africanos no Brasil, São Paulo 1932; Id., O animismo fetichista do negro bahiano, Rio de Janeiro 1935; F. Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris 1940 (trad. it. Milano 1952); A. Ramos, O negro brasileiro, São Paulo 1940; Id., A aculturação negra no Brasil, São Paulo 1942; A. Fernandes Brandão, Diálogos das grandezas do Brasil (1618), Rio de Janeiro 1943; M. Herskovits, The Southernmost Outposts of New World Africanism, in AmAnthr, 45 (1943), pp. 495-510; A. Ramos, As culturas negras no novo mundo: o negro brasileiro, São Paulo 1946; P.F. Verger, Notes sur le culte des orisa et vodun à Bahia, la Baie de tous les saints, au Brésil et à l'ancienne côte des esclaves en Afrique, Dakar 1947; E. Carneiro, Candomblé da Bahia, Salvador 1948; M. Herskovits, The Contributions of Afroamerican Studies to Africanist Research, in AmAnthr, 50 (1948), pp. 1-10; A. Ramos, Le métissage au Brésil, Paris 1952; P.F. Verger, Dieux d'Afrique, Paris 1954; R. Bastide, O candomblé da Bahia (rito nagô), São Paulo 1958; Id., Les religions afro-brésiliennes: contribution à une sociologie des interpénétrations de civilisations, Paris 1960; Id., Les religions africaines au Brésil, Paris 1960; E. Carneiro, O quilombo dos Palmares, Rio de Janeiro 1966; M. Herskovits, The Negro and the New World, Bloomington 1966; R. Bastide, Les Amériques Noires, Paris 1967 (trad. it. Milano 1970); P.F. Verger, Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos, Salvador 1968; D. Freitas, Palmares, a guerra dos escravos, Porto Alegre 1971; T. Pedreira, Os quilombos brasileiros, Bahia 1973; J.H. Mendonça, O crescimento e a localização dos centros e terreiros de Xangó do Recife, in Boletim de Recife, n.s., 2 (1975), pp. 97-114; O. Gudolle Cacciatore, Dicionario de cultos afro-brasileiros, Rio de Janeiro 1977; R. Ribeiro, Cultos afro-brasileiros do Recife, Recife 1978; L. Arcella, Rio Macumba, Roma 1980; G. Freyre, Casa-grande & senzala, Rio de Janeiro - Brasília 198020; Y. Pessoa de Castro, Das línguas africanas ao Purtuguês brasileiro, in Afro-Ásia, 14 (1983), pp. 81-106; P.F. Verger, L'Amérique Latine en Afrique, in L'Afrique en Amérique Latine, Paris 1984, pp. 305-15; M. Carneiro da Cunha, Negros, estrangeiros: os escravos libertos e sua volta à Africa, São Paulo 1985; S. Ferretti, Querebentan de Zomadonu. Etnografía de Casa das Minas, São Luiz 1985; C. Moura, Quilombos. Resistência ao escravismo, São Paulo 1987; J.J. de Carvalho, La fuerza de la nostalgia. El concepto del tiempo histórico en los cultos afrobrasileros tradicionales, in Montalban, 20 (1988), pp. 167-93; B. Gois Dantas, Vovó Nagô e papai branco. Uso e abuso da África no Brasil, Rio de Janeiro 1988; R. Ortiz, Morte branca de um feiticeiro negro: umbanda e sociedade brasileira, São Paulo 1988; B. Davidson, Storia dell'Africa, Torino 1990 (ed. or. London 1984); J. Lacourse, Quand les hommes rencontrent les dieux. Du cheminement initiatique à la logique rituelle dans le candomblé de Bahia, in L'Ethnographie, 86, (1991), pp. 9-19; R. Prandi, Os candomblés de São Paulo. A velha magia na metrópole nova, São Paulo 1991 (trad. it. Città in transe. Culti di possessione nella metropoli brasiliana, Roma 1993); C. Moura, História do negro brasileiro, São Paulo 1992; A. Moura de Figueiredo, Os Reis de Mina: a irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos no Pará do século XVII ao XIX, in Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, 9 (1992); Ph. Galembo, Divine Inspiration. From Benin to Bahia, Albuquerque 1993; R. Motta, L'invention de l'Afrique dans le candomblé du Brésil, in Storia, Antropologia e Scienze del Linguaggio, 2-3 (1994), pp. 65-85; G. Parodi da Passano (ed.), Mito e desiderio. Il corpo e la possessione nei riti afro-americani, Milano 1994; A.M. Rocha, Os candomblés antigos do Rio de Janeiro. A nação Ketu: origens, ritos e crenças, Rio de Janeiro 1994; V.G. da Silva, Orixás da metrópole, Petrópolis 1995; R. Slenen, 'Malungu, Ngoma Vem!' África encoberta e descoberta no Brasil, in Cadernos Museu da Escravadura, 2 (1995); H. Vianna, O mistério do Samba, Rio de Janeiro 1995 (trad. it. Il mistero del samba, Milano 1998); Haiti. 500 años de historia (Catalogo della mostra), Roma 1997; E. Farias, Paulo da Portela: mediator entre dois mundos, lavoro presentato nel XXII Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), Caxambu (Mato Grosso) 1998; J. Thornton, Africa and the Africans in the Making of the Atlantic World: 1400-1680, Cambridge 1998; S. Capone, L'Afrique réinventée ou la construction de la tradition dans les cultures afro-brésiliennes, in Archives Européennes de la Sociologie, 40 (1999); Ead., La quête de l'Afrique dans le candomblé. Pouvoir et tradition au Brésil, Paris 1999; M. Agier, Anthropologie du Carnaval: la ville, la fête et l'Afrique à Bahia, Marseille - Paris 2000; P. Gilroy, The Black Atlantic. L'identità nera tra modernità e doppia coscienza, Roma 2003 (ed. or. London - New York 1993); L. Matory, The Trans-Atlantic Nation: Tradition, Transnationalism and Matriarchy in the Rise of the Afro-Brazilian Candomblé, Princeton (in c.s.).
Qui di seguito si fornisce una bibliografia di riferimento concernente aree del doppio continente americano interessate in vario grado dal fenomeno schiavistico, che per ragioni di spazio sono state escluse dalla trattazione.
Belize: R. Taylor, The Black Caribs of British Honduras, New York 1951. Giamaica: F. Henriques, Family and Colour in Jamaica, London 1953; G.E. Simpson, The Ras Tafari Movement in Jamaica, in Social Forces, 34 (1955); N. Savishinsky, Transnational Popular Culture and the Global Spread of the Jamaican Rastafarian Movement, in Nieuwe West-Indische Gid/New West Indian Guides, 68, 3-4 (1994), pp. 259-81. Grenada: A. Pollak-Eltz, The Shango Cult in Grenada, British Westindies, 8th Congress of Anthropological and Ethnological Sciences 3/B-11, Tokyo 1968. Guyana Francese: J. Hurrault, Les noirs réfugiés Boni de la Guyane française, Dakar 1961; Id., Africains de Guyane, Paris 1970. Guyana Olandese: M. Kahn, Djuka, the Bushnegroes of Dutch Guayana, New York 1931. Haiti: J. Price-Mars, Ainsi parle l'oncle, Port-au-Prince 1928; Z.N. Hurston, Vodoun Gods, London 1939; J. Roumain, Le sacrifice du tambour Assotor, Port-au-Prince 1943; J. Price-Mars, Le culte des Marassas, in Afroamérica, 1-2 (1945); R. Taillant, Voodoo in New Orleans, New York 1946; M. Deren, Divine Horsemen, the Living Gods of Haiti, London 1953; A. Métraux, Haiti: la terre, les hommes et les dieux, Neuchâtel 1957; Id., Le vodu haitien, Paris 1958 (trad. it. Torino 1971). Messico: G. Aguirre Beltrán, La población negra en Méjico, México 1940; Id., Cujila, esbozo etnográfico de un pueblo negro, México 1958. Panama: A. Losonczy, Les saints et la forêt: rituel, société et figures de l'échange entre noirs et indiens Emberá, Paris 1997. Suriname: M. Herskovits, Suriname Folklore, New York 1936; S.W. de Groot, Djuka Society and Social Change, Assen 1969. Trinidad: M. Herskovits, Trinidad Village, New York 1947; D.J. Crowlely, Plural and Differential Acculturation in Trinidad, in AmAnthr, 59 (1957), pp. 817-24; G.E. Simpson, The Shango Cult in Nigeria and in Trinidad, in AmAnthr, 64, 6 (1962), pp. 1204-219; D. Hill, Calypso Calaloo. Early Carnival Music in Trinidad, Gainesville 1993. Venezuela: J.P. Sojo, Temas y apuntes afro-venezolanos, Caracas 1943; A. Pollak-Eltz, El culto de María Lionza, in Caribbean Studies, 7-4 (1958); Ead., Cultos afroamericanos, Caracas 1972; W.W. Megenney, Africa en Venezuela: su herencia lingüística y su cultura literaria, in Montalban, 15 (1984), pp. 207-60; A. Pollak-Eltz, Presencia e invisibilidad del negro en Venezuela, ibid., 20 (1988), pp. 47-251.