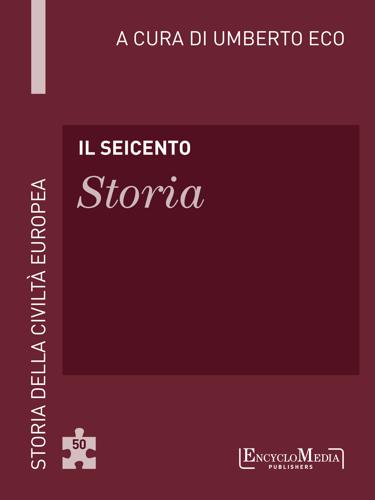L’America portoghese e spagnola
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Durante il Seicento, nonostante l’aggressività degli avversari protestanti della Spagna e del Portogallo – Olanda e Inghilterra – che riescono a strappare alcuni isole e lembi di territorio, Madrid e Lisbona mantengono sostanzialmente il controllo dei vasti imperi coloniali creati nel secolo precedente in America centrale e meridionale. Nel frattempo questi imperi vanno incontro a mutamenti sociali ed economici importanti. L’avvio della ripresa demografica degli indios e l’arrivo di un numero crescente di schiavi dall’Africa, dà vita a una popolazione etnicamente e culturalmente meticcia, mentre la distanza fra peninsulares e creoli – bianchi nati nelle Americhe – aumenta, così come aumenta l’autonomia anche economica dei viceregni americani.
Il Brasile portoghese
Nel corso del Seicento, al pari dei possedimenti asiatici dell’Estado da Índia portoghese, anche quelli americani subiscono la pressione degli Olandesi e, in minor misura, dei Francesi e degli Inglesi. Alle motivazioni economiche che spingono a impadronirsi, o quanto meno approfittare dei profitti derivanti dal traffico degli schiavi, della canna da zucchero e dell’argento, si uniscono quelle politiche e strategiche, ovvero indebolire la potenza degli Asburgo, sovrani del Portogallo tra il 1580 e il 1640.
Dopo aver creato nel 1600 alcuni insediamenti, gli Olandesi fondano nel 1621 la West Indische Compagnie (WIC) e nel 1624 conquistano Salvador, la capitale del Brasile portoghese. L’anno seguente la città viene riconquistata, ma gli Olandesi non desistono dalla loro offensiva e occupano Pernambuco e Recife, il cuore delle regione dove viene coltivata la canna, fondandovi la loro colonia di Nieuw Holland, della quale Maurizio di Nassau diventa governatore. Per assicurarsi il rifornimento di manodopera necessaria, gli Olandesi nel 1637 conquistano anche il caposaldo portoghese di São Jorge da Mina (Elmina), sulla costa dell’attuale Ghana. Neppure la riacquistata indipendenza del Portogallo dalla Spagna, nel 1640, arresta l’attacco olandese. Nel 1641 vengono prese altre piazzeforti africane, come Luanda e São Tomé.
Anche l’Impero portoghese dell’Atlantico, come quello nell’oceano Indiano, sembra dunque passare sotto il controllo degli Olandesi. Le cose però prendono qui una piega diversa. In Brasile, i Portoghesi bianchi e meticci sono molto più numerosi degli Olandesi e per la nuova dinastia nazionale dei Braganza la difesa del Brasile ha la priorità. Tra il 1645 e il 1653 dunque gli Olandesi vengono progressivamente espulsi e il controllo del Portogallo ripristinato.
Nel corso del secolo inoltre i confini del Brasile portoghese vengono enormemente estesi verso l’interno dalle spedizioni dei bandeirantes alla ricerca di giacimenti di metalli preziosi e di schiavi. La scoperta di giacimenti auriferi nella regione di Minas Gerais alla fine del secolo, e lo sviluppo dell’allevamento, compensano almeno in parte il declino della coltivazione della canna da zucchero, colpita della concorrenza delle isole caraibiche inglesi e francesi in pieno sviluppo. Alla fine del Seicento dunque il Brasile portoghese non solo è sopravvissuto alla minaccia della conquista olandese, ma la sua consistenza territoriale e la sua importanza economica per il Portogallo si sono notevolmente accresciute.
L’America spagnola e i suoi nemici
Anche gli immensi territori appartenenti ai due Vicereami spagnoli, quello della Nuova Spagna a nord e quello del Perù lungo le Ande, sono esposti all’aggressività delle potenze ostili al Rey Católico, che agiscono direttamente o indirettamente tramite corsari.
Durante tutto il Seicento l’iniziativa strategica, soprattutto sul mare, rimane costantemente nelle mani dei nemici della Spagna, la quale subisce duri colpi in acqua, sia lungo le coste metropolitane che lungo quelle americane. Olanda, Francia e Inghilterra riescono a strappare alla Spagna molte isole e piccoli ma significativi lembi di territorio. La Francia ottiene la Dominica (1632), Martinica e Guadalupe (1635), l’isola di Tortuga (1640) e soprattutto la porzione occidentale di Hispaniola (1697). L’Olanda occupa l’isola di Curaçao (1637) e successivamente il Suriname (1697). Ancora più ricco è il bottino dell’Inghilterra: Barbados, St. Vincent, Antigua, St. Kitts e altre isole delle Piccole Antille negli anni Venti e Trenta del secolo; e poi le Cayman (1655), Providence (1655), le Bahamas (1670) e sulla terraferma centro-americana il Belize e la Mosquito Coast, tra gli attuali Nicaragua e Honduras.
Gli insediamenti e le flotte spagnole sono oggetto di continui attacchi. Cartagena, Maracaibo, Puerto Principe e Portobello, ad esempio, sono saccheggiate dall’inglese Henry Morgan, prima bucaniere freelance, poi corsaro con regolare lettera patente di Sua Maestà britannica e infine governatore inglese della Giamaica, occupata nel 1655. Una carriera esemplare del complesso intreccio di guerra, politica e pura e semplice pirateria che caratterizza i Caraibi nel Seicento. Nel 1626, inoltre, l’Olandese Piet Heyn cattura l’intera flotta dell’argento diretta in Spagna. Un’impresa replicata, almeno in parte, dall’inglese Robert Blake nel 1657.
Nella seconda metà del Seicento, del monopolio economico e militare sul Nuovo Mondo che la Spagna aveva difeso con un certo successo per oltre un secolo, rimane ben poco. Con il trattato di Londra del 1670 la Spagna deve riconoscere formalmente la legittimità delle acquisizioni inglesi nelle Americhe.
Gli insediamenti di altre potenze europee hanno un significato militare, essendo spesso basi di partenza per incursioni, ma anche un’importanza economica sempre maggiore. Francesi, Inglesi e Olandesi danno infatti il via alla coltivazione di canna in concorrenza con Spagnoli e Portoghesi, e utilizzano queste basi per la loro penetrazione commerciale nei territori spagnoli.
L’Impero si allontana dalla Spagna
La minaccia più grave per il controllo della Spagna sui territori al di là dell’Atlantico non è però di natura militare.
Nel corso del Seicento lo sviluppo economico, agricolo e manifatturiero della società americana si avvia sulla strada di una sempre maggiore complessità e autonomia dalla madrepatria. Fin dalle origini la relazione economica e politica tra la Spagna e le sue colonie è stata fortemente asimmetrica. Per la Spagna, soprattutto dopo la metà del Cinquecento, le risorse provenienti dall’America sono vitali, ma essa ha ben poco da offrire in cambio. I prodotti di cui i coloni hanno bisogno per riprodurre il loro stile di vita di origine europea provengono in larga misura dall’Europa settentrionale e i trasferimenti di metalli preziosi dall’America alla Spagna non derivano, come quelli dall’Europa all’Asia, da un flusso di scambi commerciali, quanto da un prelievo di tipo tributario. Il monopolio che la Spagna pretende di esercitare non si fonda quindi su di un elevato livello di complementarità fra le due economie ma essenzialmente sulla forza militare, sulla capacità della Spagna e della sua flotta di controllare lo spazio marittimo atlantico.
Già a partire dalla fine del Cinquecento questa capacità, come si è visto, è erosa dall’emergere della potenza navale degli Stati protestanti che apre spazi crescenti al contrabbando. Nel corso del Seicento questa tendenza si aggrava, non solo per quanto riguarda le merci, ma anche per un fattore di produzione fondamentale, come gli schiavi: Inglesi, Olandesi e Francesi contribuiscono per oltre i due terzi dei circa 700-800 mila schiavi deportati in America durante la seconda metà del Seicento. Ma a complicare le cose vi è anche la tendenza delle società coloniali americane, spagnole, portoghesi e nordiche a una maggiore autonomia complessiva dall’Europa. Le città dell’America spagnola continuano per la verità a dipendere fortemente dalle importazioni esterne, ma una quota sempre maggiore del loro fabbisogno viene soddisfatta da merci provenienti, oltre che dall’Europa settentrionale, dalle colonie, soprattutto inglesi, dell’America settentrionale.
Un sintomo significativo di questa maggiore autosufficienza è la percentuale crescente di argento estratto dalle miniere delle Ande o messicane, che rimane nel Nuovo Mondo ad alimentare i circuiti economici e commerciali americani anziché prendere, sia pure provvisoriamente, la via della Spagna. In definitiva, mentre i legami interni fra le diverse componenti del mondo coloniale spagnolo, oltre a quelli con le colonie inglesi, olandesi e francesi, e le stesse metropoli dell’Europa settentrionale si fanno più stretti, quelli con la Spagna si allentano. La Spagna ha sempre più bisogno delle risorse dell’Impero per sostenere il suo ruolo internazionale, ma l’Impero ha sempre meno bisogno della Spagna. Non c’è dubbio che nel corso del Seicento il sistema di scambi economici costruito a cavallo dell’Atlantico – tra Americhe, Europa e Africa – si espanda, si consolidi e si faccia più complesso, ma in questo sistema il ruolo della Spagna diventa sempre più marginale.
Creoli e Spagnoli
Il rapporto fra le colonie e la metropoli si fa conflittuale, non solo nella sua dimensione economica e politica ma anche sociale e istituzionale.
Fin dalle sue origini, le istituzioni sociali e politiche dell’America spagnola sono una sorta di copia imperfetta di quelle spagnole. Dovendo ricostruire ex nihilo una società nuova, la Corona si trova in una posizione migliore per imporre un sistema di governo centralizzato. Quasi tutte le istituzioni spagnole – audiencias (tribunali regionali), cabildos (giunte municipali), governatorati, vicereami ecc. – vengono replicate, salvo significativamente le cortes, ovvero le assemblee rappresentative dei ceti. La monarchia cerca anche di ostacolare la formazione di un’aristocrazia terriera ereditaria analoga a quella che in Spagna – e altrove in Europa – costituisce l’ostacolo più ingombrante alle aspirazioni di potere assoluto del sovrano.
L’amministrazione spagnola nel Nuovo Mondo si fonda su un apparato burocratico relativamente esteso, al quale si affianca una gerarchia ecclesiastica potente e numerosa. Questi due apparati diventano nel Seicento il terreno di un’aspra concorrenza fra criollos – creoli, vale a dire i bianchi o quasi bianchi nati in America – e i gachupines o pensinsulares, ovvero coloro che provengono dalla Spagna.
La rivalità fra i due gruppi, peraltro niente affatto impermeabili, si traduce anche nell’elaborazione di immagini e stereotipi denigratori. I pensinsulares considerano i criollos come degli Spagnoli degenerati a causa delle condizioni climatiche e ambientali o, ancora peggio, dalle commistioni etniche con gli indigeni. Da parte sua la società creola, che nel Seicento è un realtà molto più complessa e articolata di un secolo prima, si rende sempre più consapevole della specificità della propria identità e dei propri interessi, ed elabora forme di patriottismo americano che giungono ad appropriarsi della storia e delle immagini del passato precolombiano per inventare una tradizione storica almeno in parte alternativa a quella propriamente spagnola. L’arco trionfale progettato nel 1680 dall’erudito messicano Sigüenza y Góngora per l’ingresso a Città del Messico del nuovo governatore marchese di La Laguna è, ad esempio, ornato dalle statue dei dodici imperatori aztechi, compresi gli ultimi due combattuti dagli Spagnoli, in evidente parallelismo con i dodici Cesari della tradizione classica.
Questo patriottismo americano non è però necessariamente in conflitto con la lealtà dovuta al sovrano. E neppure si traduce, almeno per il momento, in richieste di autonomia e tanto meno di indipendenza. Del resto sentimenti e tensioni analoghi sono riscontrabili in tutti i domini degli Asburgo e sono in qualche misura connaturati al carattere di “monarchia composita” del loro impero.
Bianchi, neri, indiani e meticci
Il solco che si allarga fra criollos e pensinsulares riguarda in sostanza l’élite dell’America spagnola, ma non è certo l’unica linea di frattura nella società coloniale, e neppure la più importante. La società coloniale non è meno gerarchica di quella europea, ma le rigidità e le flessibilità dell’ordinamento sociale sono diversamente distribuite.
In America, come si è visto anche per volontà della Corona, l’aristocrazia è meno presente che in Spagna. La conseguenza è una società più fluida, più mobile, dai confini di ceto più incerti. Una mobilità resa possibile anche dalle opportunità – o dai miraggi – di arricchimento che il Nuovo Mondo offre. La barriera del sangue tra nobili e plebei è dunque meno invalicabile nelle Americhe, e la distinzione fra nobile e plebeo meno netta anche perché la quasi totalità della popolazione è di origine non nobile ma assolutamente convinta di essere tale. Quanto detto vale però all’interno della componente di origine europea, molto minoritaria se si tiene conto che durante il Seicento solo 450 mila Europei attraversano l’Atlantico e circa due terzi di loro sono spagnoli.
Ma il quadro etnico dell’America spagnola e portoghese è estremamente complesso. Accanto ai bianchi vi è la República de los Indios, formalmente parallela a quella de los españoles, dotata di una propria gerarchia sociale e, a partire dai decenni centrali del secolo, in ripresa demografica dopo la catastrofe del Cinquecento. E poi naturalmente vi sono i neri, sempre più numerosi nelle aree dedite alla coltivazione della canna – Caraibi, costa settentrionale dell’America meridionale – ma in realtà massicciamente presenti anche altrove e soprattutto nelle grandi città. Matrimoni misti, violenza, sfruttamento sessuale e concubinaggi trasformano rapidamente quella che potrebbe sembrare un società tripartita in un caleidoscopio di razze (castas) e status, che si cerca vanamente di definire e classificare: i mestizos sono il risultato dell’unione di uno spagnolo e di un’indiana (il contrario è un evento molto raro), da uno spagnolo e una meticcia nasce un castizo, da un indiano e una meticcia un coyote, da un indiano e un’africana uno zambo, da uno zambo e un’indiana un chino e così via, in una casistica sempre più complessa col passare delle generazioni.
Non stupisce che la pervasività del meticciato produca un’ossessione per la genealogia e la limpieza de sangre, già presente nella tradizione della Penisola iberica a causa della contiguità con la comunità musulmana ed ebraica. Quella dell’America iberica è stata definita una “gerarchia pigmentocratica” nella quale la bianchezza della pelle è il parametro più importante per stabilire la posizione nell’ordinamento sociale e l’identità individuale. In questa prospettiva i bianchi, creoli o peninsulares che siano, costituiscono l’equivalente e il surrogato di una nobiltà ereditaria di tipo europeo. Come avrebbe notato ancora nell’Ottocento Humboldt, quando qualche plebeo ha un alterco con un personaggio titolato, comunemente gli dice “Pensi di essere più bianco di me?”
La Chiesa cattolica e le Americhe nel Seicento
Nel processo di costruzione di un’identità americana e nell’evoluzione sociale, la dimensione religiosa è decisiva. Dopotutto, ancor più dello Stato, la Chiesa è l’istituzione più influente del Nuovo Mondo. Ma si tratta di un’istituzione divisa al suo interno da contrasti profondi. Innanzitutto quello fra clero regolare, che nei decenni della Conquista e della prima evangelizzazione aveva avuto un ruolo di punta, e clero secolare, che cerca di conquistare sul campo quella centralità che il concilio di Trento gli aveva assegnato. Vi è poi il contrasto fra i diversi ordini, vecchi – come i Francescani e i Domenicani – e nuovi, come i Gesuiti. Infine, anche la Chiesa è interessata dal contrasto fra Spagnoli e creoli.
Questi ultimi, a partire dalla fine del Cinquecento, guadagnano posizioni, sia nei benefici parrocchiali che nelle cattedre vescovili. Anche gli ordini conventuali si aprono alle esigenze della società creola e i conventi che si moltiplicano nelle città coloniali si popolano di figlie e figli destinati al chiostro dalle strategie patrimoniali delle ricche famiglie creole, nonostante le perplessità circa la loro preparazione e la moralità dei confratelli provenienti dalla Spagna. L’influenza acquisita dai creoli all’interno delle istituzioni ecclesiastiche americane comporta anche l’emarginazione quasi completa degli indigeni.
In contrasto con questa tendenza prevalente si muove soprattutto l’ordine dei Gesuiti, che nel Seicento è senz’altro il più attivo nell’opera missionaria, in America come in Asia. La disponibilità dei gesuiti ad accogliere indigeni nei loro collegi e a ordinarli sacerdoti incontra però la decisa opposizione delle autorità laiche. Nel 1618, ad esempio, il viceré del Perù, Francisco de Borja Y Aragón, vieta l’accesso degli indios al collegio della Compagnia a Lima.
I gesuiti sono anche i protagonisti di una delle esperienze più significative dell’evangelizzazione nelle Americhe, quella delle reducciónes del Paraguay. La prima reducción popolata da indigeni Guaranì, viene fondata nel 1610. Nel 1631 la reducción viene attaccata da cacciatori di schiavi e i gesuiti sono autorizzati ad armare gli indios i quali, guidati dagli stessi gesuiti, riescono a sconfiggere nel 1641 i bandeirantes. Le reducciónes si organizzano come comunità semiautonome dirette dai padri i quali, oltre che dell’evangelizzazione in senso stretto e dell’istruzione, si occupano degli aspetti organizzativi, militari e dei rapporti con le autorità spagnole.