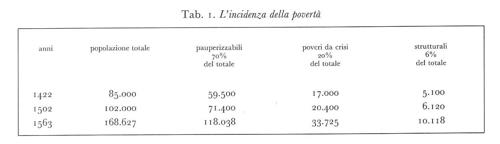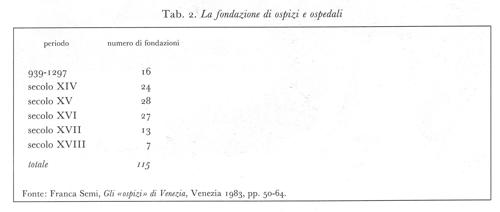L'assistenza e la beneficenza
L'assistenza e la beneficenza
Introduzione: l'ideologia della beneficenza
Debbe il mercante essere largo a porgere la mano al povero, et farli elemosina della sua facultà quanto si extende, et se nulla ha da dare pietosamente sospirare iusto quello detto d'Augustino: ῾Nunquam vidi hominem pium mala morte perire'. Et havendo, se non dà elemosina al povero peccha ecternalmente.
Così scriveva Benedetto Cotrugli nel suo Libro dell'arte di mercatura, composto nel 1458 ma edito soltanto nel 1573 presso Elefanta a Venezia (1). Per quanto il Cotrugli fosse originario di Ragusa e avesse servito Alfonso e Ferdinando a Napoli, la sua opera - che coglie lo spirito della società mercantile mediterranea del secolo XV - è "riferibile senza riserva all'orbita veneziana" (2), secondo quanto afferma Ugo Tucci.
Cotrugli scrisse il suo trattato per celebrare un ceto sociale, quello dei mercanti. A suo sentire, il mercante perfetto eccelle nel servizio del bene comune, nell'amministrazione della proprietà privata, nelle proprie associazioni tanto pubbliche che private, nella perfetta buona fede. Nel terzo capitolo del libro secondo, Cotrugli prende dunque in esame le opere di carità e, dopo aver elencato le sette elemosine corporali e le sette elemosine spirituali, passa a considerare il problema centrale: come determinare, cioè, chi sia più degno di ricevere l'altrui carità. Con l'inclinazione tipica del mercante, attento a calcolare le spese e a valutare i potenziali profitti, e ispirandosi a Tommaso d'Aquino, egli suggerisce che il mercante non dia in elemosina ciò di cui esso stesso abbisogna per mantenersi e mantenere le persone delle quali è responsabile, ma soltanto il "superfluo"; perché - sottolinea Cotrugli - "prima bisogna che l'homo provegha sé medesimo et i suoi" e poi "dello avanzo facci elemosina alli poveri" (3). Resta tuttavia da capire chi siano i beneficiari più degni della privata carità del mercante. Primo dovere del benefattore, risponde Cotrugli, è di dare a coloro i quali gli sono in qualche modo legati, prima che agli estranei; e, in ogni caso, spetta al mercante stabilire quale forma di carità sia la più giusta e la più confacente al "bene comune". Fra i poveri andranno preferiti quelli che non possono lavorare e si vedono costretti alla mendicità, mentre - per parte sua - il povero che accetti l'elemosina senza averne bisogno commette peccato in quanto sottrae ai più bisognosi il necessario beneficio; quanto al mercante, che non volga in elemosine i guadagni illeciti. Cotrugli conclude la propria disamina rilevando gli aspetti salvifici dell'elemosina, che paragona a una terapia; infatti
[...] la elemosina è salubre, singolare et optimo medicamento a ridurre l'homo a perfecta contrition, et per consequens ad emmendatione di vita, perché la lacrima della compassione che viene dentro del dritto core ha grande virtù a ffare l'homo emendare la sua vita et ad fare l'optimo fine (4).
Il discorso di Cotrugli sulle opere caritative rispecchia le attitudini e i convincimenti del ceto mercantile che governava le città italiane nel secolo XV, per i cui membri la vera carità cominciava entro le mura di casa, in favore di parenti e dipendenti, per estendersi poi ai soggetti bisognosi. Il fine era pratico e duplice: promuovere il bene collettivo, ma anche giovare all'anima del benefattore. Scarsa attenzione, o addirittura nessuna, era riservata ai motivi che stavano alla base della condizione di povertà o alla possibilità di alleviarla mediante una redistribuzione della ricchezza, e - d'altro canto - i poveri venivano considerati in primo luogo nell'ottica dei salubri effetti che le loro preghiere avrebbero convogliato a sollievo delle anime dei ricchi. È all'incirca questo atteggiamento pratico nei rispetti dell'elemosina che si riscontra nel libro dei conti di Lorenzo Priuli, padre del ben noto banchiere e diarista Girolamo. Alla fine di ciascun anno, nel registrare le spese della famiglia, egli aggiungeva la voce "dar per Dio", a dimostrazione che per lui, come per gli altri mercanti, l'elemosina era considerata un'uscita necessaria alla buona conduzione dell'impresa della vita (5).
Se nella posizione di un Cotrugli si rispecchiano le attitudini dell'élite mercantile mediterranea al riguardo della carità e dell'elemosina, i discorsi morali e filosofici di un Giovanni Caldiera ci avvicinano ancor più all'ambiente veneziano o, per meglio dire, all'ideologia dell'élite mercantile lagunare come ceto dirigente: quel bene comune che Cotrugli pone tra i due scopi fondamentali della carità, a Venezia assume il connotato dell'orgoglio locale.
Nato da famiglia cittadinesca intorno al 1400, Giovanni Caldiera fu studente e poi insegnante di medicina presso lo Studio padovano, per tornar quindi a Venezia ed esercitarvi la professione nonché entrare a far parte di un illustre circolo umanistico, formato da patrizi e non (6). Tra gli scritti di Caldiera, la produzione di maggiore rilevanza è costituita da una trilogia di opere composte negli anni 1463-1464, nelle quali si tratta di etica personale, di famiglia, di Stato ideale. Il primo di detti testi, De virtutibus moralibus et theologicis presenta un'esposizione alquanto convenzionale delle tre virtù teologali (fede, speranza e carità) e una dissertazione sulle quattro virtù cardinali e i sette vizi capitali. Il secondo, De veneta iconomia, discute della famiglia ideale assimilandola a un sistema di governo, sia pure su scala ridotta. Il terzo, De praestantia venetae politiae, esamina le sette arti meccaniche e le sette arti liberali, chiudendosi con una descrizione del governo veneto. È in quest'ultimo trattatello che - come ha sottolineato Margaret L. King - si svela l'importanza interamente sociale delle tre virtù teologali, trasfigurate in "una trinità di valori repubblicani" (7). Con gli sforzi operati a vantaggio dello Stato, i cittadini manifestano la propria fiducia nel sistema politico vigente e, insieme, la speranza di conseguire quelle cariche e quegli onori che esso assegna; e, ancora, nelle responsabilità verso la Repubblica essi rivelano il segno della carità. Carità che, meglio di tutto, si esprime nelle confraternite in cui i Veneziani si riuniscono come fratelli, giacché - secondo quanto afferma il Caldiera - la carità non è solamente una virtù personale, ma anche pubblica e come tale dev'essere coltivata e incoraggiata (8).
Tanto Cotrugli quanto Caldiera esprimono un'ideologia dell'assistenza e della beneficenza quale la intendeva il ceto dirigente mercantile veneziano alla metà e sul finire del secolo XV. Simili indirizzi sono contenuti nei documenti ufficiali.
Così, nel 1503, il maggior consiglio approva una legge che impone agli ufficiali pubblici neoeletti di versare un ducato del proprio stipendio a pro delle casse dell'ospedale di Sant'Antonio, traducendo nella pratica il parallelismo già espresso dal Caldiera tra valori individuali e pubblici. D'altra parte i membri del maggior consiglio sono persuasi delle benefiche conseguenze dell'elemosina sulle istituzioni repubblicane:
El principal e più salubre remedio a propiciar la divina gratia ad uno stato et republicha, come in particulari ad alguna persona e republica, è il sustentamento di poveri nel qual è figurata e representata la persona di missier Jesu Christo (9).
L'élite veneziana considerava la caritas una virtù ad un tempo personale e politica, cosicché l'assistenza diventava un affare riguardante non meno l'individuo che lo Stato e nel quale erano in gioco tanto la salvezza dell'anima del benefattore quanto il benessere della Repubblica. Questa mescolanza di privato con pubblico, di interessi individuali con interessi corporativi stava al centro dell'ideologia veneziana dell'assistenza e della beneficenza, e contribuì a determinare le forme con le quali l'una e l'altra si esplicavano. Durante il Quattrocento, dunque, l'azione caritativa veneziana fu caratterizzata dal concorso di istanze diverse, volte insieme alla salute dell'anima del benefattore, alla pacificazione dello Stato e - non ultima - alla creazione di un senso della comunità. Obiettivi che, alternativamente, influenzarono la visione stessa dei bisognosi da parte dei ceti abbienti e, per conseguenza, i modi della pratica di carità.
L'idea che la carità non solo aiutasse i poveri, ma che avesse un altrettanto importante effetto salvifico sul versante dei benefattori significava che gli uni e gli altri, riceventi e donatori, erano uniti da una relazione di reciprocità simbiotica. D'altronde i teologi medievali sostenevano che l'anima dei ricchi è maggiormente esposta al rischio della dannazione rispetto a quella dei poveri: la salvezza dei ricchi dipende dai poveri, in virtù delle preghiere di intercessione da quelli rivolte alla Vergine e ai santi. Così san Bernardino da Siena: "I ricchi sono di necessità alle repubbliche; e i poveri sono di necessità a' ricchi" (10). Sicché il povero giocava un "ruolo morale nella società, proprio in ordine al suo basso livello economico" (11). La convinzione che i poveri fossero necessari, e anzi costituissero una componente essenziale della società, spiega perché in età medievale e moderna la carità fosse rivolta ad alleviare la sofferenza piuttosto che a eliminare le cause della povertà. I contemporanei accettavano in tutto l'enunciato evangelico secondo il quale - parole del Cristo - "i poveri stanno sempre con noi" (Matteo 26, 11 ). In realtà, l'esistenza stessa dei poveri serviva a testimoniare e insieme ad affermare l'ordine sociale: una giustificazione della povertà che si adattava particolarmente bene al tipo di società gerarchizzata e di casta qual era la veneziana. E vigeva inoltre la convinzione che tra ricchi e poveri dovesse ricorrere un contatto reciproco e diretto; era necessario che il benefattore depositasse di persona l'elemosina nelle mani del bisognoso. Cotrugli - come s'è detto - raccomandava che i primi beneficiati fossero in qualche modo vicini ("congiunti") al donatore e, infatti, secondo il sentire corrente i più meritevoli dell'aiuto caritativo erano i poveri "conosciuti" (12).
Che poi la carità fosse ritenuta di giovamento allo Stato, lascia intendere che il gesto misericordioso doveva essere pubblico; lungi dal rimanere nascosta, la pietà doveva essere per così dire "pubblicizzata": se per un verso le pubbliche dimostrazioni di carità da parte dei singoli benefattori avevano l'effetto di affermarne la posizione sociale, l'assistenza alla povertà a cura della Repubblica voleva rendere esplicita la clemenza e la misericordia del regime marciano verso i sudditi. Ed entrambe le forme di carità, privata e statale, intendevano convogliare sui rispettivi attori il favore divino.
Dati tali presupposti, appare evidente che tanto la povertà quanto la carità si esprimevano in modi ritualizzati, quasi che l'una e l'altra fossero rette da una coreografia. Cencioso, con gli abiti a brandelli, la mano protesa, la particolare intonazione della voce gridando "ahimé" e implorando l'elemosina, tutte queste caratteristiche designavano il mendicante e all'istante identificavano in lui una persona meritevole della pietà dei passanti; e ugualmente obbligatoria la benedizione pronunciata dal mendicante all'indirizzo di chi lo aveva beneficato. Soltanto i "poveri vergognosi", vale a dire quei soggetti che già di civile condizione erano falliti in tempi difficili e avvertivano nella mendicità il proprio discredito, rifuggivano lo sguardo pubblico, anche se il loro anonimato era in fondo una forma di notorietà che li rendeva degni destinatari della carità.
Come il mendicare, così l'elemosina si svolgeva secondo un rituale pubblico suo proprio e da lungo tempo consolidato, inteso a manifestare la pietà e l'umiltà nonché lo status - di chi la elargiva. Marin Sanudo riferisce di uno di questi pubblici atti di carità, durante la Settimana santa dell'anno 1524, protagonisti i NN.HH. procuratori dell'ospedale degli Incurabili e relative signore:
[...] con grande humilità lavorno li piedi a li poveri infermi infranzozati, et le done zentildone lavorno i piedi a le done overo femene inferme dil ditto mal; che fu assa' persone a veder, et mosse molti a devution vedendo questi di primi di la terra far opera cussì pia (13).
A parere di Sanudo, fu questo un gesto "molto divoto" che ottenne l'effetto desiderato, ovvero ispirare negli astanti una maggiore devozione. Ma aveva anche un significato politico l'azione di quei "primi di la terra" che interpretavano la parte del Cristo nel lavare i piedi ai sifilitici, e il nostro diarista, ai fini della propria descrizione, non manca di annotare scrupolosamente i nomi dei signori procuratori. V'erano, tra di loro, alcuni esponenti delle più illustri famiglie del patriziato veneto, come - per fare un nome - Vincenzo Grimani, figlio di Antonio, il doge.
L'assistenza aveva un andamento strettamente legato al calendario cristiano. L'anno era costellato da festività e da ricorrenze nelle quali i parrocchiani, le fraglie e le confraternite pie rendevano onore ai rispettivi patroni, occasioni tutte - oltre che di messe celebrative e di preghiere - di elemosina. Eventi tuttavia di minor portata se paragonati alle effusioni di pietà e di carità che si dispiegavano in coincidenza con il periodo natalizio e la Settimana santa. Il governo marciano, che - come vedremo tra breve - era un importante promotore di assistenza e di beneficenza, usava in particolare le festività natalizie e pasquali per mostrare il proprio volto più misericordioso. Proprio in quest'ultimo periodo cadeva la sessione del maggior consiglio del Martedì santo, nota come consiglio "dele gratie" (14), durante la quale venivano presentate delle petizioni in cui si chiedeva l'intervento dello Stato - la "grazia", appunto - in presenza di situazioni di particolare disagio. Sotto l'anno 1522 Sanudo riferisce il caso di un padre di famiglia che impetrava un sussidio, accompagnando la propria supplica con la messa in scena di una sorta di dramma rituale:
Fu poi menato in cariega uno puto infermo fiol di sier Zuan Francesco Lion q. sier Alexandro atorno il Consejo, et il padre drio pianzendo, e leto una suplichation, dimanda una balestria in vita sua su le galie di merchi a l'anno (15).
La scena altamente drammatica - e attentamente orchestrata -, con il bimbo infermo fatto sfilare nella sala del maggior consiglio, era intesa a suscitare la compassione dei consiglieri. E funzionò: la grazia fu approvata all'unanimità.
Di tutti gli atti rituali di carità, nessuno esprimeva gli ideali sociali e politici del sistema istituzionale veneziano meglio del convito fraterno o "caritade", allorché gli iscritti a una fraglia o i confratelli di una Scuola o, ancora, i fedeli di una parrocchia si riunivano insieme per consumare un pasto comune, i cui avanzi debitamente raccolti venivano poi distribuiti ai bisognosi (16). Nel tempo questo rituale si evolvette in una forma di carità cui i privati cittadini riservavano per via testamentaria delle somme di danaro, lasciando peraltro i testatori precise disposizioni sul numero dei poveri ammessi alla mensa e sulla composizione del pasto (di solito pane e vino e, probabilmente, pesce, carne o formaggio).
Tra la fine del secolo XIII e l'inizio del XIV la donazione per "caritade" divenne particolarmente popolare, se è vero che circa un quarto di coloro che nella parrocchia di San Giacomo dall'Orio dettarono testamento tra il 1297 e il 1347 prescrisse dei lasciti da impiegarsi a questo specifico scopo a pro dei coparrocchiani: sottolineavano i testatori, così facendo, che la parrocchia è una comunità nella quale tutti, ricchi e poveri, sono posti sotto l'egida di un patrono comune (17).
E però, con il procedere del secolo XIV, i testatori cominciarono a rivolgere altrove le proprie attenzioni caritative (18) cosicché la regolarità della donazione parrocchiale per "caritade" finì per venire meno, pur restando un modo occasionale di beneficenza: ancora nel 1432 una serva di Burano disponeva un lascito per "caritade" in favore delle altre donne a servizio nell'isola (19).
La pratica della convivialità appare particolarmente significativa in quanto affermava un senso di intimità e di comunione tra i partecipanti. Così la "caritade", con i suoi alimenti obbligatori - il pane e il vino -, faceva esplicito riferimento al più importante dei pasti che furono condivisi, l'Ultima cena, quotidianamente rinnovata nella messa e rappresentata in innumerevoli produzioni artistiche. Allo stesso modo, nel contesto delle cerimonie di insediamento del doge neoeletto, era uso che la dogaressa offrisse un pranzo - uno dei quali è accuratamente descritto nelle Estoires de Venise, cronaca duecentesca di Martino da Canal (20) - alle fraglie cittadine, con ciò confermando la solidarietà vigente tra lo Stato e le corporazioni veneziane.
L'enfatizzazione della comunione tra ricchi, confraternite, associazioni di mestiere e poveri, tra coloro che detenevano il potere politico ed economico e i diseredati costituisce il regolo della pratica e della politica della beneficenza a Venezia durante il medioevo e per i primi settant'anni del secolo XV. Fu solo negli ultimi anni del Quattrocento e nei primi decenni del Cinquecento che una serie di crisi e di contrasti, insieme alla mutata composizione del popolo dei poveri e della definizione stessa della povertà, portarono a notevoli innovazioni.
L'identificazione del povero
Uno dei maggiori problemi con i quali hanno a che fare gli storici che si occupano di assistenza e di beneficenza sta nella determinazione del numero dei poveri presenti in città nei diversi periodi. Poiché, per lo scorcio temporale che qui ci interessa, non esistono dati censuari attendibili, risulta praticamente impossibile stimare con precisione l'incidenza della povertà e, pure, valutare la capacità delle istituzioni caritative veneziane di sovvenire i poveri. Nondimeno Brian Pullan, il più illustre e sensibile studioso della materia, ha azzardato alcune conclusioni generali circa le dimensioni del fenomeno pauperistico a Venezia. Fondando dunque le proprie osservazioni su analoghe situazioni in altre città in età moderna, Pullan suggerisce che qui, come dovunque, dal 50 al 70 per cento della popolazione fosse potenzialmente "pauperizzabile", cioè a dire che, dipendendo questa folla di individui dal salario percepito, qualsiasi interruzione del normale flusso delle entrate rischiava di ridurla in povertà. Inoltre lo studioso inglese ipotizza che all'interno di questo largo contingente di poveri potenziali si possano distinguere due sottogruppi: il primo - che egli definisce dei "poveri da crisi" e comprendente forse il 20 per cento della popolazione fatto di persone che vivevano in condizione così prossima alla soglia minima di sussistenza che anche un lieve aumento del prezzo del pane li avrebbe messi in crisi; il secondo, più ridotto, costituito da poveri strutturali ovvero da quanti, non in grado di lavorare come vecchi, storpi, ciechi, malati cronici, dipendevano in tutto e per tutto dall'elemosina. Pressoché ovunque - secondo Pullan - il numero dei poveri strutturali oscillava tra il 4 e 1'8 per cento della popolazione, a misura della maggiore o minore capacità delle istituzioni caritative di provvedere loro (21).
Molti storici hanno tentato di stimare la popolazione veneziana in diversi periodi storici. Dal momento che non esistono - come s'è detto - dati censuari completi, essi hanno basato i rispettivi calcoli su una varietà di misure differenti. Ad esempio, a partire dal consumo di grano si è ipotizzato che nel 1422 in città vi fossero 85.000 abitanti, con un aumento di 25.000 unità rispetto al minimo storico del 1348, sulla scia della Peste Nera. Un'altra stima, fondata sul censimento parziale del 1502, fissa la popolazione totale a 102.000 unità, quasi equivalente al livello di popolamento precedente al 1348 (22). Ancora, certuni dati contenuti in fonti manoscritte indicano per Venezia 168.627 anime nel 1563 (23). Quando si combinino questi numeri con la partizione percentuale del fenomeno pauperistico proposta da Pullan, si perviene alla tabella seguente:
Poiché queste cifre si combinano su due metodi di valutazione ovvero categorie di ipotesi (da un lato la popolazione, dall'altro l'incidenza della povertà), vanno prese con estrema cautela. Ciò nonostante esse ci forniscono almeno un quadro generale del fenomeno: i numeri riguardanti i "poveri da crisi" sono probabilmente i più indicativi giacché attestano come in tempi difficili, durante il secolo XV e la prima metà del XVI, dai 17.000 ai 33.000 abitanti fossero realmente minacciati dal pericolo della fame. Non solo, esse segnalano altresì la portata dei problemi che, in questo campo, le autorità si trovavano ad affrontare: si spiega allora perché uno dei punti più qualificanti della politica del governo veneziano vertesse sulla garanzia di un approvvigionamento adeguato di grano per la città, ché infatti l'insufficienza di pane rischiava di trascinarsi dietro ulteriori divisioni politiche e frammentazioni sociali.
Compaiono nel censimento del 1563 due raggruppamenti di poveri. L'uno, quello dei "poveri mendicanti", include 539 individui - uomini, donne e bambini - pari allo 0,3 per cento della popolazione totale; l'altro, quello dei "poveri d'hospitali", comprende 1.479 anime pari allo 0,87 per cento degli abitanti di Venezia. Sono dati la cui esiguità rispetto ai calcoli riportati nella tabella precedente fa comprendere come all'inizio dell'età moderna il concetto di povertà corrente fosse ben diverso da quello odierno. In realtà il nostro desiderio di quantificare l'incidenza della povertà suggerisce molto del nostro inquadramento del problema. La sostanziale indifferenza dei Veneziani di allora rispetto all'ampiezza del fenomeno indica la differenza della loro comprensione della povertà rispetto alla nostra (24). In che modo, dunque, i Veneziani dei secoli XV e XVI intendevano la povertà? Di recente gli storici sono pervenuti a considerare la povertà in termini di "giudizio di valore", vale a dire che in ogni società strutturata la sua definizione suppone la mancanza di alcuni beni percepiti come necessari in quel determinato ambito locale; si badi, non soltanto ciò che occorre alla sopravvivenza dell'individuo "ma anche qualsiasi cosa la cui mancanza, secondo gli usi del paese, venga considerata sconveniente per le persone stimabili, persino dei ceti più umili" (25).
Erano stati i teologi medievali a fornire una definizione fondamentale delle necessità riconosciute essenziali nell'ambito della cristianità, codificata nei "sette atti corporali di misericordia": nutrire gli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ospitare i senzatetto, visitare gli ammalati, riscattare i prigionieri, seppellire i morti, azioni tutte riassunte nella proposizione latina pasco, poto, coligno, tego, visito, librero, condo. Ne viene che la povertà restava individuata in quanto privazione dei beni materiali indispensabili al sostentamento - alimento, vestiario, ricovero - o privazione del contatto con gli altri membri della comunità cristiana a causa della malattia, dell'imprigionamento o della morte. Se proprio a soddisfare queste necessità si indirizzava la parte maggiore della beneficenza a Venezia - soprattutto quella praticata dalle Scuole -, nella visione dei Veneziani la povertà significava inoltre la mancanza di mezzi atti a condurre una vita consona alla propria reputazione e condizione sociale. Si legge nella premessa a una legge emanata nel 1403 per accrescere il numero dei vecchi marinai sovvenzionati grazie a una tassa sul pepe che è "opera pia et humana [...] subvenire in quantum fieri potest pauperibus senibus navigantibus, qui exposuerunt personas suas et totum tempum vite sue ad bonum patrie, et in honorem nostri dominii, tam reverentia dei, quam pro bono exemplo aliorum" (26). Sarebbe stato un disonore, così per quei marinai come per la Repubblica che essi avevano servito, se li si fosse lasciati precipitare nell'indigenza. In un capitolare del 1560, nel quale si stabilivano i criteri di distribuzione dei fondi destinati a costituire la dote delle fanciulle povere, il capitolo e gli altri rappresentanti della parrocchia di San Pantalon affermavano che "fra tutte le opere dela misericordia, el maridar le povere donzelle, se die giudicar esser una de le prime et mazor: per che le altre provedono alla salute del corpo del proximo: et questa del corpo e del anema". Sì, perché dotando le fanciulle povere - "povere" in quanto prive dei mezzi familiari per contrarre matrimonio e mantenere così la propria onorabilità - i benefattori le sottraevano al rischio di cadere in una "mala vita [...] per non haver habudo li sui modo de maritarle" (27).
Per i Veneziani conservare l'onore era una necessità e coincideva con la possibilità di tenere uno stile di vita adatto allo status sociale; nella coscienza dei contemporanei il livello personale e quello pubblico, il privato e il politico si sovrapponevano, in guisa tale che la carità soddisfaceva gli interessi tanto dell'individuo quanto dello Stato.
Se dunque la povertà veniva assimilata alla perdita del rango, i poveri - per così dire - più importanti, i più degni di assistenza erano i "poveri vergognosi", come proclamato dal maggior consiglio nel 1544:
È certo umano, et pietoso officio l'haver a' poveri commiseratione, et massimamente a' coloro, che nati di honesti parenti, e de' beni di fortuna per qualche tempo ben dotati, siano poi per varii, et diversi accidenti di quella, a' povero stato ridotti, delli quali in questa città ne habbiamo gran numero, et sono chiamati li poveri vergognosi (28).
Nel determinare il concetto attuale di povertà, l'élite veneziana aveva identificato e classificato le figure sociali del povero e stabilito specifiche forme di assistenza. Poveri erano gli individui incapaci di provvedere da sé ai più elementari bisogni vitali, e poi coloro che vedevano minacciato il proprio buon nome o quei negletti il cui precipizio minacciava di riverberarsi sulla reputazione stessa della Repubblica. Ma chi non corrispondeva a questi criteri morali veniva escluso dal novero dei poveri, e anzi bollato da etichette che, quando non lo criminalizzavano, lo condannavano per lo meno all'emarginazione: "vagabondi", "ruffiani", "puttane" e altri individui che conducevano un'esistenza disonesta erano considerati indegni di beneficiare dell'aiuto pubblico o privato. L'opera delle grandi istituzioni caritative e gli sforzi dei benefattori privati e dello Stato si rivolgevano ai poveri rispettabili, rispondenti ai criteri fissati dal concetto vigente di povertà. Ed erano, questi ultimi, parte della comunità, non diversamente dagli artigiani, dai cittadini o dai patrizi.
La carità tradizionale
In uno studio recente sulla carità a Venezia nella prima metà del secolo XVI, Giovanni Scarabello ha dimostrato che molte pratiche caritative, persino in quell'età di trasformazioni e di innovazioni, traevano origine da usanze e consuetudini di antica data. Pur adottando forme di assistenza e di filantropia nuove, i Veneziani erano lungi dal trascurare sistemi e istituzioni che per secoli avevano servito bene la città e se cambiamenti vi furono, si produssero pur sempre nel contesto delle locali tradizioni di carità (29).
Rivolta a favore dei poveri rispettabili o riconosciuti, la tradizionale azione di assistenza a Venezia può essere suddivisa in tre ampie sottocategorie. La prima - quella maggiormente studiata dagli storici - contempla le iniziative delle istituzioni (ospedali, Scuole, fraglie) più comunemente associate alle opere di carità: carità istituzionale o corporativa, quindi, perché erogata da organizzazioni stabili a vantaggio dei loro stessi membri o perché i beneficiati erano a loro volta organizzati e raggruppati con regole e procedure definite. La seconda è data dalla carità personale o individuale: letteralmente migliaia di singoli Veneziani, dal doge fino all'umile servitore, fino al barcaiolo, offrivano del proprio per sovvenire i bisognosi. La terza riguarda la carità del governo, destinatario nel corso dei secoli di una massa di suppliche con le quali individui e gruppi speravano di ottenerne speciali provvidenze e benefici: e la risposta dello Stato poteva assumere modi differenti, tra cui sussidi ad hoc e lavori, e persino distribuzioni di pane e di legna da ardere.
Questa tripartizione della pratica caritativa - istituzionale, personale e di governo - dà un'immagine alquanto esaustiva della molteplicità dei canali lungo i quali scorreva il flusso della carità veneziana nel secolo XV. Ma non bisogna dimenticare che ogni classificazione o tipologia è giocoforza alquanto artificiosa e può mascherare similarità e zone di sovrapposizione. Così, ad esempio, molti ospizi furono fondati per iniziativa di singoli benefattori, per poi svilupparsi in enti morali capaci di assicurarsi l'aiuto dello Stato. E i procuratori di San Marco - una delle magistrature più prestigiose della Repubblica - spesso sovrintendevano ai lasciti per beneficenza dei privati e amministravano i fondi delle istituzioni pie. Nondimeno, questa triplice categorizzazione consente di meglio comprendere la straordinaria varietà e mescolanza di motivi sottese alle pratiche caritative tradizionali.
La carità istituzionale
Illustre studioso della carità a Venezia, Alberto Stelio de Kiriaki giudicava gli ospizi una "forma elementare di beneficenza" (30). Si tratta di un giudizio certamente giustificato, basti considerare che in tutti i secoli successivi al XII furono creati degli istituti ciascuno dedicato a gruppi sociali particolari, dai pellegrini alle vedove, ai marinai anziani, agli orfani, alle prostitute e così via. Alcuni di essi erano finanziati da privati, mentre altri da Scuole o corporazioni a beneficio dei propri affiliati; per la maggior parte si trattava di fondazioni private, contornate da altre pubbliche o ecclesiastiche.
Un esempio piuttosto tipico di fondazione privata è l'ospedale voluto da Lorenza de Zenobi, vedova di Tommaso de Matteo, un fiorentino residente nella parrocchia di Sant'Agata (Sant'Ubaldo). Redigendo le sue ultime volontà nell'agosto del 1429, Lorenza lasciò istruzioni affinché, in adempimento a un lascito testamentario del marito, "in domo mea minori ad pedum planum fiant alique mansiones per modum hospitalis, in quibus ponantur pauperes mulieres in necessitate constitute, que habeant domicilium et mansionem absque affictu amore Dei continuo". La testatrice prescriveva che tutti i suoi beni ("totum mobile et stabile meum") fossero devoluti per il mantenimento dell'ospedale, onde "pauperes possint gaudere et bene stare amore Dei et pro anima mea, et dicti ser Thomasii condam viri mei predicti". E ordinava inoltre che, lei trapassata, la sua schiava Ursa venisse affrancata per prestare la propria opera in qualità di "rectorissa" dell'istituto vita natural durante (31).
Altra fondazione privata fu quella creata dal procuratore di San Marco Marco Antonio Morosini. Con testamento datato 1509 lasciò alcune case poste nella sua corte in parrocchia di Santa Trinità ai "poveri marinai", stabilendo inoltre che gli ospiti fossero "persone bisognose et da bene" e chiedendo ai propri esecutori testamentari di conservare le abitazioni in buone condizioni. E volle, ancora, che Antonello Pizolo a Napoli - un giovanotto che il procuratore aveva preso sotto la propria protezione e aveva cresciuto "a honor de Dio" - potesse scegliersi una delle case per suo uso personale (32).
Questi due esempi illustrano il curioso intreccio di interessi e preoccupazioni che sovente stava dietro alla creazione degli ospizi e che, più in generale, era tipico della beneficenza veneziana. Gli stessi testatori erano spinti da forti motivazioni religiose alla fondazione di istituti del genere. Lorenza de Zenobi desiderava acquisire meriti per l'anima sua e per quella del defunto marito, mentre Marco Antonio Morosini agiva "per l'amor de Dio"; ed entrambi si prefiggevano di soccorrere gruppi sociali, come le donne povere e i marinai poveri (e, si presume, anche vecchi), particolarmente vulnerabili e a rischio in una società in cui per le donne la sopravvivenza era determinata dal matrimonio e per gli uomini dalla capacità di svolgere lavori manuali pesanti. Sperava Lorenza che l'ospizio salvasse le povere donne da una vita di vergogna e di disonore, ove per parte sua il procurator Morosini intendeva ricompensare i marinai che avevano speso la vita al servizio della Repubblica, senza trascurare l'una e l'altro di beneficare a mezzo degli istituti di loro fondazione dei dipendenti particolarmente meritevoli: così Lorenza volle che la fedele serva fosse nominata "rettoressa" dello stabilimento da lei creato, mentre il procurator Morosini approfittò della propria istituzione per sorvegliare e insieme garantire un giovane del quale si era preso cura. In una parola, le fondazioni caritative e assistenziali sorte per iniziativa privata davano modo ai membri dell'élite marciana di gratificare le rispettive clientele.
Sebbene molti ospizi fossero di fondazione privata, altri furono istituiti da Scuole o corporazioni di mestiere a beneficio degli affiliati bisognosi. Tre delle Scuole grandi - San Giovanni Evangelista, Santa Maria della Carità e Santa Maria della Misericordia - finanziavano degli ospizi, come pure alcune Scuole nazionali - fra cui quelle degli Schiavoni o Dalmati, dei Greci e dei Lucchesi -, e diverse fraglie, tra le quali, quelle dei tessitori di seta, dei fornai, dei sarti e dei calzolai tedeschi, offrivano sussidi agli ospizi perché accogliessero alcuni loro membri vecchi e infermi.
Gli ospizi rappresentavano uno strumento di carità verso i confratelli. Di recente Franca Semi ha completato un imponente studio sugli ospizi veneziani che comprende una proficua analisi statistica di tutte le fondazioni e i siti degli ospizi conosciuti. Secondo i suoi rilevamenti, furono fondati almeno centoquindici ospizi e ospedali durante il periodo della Repubblica, di cui settantadue per iniziativa privata. Lo studio della Semi conferma l'affermazione di Kiriaki riguardo alla posizione preminente che gli ospizi occupavano nelle pratiche caritative a Venezia (33).
Come mostra la Tab. 2, tratta dallo studio della Semi, la creazione di ospizi fu diffusa in ogni epoca della storia della Repubblica.
Ma anche se il numero delle fondazioni rimase praticamente costante dal secolo XIV al XVI, i beneficiari cambiarono in maniera significativa. Dalla ricostruzione dei mutamenti nella categoria degli assistiti è possibile ricavare un grafico nel quale si evidenzia la natura cangiante dei concetti di assistenza e di beneficenza. In realtà la storia degli ospizi rappresenta come in un microcosmo la storia della beneficenza a Venezia.
Come fa rilevare la Semi, nel lungo periodo precedente la "serrata" del maggior consiglio del 1297, erano stati costituiti sedici ospizi. Di questi almeno dieci (il 62,5 per cento) si assumevano, come parte essenziale dei propri compiti, l'onere di dare alloggio ai pellegrini; sei si dedicavano alla cura dei malati e quattro erano destinati ai poveri. Tre erano specializzati nell'assistenza alle donne, due servivano i fratelli delle Scuole nazionali, uno si occupava delle pinzocchere e uno dei monaci. Quanto alla fondazione, quattro dei sedici ospizi erano sorti per iniziativa ecclesiastica, sei per impulso di privati, due di confraternite laiche, due di Scuole nazionali e uno del doge. Il forte rilievo dato agli ospizi per i pellegrini rifletteva lo spirito dell'età delle crociate: più che naturale che a Venezia, uno dei principali porti d'imbarco per la Terrasanta, proliferassero gli istituti specialmente intesi all'assistenza di quei viaggiatori devoti (34).
Il maggior cambiamento nell'attività caritativa si produsse a Venezia nel corso del secolo XIV, innescando un filone che durò per gran parte del secolo XV. Poco a poco i testatori e gli altri donatori trasferirono le proprie attenzioni dalla Chiesa e da altre istituzioni controllate da ecclesiastici - e dunque inclinate al distacco dal mondo - a stabilimenti e forme di carità volte a risolvere o quanto meno ad alleviare i problemi sociali in questo mondo. Ciò che più importa è che testatori e donatori scelsero di affidare i propri beni terreni a istituzioni di matrice laica piuttosto che ecclesiastica: insomma, una "laicizzazione" dell'assistenza (35).
Emblematica di questa crescente diffidenza verso il clero (o, al contrario, della fiducia riposta nella sfera della laicità), fu la scelta di un numero sempre maggiore di testatori di nominare esecutori testamentari i procuratori di San Marco (36). I motivi di questo cambio di indirizzo e di modalità - per così dire - amministrative non sono del tutto chiari. Sicuramente il calo demografico unito alle devastazioni della peste del 1348 accrebbe la consapevolezza generale del problema della povertà e della malattia. Di più, per tutto il secolo XV e XVI si ebbero periodici ritorni del contagio, ciò che mantenne ben presente nella coscienza individuale la questione delle avverse condizioni sociali.
Povertà e malattia erano dappertutto, e gli storici hanno trovato argomenti anche per lo specifico carattere urbano della nuova beneficenza: l'ondata di contadini impoveriti che investì la città, combinandosi con la diffusa presenza di poveri e di malati, innalzò il livello generale di coscienza della malattia sociale. Questa consapevolezza si tradusse in un nuovo tipo di elemosina, la carità come antidoto ai malanni della società (37). Sicuramente l'esperienza veneziana, come si comprende dalle nuove modalità di fondazione e di finanziamento di ospizi, procedette in parallelo a quella più generale dell'Europa. Dei cinquantadue ospizi creati nei secoli XIV e XV, solo uno era specializzato nell'accoglienza ai pellegrini, quello denominato Celsi dal nome della fondatrice, Elena Celsi, che lo istituì nel 1409 per ospitarvi le donne povere in viaggio verso la Terrasanta per visitare il Santo Sepolcro (38). Al contrario, almeno otto ospizi assistevano i poveri, quattro i malati, quattordici le donne e quattro i marinai. Gli altri erano votati all'assistenza e al mantenimento di specifici gruppi sociali quali gentildonne, vedove patrizie, prostitute. Santa Maria della Pietà - uno dei due ospedali sorti nei secoli XIV e XV per iniziativa ecclesiastica e sviluppatosi nel secolo XVI in uno dei cosiddetti "ospedali grandi" - fu fondata nel 1346 per occuparsi degli orfani. Per lo più i nuovi istituti venivano creati da privati, in ciò incoraggiati (e si tratta di un fattore di grande importanza) dalla popolazione cittadina che vedeva di buon occhio stabilimenti soprattutto volti a sollevare i bisognosi vittime della precarietà sociale. Sulla scia della peste, i parrocchiani di San Giacomo dall'Orio intensificarono il sostegno a San Lazzaro, un'antica fondazione dedita in origine alla cura della lebbra, ma che divenne un ricovero per gli appestati (39).
Certamente i secoli XIV e XV videro una grande fioritura di ospizi organizzati privatamente, spia di una politica dell'assistenza e della beneficenza basata sul vantaggio accordato a particolari categorie di persone giudicate degne, quelle considerate più esposte ai capricci della vita urbana.
La disposizione fisica e l'organizzazione degli ospizi differiva ampiamente. Ciò dipendeva, almeno in parte, dalle risorse finanziarie, dai desideri del fondatore, dai bisogni e dalle capacità degli assistiti. Ad esempio, un ospizio per i malati cronici aveva esigenze strutturali diverse dall'ospizio i cui ospiti fossero autosufficienti. Di conseguenza alcuni di tali istituti procuravano letti e prestavano servizi infermieristici ai malati, mentre altri erano sostanzialmente un agglomerato di piccoli appartamenti o stanze dotate di focolari propri per cucinare e scaldarsi. Alcuni possedevano anche un oratorio. La sopravvivenza fortuita di un prezioso documento del 1446, che registra la notizia dell'elezione di Armelina de Aragonibus all'incarico di priora dell'ospedale dei Crociferi, con il capitolare allegato che sottolinea le responsabilità del ruolo, fornisce un vaga idea sull'attività di un piccolo ospizio (40). Quello dei Crociferi era uno dei più antichi ospedali in città; fondato nel 1150 appunto dai monaci crociferi nei pressi del loro monastero, in origine ospitava pellegrini e poveri. L'ospedale crebbe in prestigio e ricchezza grazie a un cospicuo lascito di terre, case e capitali da parte del doge Renier Zeno, con testamento datato 1268, e divenne quindi noto come ospizio Zen. Poiché il doge aveva stabilito che fossero i procuratori di San Marco ad assumere l'amministrazione del suo patrimonio dopo la morte degli esecutori testamentari da lui designati, lo Stato, per azione dei procuratori, si ingerì nell'amministrazione dell'ospedale. Sorto dunque come istituto di pertinenza ecclesiastica, l'ospizio dei Crociferi si sviluppò notevolmente grazie all'eredità ricevuta da un privato, rientrando infine nell'ambito delle competenze statali per il tramite dei procuratori di San Marco. Di nuovo riscontriamo la curiosa mescolanza di interessi, tipica delle istituzioni caritative di Venezia (41). Nel secolo XIV, l'istituto dei Crociferi poteva ricevere fino a quaranta o cinquanta ospiti alla volta, uomini e donne ai quali forniva una dieta variata, letti, lenzuola, vestiti e scarpe in adempimento ai desideri del benefattore dogale. Poi, tra la fine del secolo XIV e l'inizio del XV, l'istituzione subì una profonda trasformazione "da ospedale ad ospizio", come l'ha molto acutamente definita Silvia Lunardon (42): da stabilimento che si prendeva cura di un numero abbastanza rilevante di infermi, a casa di accoglienza riservata a dodici donne povere. Il cambiamento si accompagnò a un programma edilizio che contemplava la ristrutturazione dell'ospedale in forma di ricovero suddiviso in piccoli appartamenti allo scopo di accogliere separatamente ciascuno degli ospiti. La nuova costruzione comprendeva sei stanze su ciascuno dei due piani, allineate lungo una sala centrale che finiva in un piccolo oratorio. Secondo la Semi, la casa dei Crociferi mostra "l'impianto distributivo classico degli ospizi veneziani" (43). Quanto all'oratorio, nel secolo XVI fu sottoposto a un importante intervento di ridecorazione in cui Palma il Giovane rendeva onore al nuovo mecenate dell'istituto, il doge Pasquale Cicogna.
Oltre alle informazioni sulla struttura della fabbrica, il capitolare che espone le responsabilità della priora permette di ricostruire la vita che vi si conduceva. Ciascuna delle dodici donne ospitate nel ricovero aveva una stanza propria e riceveva uno stipendio che veniva versato - secondo il ritmo del calendario della carità - a Natale, a Pasqua e per la festa dell'Assunzione della Vergine. Le povere donne dovevano vivere da sole, a meno che non fossero ammalate e dunque necessitassero di un'infermiera, che, comunque, doveva avere più di quarant'anni. Ogni settimana o ogni mese (lo decideva la priora) due ospiti a turno erano incaricate di scopare nonché riordinare "tuto l'andedo de ditto hospitale, tra luna e laltra porta". Vietato tenere animali "de algun sorte nelle sue celle excepto qualche gatto". Di notte le porte venivano chiuse a chiave e la chiave custodita dalla priora o da una sua assistente. Alle donne era proibito di entrare in altre parti della chiesa adiacente o del monastero dei Crociferi, salvo "nel casso della chiesia et primo inclaustro", e ciò per garantire una "honesta et bona exemplarità de altri". Allo stesso modo, nessuno dei fratelli dell'ordine o di altri ordini poteva entrare nell'ospizio, ad eccezione del priore o altro religioso dallo stesso priore delegato a raccogliervi le confessioni delle malate. Oltre che tenere le stanze pulite e in ordine, le ospiti erano tenute a riunirsi ogni domenica per ascoltare la messa e pregare; e ogni mattina dovevano inchinarsi dinanzi all'altare della Madonna, nell'oratorio, per "rendere gratie a quella [la Madonna]; et pregare Dio per el stato della nostra Illustrissima Signoria, libertà et conservation del Monastier, e per le anime de chi gli ha statuito tanto bene". Così pure alla priora era vietato di tenere con sé chicchessia, eccetto "una fantesca, over massara, over compagna", ma che avesse quarant'anni o più; e doveva inoltre badare a che nessuna donna incinta o bambini da allattare venissero alloggiati nell'ospedale. Ancora, le era richiesto di consentire a che i beni mobili presenti nella sua stanza al momento della morte passassero al monastero, "per l'anima vostra". Come dimostra il capitolare, l'ospizio dei Crociferi era organizzato sulla falsariga di una comunità religiosa, come attesta la terminologia in uso ai Crociferi, dove la donna designata agli incarichi di sorveglianza era chiamata "priora" e le stanze assegnate alle residenti "celle"; inoltre le ospiti si riunivano regolarmente per la preghiera comune. D'altronde, quattro degli ospedali fondati durante il secolo XV furono delegati al sostentamento delle pinzocchere, donne appartenenti al terzo ordine che compivano azioni diverse di carità. L'obbligo giornaliero fatto alle donne dei Crociferi di recitare le preghiere richiama, ancora un volta, la relazione reciproca o simbiotica che i contemporanei erano persuasi esistesse fra chi riceveva la carità e i benefattori. Né il capitolare della priora Armelina manca di raccomandare alle povere donne di ricordare nelle loro preghiere tutti i mecenati dell'ospizio, accuratamente elencati, dal monastero ai donatori privati, compreso il doge Zen, fino allo Stato. Poiché il benessere delle anime individuali così come dell'"Illustrissima Signoria" dipendeva dalle preghiere dei poveri degni che fungevano da intermediari tra i benefattori e le istanze celesti, la funzione degli ospizi era a un tempo quella di sopperire ai bisogni fisici degli ospiti e quella di soddisfare i bisogni spirituali dei benefattori.
Anche le Scuole, un'altra istituzione caratteristica della beneficenza veneziana, ponevano la preghiera al centro delle proprie attività. Le Scuole dei Battuti traevano origine da un movimento di rinascita spirituale della metà del secolo XIII. Alcuni laici si riunivano in società di mutuo soccorso dedite a pratiche ascetiche (ad esempio l'autoflagellazione) e alla preghiera. I confratelli ricercavano l'armonia sociale attraverso l'incoraggiamento reciproco e la mortificazione, tentando con questi mezzi di scansare il conflitto e il peccato. I membri di queste associazioni erano tenuti a sentir messa in modo comunitario a intervalli regolari, a presenziare alle esequie dei confratelli morti, a partecipare alle cerimonie religiose che costituivano il clou del calendario ecclesiastico. La Processione in piazza San Marco di Gentile Bellini descrive uno di questi momenti solenni. In un raffinato studio sulle confraternite nella Firenze del Tre e Quattrocento, Ronald Weissman ne ha posto in particolare rilievo la capacità di stemperare le tensioni sociali che insorgevano nel competitivo ambiente urbano del commercio e del credito, fertile terreno di coltura della diffidenza verso gli altri e del sospetto: come dimostrano i testi detti "ricordanze", molto spesso i padri esortavano i figli a non fidarsi di alcuno. Secondo Weissman, attraverso gesti rituali quali il bacio della pace e il lavaggio dei piedi, le confraternite alleggerivano le tensioni e livellavano le differenze sociali così che la sfiducia si mutasse in confidenza e i rivali in confratelli (44).
Molto probabilmente, nei primi tempi, le Scuole veneziane assolvevano a una funzione analoga a quella delle corrispondenti istituzioni fiorentine nel mantenimento dell'ordine pubblico, come si evince dai preamboli alle mariegole o agli statuti delle Scuole grandi del secolo XIII, là dove si pone in evidenza la potenza salvifica della carità. Così i confratelli di Santa Maria della Carità, per i quali "la caritade coure la moltetudene deli peccadi" (45). Ma nel corso del secolo XIV e ancor più rapidamente nel XV, le intenzioni originali delle Scuole grandi cambiarono, trasformandosi tali organizzazioni - lo rileva Brian Pullan - da "confraternite di devozione" anche in "istituzioni filantropiche" (46): da società di eguali vennero tramutandosi man mano in congregazioni di ricchi e di poveri nelle quali i confratelli più agiati, che dirigevano le Scuole, distribuivano l'elemosina ai poveri i quali, per parte loro, prendevano su di sé il fardello dei lavori spirituali - seppellire i morti, recitare le preghiere e perfino praticare la disciplina. Il ceto cittadinesco monopolizzava l'amministrazione delle Scuole grandi. Da Gasparo Contarini in poi, i cronisti hanno osservato che tali consorterie rappresentavano uno sbocco per le ambizioni personali e il talento gestionale di quegli uomini (47). Poiché le Scuole grandi crescevano in prestigio e in dimensioni, un numero sempre maggiore di affiliati le eleggevano fiduciarie dei patrimoni individuali, sì che esse si trovarono a gestire, oltre al capitale costituito dai normali contributi annuali dei confratelli, anche cospicui fondi fiduciari che destinavano a una vasta gamma di opere caritati ve nonché -soprattutto nel secolo XVI - a programmi di edificazione e di decorazione. Non solo le Scuole grandi si preoccupavano del sostentamento dei confratelli poveri per mezzo delle elemosine, ma pure della costituzione delle doti per le figlie dei membri bisognosi: calcola William Wurthmann che nel secolo XV tutte insieme le quattro Scuole grandi (giacché quella di San Rocco fu istituita nel 1489 e San Teodoro fu elevata al rango di Scuola grande solo nel 1554) provvidero a dotare circa cinquanta ragazze all'anno (48). Come già osservato, tre di queste Scuole sussidiavano gli ospizi per i membri ammalati o infermi, impiegando altri fondi per acquistare o costruire case di carità da assegnare a soggetti degni. L'insegna di ciascuna Scuola veniva esposta in modo evidente sulle facciate di queste abitazioni, ulteriore esempio di come la carità fosse considerata un'attività pubblica, che non andava nascosta agli occhi degli altri. Verso la fine del secolo XV, le Scuole grandi limitarono le proprie opere caritative quasi esclusivamente a favore degli affiliati bisognosi: le sostanze di cui potevano disporre non erano tali da consentire interventi di portata cittadina.
Mentre le Scuole grandi si evolvevano sempre più in istituti filantropici, nei quali i membri ricchi provvedevano con elemosine ai membri poveri in cambio di benefici spirituali, una gran quantità di confraternite più piccole, molte delle quali erette presso chiese parrocchiali e monasteri, continuarono ad operare come associazioni devote, la cui missione contemplava fra l'altro l'assistenza nei confronti dei rispettivi iscritti. Non si sa con precisione quante fossero le "Scuole piccole" attive all'epoca. Marin Sanudo riferisce che ben centodiciannove di esse sfilarono in processione in occasione del corteo funebre del doge Leonardo Loredan nel 1521 e Jacopo d'Albizzotto Guidi parla di circa duecento Scuole piccole per il secolo XV (49).
Il compito principale di queste confraternite era quello di provvedere al benessere spirituale degli affiliati per mezzo della preghiera, assicurando loro inoltre una sepoltura onorevole. Qualche sentore della missione svolta dalle Scuole piccole ci perviene dal testo dell'accordo stipulato nel 1451 tra la Scuola dei Santi Giorgio e Trifon degli Schiavoni e Lorenzo Marcello, priore del convento dei Gerosolimitani (50). I confratelli ottennero dal monastero il diritto di "fundar, drizzar, et fabricar uno altare ad Nome di Santissimi martiri Zorzo, et Triffon e fare una capella, et adornar quella a' spese de ditta scuola e fraternità, e scuola nostra"; ed ebbero anche il permesso di costruire una "casa" nella quale incontrarsi per celebrare "le loro cerimonie, e solennità, et allogare le cosse di ditta scuola". Quanto ai gerosolimitani, acconsentivano a officiare le messe commemorative della Scuola, come pure ad andare "con i doplieri della ditta scuola accesi, sopra l'archa e sepolture della ditta scuola, cantando, psalmizando, aspargendo l'acqua santta, incensando, et orando, si per l'anime di nostri fradelli: che saranno sta sepulti li come altrove per lo mondo". La Scuola avrebbe tenuto sempre una lampada accesa sull'altare costruito a tenore dell'accordo.
Oltre che favorire il sentimento della fratellanza fra i membri e provvedere al loro benessere spirituale, le Scuole piccole si preoccupavano di sovvenire ai bisogni materiali degli iscritti indigenti. Come si è detto più sopra, molte di esse, compresa San Giorgio degli Schiavoni, mantenevano degli ospizi a questo scopo; e, ancora, aiutavano le figlie dei soci attraverso assegnazioni dotali e facevano piccole distribuzioni di elemosina ai poveri. Accanto alle Scuole piccole, parecchie tra le corporazioni cittadine del commercio, se non tutte, crearono delle Scuole proprie meglio note come "Scuole delle Arti", che, al pari delle Scuole piccole, possedevano altari presso chiese e monasteri, si occupavano dei funerali dei membri poveri, mantenevano - quando possibile - degli ospizi e compivano altre opere di carità. Per fare un esempio, agli inizi del secolo XVI i merciai di stoffe raccoglievano 31 soldi al mese per l'elemosina a sei soci indigenti (51). Tuttavia molta della beneficenza a cura delle Scuole piccole e delle Scuole delle Arti era sporadica.
Gli studiosi che si sono occupati degli ospizi e delle Scuole hanno dovuto compiere qualche sforzo per valutare il successo di questi istituti nell'azione di assistenza verso i poveri della città. Sfortunatamente - data la scarsa conoscenza delle cifre, incluso il numero degli aderenti a tali associazioni - è impossibile essere precisi. Pullan calcola che nel 1563, quando la città contava una popolazione di oltre centosessantamila anime, le sei Scuole grandi raccoglievano cinquemilacinquecento membri, pari a circa il 3,5 per cento della popolazione cittadina totale. Rammentando che la maggior parte degli iscritti adulti erano capifamiglia, è probabile che le risorse caritative delle Scuole grandi potessero raggiungere all'incirca il 10 per cento degli abitanti di Venezia (52). Le indagini di Pullan dimostrano che, per quanto durante il secolo XVI le Scuole grandi attingessero i propri membri da "un'ampia fascia sociale e da vari mestieri e professioni", non attiravano che in misura limitata i ranghi più bassi della società, come stivatori o domestici; quanto poi alle donne, ne erano formalmente escluse. Le Scuole grandi, insomma, tendevano a essere un territorio riservato al ceto cittadinesco, agli artigiani affermati e ai piccoli negozianti (53).
Richard Mackenney ha esaminato l'elenco degli iscritti a quattro Scuole piccole dal secolo XIV al 1520, constatando che anch'esse facevano proseliti in un vasto bacino sociale, ma posto più in basso nella scala gerarchica della società veneziana rispetto a quello da cui provenivano i membri delle Scuole grandi. Ad esempio, molti testamenti di servi contemplano legati a favore delle Scuole piccole: così Maria, prima serva di Francesco Arbusini, lasciò 2 ducati alla Scuola dei Diecimila Martiri "in qua ego sum" (54); e con testamento datato 1537, Zuane Albanese, un barcaiolo del traghetto della Beccaria di Rialto, destinava un ducato perché si celebrassero messe "alla mia schola di San Bartolomeo" (55). Quel che più conta è che le Scuole piccole, a differenza delle grandi, erano aperte alle donne e offrivano loro perfino l'opportunità di occupare posizioni di prestigio come gastalda o diaconessa.
Con cinque Scuole grandi, centoventi o più Scuole piccole, oltre sessantacinque fra corporazioni e traghetti, e oltre sessanta ospizi, intorno al 1500 Venezia aveva la possibilità istituzionale di soddisfare in circostanze ordinarie i bisogni dei poveri strutturali e di alcuni di coloro che campavano in situazione molto prossima alla soglia minima di sussistenza. Finché la città non veniva investita dalle grandi epidemie, dalla fame o da altri fatti sociali traumatici, sembrava che le istituzioni caritative fossero in grado di sovvenire alle esigenze primarie dei poveri rispettabili, che erano considerati parte della comunità. Aspetto, quest'ultimo, che viene in chiaro nel citato accordo tra la Scuola dei Santi Giorgio e Trifon e i Gerosolimitani, nel quale infatti si prevedeva che i corpi dei defunti appartenenti alla Scuola medesima venissero sepolti in una delle quattro tombe normalmente messe a disposizione dei membri, ma se "per caso de peste l'arche avesse corpi freschi; o, le fusse tropo piene, che tune i corpi da sepelire se debbi sepelir nel campo santto con quelli modi e condition, che son sopraditto di corpi di Morti da sepelire in le arche" (56). In presenza di condizioni normali, si può dire che ospizi e Scuole erano in grado di provvedere a se stessi.
La carità individuale
Le migliaia di testamenti custoditi presso l'Archivio di Stato di Venezia, così come in altri archivi e biblioteche sparsi per la città, costituiscono la fonte principale per lo studio della carità individuale. E tuttavia fonte di difficile decifrazione, stante la quantità dei documenti pervenutici e i problemi inerenti al loro utilizzo, come ad esempio esperire le reali intenzioni del testatore o accertare se le sue disposizioni furono eseguite o meno secondo la volontà espressa nell'atto testamentario, senza dimenticare poi l'esposizione per formule dei contenuti dell'atto stesso. Sino ad ora, l'impossibilità di valutare l'effetto cumulativo di - letteralmente - migliaia di legati, ha reso gli storici prudenti nel maneggiare le carte testamentarie per lo studio dell'assistenza privata ai poveri. Resta nondimeno che i testamenti erano (e sono) documenti squisitamente personali, e in molti casi gli unici documenti a dare espressione alla volontà e alla personalità dei singoli. A un esame attento, essi svelano aspetti importanti delle pratiche veneziane di assistenza e di beneficenza, facendo luce sul rapporto simbiotico tra ricchi e poveri come pure sulle motivazioni individuali che stavano dietro all'opera caritativa.
Mette conto, allora, di dare uno sguardo a un testamento scelto tra i tanti conservati, quello del doge Agostino Barbarigo che, salito al trono ducale il 30 agosto del 1486, in seguito alla morte del fratello Marco, fu alla guida della Repubblica nel periodo della prima discesa francese in Italia e durante i continui conflitti con i Turchi al volgere del secolo XV. Il 20 settembre del 1501 il Barbarigo muore: lascia quattro figlie, due delle quali monache e due maritate rispettivamente con un Nani e con un Pisani, essendogli premorto l'unico figlio maschio, Francesco. La moderna edizione a stampa dell'atto testamentario, pubblicato insieme a due codicilli, occupa quasi venti pagine in corpo minore, in larga misura consacrate ai lasciti per le figlie e altri congiunti (57).
Sono tuttavia i legati caritativi a interessarci maggiormente in questa sede. Datato al 10 febbraio 1501, l'atto si apre con la tradizionale invocazione, nella quale il testatore raccomanda
[...] lanima nostra al nostro sumo chreator Idio intravegnendo la sua santissima madre nostra sancta maria verzene con tutti santi et sante et beati che sono nel paradixo che se degnano de pregar esso Signor Idio per l'anima nostra et che se degni per sua chlementia haver mixerichordia di quella.
Segue la richiesta di venir sepolto nella tomba fatta costruire nella chiesa di Santa Maria della Carità "in habitto de la nostra schuolla" e l'istituzione di un legato pio destinato alle preghiere da recitarsi dai "fratti observanti chome conventualli" e nelle parrocchie. Dei 150 ducati lasciati a titolo di decime della chiesa, la parte riservata ai poveri - prescrive il Barbarigo - dovrà essere distribuita "a queli che ne hano pluj de bexogno", mentre alla parrocchia di appartenenza il doge assegna 32 ducati così ripartiti: 12 per il clero, io per l'"hornamentto" dell'altare della Madonna, 10 da spendersi a cura del clero medesimo per quanto riterrà più necessario. Ai poveri della parrocchia, inoltre, verranno distribuiti 50 ducati per mano del parroco e di uno degli esecutori testamentari. Legati ulteriori, poi, vanno in preghiere e atti di devozione, inclusi i 12 ducati appannaggio del cappellano ducale per la celebrazione di messe di suffragio e la recita di preghiere a pro delle anime di Agostino, della moglie Isabella, del figlio Francesco "et per altri nostri che sono pasatti de questa vita". All'ospedale di Sant'Antonio il doge lascia 1 o ducati e 10o all'ospedale della Pietà, questi ultimi da corrispondersi in rate annuali di 1 o ducati ciascuna durante la Settimana santa. Nel secondo codicillo del 5 agosto 1501, il Barbarigo dichiara di voler spendere 300 ducati per la "repparatione sive fabrica" dell'ospedale di San Marco, "ad laudem et honorem omnipotentis dei, et pro remedio salutis anime nostre", deliberando altresì un lascito in natura per 10 staia di granaglie e 20 cataste di legna all'anno in favore delle povere donne di quell'ospedale.
Dopo i legati stabiliti per gli istituti di Sant'Antonio e della Pietà, il testamento seguita con ventinove legati a vantaggio di altrettanti monasteri - esplicitamente designati - della città e della laguna, nonché con il conferimento di 50 ducati "ad altri monasteri de monache observante si in Venexia chome a Muran", il tutto qual contropartita di preghiere. Né il doge trascura la Scuola della Carità, beneficata con 500 ducati in titoli di Stato e 25 in contanti da distribuire ai poveri. Legati di entità ancora maggiore dispone per il monastero di Sant'Andrea al Lido, per i frati di Santa Maria della Carità e per il convento di Santa Maria degli Angeli. Resta anche assegnato un dipinto votivo che lo ritrae dinanzi alla Vergine, da collocarsi nella loro chiesa sull'altare maggiore.
Esauriti i singoli lasciti a favore dei familiari, comprese le figlie e i generi, il Barbarigo non manca di ricordare i domestici. Andrà emancipata la schiava Caterina, e padrona dei propri effetti personali nonché di un letto completo di lenzuola e coperte, ricevendo inoltre dal padrone 15 ducati "per el suo maridar" e altri 5 "per sue altre spexe"; Ruoxa Schiavona avrà il possesso degli effetti personali, un letto e 20 ducati, oltre all'assicurazione scritta di aver riservato un posto per sé alla Ca' di Dio, così come un'altra serva, Jacoma da Vicenza - peraltro raccomandata ai familiari e beneficata con l'equivalente del salario più 5 ducati "per amor de Dio" -, potrà contare su una sistemazione presso l'ospedale di San Marco, chiedendo in cambio il testatore ch'ella si rechi "a pregare el nostro signor et la sua santissima madre per lanima nostra" nelle chiese di Santa Maria dei Miracoli e di San Fantin; a Maddalena, serva anch'essa, vanno 10 ducati e 10 ancora e un letto in caso di matrimonio, mentre ad Anna, moglie di Zorzi Gussoni, cui al tempo del collocamento era stata conferita "una buona dote", sono attribuiti 15 ducati e oggetti di famiglia per un controvalore di 10 ducati. Il Barbarigo riserva dei lasciti personali ad altri tre precedenti e attuali famigli, Matio Bergamascho, Batista de Santa Sofia e Margarita Albanese. Il testamento prosegue quindi con la divisione dell'asse ereditario, costituito da liquidi e proprietà, tra le figlie maritate e i nipoti e con lasciti minori che contemplano, tra le altre, delle assegnazioni in favore di alcuni servi (di sesso maschile). Il 17 luglio 1501 il doge procede alla compilazione del primo codicillo, espressamente rivolto ai "nostri nevodi da cha Barbarigo in morte chome in vita in ogni tempo". Quanto al secondo codicillo - già richiamato più sopra e datato 5 agosto 1501 -, vi si nomina un secondo esecutore testamentario, si aumenta di 25 ducati il legato istituito nella carta originaria per il convento di San Domenico e vi si ribadiscono i lasciti all'ospedale di San Marco.
Del tutto evidente, nel testamento di Agostino Barbarigo, la motivazione religiosa che ne ispirò la maggior parte degli atti di carità (58). La volontà di alleviare le sofferenze dei poveri stava indubbiamente alla base di taluni dei legati prescritti dal testatore, ma la finalità prima e dichiarata dei suoi lasciti era la salvezza dell'anima sua e dei parenti defunti per mezzo delle messe e delle preghiere di intercessione. Alla maniera dei testatori del tardo medioevo e dell'inizio dell'età moderna nell'Europa cattolica, il doge dispose legati a vantaggio di un gran numero di fondazioni ecclesiastiche, addirittura ricoprendo la città e la laguna con le proprie largizioni al fine di garantirsi un patrimonio di devozione indispensabile alla salute dell'anima. E tutti i beneficiati venivano reclutati a recitar preghiere per il testatore, dai confratelli della Scuola della Carità alle monache di Santa Maria degli Angeli, dal clero della parrocchia fino ai fedeli servitori.
Nel testamento del doge compaiono in qualità di legatarie molte delle principali istituzioni caritative veneziane; oltre ai fondi stanziati per il mantenimento dei poveri della Scuola e della parrocchia di appartenenza, oltre alla parte di decima del clero espressamente riservata ai più bisognosi, compaiono nell'atto - e per quote anche cospicue - quegli ospizi che si occupavano in particolare dei poveri strutturali. A Santa Maria della Pietà - istituto ubicato in riva degli Schiavoni - andavano 100 ducati e 10 all'ospedale di Sant'Antonio, fondato nel 1476 e noto anche come ospitale di Messier Gesù Cristo. In quanto doge, il Barbarigo deteneva lo iuspatronato sia sull'ospizio di San Marco che sulla cosiddetta Ca' de Dio, entrambe istituzioni votate alla protezione delle povere donne (59). Come appare chiaro dal suo testamento, il doge prendeva molto seriamente quel patrocinio: abbondanti largizioni vi figurano infatti a favore dell'ospizio marciano, e così pure la disposizione che due delle sue serve fossero accolte come ospiti rispettivamente nell'uno e nell'altro istituto.
I lasciti del Barbarigo ai servi appartengono a un settore dell'assistenza e della beneficenza che non è stato ancora sistematicamente indagato dagli storici. Il doge si preoccupò di provvedere al benessere futuro di coloro che avevano fedelmente servito lui e la sua famiglia; quanto alle serve, due furono i modi del suo intervento: le più giovani ricevettero somme di denaro contante e beni d'uso da impiegarsi per la costituzione della dote, mentre le più anziane ebbero garantita una certa tranquillità per la vecchiaia grazie all'assicurazione di un posto negli ospizi.
Agostino Barbarigo non fu l'unico dei testatori del tempo a elargire, per mezzo di legati, assistenza individuale a quanti godessero di un qualche legame personale con loro. Così Paolo Giovanni Morosini, il quale nel testamento datato al 1465 lasciò diversi oggetti di famiglia, tra cui un letto, alla fantesca Stana "azo le se posi maridar, e atender a far ben" (60); nel 1540 Laura Sanudo, moglie di Antonio Bolani, trasmise a Caterina Schiavona, "garzona de casa", una dote di 50 ducati in contanti e in natura (61); e Aldo Manuzio dispose un legato a vantaggio di due delle figlie del servo Hilario Botiro da Parma, affinché potessero prendere marito (62). Non solamente le giovani serve e le figlie dei servi di famiglia ricevevano liberalità dotali ché, anzi, venivano parimenti beneficate di un contributo per la dote le figlie di affittuari che vivevano nella corte dei palazzi patrizi, di artigiani dei dintorni, di coparrocchiani.
Sono i testamenti delle donne a mostrare la maggiore sensibilità ai bisogni delle giovani di loro conoscenza, mentre quelli degli uomini esprimono una propensione verso i legati indistinti, lasciando ad altri il compito di scegliere le beneficiarie individuali. Il doge Michele Steno lasciò una somma di danaro perché si dotassero alcune fanciulle ben individuate - fra le quali una Caterina, figlia del barbiere Silvestro della parrocchia di Santa Fosca, che ebbe 10 ducati -, ma dispose altresì affinché il residuo di bilancio del suo patrimonio fosse impiegato per maritare "filiarum bonorum hominum marinaiorum habitancium Veneciis" (63).
Né il doge Barbarigo fu l'unico patrizio ad esercitare i propri diritti di iuspatronato e a far leva sulle proprie relazioni per sovvenire dei protetti anziani. Alla fine del secolo XVI, il futuro doge Leonardo Donà - per l'intanto procuratore di San Marco - concedette un posto in un ospizio di carità, sottomesso alla giurisdizione dei procuratori, alla serva Pascha Rossi "povera et vecchia de anni 70 in circa che ha servito fidel et honestamente in casa venti e più anni per riparo della sua vecchiezza" (64). Anche coloro che non avevano accesso ai posti negli ospizi o nelle case di carità non rinunciavano a garantire ai servitori anziani dei vitalizi o il mantenimento nelle proprie residenze. Giorgio Corner prometteva per via testamentaria alla vecchia serva Magdalena cibo, vestiario e una stanza in casa propria, mentre un notaio assicurava il mantenimento a dona Anzola, la domestica a cui dava da vivere già da lungo tempo, nonostante fosse diventata cieca e non si potesse "haver da lei alcun servitio" (65).
Come da molti atti testamentari emerge la convinzione dei testatori che il collocamento in monastero o il matrimonio fossero i modi più adatti di aiutare una giovane donna, così emerge la certezza che la maniera migliore di provvedere a un giovanotto fosse quella di fornirgli le capacità e i mezzi necessari a intraprendere un mestiere e guadagnarsi la vita. Marino da Lezze lasciò in legato al servo Antonio la sua gondola, "azo ce labi cauxa de far ben" (66). E il pittore Palma il Giovane registrò nel proprio testamento di aver mantenuto in casa il figlio della serva Maria Miona e di avergli insegnato "la professione della pitura" (67). Persino, certi patrizi autorevoli, dall'ampia rosa di relazioni pubbliche, erano capaci di procurare ai dipendenti fedeli impieghi di governo minori. Insomma, questo genere di assistenza consentiva ai giovani di essere indipendenti - dunque non costituendo un fardello per lo Stato o per le istituzioni caritative - e di condurre un'esistenza dignitosa.
Sebbene gli esempi fin qui citati riguardino membri di una élite abbiente - patrizi e ricchi popolani -, anche i Veneziani di modeste condizioni impiegavano la carta testamentaria come un mezzo per praticare forme personali di carità. Di nuovo un esempio che vale per molti. Margarita, una vedova povera immigrata dal Friuli, fa stendere il proprio testamento nell'ottobre del 1541 (68), nominando esecutori testamentari Nicolò Botenigo, prete in San Tomà, e un tal Pasquale Bochaler. A fronte di un'eredità invero assai modesta, la testatrice chiede di essere sepolta nel camposanto dei Frari, lasciando agli esecutori di stabilire il costo della sepoltura. Due paia di lenzuola vanno poi alla nipote Caterina, un paio al nipote Giacomo e un altro paio al commissario testamentario e confessore, il prete Botenigo, nonché un ducato al notaio estensore del documento; ancora un paio di lenzuola e un cofanetto dipinto "a Francesco orfano sta in casa de Cecilia appresso di me". Gli altri beni residui saranno distribuiti ai "poveri bisognosi", "per l'amor di Dio". Qui è tutto il testamento di Margarita, ove si dimostra che anche i più poveri Veneziani usavano le loro limitate risorse per soccorrere gli altri. Dei lasciti prescritti da Margarita, il più interessante è certamente quello a favore dell'orfano Francesco, null'altro che un vicino. Allo stesso modo dei concittadini più ricchi, anch'essa pensò di destinare parte della propria modesta sostanza a un povero da lei ben conosciuto. Lasciò il resto ai "poveri bisognosi", e non ci è dato di sapere che cosa la testatrice intendesse con questa locuzione.
Perché i testatori disponevano dei legati a vantaggio di soggetti specifici? Certo, avevano tutta una serie di motivi validi per farlo, dalla stima all'affetto sincero per persone verso le quali provavano compassione o, nel caso dei domestici, al fatto che questi ultimi li avessero serviti fedelmente. Presso i testatori poveri un fattore determinante poteva essere il desiderio di aiutare coloro la cui condizione conoscevano molto bene e, anzi, essi stessi condividevano. Quanto all'élite abbiente, l'assistenza e la beneficenza si mescolavano impercettibilmente nel contesto del sistema della clientela e del patronaggio, assumendo un'importanza sociale e politica. Sistemare i poveri negli ospizi o procurar loro un impiego nell'amministrazione dello Stato significava per i patrizi dimostrare (e mettere alla prova) il proprio potere politico e la propria influenza. Di più, la fedeltà e la gratitudine di chi veniva così beneficiato aumentavano l'onore e il prestigio dei benefattori. Insomma, con le dimostrazioni di carità i membri dell'élite affermavano il proprio status sociale. Tuttavia il movente principale dell'azione caritativa rimaneva quello religioso. Dietro quasi ogni lascito vi era l'obbligo - chiaramente espresso o sottinteso - per i legatari di pregare per i loro benefattori. Per mezzo dei legati a soggetti ben noti - i poveri conosciuti -, i testatori instauravano un legame personale con quegli individui che si credeva Dio avesse maggiormente fornito di ricchezze spirituali; e adempivano, i testatori, al precetto formulato da Cotrugli, di far iniziare l'opera di carità dai più vicini ("congiunti"). La beneficenza privata confermava la relazione simbiotica tra ricchi e poveri.
A quest'ultimo riguardo, i legati più efficaci erano quelli in cambio dei quali si richiedeva al beneficiato di recarsi in varie chiese della città per pregare o raccogliere indulgenze per l'anima del testatore. Più sopra abbiamo già incontrato una prescrizione del genere, nel testamento di Agostino Barbarigo, laddove il doge raccomandava alla serva Jacoma da Vicenza, quale contropartita spirituale al posto procuratole presso l'ospizio di San Marco, di andare a pregare per la salute della sua anima nelle chiese di Santa Maria dei Miracoli e di San Fantin. Nel suo testamento datato al 1501, Elena, vedova di Vittore Marcello, lasciava 2 ducati a una Elena "famule domus" purché le procurasse le indulgenze concesse nelle chiese della Santa Trinità e di San Lorenzo, chiedendo inoltre a un'altra donna, Dominica, di visitare le chiese di San Pietro di Castello e di Santa Croce (69). Erano le donne anziane, come vecchie balie e domestiche, quelle più spesso impegnate in tal sorta di lavoro spirituale, al punto che Contarina, vedova del doge Nicolò Marcello, ordinò nel suo testamento agli esecutori di scegliere "aliquas bonas personas" che andassero per varie chiese a patto che non si trattasse di "famule aliquorum nec nutrices" (70). Contarina voleva che le donne incaricate di tal cura fossero pagate. La donna prescelta per recarsi in San Marco avrebbe dovuto ricevere 5 ducati, "quia ipsa persona debet ire quotidie".
Nei giorni festivi e in altre occasioni speciali le chiese veneziane si riempivano di persone in cerca di indulgenze. Riferisce Marin Sanudo che nell'aprile del 1507 Vi fu "gran concorsso di zente" che chiedeva indulgenze presso gli ospedali di Sant'Antonio e della Pietà (71). Racconta Francesco Sansovino del giorno in cui il doge si recava nella chiesa di San Zaccaria: "[...] è in quel giorno una grande indulgentia, onde vi concorre tutto il popolo della città!" (72). Erano folle di povera gente - donne, soprattutto -, che recitavano preghiere e cercavano indulgenze a pro dell'anima dei ricchi.
Il dipinto con l'Elemosina di sant'Antonino di Lorenzo Lotto, eseguito per i Domenicani dei Santi Giovanni e Paolo nel 1542, ci dà un'idea di che cosa si intendesse per "gran concorsso di zente". Nella parte in basso a destra del quadro si osserva un gruppo di donne povere ma dignitose che avanzano supplica di essere allibrate nel registro dei poveri che sta alle spalle del diacono. In basso a sinistra è un altro gruppo di persone, questa volta formato da uomini e donne che protendono le mani implorando di ricevere una delle elemosine che un secondo diacono dispensa dalla borsa del danaro. Al di sopra dei due gruppi, sant'Antonino in trono, come un giudice, ascolta il consiglio degli angeli sui meriti dei supplici. Lotto annotò nel suo libro dei conti di aver fatto dei ritratti di poveri, quasi certamente preparatori a questo dipinto; è per ciò che, forse, esso presenta in modo tanto convincente la figura del povero veneziano e la pratica dell'elemosina (73), illustrando peraltro con chiarezza quel rapporto di simbiosi tra donatore e povero di cui si è già detto: i gesti, gli sguardi fissi dei supplicanti santificano Antonino.
Abbiamo evidenziato, con gli esempi riportati sopra, il modo in cui i privati usavano i propri testamenti per mettere in pratica una forma molto personale di carità, diretta a favore di persone ben precise. Naturalmente le carte testamentarie prevedevano anche - come quella del doge Barbarigo - dei lasciti ai maggiori
istituti caritativi cittadini - chiese, ospizi, Scuole, parrocchie -, ma allo stato attuale delle conoscenze non è possibile valutare l'impatto finanziario globale dei legati caritativi sulle istituzioni di assistenza veneziane. Occorre tuttavia sottolineare come le donazioni caritative per via testamentaria non fossero del tutto spontanee, giacché i notai che aiutavano i testatori a redigere l'atto di ultima volontà erano tenuti a norma di legge a chieder loro se intendessero disporre dei legati a beneficio di istituti particolari. Nel settembre del 1431, ad esempio, il maggior consiglio approvò una legge che ordinava ai notai di domandare ai testatori se volessero far lasciti all'ospedale della peste di Santa Maria di Nazareth; in seguito, nel dicembre del 1436, ancora il maggior consiglio aggiunse alla lista delle istituzioni per le quali i notai dovevano porre tal domanda l'ospizio degli orfani della Pietà. E leggi successive furono emanate riguardo ai poveri vergognosi, ai poveri mendicanti e ai catecumeni (74).
I tentativi dello Stato di indirizzare le donazioni caritative verso destinazioni istituzionali non sempre riuscivano. Sovente, alla richiesta dei notai i testatori rispondevano di non aver intenzione di far legati del genere ovvero di non avere ricchezze residue da lasciare ("non ho da lassar"). Ma le direttive impartite ai notai aprono il discorso sul ruolo svolto dallo Stato nel contesto della carità tradizionale a Venezia.
La carità dello Stato
Insieme agli istituti di carità e all'azione dei privati, lo Stato era l'altro grande vettore di assistenza e beneficenza. Sebbene in gran parte l'intervento statale si manifestasse a seguito di calamità naturali o disastri provocati dall'uomo, va detto per un verso che alcune forme assistenziali erano praticamente regolarizzate e persino istituzionalizzate; e, per altro verso, che i Veneziani di qualunque ceto sociale - dai patrizi andati in fallimento a causa di avverse circostanze ai vecchi marinai cui l'età rendeva impossibile l'imbarco -, tutti si rivolgevano al governo marciano per riceverne l'aiuto. È d'altronde prerogativa di ogni governo mostrare clemenza per i condannati, pietà per gli sventurati, favore per i sudditi leali.
A Venezia, in origine, il diritto di dare indulgenza e di elargire grazie riposava nelle mani del doge, ma con il passaggio da ducato a comune prodottosi tra il secolo XII e il XIII, tale potere dogale fu limitato a vantaggio dei consigli di governo. Lo Stato poteva dispensare innumerevoli benefici: posti nella burocrazia in città, in Terraferma e nei domini d'oltremare venivano concessi sotto forma di "grazia" e così pure gli aumenti di salario, le promozioni e le proroghe delle scadenze; per via di grazia si garantivano i privilegi commerciali, si alleggerivano le ammende, si commutavano le pene detentive e, ancora, si assegnavano somme di denaro, abitazioni, cibo, combustibile (75).
Molti di questi favori venivano elargiti secondo il calendario usuale della carità. A Natale e a Pasqua lo Stato emanava disposizioni circa il rilascio di prigionieri poveri incapaci di pagare i loro debiti, sì che, sotto l'anno 1504, Marin Sanudo lamenta come la consueta sessione del maggior consiglio il Martedì santo, di solito riservata all'esame dei casi di singoli prigionieri, fosse stata viceversa spesa per l'assegnazione delle cariche di governo (76). In tempi di emergenza lo Stato ricorreva alla concessione di grazie o alla carità per assicurarsi la benevolenza celeste o come forma di ringraziamento per grazia - a sua volta - ricevuta: nel novembre del 1463, i pregadi approvarono una distribuzione di grano e di denaro ai poveri e ai religiosi allo scopo di placare il "Numen Divinum" e di conciliarsi con esso nell'incessante conflitto con i Turchi (77).
I beneficiari dei favori dello Stato erano tanto vari quanto lo erano le grazie accordate. Molte concessioni andavano a favore delle chiese e dei monasteri della città e della laguna. Il Martedì santo dell'anno 1523, il maggior consiglio stabilì di donare il legname proveniente da una vecchia galea in disarmo al convento di SanFrancesco della Croce (78) e - per fare un altro esempio, di cronologia precedente - il giorno di Natale dell'anno 1450 il governo stanziò 50 ducati per il vescovo di Castello, che li distribuisse come meglio credeva (79). Patrizi, cittadini, artigiani, Veneziani e forestieri, tutti chiedevano soccorso e i registri ancora esistenti riportano a migliaia le grazie concesse. Non per nulla i governanti serenissimi lamentavano nel 1420 la gran quantità delle petizioni loro rivolte (80).
Oltre che dispensare una carità intermittente e motivata dalla capacità di persuasione delle suppliche dei richiedenti, il governo interveniva sul piano assistenziale informe diverse e più istituzionalizzate. La Ca' di Dio - ospizio riservato alle donne povere e oneste del quale si è già parlato - era posta sotto il controllo dello Stato attraverso lo iuspatronato esercitato su di essa dallo stesso doge. Ricordiamo inoltre altre due forme di sostegno ai bisognosi che, sovvenzionate dalla mano pubblica, si rivolgevano a utenti tutt'affatto diversi: si tratta dei posti di "balestrieri della popa", appannaggio dei soggetti nobili decaduti, e della selezione cosiddetta dei "poveri al pevere", che dava sussidio ai vecchi marinai. Giuridicamente definito come ceto di governo cui si apparteneva per diritto di nascita, il patriziato veneziano dovette affrontare problemi molteplici e particolari soprattutto connessi all'impoverimento nobiliare. Alcune famiglie facoltose all'epoca della "serrata" del maggior consiglio ormai avevano perso il loro patrimonio in anni difficili, e tuttavia continuavano a godere dello status nobiliare. I patrizi indigenti minacciavano la dignità del ceto dirigente e costituivano un gruppo di persone facilmente soggette a varie forme di corruzione, fra cui la vendita del voto (81) in maggior consiglio.
All'inizio del secolo XV, lo Stato cercò di dare soluzione al problema dell'impoverimento nobiliare. Nel gennaio del 1413 il senato stabilì che ogni nave mercantile che salpava dalla città portasse con sé quattro giovani patrizi poveri, in qualità di "balestrieri della popa" (82); oltre a ricevere il salario, costoro avevano diritto a imbarcare una certa quantità di merce senza pagare il nolo. Il provvedimento fu preso non solo per dare a quegli uomini un piccolo stipendio, ma anche per fornir loro l'opportunità di imparare il mestiere e acquisire l'esperienza necessaria per ricostruire le ricchezze familiari. Nei primissimi anni da che era stata istituita, la condizione di "balestriere della popa" sembrò sortire gli effetti desiderati. A trarre beneficio da questo impiego fu Andrea, figlio di Nicolò Barbarigo: come ha spiegato Frederic C. Lane, questi, sfruttando sia la posizione di "balestriere della popa" sia i legami con i parenti di Creta, riuscì a restaurare il patrimonio andato in fumo con il padre (83).
Non si sa di preciso quanti altri giovani patrizi seppero sfruttare quell'incarico secondo il fine che si proponeva; ma sappiamo che era molto ambito ed entro pochissimi anni dalla sua istituzione, questa, che era nata come una forma di assistenza, divenne una fonte di corruzione. Nel 1428, il senato ammoniva che si mettesse fine al recente abuso di mandare degli altri al posto dei giovani patrizi scelti come balestrieri, i quali trattenevano per sé una parte del salario; tutto ciò - evidentemente - andava contro le intenzioni iniziali dell'impiego quali erano state concepite all'atto dell'istituzione di esso, vale a dire conferire ai rampolli di schiatte patrizie impoverite una sorta di educazione al commercio. La diffida fu di scarsa utilità, e venne reiterata nel 1440 e nel 1475, finché nel 1481 il maggior consiglio deliberò che gli assegnatari del posto di balestriere potessero farsi sostituire da figli o fratelli (84).
La domanda era davvero grande. Nel 1445 il governo calcolò in quattrocento gli uomini che aspiravano a tale incarico, e nel 1506 i pregadi contavano duecentonovantadue balestrieri scelti regolarmente, e altri cui l'impiego era stato accordato per via di grazia (85). Effettivamente, ogni anno il maggior consiglio assegnava dei posti di balestriere a patrizi che riferivano storie strappalacrime. I due figli di Pelegrin da Canal, ferito a morte nella riconquista di Padova, ebbero concessi dieci viaggi sulle galee di Fiandra (86); e ottennero il posto il figlio di Andrea Bassegio, ferito mentre serviva fedelmente la Repubblica, e i figli di Giorgio Barbaro, che era stato catturato dai Francesi (87). Col tempo questo impiego, originariamente creato nel tentativo di prestare assistenza ai patrizi impoveriti e meritevoli dando loro competenze utili, si trasformò via via in un sussidio monetario corrotto, a beneficio di quelli che sapevano raccontare le storie migliori e raccogliere più voti fra gli amici in maggior consiglio.
A differenza dei "balestrieri della popa" - istituto a sostegno dei patrizi impoveriti all'inizio della carriera - la condizione dei "poveri al pevere" era quella di vecchi popolani indigenti e ormai impossibilitati al lavoro. Gasparo Contarini descrive brevemente tal forma di carità nella sua opera sulla Repubblica e i magistrati di Vinegia: "[...] per vecchio statuto nei contratti di compara et di vendita di merci di gran prezzo l'uno, et l'altro, ciò è il compratore, e '1 venditore pagano un certo che per la somma delle merci: il che si divide tra i poveri marinaii, i quali non possono più sodisfare a' quello ufficio per l'età, la quale hanno pur consumato in quello essercito" (88). Questa posizione, istituita nel 1362 e finanziata con una soprattassa sul pepe - donde la denominazione, appunto, di "poveri al pevere" -, era destinata in principio a sovvenire trenta uomini nativi di Venezia e di età superiore ai sessant'anni. Il numero dei posti a disposizione si accrebbe rapidamente, dai quarantacinque soggetti del 1386 ai sessanta del 1393, ai settanta del 1395 fino a raggiungere gli ottantadue del 1403, livello sul quale si attestò (89). Allo stesso modo fu estesa l'applicazione della soprattassa che garantiva la copertura del provvedimento, dal pepe solo ad altri prodotti tra i quali il cotone, la lana e le pelli.
Ma quasi dall'inizio cominciarono le dispute su chi poteva essere iscritto nei ranghi degli aventi diritto e sulle procedure di selezione; erano trascorsi appena sei anni dalla creazione dei "poveri al pevere" che già il maggior consiglio, nel 1386, denunciava come il beneficio andasse in favore di uomini non degni, lasciando quindi i candidati meritevoli "sine aliqua spe vite sue". Per correggere tal difettoso andamento, il consiglio medesimo stabilì che i candidati dovessero venir designati dai consoli dei mercanti e votati successivamente dalla quarantia (90). Nel 1416 quarantia e maggior consiglio ribadirono necessario che i candidati fossero "cives nostros originarios", allargando tuttavia la cerchia degli eleggibili, oltre che ai marinai, anche ai calafati e ai carpentieri di bordo "sine quibus, ut notum est, naves nostre navigare non possunt" (91). Col tempo l'eleggibilità fu estesa anche ai non nativi di Venezia e, come per i balestrieri, l'assegnazione dei posti avveniva tanto secondo le procedure standard quanto per via di grazia. Addirittura, nel 1498, il maggior consiglio ritenne di conferire lo status di "povero al pevere" alla moglie del defunto Basegio da Coron, cosicché ella potesse mantenere se stessa e i suoi figli in età minore (92).
Gli stessi poveri erano organizzati in una associazione molto simile a una corporazione o a una Scuola; osservavano uno statuto o mariegola, eleggevano un "gastaldus", come pure un consiglio di assistenti chiamati "compagni", e tenevano riunioni periodiche durante le quali si discutevano e si votavano le questioni in essere. Per la festa dell'Assunzione della Vergine, i poveri offrivano una messa per la quale donavano le candele usate in occasione dell'elezione del gastaldo, un'offerta - quest'ultima - fatta "ad exaltation del nostro Signor Dio, et di questo glorioso stado et in augmentation de tutti quelli fano la elimosina a tutti nui poveri" (93). Comunque, come accadeva in molte altre fraglie, l'ideale di fraternità e di amicizia era continuamente minacciato da contrasti sulla conduzione: ad esempio, nel 1541 il sindaco della Scuola avanzò un reclamo contro Zuan Cordeler, accusandolo di aver rivestito il ruolo di gastaldo negli ultimi otto anni, laddove lo statuto espressamente vietava la rielezione senza un periodo di contumacia di due anni (94). Come l'istituto dei "balestrieri della popa", anche quello dei "poveri al pevere" perdette rapidamente di vista le intenzioni iniziali. Sorta per dare sostegno a degni sudditi veneziani, che avevano ben servito la Repubblica, la condizione istituzionale di povero divenne un'apprezzata sinecura, che i nobili dispensavano a candidati non meritevoli, mentre i poveri, per parte loro, si azzuffavano sui diritti e privilegi della loro corporazione.
Gli abusi non erano una prerogativa esclusiva della beneficenza dello Stato. Le Scuole e gli ospizi, soprattutto quelli che fornivano stanze separate o case di carità ai propri ospiti, lamentavano il malcostume degli inquilini, che affittavano l'alloggio o lo usavano per dare asilo ad amici e parenti non in possesso dei requisiti necessari all'assegnazione. Nelle pagine del Sogno di Caravia, datato al 1541, Alessandro Caravia sferza duramente le Scuole grandi: se ai vecchi tempi le Scuole compivano le "sett'opre corporale", oggidì "Dio appregia niente / Il suo spender danari con le pale / In fabbriche si larghe, e eminente / Perche sa ben, che gli spendon per boria / E non per far a' lui honor, e gloria" (95). Le Scuole divennero focolai di corruzione nelle quali, Caravia accusava, i reggenti "non aman Dio, ne charitate / Perche se Dio, e charità fusse in loro / Non pretiarian superbia, invidia, et oro" (96).
Gli istituti caritativi erano quelli più soggetti alle interferenze da parte di cittadini ambiziosi che li reggevano, di patrizi indiscreti che li finanziavano, di popolani parassiti che se ne avvantaggiavano. La burocratizzazione di questi istituti, assieme ai cavilli legali che la seguivano, ci aiuta a comprendere perché si produsse a Venezia una proliferazione della carità. Alla nascita delle varie istituzioni di assistenza e beneficenza, i Veneziani vennero influenzati dal fervore dei fondatori come dalla dignità dei beneficiati, volgendosi di buon animo a finanziare di tasca propria numerose opere di carità. Senonché, con l'andar del tempo, quegli stabilimenti caddero nel torpore d'iniziative e preda della corruzione, sì che i buoni Veneziani preferivano indirizzare i propri fondi verso istituti affatto nuovi capaci di rappresentare meglio gli ideali filantropici. Come per gli ordini monastici, così anche la storia dell'assistenza e della beneficenza può essere vista come uno sforzo continuo di riforma.
Gli scopi della carità e i poveri tradizionali
Gli abusi dilaganti negli istituti di assistenza sollevano il problema difficile di che cosa fosse dunque la carità. E di come si possano valutare i moventi dei benefattori e l'impatto che la carità tradizionale ebbe sulla politica e sulla società veneziane.
Come già abbiamo osservato, il fattore religioso è sempre presente, magari in modo implicito, qual motivo di fondo e giustificazione delle attività caritative. Lo Stato autorizzava spese per i poveri e concedeva grazie per propiziarsi il favore divino, come nel 1460, nel corso di una guerra contro i Turchi, quando il senato approvò un sussidio per i bisognosi, giacché "devemo procurar de plazer la Maiestà Divina, et invocar el Spirito Santo a consegliarene, et illuminarne a elezer el meglio, facendo per sua reverentia qualche degna Elemosina che li sia accepta" (97). Le Scuole e le corporazioni facevano opere di carità per assicurarsi la benevolenza dei rispettivi santi patroni, e i privati disponevano lasciti e donazioni per la salvezza delle loro anime.
Ma l'élite di governo usava la carità anche come mezzo per garantire la stabilità sociale della Repubblica, e - non ultimo - per mantenersene alla guida. Gasparo Contarini inizia la propria disamina sui vari tipi di carità - case di carità e "poveri al pevere" compresi - osservando che a Venezia non c'erano mai stati i "tumulti popolari" che avevano afflitto le altre città (98). L'epoca e, di nuovo, il governo marciano giustificavano i favori personali con la scusa che i beneficiari avevano dimostrato una fedeltà incrollabile nel servire lo Stato. Attraverso la gestione oculata dell'erogazione di privilegi a individui scelti, i benefattori cercavano di trasformare il popolo in una schiera di seguaci docili e passivi. Allorché, nel 1546, il procuratore di San Marco Vittore Grimani e la moglie Isabeta donarono 20o ducati per dote alla serva Ruosa da Budua, lo facevano come atto di ricompensa alla "fidel servitude et exemplar vita de ditta loro cameriera, accio altri simili servitori sui mossi da tal exempio habbino animo di servirli in quel medemo modo et da tal loro servitu sperar simile recompensa" (99). La carità era insomma una potente arma a difesa dell'élite urbana (100).
Intanto che proteggevano i privilegi dei ceti dirigenti, assistenza e beneficenzacostituivano altresì un valido strumento per le ambizioni dei privati. I patrizi facevano leva sulla possibilità di accedere ai fondi destinati alla carità e ad altre forme di patrocinio per favorire i propri sostenitori e per crearsi una rete informale di individui che, in cambio di aiuto, potevano riuscire utili a concretizzare le ambizioni politiche o a consolidarne la considerazione personale. In verità una delle accuse sollevate contro Francesco Foscari fu che, in quanto procuratore di San Marco, impiegò dei fondi affidati a quell'ufficio al fine di procurarsi una clientela (101). Il gran numero di patrizi poveri rappresentava un ricco terreno di caccia per gli ambiziosi. Non a caso, all'atto della elezione, il doge andava alla testa di una processione attraverso piazza San Marco, durante la quale egli lanciava monete alla folla.
I patrizi non erano i soli a piegare la carità a fini personali. Caravia condannava quei cittadini che, usando del proprio monopolio sui posti nelle Scuole grandi, instauravano in qualche forma rapporti di patronaggio, contro i quali lottavano pure le corporazioni di mestiere. Secondo lo statuto dei falegnami, a coloro che avessero ricevuto "elemosina da la banca" era preclusa la partecipazione alle elezioni, perché, naturalmente, sarebbero stati disposti ad eleggere coloro i quali avevano concesso loro l'elemosina: una pratica del genere avrebbe contribuito alla "total ruina e desolation de la ditta Scola" (102).
La carità tradizionale a Venezia, che fosse finanziata da istituti o da privati o dallo Stato, mirava a creare una società pacifica, sorretta dal favore di Dio e innervata da un senso della comunità generalizzato tanto ai ricchi che ai poveri. Questa particolare forma di beneficenza si rivolgeva a quei poveri incapaci di guadagnarsi da vivere da sé soli o perché colpiti da invalidità fisiche o perché andati vittime di disgrazie a tutti comprensibili; poveri conosciuti dai loro benefattori. Gli ospizi erano delegati in maniera quasi totale alla cura dei poveri strutturali, così come altre forme di carità sovvenzionate dallo Stato. Quanto alle Scuole e alle fraglie, provvedevano agli affiliati che avessero subito un tracollo finanziario in tempi difficili. Privatamente, i Veneziani aiutavano gli amici, i parenti e i clienti che giudicavano degni della loro assistenza, per caratteristiche e condizioni. Un certo Zuane Zanon, nel suo testamento datato 1469, lasciò una rendita di 2 ducati l'anno a un canapaio di nome Giacomo de Zuane "el qual è deventado orbo" (103).
Se la povertà avesse avuto sesso, sarebbe stata soprattutto femminile (anche se non esclusivamente). In particolare per i patrizi maschi, le donne incarnavano un tipo di povertà che non costituiva una minaccia. Una figura vaga e irreale, conosciuta come la "Vergine veneziana", ispirò l'ospedale dei Derelitti (104). Altre donne povere servirono da veicolo di comunicazione con Dio. Nel 1523 Marin Sanudo riferisce che la sorella di un "torniador", nella parrocchia di San Barnaba, cadeva in estasi (105). Con la loro presenza e vicinanza i poveri purificavano la comunità. Sempre Sanudo riporta che il giorno 21 gennaio 1526, festa di sant'Agnese, egli fece visita alla chiesa omonima "per vedere cosa nova": l'ospizio di Sant'Agnese, che si incaricava di mantenere ed eventualmente collocare in matrimonio le orfane appartenenti all'élite marciana, aveva eretto là un palchetto ("uno solereto") sul quale stavano sei giovanette di età fra gli otto e i nove anni, "vestite meze bianche e meze rosse, con caveli zo' per spala e una zoia di verdure in testa". Sanudo continua descrivendo i compiti dell'ospizio, vale a dire insegnare alle fanciulle a leggere e scrivere, e dar loro un'educazione finché non si fossero sposate. Le orfane erano sotto la tutela di una "maistra", che riceveva 40 ducati annui di salario. A queste giovanette, la dote veniva costituita in parte grazie all'intervento dello Stato e in parte con il concorso della Scuola di Sant'Agnese e, secondo Sanudo, le ragazze venivano scelte "con certo ordine bellissimo" (106). Questa era esattamente la maniera in cui Sanudo e gli altri membri del ceto dirigente volevano aver contatti con i poveri; tutto ordinato, tutto sotto controllo, le ragazze stesse erano state rese passive, non tanto fanciulle in carne e ossa quanto manichini con sembianze femminili, su di un palco. In realtà, tutta la faccenda ricorda vagamente la festa medievale delle Marie, ormai decaduta, durante la quale delle giovanette, o forse statue di giovanette, sfilavano in processione per le parrocchie. Nella stessa epoca in cui Sanudo testimoniava dello spettacolo della sagra di sant'Agnese, Venezia veniva sommersa da un genere assai diverso di poveri (e Sanudo stesso se ne lamentò): i contadini affamati provenienti dalla Terraferma. Questo grande afflusso di poveri meno rispettabili, sconosciuti e perciò più minacciosi, doveva produrre i maggiori cambiamenti nella politica dello Stato rivolta ai bisognosi e alcune modifiche alla pratica tradizionale veneziana dell'assistenza e beneficenza.
Anni di crisi e di cambiamento
Durante il secolo XIV e molta parte del XV, la carità istituzionale e privata, insieme a forme sporadiche di assistenza da parte dello Stato, probabilmente si dimostrarono adeguate a soddisfare le richieste basilari dei poveri strutturali di Venezia e perfino capaci di salvare alcuni "poveri da crisi". Non a caso nello stesso arco temporale la città raggiunse l'apogeo della propria potenza economica e commerciale. Tuttavia, negli ultimi trent'anni del secolo XV la fortuna di Venezia cominciò a cambiare. Sempre più coinvolta nelle vicende italiane in Terraferma e alle prese con l'offensiva ottomana sul fronte orientale, Venezia fu impegnata dal 1463 al 1479 in una guerra contro i Turchi che culminò nella perdita del Negroponte, di alcune isole dell'Egeo e nella cessione della fortezza di Scutari, in Albania.
Il conflitto portò con sé un'ondata di attività caritative, al fine di indirizzare il favore divino a vantaggio della Serenissima. Poi, quando le sorti della guerra volsero contro Venezia, la città venne invasa dai rifugiati provenienti dall'Egeo e dall'Albania. Nel febbraio 1471, il senato, di fronte al gran numero di povera gente che, bandita dai territori turchi, cercava rifugio sotto i portici di palazzo Ducale, ordinò che costoro fossero trasferiti a Marghera e lì fosse dato loro un riparo. Ma il provvedimento si rivelò inadeguato, sicché nel dicembre dello stesso anno i pregadi diedero ordine all'ufficio del sale di far erigere una tettoia in campo Sant'Antonio, di modo che i profughi non morissero di freddo e di fame. Nell'agosto del 1472, il senato ingiunse ai provveditori alla biave di inviare al rifugio due staia di pane alla settimana per nutrire quei poveri che erano troppo vecchi o malati per provvedere a se stessi. E nel marzo del 1473 e nell'agosto del 1474 furono ordinate ulteriori elemosine per i rifugiati di Negroponte e dell'Albania (107).
Nel settembre del 1474, in segno di ringraziamento per la temporanea salvezza di Scutari dalla dominazione turca, il senato autorizzò la edificazione di un rifugio permanente per i poveri, a Sant'Antonio, che portasse il nome di ospizio di Messier Gesù Cristo. A ispirarne la fondazione fu probabilmente, secondo Brian Pullan, l'opera dell'osservante francescano milanese Michele Carcano: il senato seguì l'esempio del duca di Milano, che aveva fatto costruire un grande ospedale generale per i poveri (108).
In uno studio recente Dulcia Meijers ha definito la decisione di erigere un cohopertum a Sant'Antonio nel 1471 "il primo intervento dello Stato veneziano in materia di assistenza ai poveri" (109). Questa sembra un'esagerazione poiché, come dimostrano la pratica delle grazie e l'istituzione dei ruoli dei "poveri al pevere" e dei "balestrieri della popa", il governo marciano aveva prestato il proprio soccorso a determinate categorie di bisognosi almeno a partire dal tardo secolo XIII, se non prima. La definizione dell'azione dello Stato negli anni Settanta del Quattrocento data da Pullan ci sembra più accurata, laddove lo storico inglese afferma che con questa risoluzione la Serenissima si stava chiaramente avventurando più in là nel settore delle responsabilità sociali (110). La costruzione del cohopertum segnò l'inizio di uno sforzo prolungato, da parte dello Stato, per aiutare i poveri sconosciuti.
La propensione verso una politica sociale più coerente e la preoccupazione per i poveri, dimostrata per la prima volta negli anni Settanta e Ottanta del secolo XV, assunsero carattere d'urgenza durante i tre decenni iniziali del Cinquecento, culminando nella legge sui poveri del 1528-1529. Anni di contagio, di invasioni straniere, di fame, anni che - stante la situazione favorirono l'afflusso in città di immigrati in cerca di cibo, riparo e lavoro. In questo periodo la peste colpì con particolare intensità; ci furono epidemie negli anni 1502, 1507, 1510, 1511, 1513, 1523 e 1528. All'orrore della peste si aggiunsero nuove malattie come la sifilide, che comparve per la prima volta a Venezia nel 1495-1496 (111). I disastri delle guerre, specie quella della lega di Cambrai, recarono con sé nuovi afflussi di rifugiati, provocando un certo allarme presso l'élite marciana per la tensione creata in città dal numero crescente di immigrati poveri. Nel gennaio del 1506 i provveditori alla sanità scrivevano che si era venuta sviluppando "una pessima consuetudine":
se attrovano molti furfanti, et persone abiette et di vilissima condition cussi homeni come femene, qual femene con le cappe in zoso coperto el volto et li homeni coperti et vestidi de sacco si che non sono conosciuti vano per la terra cercando elemosina simulando esser boni cittadini et de optime fameglie redutte in povertà, né se sa se siano forrestieri o terrieri né dove vengono, che facilmente potria de loco amorbato et saria causa de far seguir qualche gran inconveniente de peste. Oltra che con questo mezzo etiam contra el debbito extorquono el danaro de man a molti, adeo che sono causa che molte persone neccessitose et redutte con effetto in gran callamità vien a' patir per la fraude de questi tali (112).
Per por fine a questo scandalo i provveditori ordinavano che nessuno potesse chiedere l'elemosina con il volto celato, tranne le persone rispettabili, coloro che si vergognavano troppo a mendicare apertamente e avevano quindi ricevuto il permesso di farlo in incognito (dietro certificazione dei rispettivi parroci) dagli stessi provveditori alla sanità. I contravventori sarebbero stati frustati lungo il percorso da San Marco a Rialto e condannati a due mesi di galera. È importante questo provvedimento ufficiale perché esprime nel preambolo tutti i timori dell'élite riguardo ai poveri, alla malattia e alla carità fatta alle persone sbagliate. Invece che poveri rispettabili, i mendicanti che giravano incappucciati, così da essere irriconoscibili, vi vengono definiti "furfanti" di vile condizione; non persone per bene ma "abiette", il cui stratagemma le rende ignote ("non sono conosciuti"); non nativi della città ("boni cittadini e de optime fameglie"), sono "forrestieri". La triade delle virtù attribuite per tradizione ai poveri di Venezia (rispettabilità, familiarità, origine locale) si trasforma qui in una triade di vizi (abiezione, anonimato, estraneità).
Inoltre quei poveri potevano essere il veicolo della peste. Essi dunque vengono ora associati alla malattia e al contagio, e - cosa peggiore - sembrano detenere un potenziale suscettibile di sovvertire lo scopo fondamentale dell'azione caritativa, di affossare quella simbiosi tra ricchi e poveri che stava alla base della pratica tradizionale dell'elemosina. Nelle parole dei provveditori, adesso è questione di "frode" e di "estorsione", ciò che mette a repentaglio il processo stesso dell'elemosina e costituisce insieme, pur in modo indiretto, una minaccia per la salute delle anime dei benefattori. Se il preambolo all'ordinanza emessa dai provveditori alla sanità dà il segno di una reazione alla presenza di queste nuove masse di poveri da parte del ceto di governo marciano, le annotazioni di Marin Sanudo illustrano un ulteriore tipo di reazione. La sequenza dei cattivi raccolti negli anni 1527 e 1528 rese veramente disperata la situazione alimentare, intanto che la città veniva ancora una volta invasa dagli immigrati. Così scriveva Sanudo alla data del 16 dicembre 1527:
Et cussì ogni cossa è cara, et ogni sera su la piaza di San Marco et per le strade et in Rialto sta puti cridando: ῾pan, et muoro da fame et da fredo' ch'è una compassion, et vien trova la matina morti alcuni sotto i portegi del palazo. Tamen, non si far alcuna provision (113).
E in febbraio la situazione era ancora peggiorata:
Ma per non restar di scriver cosa notanda, qual voio sia a eterna memoria di la gran carestia è in questa terra, et oltra li poveri sono di questa terra, che cridando per le strade, sono etiam venuti di Buran da mar il forzo con li vesture in cao et fioli in brazo chiedendo elemosina: poi villani in numero grandissimo et vilane è venute, et stanno sul ponto di Rialto con puti in brazo dimandando elemosina. Et di visentina et brexana ne veneno assai, ch'è una cosa stupenda. Non si pol udir messa che non vegna dieci poveri a chieder elemosina: non si pol aprir la borsa per comprar alcuna cosa che poveri non dimandano un bezo, imo la sera tardi si va batando a le porte, et cridando per le strade "muoro di fame". Tamen per il publico non si fa provison alcuna a questo (114).
Alla reazione di disgusto e di diffidenza per la frode e l'inganno espressa dai provveditori, si deve aggiungere l'orrore e la genuina compassione di Sanudo per la povertà di adulti e bambini che muoiono di fame. Tali atteggiamenti discordanti indussero differenti risposte al nuovo fenomeno di una massa di malati e di poveri forestieri. La soluzione dettata dalla compassione portò alla fondazione di nuovi tipi di ospedali che giammai s'erano visti prima a Venezia, concepiti su scala diversa e con scopi diversi. Il primo di questi nuovi ospedali fu quello degli Incurabili, che, come suggerisce il nome, fu istituito essenzialmente per la cura di quanti soffrivano di sifilide o di altre malattie croniche. Un altro fu l'ospedale dei Derelitti, anche conosciuto sotto il nome di Ospedaletto, ai Santi Giovanni e Paolo.
Lo stabilimento degli Incurabili fu fondato da Gaetano da Thiene, membro della Compagnia del Divino Amore, che intraprese la sua opera a Venezia insieme alle nobildonne Maria Malipiero e Marina Grimani, offrendo un rifugio ad alcune povere donne in una casa a Santo Spirito. Nel 1523 Zaccaria Semitecolo donò un pezzo di terra lungo le Zattere per un oratorio. Questa iniziativa privata ed ecclesiastica presto incontrò il favore dello Stato, e nel febbraio 1522 i provveditori alla sanità ordinarono a tutti i vagabondi malati di sifilide di entrare in questo ospedale pena il bando dalla città. Di nuovo la paura del contagio associato ai mendicanti era dominante. L'ospedale degli Incurabili crebbe rapidamente e presto superò per dimensioni gli ospizi tradizionali, convogliando su di sé l'appoggio del ceto dirigente marciano: abbiamo ricordato più sopra l'episodio dei procuratori dell'istituto - i "primi della terra" - che lavano i piedi ai sifilitici (115).
Quando Gaetano da Thiene lasciò la città, fu Girolamo Miani che si incaricò di sovrintendere agli Incurabili. A quel tempo Miani, nato nel 1486 da una famiglia patrizia minore, si era già guadagnato una buona reputazione per il suo lavoro a vantaggio dei poveri. Fu la terribile carestia del 1527 che per prima lo spinse all'azione: iniziò alloggiando alcuni indigenti in casa propria e prodigandosi insieme ad altri presso l'ospedale del Bersaglio, un rifugio per i poveri creato su iniziativa dello Stato al posto di un campo da tiro (donde il nome) a San Zanipolo, dal quale si sviluppò la fabbrica dei Derelitti. Sebbene l'esatta cronologia e l'individuazione degli artefici della fondazione di quest'ultimo ospedale non siano del tutto certi, è tuttavia chiaro che l'impulso che fu dietro alla sua creazione venne da uomini e donne di diversa estrazione sociale (116). Durante i primi mesi di esistenza, i Derelitti furono poco più che un luogo in cui i poveri se ne andavano a morire. Sanudo registra centoquindici decessi nel marzo del 1528 e centotrentasette nell'aprile, ma col tempo, soprattutto grazie al prodigarsi di Miani, cominciò a prender forma la futura direzione dell'ospedale.
Sebbene Miani lavorasse con tutti i poveri, il suo interesse precipuo era rivolto agli orfani, per fornir loro i mezzi necessari a condurre una vita dignitosa. Già in precedenza aveva creato a San Basilio e a San Rocco dei laboratori artigianali di addestramento per i poveri, e ai Derelitti poté giovarsi della collaborazione del fabbro Zuan Antonio da Legnano per insegnare ai ragazzi a lavorare il ferro (117). Nel 1531 Miani fu chiamato alla direzione degli Incurabili, dove completò il suo programma per gli orfani includendo l'educazione alla dottrina cristiana, l'insegnamento a leggere e scrivere e l'addestramento artigiano. Gli Incurabili e i Derelitti furono due dei cosiddetti "Ospedali Grandi" di Venezia, cui si aggiunsero nel 1564 quello dei Mendicanti e quello della Pietà ristrutturato. Altri istituti, compresi le Zitelle, le Convertite, il Soccorso e i Catecumeni, si unirono a questi nel praticare, come dice Pullan, la "nuova filantropia", ma le loro singole storie ci porterebbero ben oltre i limiti di questo volume. La nuova filantropia del secolo XVI aveva come sua missione la cura di chi non corrispondeva ai criteri di appartenenza ai poveri rispettabili tradizionali, provvedeva cioè agli emarginati dalla società, fra cui le prostitute e gli Ebrei. Chi praticava la nuova filantropia si interessava non solo allo stato fisico, ma anche alle condizioni spirituali di quelli che gli venivano affidati. Un modo per capire il nuovo impulso caritatevole del secolo XVI è quello di considerare quest'ultimo un'epoca in cui i sette atti spirituali della pietà ebbero la stessa importanza dei sette atti corporali. Molto del merito di questo cambiamento deve essere attribuito al risveglio della Chiesa romana per influenza della Compagnia del Divino Amore e sotto la pressione del Protestantesimo. Come osserva Pullan, l'energia che era alla base della nuova filantropia era data da ecclesiastici, a differenza della carità essenzialmente laica svoltasi nel Tre-Quattrocento (118). Anche se molto di ciò che riguardava la nuova filantropia fu innovato, tuttavia non è difficile trovare dei precedenti nella carità tradizionale a Venezia. Gli ospedali grandi, per esempio, erano concepiti su vasta scala, ma dovevano un po' di merito anche ai loro predecessori, gli ospizi. Il desiderio di dare ai poveri delle conoscenze utili per la vita, che Miani tradusse in un programma per gli orfani, era lo stesso intento suggerito dai lasciti di strumenti e imbarcazioni, che i padroni facevano a favore dei loro servi. Infine persisteva ancora la convinzione che la donna fosse un veicolo speciale di misericordia. Madre Giovanna, la Vergine Veneziana, trovò discepoli ai Derelitti, e Vincenzo Grimani, figlio dell'ultimo doge Antonio, nonché procuratore agli Incurabili, fu ispirato da una lavorante, Chiara, che cadeva in estasi nelle chiese della Carità e di San Vio e che, secondo Sanudo, viveva solamente dell'ostia consacrata (119).
I vecchi principi e le vecchie pratiche, uniti alle nuove crisi e al rinnovato fervore religioso, suscitavano una reazione di compassione da parte di molti Veneziani, per la condizione dei poveri che affluivano in città (120). Ma questo fece esplodere anche la repressione. Dopo mesi di inattività, il senato il 13 marzo 1528 reagì approvando gli ordini che erano stati proposti dai provveditori. Il senato convenne che si dovevano costruire "doi, o, tre, over più loci" dove i poveri immigrati potevano trovare riparo e dove fosse fornito loro un letto di paglia. Inoltre i poveri venivano costretti ad entrare in questi rifugi; infatti, chi veniva colto a vagabondare per la città doveva essere imprigionato, o fustigato pubblicamente, e poi espulso dalla città. I barcaioli che traghettavano la gente dalla Terraferma all'isola, avevano il compito di mettere in guardia i passeggeri sulle nuove regole vigenti riguardo al chiedere l'elemosina. In caso di non adempimento di questo compito, ai barcaioli sarebbe stata bruciata la barca. Dopo una tolleranza iniziale, nessun altro mendicante doveva essere ammesso in città o negli alloggi. Per pagare questo tentativo di aiuto di massa, il senato impose una tassa di tre soldi per ducato sulle rendite derivanti da proprietà, date in affitto a più di dieci ducati. La responsabilità della raccolta di questa tassa fu affidata ai preti parrocchiali, assistiti dai parrocchiani nobili e cittadini. Essi dovevano registrare con cura i pagamenti: chi rifiutava di pagare sarebbe stato denunciato ad alta voce, nei giorni di festa, durante la messa grande. Tali misure dovevano rimanere effettive fino a giugno, dopo questo termine i mendicanti dovevano essere caricati sulle barche e "mandati in terraferma, con far publice proclame, che ritornando alcun di loro a mendicar saranno frustati da San Marco a Rialto". Il senato raccomandò che queste misure non interferissero con i tentativi, a carattere parrocchiale, di aiutare i poveri vergognosi (121).
Il proclama fu prontamente messo in opera. Vennero costruiti quattro rifugi (a San Giovanni in Bragora, Sant'Antonio, San Zanipolo, e a Ca' Donà alla Giudecca). Fu proprio il rifugio a San Zanipolo che attrasse il Miani. Ma la malattia incombeva minacciosa e le decisioni del marzo 1528 si proponevano solo come precauzioni temporanee. Circa un anno dopo, il 3 aprile 1529, il senato approvò una legge sui poveri molto più lunga, che progettava una politica di condotta più coerente riguardo al problema di aiutare i poveri (122). A quanto si dice, questa legge è il pezzo unico più importante della legislazione veneziana che riguarda i poveri, perciò merita una trattazione più dettagliata.
Il prologo iniziava in maniera piuttosto convenzionale. In realtà il linguaggio echeggia vagamente i sentimenti di Cotrugli e delle pratiche caritatevoli tradizionali:
La prima, et principal cosa, che per bona opera si puoi reputar certissimamente è la charità, qual verso il proximo continuamente usar si debbe, et dovendosi come ogn'uno è tenuto invigilar all'utile delli poveri, alla salute degli infermi, et alli esurienti prestargli il cibo et a' quelli che in sudore vultus potrano acquistarsi il vivere non gli mancare de auxilio, et favore sì per gratificar al nostro summo, et omnipotente dio, dal quale ogni bene excogitata operatione, et da buono animo compensata, e redutta a' perfetto fine.
Ma il tono cambiava molto in fretta quando il senato osservava che era necessaria qualche misura "per levar una pessima consuetudine et male modo di viver qual è la furfantaria, et mendecità". Dopo aver creato una distinzione fra i poveri meritevoli (anche chiamati "li poveri terrieri") e gli indegni fraudolenti, poveri immigrati, il senato emise una lunga serie di ordini. Per prima cosa, ordinò l'espulsione di tutti "i mendicanti forastieri" verso le loro terre d'origine. Bisognava consegnar loro delle lettere nelle quali si richiedeva ai reggenti del loro paese di prendersi cura di loro, in patria, e di assicurarsi che non tornassero a Venezia. Questi poveri immigrati dovevano essere curati "nella sua patria cum quelli modi, quali a' cui tal carica hava', più expedienti, et opportuni". Dopo aver dato disposizioni molto precise riguardo ai poveri stranieri, il senato si occupò dei poveri terrieri. Anche in questo caso il senato tracciò una serie di distinzioni fra poveri autosufficienti e disabili, fra donne e uomini. I poveri non autosufficienti che possedevano una casa propria dovevano rimanere là e fare affidamento sul clero della propria parrocchia per un aiuto. A loro era proibito mendicare. I poveri disabili, che non avevano un tetto, dovevano essere alloggiati negli ospizi. Gli autosufficienti, quelli che erano "robusti, et gagliardi [...] ma per essere dediti alla furfantaria, vituperosa et prohibita arte", dovevano essere impiegati sulle navi, i cui proprietari erano obbligati a pagar loro solo metà del salario che davano agli altri naviganti. Chi non andava per mare doveva intraprendere un mestiere. Il senato incoraggiava ciascuna delle corporazioni cittadine a prendere tre o quattro poveri uomini, ad insegnar loro un mestiere e a provvedere al loro mantenimento durante il periodo dell'addestramento. Così per le donne povere, il senato stabilì che i preti parrocchiali trovassero loro dei lavori adatti, e se esso non era sufficiente al loro mantenimento, allora dovevano aiutarle con la necessaria elemosina. Un'altra clausola invitava le badesse a prendersi cura delle ragazze ("povere donzelle bisognose") di "honesta vita", raccomandate dai loro parroci.
La legge prevedeva anche che i poveri non potessero trasferirsi da una parrocchia all'altra, senza una licenza. La responsabilità principale di far rispettare queste misure ricadde sui parroci. In una affermazione di principio piuttosto illusoria, il senato decretò che i poveri dovessero essere distribuiti fra le parrocchie in modo che "cadauna contrada habbi secondo la qualità et opulentia sua la quantità, delli poveri". Le risorse personali e materiali della parrocchia dovevano essere a disposizione dei poveri. Le Scuole del Sacramento su base parrocchiale dovevano incoraggiare i membri ad elargire elemosine. Il clero parrocchiale doveva esortare i parrocchiani ad aiutare i poveri, inoltre doveva mettere in chiesa una cassetta per raccogliere le elemosine per i poveri.
I poveri dovevano essere assistiti da un gruppo di delegati (due nobili, un cittadino e un artigiano) che erano scelti dai parrocchiani. I parrocchiani riuniti dovevano essere spinti ad approvare una "voluntaria taxa" per aiutare i poveri. I delegati avevano, fra l'altro, il compito di esaminare i conti fiscali di tutte le Scuole piccole e di incoraggiarle ad usare eventuali surplus di bilancio in favore dei poveri. Il parroco e i suoi delegati dovevano riferire mensilmente sulle loro attività, all'ufficio della sanità o al Patriarca, anch'egli coinvolto ad esortare i parrocchiani alla beneficenza, durante le sue visite. Le misure adottate dallo Stato nel 1528 e 1529, per fronteggiare il problema dell'accattonaggio e della malattia, rappresentarono una svolta nella pratica della beneficenza a Venezia e negli atteggiamenti. Secondo Brian Pullan, l'importanza di queste leggi sta nel fatto che segnarono una nuova operosità dello Stato e un diverso atteggiamento verso gli scopi della carità.
Egli osserva che la legge del marzo 1528 fu "il primo tentativo fatto dal governo veneziano per l'eliminazione totale del vagabondaggio" (123). I provvedimenti dell'aprile 1529 furono altrettanto importanti, perché codificarono e sancirono ufficialmente la distinzione fra i poveri nativi del luogo, che per lungo tempo erano stati oggetto della beneficenza veneziana, e i poveri forestieri. Allo stesso tempo lo Stato riuscì a coordinare una varietà di interventi di sostegno, usando le parrocchie per integrare altre attività caritatevoli (124). Bronislaw Geremek, al contrario, ha messo in evidenza l'aspetto repressivo piuttosto che il caritatevole di queste leggi. Egli sostiene che la carità fu sopraffatta dai tentativi di ghettizzare i poveri nei rifugi, di espellere gli stranieri, di proibire l'accattonaggio e di forzare al lavoro. La carità assumeva un tono diverso, coercitivo (125).
Sono state tentate molte spiegazioni per capire e spiegare questo radicale mutamento nella carità veneziana, negli anni Venti del secolo XVI. Sicuramente non dovremmo minimizzare il fatto che i cattivi raccolti, le guerre e le malattie concorsero a creare una situazione che sopraffece il meccanismo ordinario della carità, predi-sposto dalla società, e che costrinse a interventi drastici. La decisione del 1528, di espellere entro giugno tutti i mendicanti, sicuramente sembrò una reazione sconsiderata al problema, in verità, entro un anno, lo Stato avrebbe elaborato una linea di condotta più coerente riguardo al problema della mendicità. Tuttavia, poiché la situazione migliorò col raccolto del 1529, persino quella legge non fu fatta rispettare strettamente (126).
Pullan, per spiegare la legge sui poveri, ha gettato uno sguardo oltre i confini di Venezia. Sicuramente, nei primi secoli la pratica della carità a Venezia aveva seguito le tendenze più diffuse in Europa. Egli crede che Venezia possa essere stata influenzata dall'esempio di alcune città in Germania, che stavano attuando misure per i poveri. L'arrivo a Venezia di parecchi membri della Compagnia del Divino Amore, fra cui il Thiene e Gian Pietro Carafa, fu sicuramente di stimolo per molte delle maggiori innovazioni della nuova filantropia, sebbene Pullan metta in guardia dall'immaginare che ci fosse un'unica posizione, di tutto il mondo cattolico, sul problema dell'accattonaggio e del sostegno ai poveri (127). Tuttavia le spiegazioni proposte da Pullan aiutano molto meglio a capire gli aspetti caritatevoli della nuova filantropia che quelli repressivi. Per comprendere questo secondo aspetto del problema sarebbe opportuno guardare alla storia interna della città, in modo particolare bisogna analizzare i cambiamenti all'interno dell'élite dominante e la paura onnipresente di agitazioni popolari. Come risulta chiaro dalle proteste di Sanudo, contro l'inerzia dello Stato, c'era discordia fra i patrizi sulla politica da seguire. Antonio Tron, procuratore di San Marco, era uno dei difensori politici dei poveri, soprattutto dei poveri patrizi. Ancora nel 1501 egli aveva lottato per una legge che annullasse tutti gli impieghi ai "balestrieri della popa", assegnati dai quaranta, poiché le cariche erano state vendute e abusate. Nel 1520 Tron propose una legge che obbligava i procuratori a distribuire imparzialmente le case di carità a loro disposizione, e tentò, senza successo, di ottenere un'autorizzazione ufficiale per un Monte di Pietà. Tron lavorò instancabilmente per mantenere la rettitudine del governo. Inventò una nuova urna per le votazioni e introdusse dei non-nobili "ballottini ", fu il maggior sostenitore dell'ufficio dei censori, ufficiali incaricati in parte di combattere la corruzione elettorale e i brogli (128). Tutte le azioni di Tron erano rivolte a mantenere un certo equilibrio fra la piccola cerchia dei patrizi estremamente ricchi (i Primi) e il numero crescente di nobili poveri e senza potere. Questa divisione era aumentata durante la guerra della lega di Cambrai, perché i Primi concentrarono la loro forza nel senato e soprattutto nel consiglio dei dieci, mentre la massa dei patrizi era relegata al meno potente maggior consiglio.
Con la morte del doge Grimani, nel 1523, Antonio Tron fu unanimemente riconosciuto come il più valido pretendente al trono ducale. Egli non solo aveva l'appoggio dei poveri patrizi che aveva aiutato, ma riscuoteva largo seguito anche fra il popolo. Ma quando annunciò che non avrebbe accettato la carica, la campagna elettorale avanzò con zelo e finì con la vittoria di Andrea Gritti. Con il suo matrimonio Gritti si era legato al potente banchiere Alvise Pisani, inoltre apparteneva ai Primi. Il popolo fu particolarmente sgomento per la sua elezione (129), Durante il suo mandato, che durò fino al 1538, Gritti formulò un programma di rinnovamento della città, che conteneva un certo numero di componenti politiche e culturali. Un aspetto del suo programma fu la riforma dei riti del carnevale, fra cui la rinuncia dei patrizi ad intervenire ai suoi aspetti più popolari. Gritti voleva impedire la partecipazione dei patrizi al rituale macello dei maiali e alla distruzione dei modelli di castelli. Egli si adoperò per creare un centro civico più decoroso e nobile a San Marco, patrocinando i maggiori progetti di costruzione, fra cui la Procuratia nuova, la Zecca, e la loggetta del campanile (130). Sebbene le manovre personali e politiche, che avevano ispirato le leggi sui poveri del 1528-1529, debbano ancora essere completamente stabilite, tuttavia il tono repressivo di queste leggi sembrava consono al programma e agli scopi di Gritti. In realtà, uno degli aspetti delle leggi, che non ha avuto sufficiente rilievo, è il fatto che la legge del marzo 1528 fu approvata con la motivazione che i poveri portavano disonore alla città. Si deplorava il povero che girava "cridando sopra li ponti et per le contrate, dimandando elemosina cum grande ignominia de questa città, il che è etiam cosa scandalosa et di mal exemplo".
Le misure adottate sarebbero risultate "ad laude et gloria dell'Omnipotente Dio et per honor di questa excelsa Repubblica" (131). Un'ordinanza dei dieci, nel 1524, proibì di girovagare per la città, senza autorizzazione, in cerca di elemosine accompagnati da "Pendii et Piphari", considerandolo un affronto alla "fede nostra Catholica, et contra el decoro de questa Nostra Città" (132). L'interesse per l'ordine e il decoro, oltre alla paura concomitante di tumulti popolari, furono fattori in più che portarono alla soppressione dell'accattonaggio.
Altri motivi dell'aspetto repressivo della nuova politica di assistenza e beneficenza si devono attribuire poi alle trasformazioni all'interno della stessa élite veneziana. Dopo tutto, la politica di sostegno ai poveri e la definizione stessa della povertà erano creazioni di quelli che non si trovavano realmente nel bisogno. Anche se i patrizi veneziani continuavano a provare simpatia e compassione per quelli che rispondevano ai canoni tradizionali dei poveri, cioè poveri materiali ma rispettabili, essi crearono una nuova categoria di poveri che non solo soffrivano fisicamente, ma anche mancavano di vergogna (133). Questi poveri ribaldi dediti alle frodi e agli inganni, non solo erano essi stessi privi di onore, ma mettevano a repentaglio quello della Repubblica. Per fronteggiare tale minaccia al "decoro di questa ben instituita Republica" (l'espressione è tratta dal preambolo alla legge dell'aprile 1529), erano necessari provvedimenti drastici.
Tradizione e innovazione
Dopo gli anni Trenta, relativamente prosperi, la situazione alimentare tornò a farsi critica negli anni Quaranta, e nel febbraio del 1545 provveditori alla sanità emanarono un lungo capitolare che aveva lo scopo di rendere pienamente effettiva la legge sui poveri del 3 aprile 1529. Il capitolare stabiliva ad una ad una le procedure che dovevano essere seguite in questo sistema di soccorso ai poveri basato sulle parrocchie (134). Per prima cosa il governo dei poveri della parrocchia doveva essere affidato ad un comitato composto dal parroco, due nobili, due cittadini e due artigiani. Una cassetta dell'elemosina con scritte in chiaro le parole "per li poveri della contrà" doveva essere posta in ciascuna chiesa, e le tre chiavi della cassetta erano custodite dal parroco, da uno dei due nobili e da uno dei due cittadini che lo assistevano. In più si doveva scegliere un povero residente nella parrocchia, "over altro homo da ben" che andasse ogni giorno in giro per la parrocchia, cercando elemosina per i poveri "con sacho et casseta". Per incoraggiare l'elemosina il prete visitava ogni famiglia della parrocchia "ricomandoli li Poveri della Contrada, facendoli intender che senza la sua elemosina non potrano viver" ed esortava i parrocchiani, ad ogni sermone, a fare l'elemosina. Se si riusciva a raccogliere una somma maggiore del necessario, il denaro in più veniva messo da parte segretamente "accio le elemosine non manchase".
A queste azioni compassionevoli se ne aggiungevano altre più severe. Nessuno, all'interno della parrocchia, poteva ricevere elemosina senza il permesso della sanità. Era proibito mendicare eccetto che per i preti e le suore che avevano una speciale licenza per farlo. Ai parrocchiani era proibito ospitare poveri mendicanti senza il permesso, e tutti gli accattoni che sembravano malati dovevano essere schedati entro un giorno. Tutti quelli che erano in grado di lavorare dovevano farlo. I giovani poveri dovevano essere messi a fare un mestiere o andare a lavorare come marinai e le ragazze dovevano andare con le donne più anziane o con le suore "accio non vadino al male". Perfino ai disabili si dovevano affidare certi lavori. Ai preti si dava l'ordine di registrare bene tutte le entrate e le spese, "accio sempre si possi veder el bon governo de ditti deputadi". Ai provveditori stessi era richiesto di inviare, ogni anno, una copia stampata di queste regole a ciascun parroco e ai predicatori, il primo giorno di Quaresima. Le regole dei provveditori, del 1545, come completa-mento della legge sui poveri del 1529, sancirono il punto finale di questo modo di considerare l'assistenza e la beneficenza nel periodo del rinascimento: infatti le regole e le procedure stesse, come pure le loro intenzioni, mostrano quello stesso miscuglio di pubblico e privato, di elementi caritatevoli ed elementi repressivi, che caratterizzarono la filantropia veneziana in generale. Esse contengono sia elementi innovativi che tradizionali.
Uno degli aspetti più significativi della legge sui poveri del 1529 e del capitolare del 1545 fu lo sforzo di fare delle parrocchie, ancora una volta, il fulcro della politica filantropica veneziana. Come in precedenza osservato, fino alla comparsa della Peste, la parrocchia svolse spesso un ruolo importante nella politica veneziana di assistenza e beneficenza.
Chi faceva testamento, lasciava denaro per opere di carità, quali la distribuzione di pane, di vino e altro cibo, a testimonianza, attraverso questo atto della commensalità, di un forte senso della comunità e di una forte simbiosi fra ricchi e poveri. Ora nei primi anni del secolo XVI, mentre le divisioni all'interno della società erano sempre più pronunciate, il governo fece uno sforzo per incoraggiare ancora una volta la carità basata sulla parrocchia. Ciò che non è chiaro è se la politica governativa era la forza trainante di questo sforzo, o se stava semplicemente seguendo le indicazioni spontanee che venivano dalle azioni delle parrocchie stesse. Sanudo riporta che, nel dicembre 1527, prima che il governo fosse incitato ad una più vigorosa azione, un prete da Cannaregio (Sanudo non riferisce il nome della parrocchia),
vedando tanta povertà in la contrà, convocò in chiesia li parrocchiani per far provision di trovar danari per darli il viver almeno di pan; et venuti, fu tra loro trovato ducati 200 d'oro, et ne troveranno zerca altri 200, di quali si comprerà farine, si farà pan et si darà per li deputadi con el piovan a poveri mixerabeli; ch'è stà bellissima provision (135).
E i benefattori, nei loro testamenti, continuavano occasionalmente a provvedere i compagni di parrocchia bisognosi. Per esempio, nel suo testamento, datato giugno 1539, il nobiluomo Antonio Capello lasciò dieci ducati ai poveri della sua parrocchia di San Samuele (136). L'ordine dei provveditori che ciascuna parrocchia selezionasse un povero o un altro "homo da ben" per raccogliere l'elemosina per i poveri, potrebbe essere stato un tentativo di mantenere un contatto diretto fra il benefattore e il povero, cosa che tradizionalmente era il fulcro della pratica della carità, mentre allo stesso tempo proibiva l'accattonaggio non autorizzato. Se questo sistema di assistenza ai poveri si rifaceva alle migliori tradizioni veneziane, esso in più forniva al governo un metodo efficiente e innovativo per controllare i poveri. Le quasi settanta parrocchie della città, con le loro corti di preti e deputati eletti fra le classi nobili, cittadine e artigiane, erano un formidabile strumento di sorveglianza e controllo, strumento che il governo avrebbe potuto copiare solo a prezzo di grandi sforzi e spese. Condizionando l'assistenza dei poveri all'obbligo di residenza, il governo fu in grado fino ad un certo punto di istituzionalizzare la distinzione fra "poveri terrieri" e "forastieri" e di avvantaggiarsi delle gelosie che si creavano fra i poveri nativi del luogo e quelli immigrati (137). Infine oggetto di particolare interesse e compassione rimasero quei poveri che in un modo o nell'altro furono identificati con la comunità. Essi potevano intercedere presso Maria e i santi a favore dei benefattori, perciò una particolare sollecitudine nei loro confronti rifletteva l'onore e il decoro della Repubblica. Per ingraziarsi il favore divino, nel 1545 i provveditori raccomandarono ai predicatori di ricordare a chi li ascoltava, che "il fondamento di tutte queste sante opere sono et sarano le large elemosine della caritade vostre" (138).
Traduzione di Vera Sommacal
1. Benedetto Cotrugli Raguseo, Il libro dell'arte di mercatura, a cura di Ugo Tucci, Venezia 1990, p. 190.
2. Ugo Tucci, Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano, Bologna 1981, pp. 36-37.
3. B. Cotrugli Raguseo, Il libro dell'arte di mercatura, p. 191.
4. Ibid., p. 193.
5. Venezia, Museo Correr, Mss. di provenienza diversa, C 912/II, cc. 27, 37, 44. Per un altro esempio v. Frederic C. Lane, Andrea Barbarigo: Merchant of Venice, 1418-1449, Baltimore 1944, pp. 188-190.
6. V. Juliana Hill Cotton, Caldiera, Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani, XVI, Roma 1973, pp. 626-628.
Margaret L. King, Umanesimo e patriziato nella Venezia del Quattrocento, I-II, Roma 1989: I, La cultura umanistica al servizio della Repubblica, p. 153.
Ibid., pp. 153-156.
Marino Sanuto, I diarii, a cura di Federico Stefani et al., I-LVIII, Venezia 1879-1903: IV, coll. 810-812.
10. La citazione di san Bernardino in Amleto Spicciani, La povertà ῾involontaria' e le sue cause economiche nel pensiero e nella predicazione di Bernardino da Siena, in Atti del simposio internazionale cateriniano-bernardiniano (Siena, 17-20 aprile 1980), a cura di Domenico Maffei - Paolo Nardi, Siena 1992, p. 829 (pp. 811-834).
11. Maureen Flynn, Sacred Charity: Confraternities and Social Welfare in Spain, 1400-1700, Ithaca 1989, p. 76.
12. Per un elenco di priorità nell'assegnazione delle elemosine, simile a quello compilato da san Bernardino, v. A. Spicciani, La povertà ῾involontaria', p. 829 n. 77.
13. M. Sanuto, I diarii, XXVI, coll. 102-103.
14. Girolamo Priuli, I diarii, in R.I.S.2, XXIV, 3,
vol. I, a cura di Arturo Segre, 1912-1921, p. 296.
15. M. Sanuto, I diarii, XXXIII, col. 154.
16. Brian Pullan, Rich and Poor in Renaissance Venice: The Social Institutions of a Catholic State, 1500 to 1620, Cambridge, Mass. 1971 (trad. it. La politica sociale della Repubblica di Venezia 1500-1620, I-II, Roma 1982), p. 63.
17. Dennis Romano, Charity and Community in Early Renaissance Venice, "Journal of Urban History", 11, 1984, pp. 63-82.
18. Ibid.
19. A.S.V., Notarile, Testamenti, b. 746, notaio Marcilianus de Naresis, protocollo, testamento nr. 53.
20. Martin da Canal, Les estoires de Venise: cronaca veneziana in lingua francese dalle origini al 1275, a cura di Alberto Limentani, Firenze 1972, pp. 284-305.
21. Brian Pullan, La nuova filantropia nella Venezia cinquecentesca, in Nel del regno dei poveri. Arte e storia dei grandi ospedali veneziani in età moderna, 1474-1797, a cura di Bernard Aikema - Dulcia Meijers, Venezia 1989, p. 19 (pp. 19-34).
22. Reinhold C. Mueller, Peste e demografia: Medioevo e Rinascimento, in AA.VV., Venezia e la peste, 1348-1797, Venezia 1979, pp. 93-95.
23. Giulio Beloch, La popolazione di Venezia nei secoli XVI e XVII, "Nuovo Archivio Veneto", n. ser., 3, 1902, P. 14 (pp. 5-49).
24. Dobbiamo distinguere fra "storia della povertà" e "storia dei poveri". Per questa distinzione v. Giovanni Ricci, Povertà, vergogna e povertà vergognosa, "Società e Storia", 5, 1979, p. 309 (pp. 305-337).
25. Christopher F. Black, Italia Confraternities in the Sixteenth Century, London-New York 1989, pp. 131-132.
26. A.S.V., Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 21, Leona, c. 138.
27. Venezia, Archivio istituzioni di ricovero e di educazione, Patr. 1 S, fasc. 46, carte sciolte non numerate datate 7 dicembre 1506. L'autore desidera ringraziare Giuseppe Ellero, dell'archivio sopra menzionato, per il suo generoso aiuto.
28. Capitulare notariorum: non tabellionibus solùm, verùm et iudicibus, Advocatis, causarum Procuratoribus, et aliis quislibet in Veneto foro versantibus, Venezia 1591, p. 51.
29. Giovanni Scarabello, Strutture assistenziali a Venezia nella prima metà del '500 e avvii europei della riforma dell'assistenza, in "Renovatio urbis": Venezia nell'età di Andrea Gritti (1523-1538), a cura di Manfredo Tafuri, Roma 1984, pp. 119-133; Id., Le strutture assistenziali, in Storia di Venezia, VI, Dal Rinascimento al Barocco, a cura di Gaetano Cozzi-Paolo Prodi, Roma 1994, pp. 863-872.
30. Alberto Stelio de Kiriaki, La beneficenza di ricovero a Venezia nel passato e nei nostri tempi. Ricordo per l'anno 1900, Venezia 1900, p. 149.
31. Ibid., pp. 181-182.
32. Iacopo Bernardi, Antichi testamenti tratti dagli archivi della Congregazione di carità di Venezia, X, Venezia 1891, pp. 31, 39.
33. Franca Semi, Gli "ospizi" di Venezia, Venezia 1983, pp. 28, 32.
34. Ibid., pp. 31-33
35. Ibid., p. 36.
36. Reinhold C. Mueller, The Procurators of San Marco in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: a Study of the Office as a Financial and Trust Institution, "Studi Veneziani", 13, 1971, p. 185 (pp. 105-220).
37. Richard Goldthwaite, The Empire of Things: Consumer Demand in Renaissance Italy, in Patronage, Art and Society in Renaissance Italy, a cura di Francis W. Kent - Patricia Simons, Oxford 1987, p. 165 (pp. 153-175). V. anche Bronislaw Geremek, La popolazione marginale tra il medioevo e l'era moderna, "Studi Storici", 9, 1968, pp. 632-633 (pp. 623-640).
38. F. Semi, Gli "ospizi ", p. 106.
39. D. Romano, Charity and Community.
40. Il documento è pubblicato in Hospitale S. Mariae Cruciferorum: L'ospizio dei Crociferi a Venezia, a cura di Silvia Lunardon, Venezia 1984, pp. 155-156.
41. Ibid., pp. 19-32.
42. Ibid., p. 32.
43. F. Semi, Gli "ospizi", p. 185.
44. Ronald F.E. Weissman, Ritual Brotherhood in Renaissance Florence, New York 1982.
45. A.S.V., Scuola grande di Santa Maria della Carità, torno 234, c. 8v.
46. B. Pullan, Rich and Poor, p. 63.
47. Ibid., pp. 107-108.
48. William B. Wurthmann, The Council of Ten andthe Scuole Grandi in Early Renaissance Venice, "StudiVeneziani", n. ser., 18, 1989, p. 51 (pp. 15-66).
49. Richard Mackenney, Tradesmen and Traders. The World of the Guilds in Venice and Europe, c. 1250-c. 1650, Totowa 1987, p. 48.
50. Pubblicato in Guido Perocco, Carpaccio nella Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, Venezia 1964, pp. 209-214.
51. R. Mackenney, Tradesmen and Traders, p. 61.
52. Reinhold C. Mueller, Charitable Institutions, the Jewish Community and Venetian Society. A Discussion of the Recent Volume by Brian Pullan, "Studi Veneziani", 14, 1972, pp. 44-45 (pp. 37-81). V. anche R. Mackenney, Tradesmen and Traders, p. 49.
53. B. Pullan, Rich and Poor, pp. 95-98.
54. A.S.V., Notarile, Testamenti, b. 754, notaio Antonio de Vataciis, testamento sciolto datato 4 luglio 1435.
55. Ibid., b. 190, notaio Girolamo Canal, testamento sciolto nr. 377.
56. G. Perocco, Carpaccio nella Scuola di San Giorgio, p. 212.
57. Filippo Nani Mocenigo, Il testamento del Doge Agostino Barbarigo, "Nuovo Archivio Veneto", n. ser., 17, 1909, pp. 234-261.
58. Per un'ulteriore analisi di alcuni testamenti del secolo XVI v. Federica Ambrosini, Ortodossia cattolica e tracce di eterodossia nei testamenti veneziani del Cinquecento, "Archivio Veneto", ser. V, 136, 1991, pp. 5-64.
59. Su questi ospedali v. F. Semi, Gli "ospizi", pp. 87-95, 103-105, 113-114, 156-157.
60. A.S.V., Notarile, Testamenti, b. 1195, notaio Victor de Rosatis, protocollo, cc. 53v-54.
61. Ibid., b. 190, notaio Girolamo Canal, testamento sciolto nr. 407.
62. Rinaldo Fulin, Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana, "Archivio Veneto", 23, 1882, p. 160 (pp. 84-212, 390-405).
63. Il testamento di Steno è pubblicato in Jacopo Bernardi, Antichi testamenti, VI, Venezia 1887, pp. 26-28. Per le differenze fra i testamenti degli uomini e delle donne v. Dennis Romano, Patricians and Popolani: the Social Foundations of the Venetian Renaissance State, Baltimore 1987 (trad. it. Patrizi e popolani: le società veneziane nel Trecento, Bologna 1993), pp. 119-140.
64. Venezia, Museo Correr, Donà dalle Rose, b. 174, pt. 4, c. 14.
65. A.S.V., Notarile, Testamenti, b. 1195, notaio Victor de Rosatis, testamento sciolto nr. 30; ibid., b. 372, notaio Donati Viti, protocollo, cc. 11v-14, testamento nr. 14.
66. Ibid., b. 192, notaio Girolamo Canal, protocollo, cc. 135v- 137v, testamento nr. 156.
67. Nicola Ivanoff - Pietro Zampetti, Giacomo Negretti detto Palma il Giovane, Bergamo 1980, p. 428.
68. A.S.V., Notarile, Testamenti, b. 595, notaio Giovanni Lombardo, protocollo, c. 17.
69. Ibid., b. 1060, notaio Giovanni Francesco Orso, testamento sciolto nr. 10.
70. Ibid., b. 378, notaio Sebastianus Nasimben, testamento sciolto nr. 2.
71. M. Sanuto, I diarii, VII, coll. 40-41.
72. Francesco Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare [1663], Farnborough 1968, p. 496.
73. Bernard Aikema considera il dipinto come l'emblema della "concezione di carità e assistenza nella prima metà del Cinquecento": Bernard Aikema, L'immagine della "carità veneziana", in Nel regno dei poveri. Arte e storia dei grandi ospedali veneziani in età moderna, 1474-1797, a cura di Id. - Dulcia Meijers, Venezia 1989, pp. 85-88 (pp. 71-98).
74. Capitulare notariorum, pp. 18-20, 51-52, 70.
75. Cassiere della bolla ducale. "Grazie. Novus liber" (1299-1305), a cura di Elena Favaro, Venezia 1962.
76. M. Sanuto, I diarii, VI, col. 7.
77. A.S.V., Compilazioni leggi, b. 196, c. 431.
78. M. Sanuto, I diarii, XXXIV, coll. 58-59.
79. A.S.V., Compilazioni leggi, b. 196, c. 401.
80. Ibid., c. 351r-V.
81. Donald E. Queller, The Venetian Patriciate: Reality versus Myth, Urbana 1986 (trad. it. Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito, Roma 1987), pp. 30-31.
82. A.S.V., Compilazioni leggi, b. 68, cc. 340-344V.
83. F.C. Lane, Andrea Barbarigo, pp. 17-18.
84. A.S.V., Compilazioni leggi, b. 68, cc. 350-351V, 364, 440r-v, 460. V. anche D.E. Queller, The Venetian Patriciate, pp. 34-39.
85. A.S.V., Compilazioni leggi, b. 68, cc. 406, 494-495v.
86. Ibid., b. 196, c. 545r-v.
87. Ibid., cc. 553r-v, 563r-v.
88. Gasparo Contarini, La Republica e i magistrati di Vinegia, Vinegia 1544, c. 66v.
89. A.S.V., Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 19, Novella, c. 97. V. anche B. Pullan, Rich and Poor, pp. 214-215.
90. A.S.V., Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 19, Novella, c. 125V.
91. Ibid., reg. 22, Ursa, c. 19.
92. Ibid., Cassiere della bolla ducale, Mariegola dei poveri al pevere (non numerata), cc. 21V-22, 23-24v
93. Ibid., c. 17.
94. Ibid., c. 36 sinistra e destra.
95. Alessandro Caravia, Il sogno dil Caravia, Venetia 1541, p. I5v. Ho usato una copia conservata a Venezia presso la Biblioteca Nazionale Marciana, segnata Misc. 2477, alla quale è stata aggiunta la numerazione dei fogli.
96. Ibid., p. 13. V. anche B. Pullan, Rich and Poor, pp. 117-121.
97. A.S.V., Compilazioni leggi, b. 196, c. 421.
98. G. Contarini, La Republica, cc. 65v-66.
99. A.S.V., Notarile, Atti, b. 8092, notaio Vettor Maffei, c. 103r-v.
100. V. Richard C. Trexler, Charity and the Defense of Urban Elites in the Italian Communes, in The Rich, the Well Born and the Powerful: Elites and Upper Classes in History, a cura di Frederic Cople Jaher, Urbana 1973, pp. 64-109.
101. Citazione da R.C. Mueller, The Procurators of San Marco, p. 189.
102. Agostino Sagredo, Sulle consorterie delle arti edificative in Venezia, Venezia 1856, pp. 329-330.
103. Venezia, Archivio della Curia Patriarcale, b. n.n. recante l'intestazione Testamenti. Archivio antico (Raccolta di testamenti diversi), cc. 172-173v.
104. Giuseppe Ellero, San Girolamo Miani e i Somaschi all'ospedale dei Derelitti, in AA.VV., San Girolamo Miani e Venezia nel V centenario della nascita, Venezia 1986, p. 44 (pp. 39-54).
105. M. Sanuto, I diarii, XXXIII, col. 562.
106. Ibid., XL, coll. 696-697; v. ibid., XXXVII, coll. 670-671.
107. A.S.V., Compilazioni leggi, b. 309, cc. 471, 473, e b. 196, cc. 191-194, 451. V. anche B. Pullan, Rich and Poor, p. 212.
108. Ibid., pp. 211-215; F. Semi, Gli "ospizi", pp. 113-114.
109. Dulcia Meijers, L'architettura della nuova filantropia, in Nel regno dei poveri. Arte e storia dei grandi ospedali veneziani in età moderna, 1474-1797, a cura di Bernard Aikema - Dulcia Meijers, Venezia 1989, p. 43 (pp. 43-69)
110. B. Pullan, Rich and Poor, p. 215.
111. Ibid., pp. 219, 223.
112. Pubblicato in Pompeo G. Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata, I-III, Trieste 19737:.II, p. 473.
113. M. Sanuto, I diarii, XLVI, col. 380.
114. Ibid., col. 612. V. anche B. Pullan, Rich and Poor, p. 244.
115. B. Pullan, Rich and Poor, pp. 235-237; F. Semi, Gli "ospizi)), pp. 273-274.
116. Carlo Pellegrin, San Girolamo Miani, i Somaschi e la cura degli orfani nel sec. XVI, in AA.VV., San Girolamo Miani e Venezia nel V centenario della nascita, Venezia 1986, pp. 10-11 (pp. 9-38); G. Ellero, San Girolamo Miani, pp. 39-44.
117. Ibid., pp. 40-41.
118. B. Pullan, La nuova filantropia, pp. 31-33.
119. Id., Rich and Poor, p. 236.
120. G. Scarabello, Strutture assistenziali, p. 126.
121. M. Sanuto, I diarii, XLVII, coll. 81-84. V. anche B. Pullan, Rich and Poor, pp. 247-248.
122. A.S.V., Senato, Terra, reg. 1529, CC. 125V-127; ho usato la copia conservata ivi, Compilazioni leggi, b. 309, cc. 507-513. V. anche B. Pullan, Rich and Poor, pp. 252-254.
123. B. Pullan, Rich and Poor, p. 248.
124. Ibid., p. 253.
125. Bronislaw Geremek, La pietà e la forca: storia della miseria e della carità in Europa, Roma 1986, p. 142.
126. B. Pullan, Rich and Poor, p. 254.
127. Ibid., pp. 254-267, 279-286.
128. Robert Finlay, Politics in Renaissance Venice, New
Brunswick 1980 (trad. it. La vita politica nella Venezia del Rinascimento, Milano 1982), pp. 241-251.
129. Ibid., pp. 156-160.
130. Edward Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton, N.J. 1981 (trad. it. Il rituale civico a Venezia nel Rinascimento, Roma 1984), pp. 162-163.
131. M. Sanuto, I diarii, XLVII, col. 81.
132. A.S.V., Compilazioni leggi, b. 309, c. 491.
133. Contemporaneamente, negli anni Trenta del secolo XVI, fu creata una confraternita che si occupava dei "poveri vergognosi": cf. B. Pullan, Rich and Poor, pp. 267-268.
134. A.S.V., Provveditori alla sanità, b. 2, Capitolare I, cc. 50 sinistra-52 sinistra. V. anche B. Pullan, Rich and Poor, pp. 297-309.
135. M. Sanuto, I diarii, XLVI, col. 414.
136. Venezia, Archivio istituzioni di ricovero e di educazione, Der. E, b. 62, fasc. 10, c. 3v.
137. Cf. John BossY, The Counter Reformation and the People of Catholic Europe, "Past and Present", 47, 1970, pp. 52-70.
138. A.S.V., Provveditori alla sanità, b. 2, Capitolare I, c. 52 sinistra e destra.