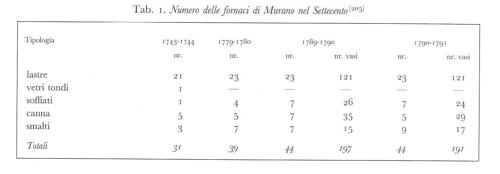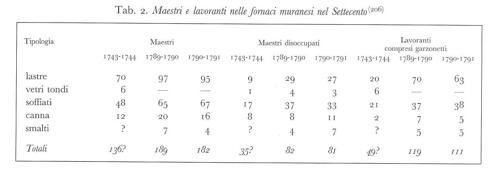L'economia: imprenditoria, corporazioni, lavoro
L'economia: imprenditoria, corporazioni, lavoro
Venezia al centro di uno spazio economico regionale
Oltre la crisi seicentesca
La crisi abbattutasi sul commercio veneziano nei primi decenni del Seicento non aveva trovato possibilità alcuna di soluzione, a causa dei difficili rapporti con il Levante nel corso della lunga guerra di Candia (1645-1669) e dell'affermazione ormai incontrastata delle potenze atlantiche. All'inizio del Settecento Venezia non si trovava più, come ancora un secolo prima, al centro del complesso sistema di scambi che univa l'Oriente al mondo mediterraneo e al cuore dell'Europa. Il ruolo d'intermediazione svolto dall'emporio realtino era divenuto marginale rispetto alle correnti dei grandi traffici internazionali. Ormai subordinata al movimento commerciale che faceva capo alle due sponde della Manica e alla navigazione anglo-olandese, la stessa marineria veneziana si era ridotta a poco più che una funzione di collegamento lungo le coste adriatiche e verso il vicino Oriente (1).
Il ridimensionamento degli scambi aveva portato con sé anche una grave flessione nella produzione manifatturiera cittadina. La principale industria esportatrice, quella della lana, era stata battuta in breccia dalla concorrenza francese e inglese, anche e soprattutto in virtù dei mutati equilibri all'interno dello spazio mediterraneo (2). Alla fine del Seicento i lanifici di Venezia non producevano in media che 2.600 panni all'anno (media 1695-1699) contro la rispettabile quota di 13.200 del quinquennio precedente il conflitto con gli Ottomani. Il centro lagunare non aveva più quella capacità di attrarre manodopera dalla Terraferma, che ancora conservava nei primi decenni del Seicento, perché questo settore un tempo trainante si era contratto in modo davvero impressionante. La tenuta della produzione serica e, forse, l'espansione del commercio delle conterie non avevano potuto compensare del tutto il declino del lanificio, accompagnato da quello della cantieristica e della tipografia.
Era realmente la fine di un modello e di un'epoca. L'economia municipale, centrata sull'esportazione di alcuni prodotti dominanti che godevano del favore di bassi costi transizionali e dei vantaggi offerti dalla posizione strategica dello scalo, aveva cessato di esistere. Da questo punto di vista, la nostra storia potrebbe degnamente iniziare in data 11 gennaio 1719, quando il senato veneziano, allo scopo di "redimere il pregiudicato commercio di questa piazza", decise in via di principio di lasciare libero l'esercizio di tutte le Arti, cioè di affrancare il mondo produttivo e commerciale da quel tipo di vincoli e regolamentazioni che avevano caratterizzato l'economia di una città-stato. Nel Settecento si dipanerà infatti la vicenda del contrastato processo di apertura e di scioglimento delle corporazioni, che verrà portato a termine soltanto in età napoleonica (3).
Ma d'altro lato, una tendenza nuova si veniva enucleando, a partire per lo meno dagli anni Settanta del Seicento. Venezia era pur sempre la capitale di uno Stato per sua natura policentrico, anche dal punto di vista economico. Non solo città come Padova, Verona, Vicenza e Bergamo avevano conservato importanti nuclei produttivi, in particolare nel settore tessile, ma i loro mercanti avevano saputo reagire efficacemente alla crisi seicentesca. Attraverso riconversioni produttive, innovazioni nel prodotto e nei modi di produzione, strategie commerciali spesso anche di ampio respiro, le principali economie urbane della Terraferma veneta potevano presentarsi sullo scorcio del secolo con rinnovate capacità propulsive. È il caso, ad esempio, di Padova: grazie a importanti legami con Venezia e alla dislocazione di alcune produzioni sul territorio, aveva rafforzato il suo nucleo laniero, sia nel campo del tessuto che della maglieria, e si era proposta come leader nella fabbricazione delle passamanerie di seta. I suoi operatori economici, pur mantenendo forti legami con le tintorie e il porto veneziani, agivano autonomamente sui mercati esteri e utilizzavano proprie e originali strategie finanziarie e commerciali (4).
Nella Terraferma veneta, inoltre, almeno dagli ultimi tre decenni del Seicento, un nuovo dinamismo aveva investito una pluralità di centri minori, fino all'embrionale costituzione di poli produttivi specializzati, attorno ai quali ruotava la galassia dei lavoratori a domicilio. È il caso del distretto bassanese della torcitura della seta, dei distretti lanieri della Val Gandino, dell'alto Vicentino e dell'Asolano, delle produzioni di carta attorno a Vittorio Veneto o a nord di Treviso (5). Accanto alle tradizionali lavorazioni per l'autoconsumo delle famiglie contadine, attività industriali più o meno nuove andavano rafforzandosi e si affacciavano sempre più alla ribalta dei mercati internazionali. Il loro sviluppo poteva contare sulla ricostituzione della base demografica nel secondo Seicento e sull'opportunità di sfruttare più intensamente le grandi risorse di energia idraulica e le materie prime disponibili in loco. Queste attività di trasformazione trovavano fuori dei tradizionali centri urbani capacità di espansione e di sviluppo mai prima sperimentate.
Una città come Venezia, nella quale si erano sedimentate grandi potenzialità sotto il profilo delle strategie imprenditoriali, non poteva dal canto suo rimanere inerte di fronte a più generali sollecitazioni di mercato, anche se diverse rispetto al passato. Né, d'altro canto, la posizione del suo ceto politico, per sua natura propenso nonostante tutto a seguire con grande attenzione le dinamiche economiche, era tale da determinare una sottovalutazione, se non l'indifferenza nei confronti di quanto stava accadendo fuori della laguna. Nel Settecento, l'economia urbana restò ancora in parte favorita dal ruolo di Venezia come capitale politica. Il governo continuò a considerare con un occhio di riguardo le possibilità di sviluppo e le problematiche dei diversi comparti (6). Ma Venezia era pur sempre il più importante porto dello Stato e un centro manifatturiero che vantava una grande e antica tradizione in diversi settori.
Come spesso accade, spinte al rinnovamento, resistenze e inerzie, accanto a veri e propri anacronismi, si fusero in un mix originale. La Venezia produttiva del Settecento non si poteva certo identificare solo col suo vasto, variegato e peraltro elastico mondo corporativo. Accanto ad appannati monopoli giuridici, come quello del sapone, e al declino della produzione laniera e delle tintorie, poterono trovare nuovo vigore l'industria tipografica, quella serica e quella chimica e l'industria vetraria conservare il suo alto profilo di vero network plurisecolare. La positiva ripresa del commercio veneziano, pur all'interno della perdita d'importanza relativa rispetto alle nazioni emergenti (7), non è spiegabile senza questa capacità di risposta del settore secondario. Verso la fine del secolo vennero addirittura ad aggiungersi alcune nuove grandi fabbriche, simbolo della persistente vitalità dell'ambiente economico. È il caso della Manifattura Tabacchi, sorta nel 1786 su iniziativa di Girolamo Manfrin, in sostituzione dei vecchi impianti di Cannaregio, o della fabbrica di birra "ad uso d'Inghilterra", aperta nel 1789 nel quartiere di S. Agnese, nei pressi delle Zattere (8).
Spazio regionale e rapporti centro periferia
Lo spazio economico regionale, che si andò sempre meglio delineando nel corso del Settecento, solo parzialmente si sovrapponeva ai confini della Serenissima. Verso nord gli snodi commerciali fondamentali erano le fiere franche di Udine e di Bolzano, veri e propri regolatori dell'interscambio con le aree tedesche e asburgiche tramite i passi del Brennero e di Tarvisio. Le quattro fiere bolzanine, in particolare, muovevano il grande flusso di merci dell'asse economico della vallata dell'Adige, dalle quali, almeno secondo i mercanti veronesi, "tutto comincia e tutto termina sia in specie o in contratto" (9). Sulla grande dogana fluviale di Verona, il terminal più importante dentro lo Stato dopo quello veneziano, convergevano i traffici via terra da e per il centro Europa, con funzioni anche di cerniera con l'area della Lombardia veneta, che dimostrava un'incipiente tendenza all'integrazione col cuore della Padania (10). L'area veneto-friulana restava invece in se stessa più coerente, legata in modo più stretto alla capitale e con essa al Levante e all'Europa nord-orientale. Verso ovest, comunque, il sistema delle due fiere di Bergamo e Brescia, a dispetto dei regolamenti che ne vietavano l'integrazione e l'estensione temporale, collegava la regione con il Milanese, con Genova e con il Tirreno.
Verso est la regione economica faceva perno sui grandi porti di Venezia e Trieste, ufficialmente in posizione antagonistica, ma che dovevano apparire agli occhi degli operatori come complementari. Non mancavano, sul litorale, numerosi altri approdi, grazie ai quali sfuggire ai pedaggi e ai divieti d'importazione ed esportazione. Verso sud, le fiere franche di Zocco (Padova) e i grandi crocevia di Verona e di Venezia funzionavano da centri propulsori dell'interscambio con l'Adriatico, con il Levante e con l'Italia centro-meridionale, collegati all'esterno con altri importanti snodi, come Ancona, Ferrara e Senigallia, e all'interno con i terminals di Chioggia e di Pontelagoscuro sul Po (11).
Per quanto riguarda le attività manifatturiere, esisteva un'ideale linea di demarcazione sull'asse Brescia-Verona-Vicenza-Padova-Treviso, a sud della quale le attività economiche restavano limitate all'agricoltura e alla pastorizia, fatta salva l'eccezione dei telai a domicilio per le passamanerie dislocati sui colli Euganei. Oltre questo asse, che corrisponde all'incirca alla linea delle risorgive, si apriva nell'alta pianura e nella zona collinare e valliva il mondo delle attività manifatturiere. Tutti i poli specializzati, urbani e non, si collocavano in questo "spazio intermedio" tra bassa pianura e montagna, fino a quelli più lontani, a volte al di fuori dei confini politici dello Stato: l'industria metallurgica delle valli bresciane e bergamasche, il polo cartario della riviera salodiana, i distretti serici di Ala, Rovereto e Gorizia, le telerie della Carnia (12). La coerenza del sistema era data dalla forte specializzazione produttiva dei singoli poli, che garantiva tra di essi una virtuale assenza di concorrenza, dagli stretti legami tra imprese al loro interno, dal collegamento infine con i mercati internazionali, sostenuto da un complesso sistema commerciale integrato.
In questo ambito economico regionale, in senso pollardiano, la mobilità dei fattori produttivi e dei prodotti, per quanto riguarda l'industria, divenne via via sempre più forte, all'interno di un secolare processo di riallocazione delle risorse, dato che spesso si trovavano in periferia condizioni più favorevoli rispetto al centro (13). La disponibilità di energia idraulica ed il minor costo della manodopera favorivano maggiormente le cittadine della fascia pedemontana rispetto alle città. L'inerzia riguardo all'adeguamento della legislazione in materia doganale, cui si cercò di ovviare solo negli ultimi anni di vita della Repubblica, e l'apparente particolarismo e frammentarietà degli incentivi e delle facilitazioni, non devono trarre in inganno. Il sistema economico non era più di tipo municipalistico. Una complessa rete di relazioni, d'integrazioni e di gerarchie strutturava già nel Settecento lo spazio economico del Nord-Est italiano.
In questo quadro, il centro lagunare si proponeva sempre come il principale snodo di traffico, e di ciò renderà conto Massimo Costantini in questo stesso volume, e quale complesso centro manifatturiero, come vedremo dettagliatamente in seguito. Ma un altro aspetto specifico furono i rapporti con le manifatture della Terraferma, che si esplicitarono principalmente attraverso due vie non istituzionali: le iniziative dirette del patriziato veneziano e la diffusione del know-how.
Già negli ultimi decenni del Seicento, Venezia funzionò come centro di irradiazione di conoscenze tecniche e di maestranze specializzate. All'inizio del nuovo secolo, uno degli aspetti più evidenti della politica economica dello stesso governo fu proprio lo stimolo fornito all'innovazione in campo tecnologico (14). Ad esempio, i tecnici stranieri chiamati o attirati a Venezia per rianimare il lanificio cittadino portarono le ruote alte da filatura, le prime tecniche per la lavorazione dei cardati e per la tintura mista in lana. Fu da Venezia che partirono i primi tentativi per la produzione di nuovi tipi di tessuto, che trovarono poi terreno fertile nel Vicentino e nel Trevigiano. Una delle figure più interessanti fu Lambert de Micheroux, un tecnico belga, probabilmente un tintore, che venne assunto nel 1722 da una compagnia finanziata da nobili veneziani per dirigere una grande manifattura accentrata dislocata a Treviso, un'iniziativa che purtroppo non ebbe fortuna. Negli anni Trenta il Micheroux si trasferì a Pieve di Soligo e più tardi a Follina, dove diventò titolare di un lanificio per i "panni ad uso estero". Ancora più evidente questo legame tra nobiltà veneziana, innovazione e Terraferma veneta nel caso ben noto di Niccolò Tron, che fondò un lanificio prima a Schio (1718) e poi anch'egli a Follina verso il I740 (15). Egli chiamò al suo servizio manodopera specializzata inglese e poi nel 1766 quel Jean-Pierre Douarche, nativo di Lodève in Linguadoca, al quale va ascritto il merito di aver portato la navetta volante nel Veneto, oltre ad altre innovazioni tecniche nel campo della rifinitura dei panni. Negli anni Ottanta, infine, è la volta del burbero e inflessibile Thomas Bamford, un tecnico dello Yorkshire chiamato dal senato veneziano a proporre innovazioni organizzative e tecniche per i lanifici nazionali e al quale venne offerto, senza successo, di dirigere una grande fabbrica prima a Vicenza e poi di nuovo a Follina. Il vento di rinnovamento, se non riuscì mai a rianimare il lanificio di Venezia, diede l'abbrivo a una grande stagione della produzione laniera nella Terraferma veneta, in un movimento espansivo che durò fino agli anni della dominazione napoleonica (16).
L'intervento diretto del capitale nobiliare veneziano era inoltre ben evidente, addirittura fin dal primo Seicento, nelle cartiere del territorio trevigiano, dove alla proprietà degli impianti si associavano forme di finanziamento e a volte di controllo diretto sulle imprese (17). L'interesse del capitale veneziano si rivolse anche agli "edifici da orsoglio", ossia i grandi impianti a energia idraulica per la torcitura della seta, sia nella zona di Bassano che nel Trevigiano e nel Friuli. I rapporti con le industrie della Terraferma non si esaurivano certo con la proprietà degli impianti, che nella maggior parte dei casi venivano locati ai gestori delle diverse imprese. I legami commerciali e gli interessi comuni tra Venezia e la Terraferma creavano reti di relazioni, che in certi casi assumevano un volto strutturale. È il caso delle tintorie veneziane, che all'inizio del Settecento lavoravano quasi tutti i pannilana tessuti a Padova e destinati al Levante. Il legame fra ambiente industriale veneziano e padovano è ben testimoniato dal privilegio per la tintura in nero concesso nel 1713 al tintore padovano Alessandro Ceroldi. Il finanziatore dell'impresa era il mercante veneziano Gabriele Borlandi, il quale era riuscito a strappare il segreto per la tintura al tecnico fiammingo Pietro Comans (18). Viceversa, il mercante di Crespano Michele Melchiori divenne nel secondo decennio del secolo prima presidente dei drappieri e poi gastaldo della camera del purgo di Venezia. Egli poté aprire bottega in città, come fecero nel 1750 i tipografi Remondini di Bassano in Merceria o come il Lischiuta nel 1754 per le sue tele di lino e cotone, per lo più lavorate fuori Venezia (19).
Questa tendenza degli operatori economici a muovere dalla periferia per accedere alla capitale mi sembra una delle caratteristiche più interessanti del clima economico veneziano del Settecento. Evidentemente, rimaneva molto importante poter contare su di una propria filiale nella Dominante e, almeno in alcuni casi, riuscire ad emergere nell'ambito delle strutture istituzionali delle corporazioni cittadine. Resta ancora da chiarire, peraltro, la reale partecipazione del capitale veneziano, in particolare di provenienza nobiliare, in molte imprese industriali e commerciali della Terraferma, oltre che della stessa Venezia. L'invito di Andrea Tron alla classe dirigente, contenuto in un famoso discorso del maggio del 1784, era quello ad impegnarsi nel commercio e nell'industria, al fine di escludere da cose di tanto interesse pubblico e privato la "gente volgare" (20). Allo stato attuale delle nostre conoscenze, non possiamo far altro che chiederci se questo atteggiamento conservatore e un po' nostalgico non facesse che nascondere un reale scontro in atto tra un certo tradizionale paternalismo e la logica del "procacciarsi un particolare vantaggio" (Tron), ossia la pura logica del profitto. Uno scontro tra nobiltà e ceti borghesi, che forse è rimasto finora nascosto nelle pieghe del linguaggio elusivo delle carte di Stato, oltre che negli atti notarili e nelle scritture di società, il cui esame potrebbe aprire prospettive diverse sui movimenti di capitale nel campo delle attività manifatturiere.
La politica economica tra mercantilismo e liberismo
La legittimità di un approccio regionale nel campo dell'analisi delle attività manifatturiere mi sembra ben confermata da alcune significative aperture del governo veneziano tra la fine del Seicento e il primo Settecento. La prospettiva mercantilista, che guardava all'attivo della bilancia commerciale come al principale fattore di potenza e solidità dello Stato, venne adottata con la chiara consapevolezza che lo sviluppo delle attività della Terraferma non poteva più essere considerato come un ostacolo agli interessi della città. È il caso nel 1670 del permesso di esportazione della seta torta, dal 1673 in esenzione di dazio, che contribuì certamente alla grande espansione del settore (21). Nel 1 711 fu la volta del permesso di fabbricazione dei tessuti di lana "ad uso estero", con la sola riserva dell'utilizzo delle lane spagnole di miglior qualità, che ormai non venivano quasi più usate, ai lanifici veneziani. Nel 1712 e poi nel 1737 fu il turno delle riforme fiscali sulla trattura della seta, la cui semplificazione contribuì al grande progresso della gelsibachicoltura, pur implicando un'oggettiva diminuzione del gettito erariale. Tra il 1725 e il 1727 venne liberalizzato e unificato il mercato delle materie prime per l'industria cartaria ed esonerata dai dazi interni la carta destinata all'esportazione. Nel 1725 Giacomo Linussio ottenne le prime agevolazioni per la sua attività di fabbricazione delle telerie in Carnia, a cui arrise poi uno spettacolare successo. Nel 1727 privilegi consimili vennero decretati a favore dei fratelli Boschetti, ossia i gestori della manifattura laniera di Niccolò Tron a Schio (22). Questi e altri provvedimenti ebbero certo carattere particolaristico, mirante più spesso ad andare incontro a specifici interessi dei singoli mercanti o di gruppi di pressione, piuttosto che a rispondere a criteri di massimizzazione del reddito nazionale. Tuttavia, non si può più parlare per questo periodo di una legislazione tesa esclusivamente a favorire le industrie della Dominante. Peraltro, il ceto dirigente veneziano non poteva utilizzare strumenti di lettura e d'intervento sulla realtà economica che erano ben lontani dall'essere stati messi a punto nell'intera Europa. La vera questione riguarda piuttosto la prassi dell'intervento pubblico in campo industriale. Quanto si può considerare oggi frutto di eccezione e quanto di consapevole accoglimento delle mutate esigenze?
Al pragmatismo di fondo si aggiunsero, nella seconda metà del secolo, il dibattito e il confronto scaturiti dalla penetrazione delle nuove idee fisiocratiche e liberiste. Partita nel 1775, la discussione sull'unificazione del mercato nazionale fu certamente il punto più alto raggiunto in sede di confronto teorico. La completa abolizione delle dogane interne avvenuta nel 1794, accompagnata dalla libera uscita di tutti i manufatti nazionali e dalla revoca di tutti i provvedimenti speciali in materia, dimostra se non altro che nel suo ultimo secolo di vita il governo della Serenissima aveva compiuto un percorso di rielaborazione e di ridefinizione dell'intervento pubblico in economia che andò molto oltre i semplici aggiustamenti ed eccezioni. A posteriori, è fin troppo facile dire che si arrivò con ritardo. Ma bisogna riconoscere che gli altri Stati europei poco avevano fatto di meglio sulla strada che poteva portare alla libertà di commercio. È preferibile, piuttosto che limitarsi a giudicare con il senno di poi, affidarsi di più ai fatti, alle tappe di una lunga rielaborazione nelle linee di politica economica dello Stato veneto.
Fino al 1720 circa, le nuove disposizioni legislative riguardarono in generale i divieti d'importazione di merci concorrenziali a quelle fabbricate nello Stato e i tentativi, per converso, d'imitare le produzioni straniere più in voga. Nella prima delle due direzioni, non si fece altro che proseguire con più coerenza in un'opera che già era stata intrapresa fin dai primi decenni del Seicento. Di decreto in decreto, per i tessuti di lana si arrivò nel 1712 alla "proibizione universale" di tutte le importazioni. Per quelli di seta non si fece che ribadire il divieto generale già operante da tempo. Altre proibizioni "universali" continuarono ad essere applicate nel settore della vetreria. Ma una volta raggiunto l'apice della legislazione protezionista, si fece subito strada il dubbio se non fosse meglio introdurre delle tariffe doganali in grado di operare in maniera selettiva sulle importazioni, piuttosto che lasciare di fatto campo libero al contrabbando. Nel settore delle produzioni laniere il quesito venne sollevato dal senato già nel 1722, anche se poi la linea "proibizionista" prevalse fino al 1788. Ciononostante, fino alla fine degli anni Ottanta del secolo, l'iterazione di decreti e proclami sulle merci proibite continuò di pari passo alla loro palese e riconosciuta inosservanza: "bando effimero offende la pubblica dignità, nuoce a molti, non giova ad alcuno", scrivevano gli inquisitori in Terraferma nel 1772 (23).
Di fatto, l'interesse del commercio, soprattutto nel campo della moda, era in aperta contraddizione con quello dello sviluppo dell'industria protetta. Erano "l'uso e il lusso" del secolo, scrivevano i rivenditori (marzeri) veneziani nel 1711, a determinare il successo delle manifatture (24). E il deficitario sistema di controllo doganale della Repubblica, la cui inefficacia veniva unanimemente riconosciuta, non faceva che favorire un regime di contrastata, ma sostanziale, libertà di commercio. La legislazione proibitiva non rimase sempre e dappertutto lettera morta, ma inoltrandosi nel secolo si ha l'impressione che una sorta di tacita e larga tolleranza divenisse del tutto prevalente, a mano a mano forse che ci si accorgeva dell'inanità degli sforzi prodotti. Né a molto servirono, in materia di repressione del contrabbando, gli interventi dei "servizi segreti" veneziani e i continui richiami alla vigilanza diretti alle autorità di Terraferma, ai conduttori dei dazi e ai controllori delle dogane (25).
Di carattere più concreto furono certamente i provvedimenti volti a introdurre nuove produzioni, che di solito rispondevano alla stessa utopia di escludere dal mercato i prodotti stranieri. Privative, incentivi, esenzioni piovvero a più riprese soprattutto sul settore tessile, ma coinvolsero ad esempio anche la chimica e la vetreria per l'imitazione del cristallo boemo (26). Ben di rado gli stimoli al rinnovamento, che partirono quasi sempre proprio da Venezia, giunsero a buon fine. Ma gli effetti di questo aspetto della politica economica veneziana si ebbero molto spesso a lungo termine, nella crescita di capacità tecniche e imprenditoriali, grazie a percorsi e con esiti a volte molto lontani da quelli immaginati. Un esempio per tutti. Il fiammingo Pietro Comans arrivò in laguna, assieme ad altri quattordici operai, grazie all'interessamento dell'ambasciata di Londra, per fabbricare "saghie" di lana sul modello olandese. Nel 1683 si trasferì a Follina al servizio della ditta Fada-Bortolotti, l'azienda che ebbe il merito di avviare nella Valmarino la produzione laniera in grande stile. Grazie a questo stimolo, si sviluppò un'attività che doveva risultare ancora fiorente in pieno Ottocento. Il ritorno del Comans a Venezia nel 1697 coincise, infine, con gli ultimi tentativi di rianimare seriamente la produzione cittadina (27).
Lo strumento della privativa, intesa come esclusiva riguardante un certo tipo di produzione, estesa alla totalità o a una parte del territorio dello Stato, era certo legato a una concezione che ancora guardava al modello di produzione urbana regolamentata. L'assenza di concorrenza interna doveva cioè favorire il decollo di produzioni considerate strategiche sui mercati internazionali. La sua scarsa utilità sul piano generale venne però ben presto in luce, già nel 1711 per quel che riguarda i tessuti di lana "ad uso estero". Le controversie giudiziarie, che sembravano dover seguire quasi di necessità questo tipo di privilegio, ne sconsigliarono a un certo punto l'adozione. Dopo la metà del Settecento, ben di rado le magistrature veneziane ricorsero a questo strumento: un'implicita ammissione che provvedimenti di questo genere non avevano possibilità di concreta incidenza, soprattutto di fronte a un mercato del lavoro di fatto aperto. Troppo facile risultava infatti sottrarre la manodopera specializzata, iniziare produzioni identiche sotto classificazioni merceologiche diverse, provare più o meno pretestuosamente che il diritto di esclusiva era illegittimo perché qualcun altro aveva precedentemente fabbricato le stesse merci. In vicende di questo tipo vennero invischiate alcune delle più importanti imprese settecentesche, come quella del Tron a Schio o quella di Linussio a Tolmezzo. Ma nello stesso ambiente lagunare si faticava, spesso inutilmente, per garantire in questo modo possibilità di sviluppo a singole iniziative. Nella città che era giunta per prima a legiferare in materia di brevetti, fare rispettare un'esclusiva di produzione risultò nel Settecento un'impresa assai ardua (28).
Fu, invece, quello dell'esenzione dai dazi lo strumento più efficace dell'intervento statale. Sulla carta, tutte le attività manifatturiere soffrivano del peso di un'imposizione indiretta che per le complesse modalità delle diverse riscossioni invitava apertamente gli operatori ad adottare sistemi illegali. Ad esempio, nel 1780 un panno prodotto a Padova e destinato ad essere venduto a Bergamo doveva pagare prima il "dazio bollo" (imposta di fabbricazione), poi il dazio Stadella per il transito ed infine il dazio d'ingresso a Bergamo per un totale di spesa pari al 16,5% del prezzo di vendita (29). Passare indenni al vaglio delle diverse dogane dello Stato significava scendere a patti con i daziali, spesso accordandosi per cifre prefissate, affidarsi a spedizionieri specializzati quanto collusi con sbirri e contrabbandieri, rischiare sequestri e controlli sulle merci in virtù vuoi dei complicati meccanismi burocratici di riscontro, vuoi di una legislazione difforme da piazza a piazza e non sempre di chiara interpretazione. Il farraginoso sistema dei dazi e delle dogane interne andava a incidere, a volte pesantemente, sia sul costo globale del prodotto, sia sulla velocità e sicurezza nella circolazione delle merci.
Il sistema legale delle fiere franche, spesso concesso per punti nevralgici come Bergamo o Udine, consentiva innanzi tutto di evitare i dazi di ingresso, di uscita o di transito per alcune importanti piazze della Terraferma. Il fatto che la loro durata fosse limitata nel tempo non impediva di trovare il modo di contrattare il diritto di fiera per ottenere un accordo di durata annuale con i daziali, com'è ben documentato nel caso di Bergamo (30). Pur avendo come sola finalità quella di facilitare gli scambi internazionali, questo meccanismo finiva per incidere positivamente sul costo dei prodotti e ne semplificava le spedizioni.
Ma più interessanti ancora erano, sul piano generale, le esenzioni concesse per taluni tipi di merce, come nel caso della carta destinata all'esportazione. Alcune di queste facilitazioni non riguardavano le imposte indirette, ma altri particolari diritti di signoria, come già dal 1634 l'esenzione per la concessione delle acque per i filatoi da seta "alla bolognese" (31). Un'altra via, che appare tipicamente settecentesca, fu quella dell'assunzione di particolari imposte da parte degli stessi mercanti-imprenditori, che diventarono per questa via gli esattori di se medesimi. Un ottimo esempio si ebbe a Verona, dove attorno al 1720 i mercanti cittadini ottennero l'appalto delle imposte sulle lane, sulle sete lavorate e sui panni, assicurando allo Stato un gettito più elevato e contemporaneamente riuscendo a ripartire meglio all'interno della consorteria mercantile gli oneri relativi, tanto che l'imposta ad valorem sui prodotti poté subire sensibili diminuzioni. A questa iniziativa venne attribuito il merito della veloce ripresa del settore tessile veronese e addirittura l'aumento di quasi quattromila abitanti registrato tra il 1715 e il 1725 (32).
La via maestra di un nuovo corso in materia doganale fu però quella delle esenzioni concesse alle singole ditte, un tipo d'intervento che è stato spesso considerato come un meccanismo di distorsione del mercato. In realtà, partendo dal privilegio daziario come incentivo all'imitazione di prodotti d'importazione, passando attraverso le timide concessioni dei primi decenni del secolo, si giunse dopo il 1750 ad elaborare un modello d'intervento che prevedeva la completa defiscalizzazione del prodotto finito e spesso anche delle materie prime più importanti. Il settore laniero fu forse il più coinvolto in questo processo. Entro il 1770 già una quarantina di ditte, vicentine, veronesi e trevigiane, potevano contare su questi vantaggi. Negli anni Ottanta, tutti i lanifici nazionali, ad eccezione dei padovani, non erano più gravati da imposte di fabbricazione, né ostacolati dal regime doganale interno. Uno strumento nato dalla concezione mercantilista della "guerra d'industria" finì, anche per altri settori produttivi, per costituire una prassi standardizzata in grado di trasformarsi in un valido strumento di sviluppo. Di ciò erano consapevoli le magistrature veneziane, che arrivarono ad asserire che l'ovvia decurtazione del gettito fiscale sarebbe risultata più che compensata dal maggiore gettito dei dazi di consumo che l'aumento complessivo del reddito prodotto avrebbe comportato (33). L'assenza di una formulazione teorica di questi indirizzi di politica economica non deve distogliere l'attenzione dal loro significato eminentemente liberista, soprattutto se consideriamo la scarsa incidenza delle barriere doganali verso l'estero. Insomma, nella seconda metà del Settecento, l'unificazione del mercato su scala regionale appariva, grazie anche a questi provvedimenti, molto più avanzata rispetto a ciò che la legislazione generale lasciava trasparire. La concorrenza su scala internazionale era nei fatti estremamente libera: un'economia molto più "aperta" di quanto si è spesso supposto.
In negativo, la controprova è forse costituita dagli effetti deludenti di uno dei più classici strumenti del mercantilismo, ossia i premi all'esportazione. Erogati per le "londrine seconde" ad imitazione dei tessuti di lana francesi, delle porcellane su modello inglese, dei cristalli ad uso di Boemia, gli incentivi all'esportazione non riuscirono mai a raggiungere lo scopo prefissato. Gli effetti degli esborsi della "cassa donativi", istituita presso i cinque savi alla mercanzia nel 1754, non furono mai tali da consentire il decollo di produzioni in grado di contrastare seriamente i più diretti concorrenti sui mercati internazionali. Osservatori non sprovveduti, come quel Gabriele Marcello cui dobbiamo la sintesi forse più completa delle attività industriali dello Stato (1767), sottolinearono il carattere, questa volta sì, velleitario e nostalgico di questi interventibi (34).
Il sistema delle Arti
L'articolazione di un sistema polifunzionale
Il mondo delle Arti veneziane, l'organizzazione corporativa del sistema produttivo e commerciale cittadino, si presentava nel Settecento con alcune caratteristiche particolari. Innanzi tutto, esso aveva conservato nei secoli una pretesa pervasività nell'inquadramento della forza lavoro per quel che riguardava il ceto dei popolani, ossia dell'ordine che non godeva di alcuna particolare prerogativa. Ad esclusione dei grandi mercanti internazionali, che s'identificarono fin da principio con lo stesso ceto di governo della Repubblica, della burocrazia di Stato, degli avvocati, dei notai, dei servitori e di alcuni mestieri ambulanti di scarso peso economico, l'intero mondo del lavoro cittadino era istituzionalmente legato ai corpi d'Arte. Già assai numerose nel XIV secolo, le corporazioni veneziane erano un centinaio nel Quattrocento e raggiunsero la cifra record (per Venezia e per l'Italia) dei centoquarantadue corpi di mestiere censiti nel 1773. Nel Settecento, la cifra di trenta-trentacinquemila persone regolarmente iscritte alle corporazioni rappresentava circa il 20% della popolazione residente e circa la metà della popolazione attiva (35). Lo sforzo teso alla regolamentazione e alla ridefinizione dei rapporti sociali ed economici continuò per tutta l'età moderna, fin sullo scorcio del Settecento, finendo per incrociarsi e in parte confondersi con i progetti di ridimensionamento del mondo corporativo della seconda parte del secolo. Fra le Arti veneziane spiccavano quelle antiche della cantieristica, come i calafati e i marangoni dell'Arsenale o i vari mestieri dell'edilizia, quelle altrettanto numerose del sempre attivo ramo tessile, quelle della vetreria, quelle cinquecentesche della stampa e dell'editoria. Ma accanto a quelle che si presentavano come grandi costellazioni di un mercato del lavoro regolato, apparivano numerose le associazioni del commercio al minuto (dai fioreri agli erbaroli ai forneri), dell'artigianato vero e proprio (barretteri, cappelleri, intagliatori, sartori, calegheri, ecc.), dei diversi servizi (ad esempio: chirurghi, senseri, osti). La complessa articolazione del sistema delle Arti rispondeva a un principio forse non molto dissimile da quello che aveva guidato e continuava a guidare in pieno Settecento la strutturazione dell'assetto costituzionale dello Stato. La giustapposizione e l'accumulazione degli istituti, la parcellizzazione degli scopi e delle funzioni sembravano assurgere ad unica risposta possibile nei confronti della crescente complessità del sociale e della diversificazione delle funzioni, fenomeni a cui la capitale si trovò a rispondere nel corso di tutta l'età moderna.
In secondo luogo, le Arti veneziane restarono sempre escluse dalla sfera prettamente politica. Contrariamente a quanto accadde in altri centri urbani italiani, prima di tutto a Firenze, le associazioni di mestiere furono fin da subito a Venezia sottoposte al controllo e alla vigilanza degli organi dello Stato, di uno Stato che tra l'altro si presentò dominato da una grande oligarchia finanziaria e mercantile. Questo limite invalicabile della sfera di azione delle corporazioni era ben rappresentato dall'obbligo che atti e statuti sottostessero al vaglio degli organi dello Stato. Giustizia vecchia e nuova, provveditori di comun, censori, cinque savi alla mercanzia, addirittura il consiglio dei dieci furono solo alcune delle numerose e diversamente collocabili magistrature che avevano competenza sulle corporazioni. Nel Settecento, con il solito processo di accumulo, si aggiunsero alle magistrature ordinarie quelle create appositamente per attuare progetti di riforma e riorganizzazione, come l'inquisitore alle Arti o la deputazione alle Arti. Un solo esempio: l'Arte degli scaletteri, i venditori di ciambelle, che contava nel 1773 la bellezza di ottantacinque capimaestri, dipendeva prima di tutto dal magistrato al frumento, ma anche dal magistrato alle biave per il consumo della farina e dal collegio della milizia da mar, come tutte le altre Arti, per l'imposizione fiscale. Grazie a questo stretto controllo, le strategie, anche particolari, di politica economica sfuggivano all'autonomia dei corpi di mestiere, per essere delineate direttamente dai massimi livelli istituzionali, molto spesso il senato per il tramite delle diverse magistrature. Alle Arti restava però sempre aperta la via della contrattazione, della proposta, della mediazione. Lo Stato veneziano fu sempre attento a che l'aspetto dirigistico in questa sfera d'azione si confondesse con un rapporto paternalistico, con il buon senso e l'empiria di uno Stato inteso come grande mercante-imprenditore. Tuttavia, mi sembra illuminante che lo strumento della supplica, tipico segno di un rapporto di subordinazione, restasse l'unico modo per le corporazioni di iniziare un dialogo con le istituzioni e che non pochi tra i contrasti e le controversie trovassero modo di definirsi solo all'interno dei tribunali ordinari dello Stato.
Un terzo elemento originale, che contribuiva a rendere molto più mosso il quadro, è il fatto che le funzioni svolte dalle Arti veneziane s'integravano con quelle di tipo assistenziale, previdenziale e devozionale delle confraternite laiche, in particolare delle Scuole d'Arti e mestieri, organismi autonomi eppure correlati ai relativi corpi (36). Strumenti di organizzazione del consenso o, se si preferisce, di partecipazione alla vita associata, in questa direzione le corporazioni andavano ben oltre la loro funzione di trasmissione ereditaria del mestiere e di stabilizzazione del sistema della produzione e della distribuzione. Attraverso questa via il capomaestro o il lavorante potevano trovarsi partecipi di più complesse articolazioni del sociale, considerato anche che l'appartenenza al mestiere non impediva l'iscrizione ad altre Scuole e confraternite. La riconoscibilità e, direi, la "rispettabilità" derivanti dall'inquadramento nel corpo offrivano dunque la possibilità di avvalersi di una rete di relazioni e di protezioni, anche a prescindere dagli specifici sussidi in caso di malattia o di morte. Tutto questo, senza considerare che il patrimonio accumulato nel tempo dalle Scuole d'Arti rappresentava forse un'autonoma possibilità di sfruttamento economico e di carriera individuale, oltre che una garanzia rispetto agli scopi istituzionali delle Scuole medesime. Da questo punto di vista, è significativo che nella prima metà del Settecento alcune tra le Scuole d'Arti e mestieri, come altre Scuole veneziane, divenissero di fatto intermediarie del debito pubblico, attraverso i cosiddetti capitali instrumentati. Esse anticiparono allo Stato somme ingenti, reperendo i capitali necessari in parte smobilizzando il loro patrimonio e in parte offrendo agli associati la possibilità di sottoscrivere quote di prestiti fruttiferi. La facile trasferibilità di queste quote diede luogo a un meccanismo abbastanza simile all'attuale sistema del debito pubblico, fino a quando nel 1753 lo Stato mise in atto un piano di ammortamento (37).
Infine, non di poco conto era la funzione di sostituto d'imposta che le corporazioni esercitavano per conto dello Stato. I due tributi fondamentali, la tansa insensibile e il taglione si definirono entro la prima metà del Seicento ed erano commisurati alla consistenza economica e numerica di ciascuna Arte, che provvedeva poi a ripartirne il carico tra i propri membri. Alla fine del Settecento il mondo corporativo contribuiva direttamente, con 45-50.000 ducati all'anno, per oltre 1'8% del totale delle imposte della capitale (38). Istituzioni di tipo amministrativo, per questa via le Arti accumulavano spesso debiti d'imposta, aspetto che poteva diventare assai evidente nel caso di una crisi produttiva. L'indebitamento venne in alcuni casi aggravato dal ricorso, autorizzato dallo Stato, a grossi prestiti per far fronte con la distribuzione di sussidi ai momenti di grave disoccupazione. Ad esempio, le tre Arti laniere dei tessitori, cimatori e laneri si trovavano nel 1753 ad essere ancora debitrici complessivamente per 139.900 ducati in linea capitale e 56.000 ducati d'interessi, a causa di debiti contratti negli anni della guerra di Candia, che corrisposero anche al momento di definitiva smobilitazione del lanificio cittadino (39). Nel 1773, le tre Arti risultarono sempre debitrici per la consistente cifra di 232.920 ducati tra capitali passivi e interessi, oltre ai 1.821 ducati per imposte non corrisposte da parte dei laneri. Gli stessi progetti di riforma o di soppressione dei corpi di mestiere si scontrarono con questa spinosa realtà. A ciò si aggiungevano gli inviamenti delle botteghe, ossia il valore attribuito alla concessione dell'esercizio commerciale, laddove esisteva. Si trattava, dunque, di un ottimo presupposto a che il governo considerasse con particolare attenzione l'opportunità di conservare la personalità giuridica, almeno di alcune corporazioni e non delle meno importanti. L'Arte dei tessitori di seta, che comprendeva nel 1773 ben seimilatrecentoquarantaquattro persone, aveva un debito verso lo Stato di quasi 3.400 ducati e capitali passivi per un totale di 30.805 ducati.
Quello delle Arti veneziane era dunque un sistema polifunzionale, difficilmente riducibile entro la sfera squisitamente economica. Gli interessi collegabili al suo mantenimento erano molteplici e non sempre facilmente identificabili. Semplificando, potremmo dire che lo Stato vi riponeva un'attenzione di natura fiscale, amministrativa e, nel contempo, di carattere politico per quel che riguarda il mantenimento di un ordine consuetudinario, percepito come "naturale" e legittimo. Le famiglie popolane godevano all'interno delle Arti di una garanzia soprattutto per la trasmissione ereditaria del mestiere, base per una continuità della casata famigliare che spesso non poteva contare su elementi di tipo patrimoniale. Infine, l'individuo poteva contare sulla sicurezza che il sistema gli garantiva a vario titolo, ma anche sulle possibilità che la vita associata gli offriva in termini di alleanze e di opportunità di sfruttare capacità a volte diverse da quella dell'esercizio effettivo del mestiere. Sistema conservatore certo, nelle linee che ne avevano informato il senso e lo sviluppo, tuttavia non incapace di rispondere agli stimoli del mercato e di piegarsi ad adattamenti che, come vedremo per alcuni casi evidenti, consentirono alla città di continuare a proporsi nel Settecento come un vero e proprio distretto manifatturiero.
È a causa di questa complessità che lo sforzo tassonomico di classificare le diverse Arti in base al loro significato economico poté nel corso del secolo assumere aspetti differenti. Nella rilevazione del 1773, le corporazioni vennero censite in base alla clientela di riferimento: sessantuno Arti che operavano sia per il consumo interno che per il commercio estero (ad esempio, le varie categorie di tessitori), trentanove che operavano per il solo mercato cittadino (dai parrucchieri ai calzolai, ma anche i segatori dell'Arsenale o i fabbricanti di remi), diciassette Arti meccaniche (travasatori di vino e di olio, muratori, facchini, ecc.), ventuno Arti di vittuaria (osti, fornai, fruttaroli e così via), quattro corpi non meglio definiti, come i suonatori. Altre suddivisioni erano però possibili. Nel 1719 le Arti vennero definite in tre classi: vittuarie, meccaniche, manifatturiere; nel 1754 in: fabbricatori e venditori; nel 1759 in: di sola industria (dove per industria s'intende il lavoro), d'industria e capitali, di soli capitali propri o altrui; nel 1772 in: commestibili e manifattura (suddivise nel mercato interno e commercio), preludio alla classificazione del 1773. Alla fine del secolo, Apollonio del Senno optò per un quadro più articolato: diciotto Arti di vittuaria, trenta Arti manifattrici di consumo, quarantatré Arti manifattrici di consumo e di commercio, sedici Arti di meccanismo, sette professioni diverse (40). Tutte insoddisfacenti, tutte comunque pregnanti, le tassonomie delle Arti dipendevano in fin dei conti dall'ottica da cui si guardava loro. Nel 1759 l'apparente modernità di un approccio che teneva conto della fondamentale divisione tra capitale e lavoro non era che il preludio per l'ammissione alle Arti formate da soli lavoratori di manodopera proveniente da fuori Venezia, come poi statuì il decreto del 22 marzo dello stesso anno (41). Non si trattava neppure di una novità, dato che l'Arte dei laneri, gli addetti alle operazioni di preparazione della materia prima per i tessuti di lana, i ciompi di Venezia, era da sempre un'Arte talmente "aperta" da non esigere nemmeno l'obbligo d'iscrizione. La scelta cadde sulla liberalizzazione del mercato del lavoro verso il basso e sulla permanenza dell'esclusiva di esercizio del mestiere per il commercio al minuto, l'artigianato e il capitale mercantile.
Ma neppure la linea di demarcazione tra capitale e lavoro rimase stabile nel tempo, perché alla successiva classificazione per destinazione dei beni e dei servizi si accompagnò l'apertura di Arti come gli osti, i merciai, i mercanti di legname, mentre le Arti dei lavoratori del vetro restarono fino alla fine rigorosamente chiuse. Il catalogo delle Arti predisposto da Apollonio del Senno nel 1798-1799 registrò certo gli effetti del contraddittorio riformismo veneziano, ma anche la capacità di resistenza di un sistema troppo complesso per prestarsi a una definizione del tutto razionale e completamente soddisfacente.
Mercato del lavoro e riforma delle Arti
Dal punto di vista dei requisiti per l'ammissione, le Arti di Venezia si distinguevano tradizionalmente in chiuse, cioè riservate ai soli cittadini veneziani, parzialmente aperte, a cui potevano accedere tutti i sudditi veneti, e senz'altro aperte. Esistevano poi ulteriori restrizioni particolari, come il requisito della cittadinanza muranese per l'Arte dei vetrai. La sostanziale rigidità del quadro, garanzia di controllo sul mestiere e in ultima analisi di difesa dei redditi, era stata già più volte scalfita in occasione di particolari momenti di scarsa offerta di forza lavoro. Dopo la grande pestilenza del 1630, ad esempio, provvedimenti temporanei di apertura anche a cittadini stranieri vennero adottati in parecchi settori, onde ripristinare lo stock di manodopera, falcidiata dall'epidemia. Ma in quel caso si era trattato soprattutto di venire incontro alle richieste dei mercanti, preoccupati del forte lievitare delle retribuzioni. Addirittura, nel settore vetrario l'ingresso di manodopera, inizialmente impiegata solo stagionalmente, proveniente dal Friuli e in particolare da Maniago, portò alla costituzione di un nuovo corpo, quello appunto dei friulani, che continuò ad operare in evidente concorrenza con le stesse Arti degli specchieri e dei vetrai muranesi (42). Questi aggiustamenti di natura congiunturale si combinavano con i permessi particolari d'iscrizione alle corporazioni, che le magistrature accordavano facilmente quando si trattava d'introdurre nuovi procedimenti tecnici e nuovi tipi di prodotto. Frutto sempre di contrattazione tra l'interessato o gli interessati, gli organi di controllo e i corpi d'Arte, queste forme di privilegio si moltiplicarono tra fine Seicento e Settecento e a volte si concludevano con la semplice esenzione dall'obbligo d'iscrizione formale alla corporazione di riferimento. Le eccezioni alla norma riguardavano, in questo caso, interessi e propositi a volte molto diversi. Un conto era l'ammissione all'Arte della stampa veneziana dei tipografi Remondini di Bassano, titolari di una delle aziende più ricche e di più ampio respiro dell'intero Stato, un altro il permesso accordato nel 1697 al fiammingo Pietro Comans di portare a Venezia sedici operai tessili che avevano lavorato con lui a Follina e d'istruire nuove filatrici all'interno degli ospizi cittadini. Di qualsiasi natura fossero spinte e finalità, di certo le Arti interessate opponevano sempre le loro ragioni, esigevano comunque di essere criticamente partecipi delle decisioni governative, contrastandole a tratti nella forma e soprattutto nei fatti. Ostacoli al rinnovamento, custodi del privilegio, zavorra del Medioevo: forse; ma in ogni caso le Arti ben rispondevano al loro compito di tutela del lavoro, in un mondo che (ricordiamoci sempre) non possedeva una legislazione specifica in materia. D'altro canto, il risultato più frequente che gli organismi corporativi riuscivano a spuntare era quello di mitigare gli effetti dell'impatto di nuovi concorrenti sul mercato del lavoro cittadino.
La tendenza di fondo espressa dal mondo imprenditoriale fu però, nel corso del Settecento, proprio quella di ampliare l'offerta di forza lavoro, attingendo da manodopera esterna alla città. La situazione generale del mercato interno e internazionale non permetteva più di conservare la competitività delle imprese attraverso l'esclusiva di fabbricazione, il segreto, il monopolio giuridico. Bisognava quindi agire in direzione dell'aumento della produttività del lavoro e del contenimento dei costi delle materie prime, laddove possibile. Una maggiore concorrenza tra i lavoratori veneziani avrebbe contribuito a contenere le retribuzioni e forse anche ad aumentare l'intensità del lavoro. In effetti, il risultato concreto di un riformismo in apparenza contraddittorio, tanto precoce nell'enunciazione quanto timido nelle realizzazioni, fu il frutto più di una mediazione tra gli interessi del mondo imprenditoriale e quelli delle classi subalterne, che di una presunta incertezza o incapacità del ceto di governo. Quest'ultimo, piuttosto incline per sua stessa natura, oltreché spinto dall'oggettiva tendenza dei tempi, ad abbracciare la causa dei mercanti-imprenditori dell'epoca, non poteva peraltro rinunciare del tutto alla sua funzione paternalistica e a conservare il consenso sociale della popolazione della capitale. Fu così che nella seconda metà del secolo il vento riformista dell'Illuminismo d'Oltralpe e nostrano poté ben fornire ottimi argomenti all'urgenza della liberalizzazione del mondo economico (43), senza peraltro poter ribaltare l'ovvia verità che l'abolizione del sistema polifunzionale delle Arti avrebbe provocato dei contraccolpi imprevedibili sull'intero corpo sociale. Lo stesso Marcantonio Dolfin, convinto assertore del fatto che l'apertura delle Arti e il libero esercizio dei mestieri avrebbero permesso una forte ripresa produttiva e favorito l'occupazione, non si spinse fino a chiedere l'abolizione dei corpi. Le loro funzioni amministrative e fiscali, i loro istituti e i loro patrimoni ne consigliavano il mantenimento. Il suo vero obiettivo non era che quello di "aprire almeno quelle tutte che non avessero qualche difficoltà invincibile", laddove alla parola invincibile possiamo associare la più ampia polisemia (44).
Il processo di riforma del sistema delle Arti veneziano, dopo l'enunciazione di principio del 1719, fu dunque denso di dibattiti, studi, realizzazioni, revisioni, pentimenti. Il percorso conoscitivo e tassonomico di cui si è parlato condusse nel 1751 alla necessità di rendere stabile un'apposita magistratura, l'inquisitorato alle Arti, in grado di promuovere e realizzare un programma di riordino, che doveva essere affidato a un unico centro propulsore proprio perché coinvolgeva una pluralità di organi e istituti. Fu così che già nel 1752 si poté procedere all'apertura di alcune Arti, come quelle dei boccaleri e dei venditori di acquavite e allo scioglimento di altre, come quella dei gallineri, peraltro in seguito ripristinata (45).
L'intervento appassionato ma prudente dell'inquisitore Marcantonio Dolfin condusse il senato ad adottare nel marzo del 1754 un nuovo provvedimento quadro, in cui si ribadiva l'impegno di massima riguardo all'apertura delle corporazioni e si affidava allo stesso inquisitore, unitamente ad almeno uno dei componenti delle altre magistrature interessate, la realizzazione degli opportuni interventi. Seguirono quindi altri provvedimenti parziali, fino a quando l'inquisitore Polo Querini non riuscì, con l'individuazione della discriminante capitale/lavoro, a fornire un criterio plausibile per un intervento più generalizzato. Nel marzo del 1759, cinquant'anni dopo l'avvio del processo, vennero così aperte in un solo colpo ben trentatré Arti "di sola industria", cioè i corpi di soli lavoratori manuali, tra i quali spiccavano per numero e importanza i tessitori e i tintori. L'ammissione all'esercizio del mestiere venne dichiarata libera, anche se subordinata al controllo dell'inquisitorato alle Arti e dei savi alla mercanzia; i forestieri vennero esentati per due anni da qualsivoglia carico fiscale, ma vennero obbligati a "tener garzoni nati veneti [=veneziani]".
Nell'aprile del 1772 fu la volta delle quattro importanti e dense relazioni, presentate l'anno successivo, dei tre provveditori alla giustizia vecchia e dei tre giustizieri vecchi, i membri della più antica e più rappresentativa tra le magistrature veneziane in materia di corporazioni. La contraddizione di fondo tra l'opportunità di una complessiva revisione in funzione della nuova realtà economica e i vincoli posti dalle funzioni amministrative, sociali e politiche delle Arti emergeva con chiarezza dalle parole dettate da Andrea Memmo, personaggio che va annoverato tra i più convinti riformatori veneziani (46). Nella sostanza, le nuove proposte si riducevano a sollecitare una più larga estensione dell'apertura delle Arti di manifattura, soprattutto per i settori che apparivano orientati all'esportazione. Per quel che riguardava l'approvvigionamento e il consumo interno, il Memmo riteneva dannosa l'apertura perché le Arti consentivano di evitare monopoli ed incette, permettevano la riscossione delle imposte, garantivano il valore degli avviamenti ed infine allontanavano la "viziosa anarchia" della concorrenza. Grande affresco, non certo a tinte ottimiste, dell'economia nazionale e cittadina, le scritture della giustizia vecchia finivano come sempre per negare solo ai più deboli il diritto di rappresentanza: "Quando gli operai di qualche Arte d'industria son ridotti a pochi, non credono d'aver più bisogno d'esser eccellenti. Padroni del prezzo, non lavorano con assiduità, mentre conoscono che non ostante la loro lentezza e le loro distrazioni troveranno il modo di vivere, alzando il prezzo di tutto ciò che eseguiscono". In questo caso la concorrenza, concorrenza sul mercato del lavoro naturalmente, costituiva il solo rimedio contro il "privilegio", il "perniciosissimo monopolio" esercitato dagli operai veneziani (47). Per loro fortuna, questi ultimi potevano ancora contare sulla vischiosità del sistema decisionale della Repubblica, tanto che il solo effetto dello sforzo di Andrea Memmo fu l'istituzione della deputazione straordinaria alle Arti, di cui lo stesso Memmo fece parte, e che condusse, tra intralci, opposizioni e diatribe, alla ormai famosa "Statistica delle Arti" accompagnata da una corposa relazione prodotta il 6 settembre del 1773.
Il più grande, onesto e coerente sforzo conoscitivo promosso dalla Repubblica finiva però per partorire il classico topolino, con la proposta di soppressione delle due Arti dei sabbioneri (venditori e trasportatori di sabbia) e dei calcineri (venditori di calce), due mestieri sussidiari dell'edilizia che raccoglievano rispettivamente quarantuno e venticinque persone. Dopo alcuni altri parziali aggiustamenti, seguirono i radicali interventi promossi negli anni Ottanta da Andrea Tron sulle Arti del setificio e del lanificio. In pratica, venne sancito il divieto di autonoma organizzazione di mestiere per le attività tessili, mentre restarono in vita gli organi di autogoverno dei mercanti-imprenditori, l'officio seda e la camera del purgo. Pur aperte, ma conservando limiti all'ammissione, queste Arti di mercanti assunsero in via definitiva l'aspetto di consorteria d'affari, capace di esercitare un totale controllo da parte del capitale mercantile sul processo produttivo. Organismi con analoghe caratteristiche esistevano del resto a Padova o Verona già da secoli. Insomma, la soppressione di antiche e importanti corporazioni come i samiteri, i tessitori di seta, non costituiva di per sé un elemento di particolare modernità. Certo, ben poco capitalistico il ritratto che della camera del purgo ci ha lasciato l'ex provveditore di comun Giovanni Battaglia. Nel 1789, il gruppo di persone che la controllava era del tutto estraneo all'industria laniera e difendeva la sua posizione in nome del privilegio di vendita dell'olio residuato dalla purgatura e di piccole operazioni finanziarie, mentre l'Arte perdeva annualmente circa 5.500 lire, oltre ai debiti perenti e alle malversazioni di cassa (48).
Dopo quasi un secolo, il risultato finale dei progetti di riforma del mondo corporativo restò documentato dal prospetto statistico elaborato da Apollonio del Senno nel 1798-1799 e reso pubblico nell'aprile del 1814 (49). Le centoquattordici Arti descritte raccoglievano ancora trentunomilaseicentosessantaquattro lavoratori: trentotto di esse risultavano del tutto aperte, solo diciannove ancora chiuse (tra le quali spiccavano le Arti vetrarie), le rimanenti venivano classificate come "soggette a servitù", il cui accesso cioè era ancora regolamentato da norme sull'apprendistato e la lavoranza. A prescindere dalle proposte di del Senno, che contemplavano un'apertura generalizzata dei corpi di mestiere, proposte che giungevano però dopo gli sconvolgimenti del ventennio rivoluzionario, il documento registrava una situazione ancora una volta complessa. Potremmo quasi dire che alla fine della Repubblica il sistema delle Arti si trovasse nel bel mezzo dell'assedio: mura in buona parte sbrecciate, squarci ormai indifendibili, alcune roccaforti ancora intatte e ancora in grado di opporre resistenza, come di fatto accadde negli anni immediatamente successivi. Le informazioni sulla consistenza economica e patrimoniale delle Arti, infine, evidenziavano quali fossero, fino all'ultimo, le diverse funzioni di questi istituti. Ai depositi in Zecca, agli interessi attivi, censi, canoni e rendite, al valore degli inviamenti delle botteghe, facevano riscontro mutui, livelli, debiti d'imposta. Il solo valore delle concessioni commerciali, in quanto elemento attivo del patrimonio degli esercenti ed essenziale anche come elemento di garanzia dei debiti contratti, veniva stimato in 3 milioni di ducati. "Una fitta rete di rapporti economici e sociali che dimostrava la perdurante vitalità del sistema corporativo e nel contempo ne ritardava l'inesorabile declino, frenando e ostacolando ogni progetto radicalmente innovatore", come ha giustamente concluso Massimo Costantini(5°). A questo bisogna aggiungere che nella realtà dei fatti la libertà del mercato del lavoro, anche quando questo risultava sulla carta rigidamente regolamentato, era nel Settecento ben più ampia di quanto si sia spesso supposto. La drastica diminuzione nel numero complessivo delle registrazioni dei contratti di garzonaggio nel corso del secolo dimostra inequivocabilmente l'avvenuta perdita d'importanza e di significato degli istituti corporativi anche in questa direzione (51).
Gerarchie corporative, imprenditoria e lavoro
La forza lavoro delle corporazioni si distingueva normalmente al suo interno nella suddivisione gerarchica tra garzoni, lavoranti e capimaestri. Salvo che per i figli di questi ultimi, che potevano essere ammessi direttamente al vertice della gerarchia, l'ingresso nell'Arte avveniva appunto attraverso l'apprendistato. L'istituto del garzonaggio era precisamente regolamentato, tanto che la legge vietava l'assunzione dei garzoni prima del compimento del dodicesimo anno d'età, e prescriveva che una copia del contratto di assunzione venisse depositata presso la magistratura della giustizia vecchia. Il relativo fondo archivistico, comprendente il periodo tra il 1575 ed il 1772, non è stato purtroppo ancora adeguatamente sondato, anche a causa delle difficoltà derivanti dalle sue lacune e dall'ordine quasi sempre soltanto cronologico delle registrazioni (52). L'accordo, stipulato tra il capomaestro datore di lavoro e un garante, prevedeva la corresponsione di un compenso, erogato per lo più sotto forma del mantenimento dell'apprendista. La durata minima del tirocinio venne portata alla fine del Seicento da cinque a sette anni. Finito il periodo del garzonaggio, si accedeva al ruolo dei lavoranti, nel quale si doveva sostare per il periodo minimo previsto dagli statuti dell'Arte, anch'esso salito da tre a sei anni (53). Solo a questo punto, spesso ben avanti con l'età, attorno ai trent'anni, il lavoratore poteva aspirare ad accedere al ruolo di maestro, tramite il pagamento di una cifra fissa (benintrada) e l'esecuzione di una prova. In effetti, solo raggiungendo il grado di maestro si entrava a far parte a pieno titolo dell'Arte, ossia si accedeva al Capitolo, l'assemblea generale dei capimaestri, e si poteva essere eletti alle cariche statutarie, di solito la Banca, formata dal gastaldo e dai suoi consiglieri.
Solo poche volte la gerarchia ufficiale del mestiere differiva dallo schema suddetto. Era il caso, ad esempio, dei sensali che venivano nominati direttamente dalle magistrature competenti. O ancora, dell'Arte dei vetrai di Murano, che non conosceva un vero e proprio garzonaggio, dato che col termine di garzoni venivano indicati i lavoranti e con quello di garzonetti gli aiutanti più giovani assunti per mansioni di scarsa rilevanza. Il garzonaggio e la lavoranza avevano la precipua finalità di promuovere una formazione professionale che risultasse funzionale all'esercizio del mestiere. Ossia, il tirocinio obbligatorio nei due gradi doveva assicurare in tutti i campi del commercio, dell'artigianato e dell'industria l'acquisizione di quelle competenze che sole sembravano garantire la qualità del prodotto e/o delle prestazioni, una volta acquisito il grado di maestro. La tutela corporativa doveva, per questa via, esercitarsi come controllo preventivo sulla professionalità dei diversi operatori, strumento di un mercato urbano regolato e di sostegno dell'immagine dei prodotti verso l'esterno.
In realtà, con il garzonaggio e la lavoranza si poteva effettuare un controllo diretto sul mercato del lavoro, stipulare alleanze trasversali ai diversi mestieri e, soprattutto, assicurare continuità alla stirpe grazie alla corsia preferenziale riservata ai figli dei maestri. C'è da essere persuasi che l'iter normale di accesso al mestiere fosse costruito più per evitare l'allargamento dei ranghi della singola Arte che per assicurare la perizia nel lavoro e un'alta qualità dei prodotti. La dimostrazione sta nel fatto che le eccezioni alla norma, cioè le chiusure temporanee del ruolo dei garzoni o, viceversa, le aperture dirette al ruolo dei maestri, non furono affatto infrequenti. Gli istituti del garzonaggio e della lavoranza dovevano quindi garantire un certo equilibrio tra domanda e offerta di forza lavoro o nell'erogazione di servizi. In ultima analisi, l'obiettivo da perseguirsi era quello del sostegno del reddito. Infatti, le corporazioni veneziane riuscirono fino all'ultimo a salvaguardare in linea di principio, se non sempre nei fatti, l'obbligo di pagamento dei salari in moneta, mentre nella Terraferma si ricorreva molto più spesso a pagamenti in natura. Esse riuscirono anche nell'intento di limitare il numero delle licenze commerciali e di far rispettare le distanze prescritte tra botteghe dello stesso genere per evitare forme di esasperata concorrenza.
Il blocco dell'assunzione dei garzoni, com'era avvenuto ad esempio per le Arti di seconda lavorazione del vetro (margariteri, specchieri e perleri) a partire dagli anni Settanta del Seicento, provocava per converso il fenomeno dell'assunzione di manodopera priva di accordo, ossia di contratto, vera e propria forma di lavoro nero corporativo (54). Per questa via si apriva la possibilità di accedere a un mercato di manodopera non specializzata, il cui rapporto di lavoro possedeva quelle caratteristiche di elasticità e di precarietà che proprio il sistema corporativo doveva a tutti gli effetti scongiurare. Di qui alla crescita di laboratori o botteghe autonomi e paralleli a quelli ufficiali il passo era breve. Pertanto, almeno nel Settecento, la gerarchia del mondo corporativo si arricchì di una massa di lavoratori non inquadrati nei ranghi delle Arti, a volte sottoposti a volte no ai maestri delle corporazioni, la cui presenza non venne spesso neppure registrata dalle statistiche. È il caso delle trecento persone che nel 1756 lavoravano specchi di piccole dimensioni al di fuori dell'Arte (55), o dei circa centocinquanta avventizi dell'Arte dei tessitori da fustagni, che affiancavano nel 1780 i cinquantadue capimaestri e i sessantacinque tra lavoranti e garzoni regolarmente iscritti alla corporazione, o dei calzolai che svolgevano abusivamente il lavoro a domicilio (56). I capimaestri margariteri poterono lamentarsi della presenza di donne e "stranieri", lavoratori precari assunti a giornata a titolo di servitori nelle case dei maestri "patroni" (57). Ancora scarsamente studiato, questo fenomeno, analogamente a quanto accadde in altre città europee (58), rese certamente il sistema delle Arti veneziano molto meno rigido, molto più mobile e aperto di quanto le norme statutarie e gli stessi progetti di riforma lasciassero intravedere. Esisteva cioè un'area opaca di lavoro sommerso che integrava e contornava il mondo corporativo e che al suo limite inferiore probabilmente confinava con i mestieri ambulanti, col servidorame, addirittura con la mendicità. La galassia della dequalificazione e sottoccupazione dell'ambiente urbano settecentesco si nutriva soprattutto di donne e immigrati, categorie alle quali restava preclusa anche l'unica vera eredità dei popolani poveri, quella appunto della trasmissione del mestiere (59).
Proprio l'espansione del lavoro femminile mi pare possa essere la spia di una tendenza nei fatti ad un'erosione della tutela del lavoro esercitata dagli istituti corporativi. L'evoluzione del setificio cittadino, che si rivelò formato nel 1783 da milleduecentonovantadue lavoratrici (di cui solo trentadue ufficialmente maestre) e da appena quattrocentoventidue tra maestri e garzoni, costituì un caso esemplare. In tutto il settore tessile veneziano, all'assenza di discriminazioni palesi fino al tardo Cinquecento seguì soprattutto tra il tardo Seicento e i primi del Settecento una legislazione vincolistica, che da un lato evidenziava l'esistenza del fenomeno dell'occupazione femminile e, dall'altro, tendeva a contrastarlo. Nel caso dei tessitori di fustagni, tessuti misti di lino e cotone, il lavoro femminile venne limitato già nel 1596 alle sole vedove e orfane di capimaestri. Ciononostante, nel 1744 operavano una cinquantina di lavoratrici teoricamente non abilitate, destinate ad aumentare fino a duecentoventicinque nel 1788. L'Arte dei fustagneri riuscì a impedire un pieno riconoscimento del lavoro femminile sul piano giuridico, ma non a bloccarne l'utilizzo perché esso garantiva al settore un buon livello di concorrenzialità. Nell'Arte delle calze di seta al telaio, introdotta a Venezia nel 1657, il ricorso a manodopera femminile venne vietato nel 1704. La prescrizione venne probabilmente osservata in modo abbastanza rigoroso, ma nel 1780 l'apertura dell'Arte medesima si concretizzò nel permesso per gli imprenditori di servirsi di manodopera femminile per abbattere il costo del lavoro (60).
Oltre al comparto dell'abbigliamento, dove operavano numerose sarte, fu nel settore vetrario che la manodopera femminile tese ad affermarsi prepotentemente, a dispetto delle statistiche generali che continuarono a non registrare il fenomeno. Nel 1779 vennero contate ben trecentoquaranta donne tra le fila dei perleri veneziani, contro meno di trecento maestri, e addirittura millequattrocento impiraresse, lavoratrici a domicilio che infilavano e legavano le perle in mazzi e collane, pronti per essere venduti (61). Ancora, molte erano le donne impiegate nelle operazioni di cernita e di taglio della canna di vetro per la produzione delle conterie, mestiere idealmente riservato ai membri dell'Arte dei margariteri della città. Nella stessa Murano pare che le donne potessero assumere un ruolo produttivo nella fabbricazione e nel piccolo commercio delle perle di vetro (62). Anche nella tessitura laniera la manodopera femminile arrivò nella seconda metà del secolo a superare di gran lunga quella maschile: nel 1773 vennero contate centotrentasei lavoranti donne contro sedici lavoranti maschi e nel 1781 il corpo dei tesseri era formato da trentasei capimaestri, trentotto lavoranti e centoquindici donne. Il ricorso massiccio a manodopera femminile proprio in alcuni dei settori strategici dell'economia cittadina evidenzia la capacità del sistema corporativo di flettersi di fronte alle esigenze di abbattimento dei costi e di maggiore subordinazione della forza lavoro. I salari erogati alle donne dovevano essere comunemente considerati integrativi del reddito familiare e, d'altro lato, il tradizionale impegno domestico poteva giustificare il carattere spesso precario (e per questo motivo tanto più prezioso e conveniente dal punto di vista dell'imprenditore) del lavoro femminile. La minore "dignità" della donna rispetto al maschio, riconosciuta anche dalla teoria giuridica dell'epoca (63), non ne escludeva l'impiego proprio nei meno "dignitosi" tra i lavori manuali, all'interno di un'area di lavoro sommerso che per certi versi costituiva il segno di una poco edificante modernità.
E infine, sempre restando in tema di gerarchie, all'allargamento alla base dei rapporti informali di lavoro, di segmenti che sfuggivano a regolamentazioni e vincoli, corrispondeva verso l'alto l'esistenza dei "maestri capitalisti", ossia di coloro che all'interno del mondo corporativo potevano essere considerati dei veri e propri imprenditori. Tra questi vanno certamente annoverati almeno i gestori (patroni) delle fornaci muranesi, i capi-maestri tessitori di seta con laboratorio proprio, alcuni dei tipografi e non pochi librai-stampatori. Non era infrequente che all'interno delle singole Arti si scatenassero controversie e contrasti proprio a causa del divergere degli interessi tra maestri capitalisti e maestri lavoratori. Fu il caso, ad esempio, dell'Arte dei fabbricanti e venditori di amido (polvere di Cipro), una branca dell'importante Arte dei marzeri, che dal 1778 godeva di proprie regole particolari ed era sottoposta anche al controllo della Sanità, in quanto l'amido veniva usato come medicinale. Verso la fine del secolo, un violento contrasto sull'esclusiva di vendita del prodotto vide opposti venti "poveri ricorrenti" ai sette "fabbricatori opulenti" che ne controllavano l'intero traffico (64). Anche nell'Arte degli specchieri si distinguevano dei "negozianti capitalisti" e i capimaestri perleri potevano sostenere nel 1764 che alcuni "maestri-mercanti" pretendevano di esercitare abusivamente l'esclusiva nell'acquisto della materia prima e nella vendita del prodotto finito (65). Nell'Arte dei margariteri si poteva asserire che il "patrone margariter" aveva un ruolo diverso dai semplici capimaestri perché "assume per il suo interesse [= profitto] le commissioni che gli vengono offerte dai mercanti" (66). Insomma, sempre di più, alla distinzione tradizionale tra maestro, lavorante e garzone, si sovrapponeva quella tra imprenditore ed operaio. Il carattere sostanzialmente conservatore e livellatore degli istituti corporativi non poteva nascondere la realtà di rapporti di produzione più liberi, non regolamentati, orientati verso la separazione tra capitale e lavoro. Non deve dunque sorprendere se nell'Arte della seta la maggior parte dei duecentonovantacinque capi-maestri censiti nel 1769 "non lavora e si esercita in altri mestieri": il lavoro, condotto soprattutto da donne, era direttamente controllato dai mercanti o dai capimaestri capitalisti (67).
Ad esclusione del piccolo commercio al minuto e dell'artigianato vero e proprio, l'apice della gerarchia corporativa finiva per integrarsi nei fatti e in parte entrare in concorrenza con le Arti di soli mercanti, quelli di lana e di seta, di pellami e di ferro, i marzeri e i drappieri, gli editori e i librai. Il volto dell'imprenditore veneziano settecentesco si poteva ritrovare indifferentemente all'interno di categorie sociali teoricamente differenti, fino ovviamente alle famiglie nobili. Qualche volta si arrivava a sospettare, indice di un certo grado di realtà, che le vere funzioni imprenditoriali fossero in mano a mercanti ebrei, greci, turchi. Era il caso delle residue produzioni laniere veneziane, destinate interamente all'esportazione verso il Levante, per le quali si poteva sospettare un diretto interessamento degli intermediari ottomani residenti a Venezia. In ogni caso, era normale che i panni venissero "affidati" a mercanti turchi, contro baratto in cera, lane e pellami (68). Molto evidente fu il coinvolgimento in questo settore della famiglia israelita dei Gentili, che a partire dal 1745 gestì nei pressi della Madonna dell'Orto una manifattura di panni militari. L'impresa poté contare fino al 1777 sull'appalto delle forniture allo Stato (69). Un altro campo dove operarono imprenditori ebrei fu senza dubbio quello protochimico. Fin dal lontano 1660, l'ebreo Giuseppe Sarfati ottenne di gestire nella contrada di S. Lucia una fabbrica di tartaro emetico, cinabro, acquaforte ed altri prodotti, pervenuta nel 1767 nelle mani di Isacco Muggia, originario di Mira (70).
Fu forse la precisa consapevolezza del fenomeno da parte di Andrea Tron ad indurlo a proporre le misure restrittive che vennero adottate con la "ricondotta" della nazione ebraica del 1777, volte a impedire agli Ebrei l'esercizio delle Arti e la libertà d'iniziativa in campo manifatturiero. Mentre cercava di spronare il patriziato veneziano verso nuovi campi d'investimento, egli riteneva importante restringere la rosa dei concorrenti, nella sfida tra liberi gruppi imprenditoriali, in grado ormai di agire a tutto campo a dispetto di regolamenti e corporazioni. Gli effetti piuttosto gravi dell'azione del Tron non furono tuttavia decisivi, anche a causa dei contrasti interni al patriziato che queste drastiche e pericolose misure suscitarono (71). Sicuramente, la nazione ebraica vantava interessi di tutto rispetto nell'industria serica, il settore emergente dell'intera economia nord-italiana. Le iniziative in questo campo dell'ebreo veneziano Salomone Treves e di Benedetto Luzzatto di Rivignano spaziavano dal controllo diretto dei fornelli di trattura al commercio delle sete tratte, alla gestione o partecipazione nelle filature in varie zone dello Stato. A Padova, erano ben sette le ditte ebree che operavano nel campo delle passamanerie e della lavorazione dei cascami di seta, uno dei campi più vitali dell'economia cittadina (72).
Indizi, tasselli, riflessi di una lotta che probabilmente si combatté da parte di gruppi diversi di pressione dentro, contro e nonostante la pretesa pervasività e rigidità del sistema corporativo e che travolgeva gli illusori confini tra città e città, tra ceto e ceto, gli steccati che difendevano l'ordine di una società tradizionale. Più che le riforme furono i fatti a ridimensionare drasticamente il significato del sistema delle Arti, a creare gerarchie trasversali e insanabili divisioni che andavano ben oltre un improbabile ordine naturale, garantito dal sicuro esercizio del mestiere.
Nel Settecento veneziano si consumò, insomma, in modo certo contrastato e ambiguo, il divorzio tra la funzione amministrativa/assistenziale dei corpi e la reale gestione del processo produttivo.
Monopoli giuridici e settori manifatturieri privilegiati
Quasi tutti i rami manifatturieri della città di Venezia godettero nel Settecento di particolari facilitazioni. I comparti più antichi, come il lanificio e il setificio, potevano contare sulla tradizionale legislazione protezionistica e vincolistica, di volta in volta rivista, adattata, modificata. Le nuove iniziative venivano dal canto loro sempre accolte dagli ambienti governativi con un occhio di riguardo, nella speranza dichiarata che il loro attecchire favorisse l'attivo della bilancia commerciale, incrementasse l'occupazione e il reddito tassabile. In questa direzione la prassi mercantilista ebbe agio di esplicarsi in modo chiaro e coerente, con l'avvertenza che essa riguardò sempre di più l'intero Stato veneto e non la sola capitale.
Operare delle distinzioni concettuali tra i diversi settori industriali in base al tipo di protezione su cui poterono contare appare tuttavia alquanto fuorviante. La suddivisione fondamentale tra i veri e propri monopoli giuridici - le costruzioni navali, la vetreria, il saponificio e in parte il setificio - e gli altri settori veniva in buona parte annullata dalla sostanziale apertura dei mercati di riferimento e dai privilegi offerti con larghezza alle nuove produzioni, nonché dalle numerose deroghe alla norma che si verificavano nei fatti. Più importante appare invece operare una distinzione tra branche manifatturiere circoscritte a un ambito ristretto o addirittura in fase di ripiegamento, come il lanificio o le tintorie, e quei settori che nel Settecento costituirono nell'ambito urbano dei veri e propri distretti industriali.
Per l'industria tipografica, quella vetraria e quella serica, la specializzazione produttiva, la divisione del lavoro tra le diverse aziende, le reti di relazioni e di scambi di merci e semilavorati all'interno della città, il regime concorrenziale e la concentrazione territoriale furono tutti elementi che possiamo ritenere peculiari di veri e propri sistemi d'imprese (73). Al di là dei momenti di crisi e di alcuni processi di ristrutturazione in atto, questi tre settori costituirono nel Settecento gli assi portanti dell'esportazione di prodotti manufatti veneziani. Essi furono anche quelli che offrirono le maggiori opportunità occupazionali e che per questo ebbero un ruolo decisivo per la sostanziale stabilità della popolazione veneziana nell'ultimo secolo di vita della Repubblica (74). Il quadro generale, anziché statico o peggio ancora in irreversibile declino, si presentava mosso, aperto a novità e mutamenti. Le apparenti contraddizioni e il trend a volte davvero divergente tra le diverse attività produttive si spiegano con le specifiche congiunture, con le fluttuazioni della domanda interna ed estera, con le differenti capacità di risposta dell'ambiente produttivo. Un ambiente che, comunque, conservò fino all'ultimo un certo dinamismo e la possibilità di riallocare opportunamente le risorse disponibili.
I saponifici e la cantieristica
Fino alla fine del Settecento, la produzione del sapone restò legata di necessità alla conoscenza empirica del processo di fabbricazione e a una larga disponibilità delle due materie prime essenziali: l'olio d'oliva e le ceneri ricavate da piante ricche di sodio o di potassio. Venezia, pare fin dal Trecento, disponeva sia del know-how, sia delle fonti di approvvigionamento delle ceneri di soda, che servivano anche per la vetreria, e dell'olio, che veniva anche utilizzato per la pettinatura delle fibre di lana e per l'illuminazione. A sua volta, il sapone risultava indispensabile per il trattamento di sgrassatura delle fibre tessili, seta e lana, lavorazioni da lungo tempo presenti in laguna e nella Terraferma veneta (75). Tutte queste circostanze avevano fatto sì che "la fabbrica del sapone [...] o fu inventata in Venezia o in Venezia vi fu perfezionata, in modo da considerarsi di veneta invenzione, e fu perciò riguardata con gelosia pari alle manifatture di vetro, della triaca e simili" (76). In altre parole, Venezia ebbe un posto di preminenza nella fabbricazione e nel commercio di questo prodotto, tanto che già nel 1489 venne istituito un monopolio giuridico: l'attività poteva essere esercitata solamente nella capitale e non erano permesse le importazioni. Tale esclusiva rimase sempre in vigore, ribadita dal maggior consiglio nel 1556, dal senato nel 1659 e infine ancora nel 1793 (77).
Tuttavia, l'evoluzione dei tempi aveva progressivamente modificato la posizione della città lagunare nell'ambito del commercio internazionale del sapone. L'estensione della coltura dell'ulivo sulle coste italiane e francesi, le nuove produzioni francesi e dell'isola di Creta, seguite da quelle dei porti franchi dell'Adriatico, Trieste, Ancona e Fiume, lo spostamento verso questi ultimi del traffico d'olio diretto all'entroterra lombardo e in Germania arrivarono a ridurre la produzione veneziana a una presenza quasi marginale (78). Ciononostante, settore capitalistico per eccellenza, la fabbricazione del sapone continuò ad essere tutelata con particolare interesse, nel tentativo di riportarla su più alti livelli. Negli anni Settanta-Ottanta del Settecento, con una media di 102.000 ducati all'anno, il sapone si collocherà ancora al nono posto nella classifica dei generi esportati dal porto di Venezia (79).
Già nei primi due decenni del secolo, gli effetti di una crisi profonda si manifestarono però in tutta la loro evidenza. Nel 1707, su ventidue saponifici ben sei risultavano chiusi (cinquantaquattro caldaie attive contro tredici inoperose) e undici anni dopo ne restavano aperti in totale solo sette. La caduta delle esportazioni verso l'estero e addirittura l'arrivo illegale di altri saponi nella stessa Venezia, a causa del loro prezzo competitivo e del diffondersi del know-how, indussero il senato a esentare i saponifici dal dazio dell'olio sui quantitativi esportati. Ma, ormai, si trattava più che altro di conservare una quota del mercato interno, visto che anche verso l'importante piazza di Verona i Veneziani non spedivano più nulla (80). Il tentativo di avviare delle produzioni "ad uso di Marsiglia", portato avanti dalla saponeria privilegiata dell'abate Michelangelo Bozzini ai SS. Giovanni e Paolo tra il 1737 e il 1740, si concluse con un clamoroso insuccesso, su cui gravarono seri sospetti di frode, anche a causa dei precedenti penali dell'abate, già condannato come falsario di monete (81). La sopravvivenza del saponificio veneziano nella seconda metà del secolo rimase a questo punto legata a due elementi solo in apparenza contraddittori: la presunta scarsa qualità e la costituzione di veri e propri cartelli per la fabbricazione e la vendita del prodotto.
Nonostante il controllo esercitato dai consoli dei mercanti e dai provveditori sopra olii, la frode commerciale sembrò costituire un tratto distintivo delle produzioni veneziane settecentesche, tanto che la sofisticazione assurse quasi a prassi normale (82). L'aggiunta di acqua, l'uso di succedanei dell'olio d'oliva, la scarsa cottura o stagionatura del prodotto parevano averne non poco pregiudicato l'immagine. Nel 1761, ad esempio, giunsero da Bergamo, da Vicenza, da Udine, dalla stessa Venezia segnalazioni inequivocabili in tal senso. Nel 1788 tutti i fabbricanti di lana e seta dello Stato furono unanimi nel sottolineare la pessima qualità dei saponi della laguna, "che lasciano un untuoso e una puzza irremovibili" (83). Non si deve affatto escludere che tante e tali testimonianze contengano seri elementi di verità, ma d'altra parte è la contestuale insistenza sugli alti prezzi e la perfetta corrispondenza temporale con un altro fenomeno a renderle quanto meno sospette di esagerazione e di un certo grado di parzialità.
Nel 1759 venne infatti creata una "Società dei Fabbricatori di Sapone", che raccoglieva le sei superstiti ditte, poi salite a sette, in un cartello che aveva come obiettivi il contingentamento della produzione e la vendita consorziata del prodotto. In cambio, la società s'impegnava con lo Stato a tener fisso per dieci anni il dazio sull'olio consumato, che continuava a subire continue diminuzioni, dato che la produzione globale era scesa nel 1754 a un quarto di quella dichiarata nel 1708. Fu proprio l'impossibilità a tener fede a questo impegno, più che le opposizioni che incontrò il cartello, che spinse i fabbricanti a chiedere nel 1765 lo scioglimento anticipato della società (84). Successivamente, l'attività si rianimò, tanto che attorno al 1770 si contavano una decina di fabbriche, dotate di una ventina di caldaie (85). Il 16 marzo 1785 venne così creata una nuova società tra i nove saponifici allora in attività, che aveva come scopo di risolvere i problemi di concorrenza e di sovrapproduzione, facendo fronte all'insolvenza di molti compratori e garantendo la qualità del prodotto. Nei trenta articoli della compagnia vennero severamente contingentate le consegne riservate a ciascun fabbricante (per un totale annuo di 2.050.000 libbre sottili, circa 617 tonnellate), e stabilite le modalità di fissazione dei prezzi, di elezione delle diverse cariche societarie con gli obblighi ad esse connessi, di tenuta dei libri contabili, assieme alle clausole finanziarie e di scioglimento. La particolarità di questa società, che aveva il suo magazzino presso la saponeria Pasini a S. Fosca e sede legale presso il fabbricante Francesco Fracasso a S. Cassian, è che si trattava di una compagnia per la vendita, di un vero e proprio cartello "che sarà intitolato di Fabbricatori di Sapone, sotto questa anonima ragione" (86). Gli aspetti monopolistici del settore ne risultarono rafforzati, non senza elementi di modernità, come i compiti affidati ai due direttori, veri e propri amministratori delegati, che il concetto stesso di anonimato sociale ben riassumeva.
Fu contro questo cartello che insorsero i produttori tessili dello Stato, che evidentemente ancora si servivano largamente di sapone veneziano, lamentando per l'appunto un aumento del prezzo da 93 a 135 ducati per 1.000 libbre tra 1785 e 1787 (+ 45%). Inoltre, contro la compagnia si schierò Giuseppe Loris, intenzionato ad aprire un nuovo saponificio a Venezia e che evidentemente si era trovato di fronte a una forte opposizione. Fu dunque convocata una conferenza tra i magistrati dei savi alla mercanzia, i provveditori sopra olii, i consoli dei mercanti e l'inquisitore alle Arti, che produsse nel maggio 1788 un parere chiaramente negativo sull'esistenza della società dei fabbricanti di sapone, dichiarata contraria agli interessi nazionali (87). Questa posizione portò al decreto del 5 giugno 1788, che ripristinò la libertà di fabbricazione, sempre però nella sola Venezia, e ai successivi decreti del 22 febbraio 1794 e 10 marzo 1796, con i quali venne varato un nuovo regolamento sulle fabbriche di sapone (88). Rimase comunque in essere il monopolio giuridico riservato alla sola città e la proibizione totale delle importazioni.
Ancora nell'agosto del 1797, in piena municipalità provvisoria, i fabbricanti di sapone potevano asserire che il loro era "uno dei principali rami dell'attivo commercio", che garantiva allo Stato un'entrata annua di oltre 43.000 ducati solo per il dazio sull'olio consumato. E Giuseppe Loris, riuscito alfine a far partire la sua fabbrica a S. Croce, con due caldaie e cinque operai fissi, poteva dire con soddisfazione che il suo sapone si vendeva bene e che aveva in progetto di ingrandire l'azienda (89). In conclusione, seppure ridimensionata dalla crisi della prima metà del secolo, la fabbricazione del sapone rimase un'attività di una certa rilevanza, con un giro d'affari non disprezzabile e che trovava sul mercato interno facili opportunità di sbocco. Soprattutto, si trattò di un caso evidente di modernizzazione delle strutture commerciali e finanziarie, un terreno di prova e di scontro per interessi imprenditoriali del tutto avulsi dall'ambiente corporativo. Non un settore di punta, ma un settore nel quale le capacità di resistenza e di adattamento dell'ambiente veneziano diedero prova di sé. E nel 1802, Francesco Ruziezka d'Odmark, un tecnico-imprenditore praghese, poté aprire a S. Lucia una ditta dotata di una nuova macchina per il sapone, segno che le nuove tecnologie che si stavano affermando in Europa e che avrebbero presto rivoluzionato l'intero comparto trovarono terreno fertile e un pronto accoglimento nella città lagunare (90).
La grande azienda di Stato dell'Arsenale era stata impreziosita alla fine del Seicento, in corrispondenza con la guerra del Peloponneso, dai leoni, dalla terrazza e dal porta-bandiera bronzeo, opere in grado di trasformare il campo prospiciente l'ingresso da terra in luogo simbolico delle rinate velleità belliche della Repubblica marciana (91). La successiva riconquista turca e il trattato di Passarowitz (1718) smorzarono tuttavia, assieme agli effimeri entusiasmi, anche l'attività della cantieristica da guerra. Essa rimase per tutto il Settecento oltremodo ridotta. Il ritmo di produzione di meno di una nave all'anno dimostrava che lo scopo precipuo dell'esistenza stessa dell'Arsenale era quasi venuto meno (92). Ma la sopravvivenza dell'attività e addirittura un parziale rilancio trovarono impulso dall'incoraggiamento governativo al potenziamento della marina mercantile. Dopo aver provveduto all'escavo del canale tra la bocca di Malamocco e il bacino marciano, nel 1736 la Repubblica decise un piano di rilancio dell'armatoria, facente perno proprio sulla struttura pubblica. Il costo eccessivo e, a tratti, l'inutilità dei convogli protetti, fecero sì che la scelta cadesse sulla costruzione di navi mercantili armate, dette navi atte, per le quali si fissarono precisi requisiti di costruzione, di armamento (ventiquattro cannoni), di scorte e di equipaggio (almeno quaranta uomini). In cambio del rispetto di questi nuovi standards, gli armatori potevano contare per tre mesi sull'apporto gratuito delle maestranze dell'Arsenale e sulla cessione a prezzi agevolati del legname da costruzione, dell'armamento e delle munizioni. Le agevolazioni daziarie per le navi atte battenti bandiera veneta completavano il quadro di un progetto ben articolato. Pur costituendo un oggettivo ritorno all'antico, quando la distinzione tra navi da guerra e mercantili doveva ancora apparire, la riforma permise una nuova espansione delle costruzioni navali, che a sua volta non poté che riflettersi positivamente sulle potenzialità commerciali dello scalo. Già una decina di anni dopo, gli effetti di questo provvedimento si fecero sentire e, in seguito, la neutralità veneziana nel corso delle diverse guerre europee del Settecento fece sì che la ripresa della marina mercantile si consolidasse nel tempo. Se nel 1763 erano ancora solo una settantina le unità classificate come "navi", esse erano oltre trecento negli anni Novanta. Forse, al culmine di questa fase di espansione, il tonnellaggio globale che transitava per il porto lagunare raggiunse dimensioni mai prima toccate (93).
Le riforme nel campo delle costruzioni navali vennero accompagnate dall'avvio nel 1737 dell'erezione di un nuovo corpo di fabbrica all'interno dell'Arsenale, chiamato "Tezzone alle seghe" (officina degli squadratori nell'Ottocento) e dall'innalzamento di alcuni squeri. Nell'edificio degli squadratori venivano modellati i costoloni per le chiglie delle navi, secondo regole più precise e più appropriate ai tempi; operazione che risultava di molto favorita dall'essenzialità e dalla funzionalità dell'edificio (94). Nel secondo Settecento, il riordinamento degli spazi adibiti ai servizi d'artiglieria, la costruzione della fucina da ancore, il rinnovamento delle fonderie si accompagnarono al progressivo abbandono del tradizionale empirismo che guidava l'attività produttiva. La creazione del corpo degli ingegneri militari e del corpo d'artiglieria (1770-1771), l'istituzione della scuola navale (1777), infine la costituzione di una direzione tecnica dei lavori e di un ispettorato tecnico nel campo della sistemazione e manutenzione degli edifici completarono una lunga operazione di riassetto e di rilancio del grande bacino armatoriale. Le spese correnti per il mantenimento dell'Arsenale salirono in media di quasi il 15% tra i primi anni Quaranta e i primi anni Cinquanta del secolo (95).
La caduta della Repubblica colse l'Arsenale all'apice di un processo di adeguamento tecnico e organizzativo che lo stava trasformando nuovamente in un complesso d'avanguardia (96). La lentezza dei meccanismi decisionali a livello politico, il probabile sottoutilizzo degli squeri, pari a fine secolo forse al 50% della capacità produttiva totale, una certa irrazionalità che permaneva giocoforza nella distribuzione degli spazi, non inficiano il fatto che il secondo Settecento rappresentò un periodo positivo per questa grande fabbrica di Stato. Certamente, tutto questo non permise la ricostituzione di una flotta mercantile degna di competere alla pari con quella delle potenze atlantiche, ma si riuscì nondimeno a controbilanciare almeno in parte la tendenza ad affidarsi alle navi battenti bandiera estera.
Una valutazione sulla forza lavoro effettivamente impiegata all'interno dell'Arsenale risulta piuttosto difficile, sia perché gli arsenalotti godevano del privilegio di poter lavorare anche in cantieri e aziende private, sia per i loro diversi impegni istituzionali, come quello di pompieri o di guardie di palazzo (97). Le corporazioni che li inquadravano erano cinque: calafati, marangoni, remeri, segadori e squeraroli. Tutte erano sottoposte al controllo del reggimento dell'Arsenale e anche a quello della giustizia vecchia per quanto riguardava il lavoro esterno. Secondo i dati forniti da Daniele Beltrami, se la manodopera iscritta nei diversi corpi era caduta dai duemilatrecentoquarantatré addetti nel 1645 ai soli milletrecentonovantatré nel 1696, era poi risalita a millequattrocentoquarantadue nel 1766 e negli anni Ottanta e Novanta a oltre millesettecentocinquanta (98). Nel 1696, i marangoni impiegati risultavano quattrocentosessantaquattro, settecentoventi i calafati e ottantasei i remeri (99). La statistica del 1773 evidenziava, invece, l'esistenza di cinquecento calafati, settecento marangoni, duecentoquarantaquattro remeri, duecentocinque segadori e duecentosessantacinque squeraroli, per un totale di millenovecentoquattordici lavoratori, compresi però quelli momentaneamente disoccupati o impiegati negli squeri privati, presenti in numero di quarantacinque. A fine secolo, la rilevazione di del Senno riportava seicentotrenta calafati, ottocento marangoni, centosettantasei remeri, duecentoquattro segadori, duecentosessantacinque squeraroli.
Ci sembra di poter concludere che la cantieristica veneziana, compresa quella minore, ancora vivace nell'arco del secolo (100), fornì una prova di sufficiente tenuta. Quanto meno, venne trasmesso all'Ottocento il bagaglio tecnico e artigianale necessario nel campo della navigazione lagunare e una struttura statale di lunga tradizione, ancora dotata di grandi potenzialità, che non mancheranno di essere sfruttate dai successivi governi.
Chimica, cereria e porcellane
A Venezia, lo spazio riservato a produzioni che facevano riferimento a processi empirici nel campo chimico era ben rappresentato dalla lunga tradizione in materia di tinture. Fin dal Duecento, le tintorie veneziane avevano costituito l'essenziale complemento delle industrie tessili cittadine. Circondate dal segreto sui dettagli di fabbricazione e sottoposte a norme rigorose per il controllo della qualità, le tinture veneziane furono particolarmente apprezzate, soprattutto nella colorazione dello scarlatto, ottenuto con la cocciniglia triturata (grana), e in quella del nero, ottenuto con un bagno d'indaco (guado), cui seguivano un bagno di robbia e il trattamento tannico con solfato ferroso, estratti di quercia, galla o vallonea (101). Tutti i tessuti fabbricati in città o importati allo stato greggio, come nel caso dei broadcloths inglesi nel Tre e Quattrocento, dovevano per legge subire il trattamento nelle tintorie di Venezia. Precise e minute prescrizioni vincolavano i maestri veneziani a seguire i processi tradizionali, ben distinti già dalla fine del Quattrocento per le quattro branche dell'Arte della tintura: da seda, da guado, da scarlatto e da cremisi (102).
Tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento, la storia delle tintorie veneziane si arricchì di alcuni tentativi d'introdurre nuove tecniche, grazie all'apporto di tecnici stranieri richiamati in città dai privilegi concessi dallo Stato. Essendo il nero, o cupo, la colorazione in quel momento più gradita agli acquirenti dei mercati levantini, i tentativi si concentrarono in quella direzione, anche per la necessità di evitare l'utilizzo di vetrioli di ferro che venivano largamente usati per ottenere una buona apparenza, con il risultato di indebolire le fibre e rendere poco stabile la tinta (103). Privilegi per nuove tecniche tintorie vennero così decretati per il polacco Giovanni Bez e per il fiammingo Pietro Comans, che condusse a Venezia un tintore tedesco, il quale si trasferì poi a Milano e in seguito a Firenze. Dei segreti del Comans poté impossessarsi in qualche modo il mercante Gabriele Borlandi, che si accordò col tintore padovano Alessandro Ceroldi, a nome del quale venne rilasciato un privilegio di tintura nel maggio del 1713 (104). Ma l'episodio certamente più noto è quello dell'arrivo in laguna del tecnico fiorentino Cosmo Scatini, che nel gennaio del 1712 ottenne dal senato il privilegio esclusivo per la tintura in nero di tutte le sete prodotte a Venezia, contro la corresponsione di un vitalizio di 30 ducati al mese. La sua innovazione, che consisteva in un metodo di colorazione che utilizzava anche limatura di ferro e vetriolo, doveva accompagnarsi a un progetto per una compagnia generale di tutti i tintori di nero, che avrebbe dovuto trovare sede fuori Venezia, sul fiume Sile. A questo punto si aprì un duro conflitto tra l'Arte dei tintori da un lato e i mercanti dell'officio seda dall'altro, i quali paventavano gli effetti che il monopolio esercitato dalla nuova compagnia avrebbe potuto avere sui costi di tintura. La controversia durò a lungo e si concluse soltanto nel marzo del 1720, quando venne emanato un definitivo regolamento sulla tintura in nero che escludeva la possibilità di formare una compagnia generale dei tintori e affidava allo Scatini il compito di soprintendente alle operazioni di tintura dei singoli laboratori (105)).
In questo caso, i vincoli corporativi e il tradizionale rapporto di dipendenza dei tintori dai mercanti sembrano avere avuto la meglio su ogni altra istanza di rinnovamento, anche nei rapporti di produzione. Ma è davvero dubbio che i casi del Ceroldi e dello Scatini abbiano avuto qualcosa a che spartire con l'effettivo ripiegamento delle tintorie veneziane avvenuto nel corso del Settecento. Il privilegio Ceroldi aveva sì sviato da Venezia le produzioni laniere padovane, per lungo tempo dipendenti dalla capitale per la fase finale della lavorazione. Ma ciò che danneggiò veramente le tintorie lagunari fu l'impossibilità, a causa dei più alti costi e probabilmente dei limiti ambientali, di seguire la moda dei cosiddetti mischi tinti in lana e la concorrenza sempre più agguerrita delle altre tintorie della Terraferma veneta e addirittura della Dalmazia, dove trovarono impiego anche molte delle maestranze veneziane (106). Di nessun effetto fu l'iniziativa di avviare nel 1784 una tintoria sul Sile, gestita dal tintore veneziano Francesco Cerro, sottoposta direttamente al controllo dell'Arte della seta. Essa finì per essere ceduta sotto costo nel 1796, con gravi perdite, al tintore Zanibon, che operava privatamente sempre a Treviso (107). Nel corso del secolo i laboratori veneziani si ridussero grandemente di numero, dai cinquantasette del 1711 ai trentasette del 1773, ai ventidue del 1792, e l'Arte dei tintori si contrasse fino ai centoquarantasei iscritti, tra garzoni, lavoranti e maestri, alla fine del secolo. Un dato certo negativo, un effettivo regresso, ma che restò in buona parte compensato dal diffondersi delle capacità tecniche e imprenditoriali nel resto dello Stato.
Un'altra compensazione al ramo delle tinture venne dallo sviluppo di altre attività protochimiche che conobbero un certo successo a Venezia nel corso del Settecento. Antesignana di queste fu la bottega di Ventura Fua, aperta dopo il 166o a S. Lucia, in virtù di un privilegio elargito dal senato a Giuseppe Sarfati. Il "segreto di lavorare sublimati, precipitati, cinapri, pietra infernale, acquaforte di particolare qualità" poteva ancora essere rivendicato in esclusiva da Isacco Muggia, genero di Benedetto Sarfati, nel 1777 (108). L'azienda del Sarfati, che era stato convinto a ritornare a Venezia da Trieste nel 1753, era però già stata trasferita a Campalto e poi a Mira prima del 1759, a causa dell'inquinamento atmosferico determinato dalle esalazioni di fumo (109). In realtà, le ditte che producevano in città sublimato di mercurio, cremor di tartaro (bitartrato di potassio) e tartaro emetico (tartrato di potassio) erano già due nel 1753 e divennero sei nel 1767. Esse lavoravano con ben cinquantasei caldaie per la produzione del cremor di tartaro, che "non stanno mai in inazione se non per deficienza di materia, ch'è la gripola", ossia la gromma delle botti di vino (110). Il sublimato di mercurio, o sublimato corrosivo, veniva utilizzato per la conciatura delle pelli, attività che a Venezia contava una decina di laboratori. Cremor di tartaro e tartaro emetico trovavano applicazione in medicina, il primo come diuretico e lassativo, il secondo appunto come emetico. Il cremor di tartaro veniva utilizzato anche come mordente per le incisioni e per le tinture. Il segreto della sua fabbricazione si asseriva fosse conosciuto solo a Venezia e in Olanda, tanto che a più riprese venne fatto oggetto di spionaggio industriale, con emigrazioni di operai verso Ancona, Livorno, Trieste (111). Questo tipo di produzione utilizzava come materia prima anche il salnitro (nitrato di potassio), sottoposto al controllo pubblico fin dal Cinquecento, a causa della sua enorme importanza nella fabbricazione della polvere da sparo. È per questo che lo Stato decise opportunamente di aprire i suoi depositi a favore di queste imprese, oltre che per la fabbricazione dei cristalli e degli smalti (112).
La produzione annua di cremor di tartaro veniva stimata nel 1767 in 576.000 libbre sottili (173 tonnellate), per un valore di circa 49.000 ducati. Quasi tutto il quantitativo veniva esportato verso la Germania, l'Olanda, l'Inghilterra. Il settore offriva impiego a parecchi lavoratori non qualificati, come facchini e acquaroli, ed offriva l'opportunità di utilizzare la canna palustre per il funzionamento delle caldaie (113). Alle imprese censite nel 1767 andarono poi ad aggiungersene altre, come quella di Giuseppe Tasca a S. Trovaso, del tedesco Tommaso Greber a S. Girolamo, dello speziale Vincenzo Dandolo (114). Insomma, nonostante i riconosciuti problemi di localizzazione delle aziende, determinati dal rilascio di fumi tossici, questa attività, non di primo piano e dispersa ai quattro angoli della città, poté trovare modo di crescere e svilupparsi.
Oltre alla modesta attività della fabbricazione della biacca, il settore chimico si completava con la tradizionale lavorazione della triaca e del mitridato, celebri pseudomedicinali di larghissimo consumo, per i quali la città di Venezia andava famosa da secoli. Questi composti aromatici ed eccitanti, vere panacee per tutti i mali, peste compresa, trovavano nella carne di vipera (preferibilmente dei colli Euganei) il loro principale ingrediente. Fabbricati direttamente dagli speziali, questi farmaci erano oggetto d'imitazione non solo nelle altre città venete, ma addirittura in Francia e Germania, oltre che nella stessa Venezia (la cosiddetta "falsa triaca") (115). E per questo che vennero promulgate precise norme per la tutela qualitativa del prodotto e per la vigilanza contro le contraffazioni. Le farmacie triacanti erano sottoposte a preventiva autorizzazione della magistratura della giustizia vecchia. I farmacisti dovevano mettere in mostra all'esterno delle loro botteghe gli ingredienti utilizzati, prima di triturarli al mortaio. Poi il composto doveva essere lasciato a fermentare per almeno sei mesi in grandi giare di terracotta (116).
Ancora verso la fine del Settecento si producevano ed esportavano circa 200.000 libbre all'anno di triaca (117). Del resto, l'Arte della farmacia veneziana, raccolta nel corpo degli spezieri da medicinali, doveva costituire nel Settecento un ramo di florido e attivo commercio, con le sue novanta botteghe censite nel 1773, un numero davvero notevole, perfino ai nostri occhi ormai abituati all'uso e all'abuso di farmaci e rimedi di vario genere e tipo.
Infine, un altro ramo, a metà strada tra il commercio d'intermediazione e l'industria, era quello della lavorazione della cera. Concentrato in una decina d'imprese, con un centinaio di occupati, esso conobbe nel corso del Settecento una forte espansione, tanto che la produzione del 1790 venne stimata in valore pari a un milione e mezzo di ducati. Le cere vergini provenienti dall'area adriatica venivano raffinate a Venezia e da qui in gran parte riesportate verso la Terraferma, gli altri Stati italiani, la Spagna e il Levante. Anche nella fabbricazione delle cere ebbero modo di espandersi nuove iniziative, come nel caso del mercante del Bene, originario di Pesaro, che ottenne negli anni Cinquanta un privilegio decennale connesso ad alcune facilitazioni daziarie (118). I fabbricanti di cere facevano parte di un'altra corporazione piuttosto importante, quella degli spezieri da grosso, che raccoglieva oltre a loro anche i droghieri, i fabbricanti di olio di mandorle dolci e i raffinatori di zucchero, per un totale di ben ottantaquattro esercizi.
Un'interessante e nuova iniziativa fu quella assunta da Giminiano Cozzi che nel marzo del 1765 aprì a Cannaregio una fabbrica per la produzione di porcellane "ad uso del Giappone". Nel 1767, quando venne poi privilegiata dallo Stato, essa lavorava con quattro fornaci, di cui una di grandi dimensioni per la fabbricazione dei piatti, e dava lavoro a quarantacinque operai e sei apprendisti. La fabbrica risultava dotata di una nuova macchina "inserviente alla macinatura delle vernici e minerali" ed esportava un terzo della sua produzione verso Trieste ed il Levante ed un terzo verso l'area padana (119). Cozzi ottenne tra il 1765 ed il 1795 dalla cassa donativi dei savi alla mercanzia ben 22.000 ducati di premi all'esportazione, mentre i divieti d'importazione, appositamente adottati per facilitarlo, poco poterono contro il potere del gusto e della moda.
Pur non in grado di contrastare efficacemente i flussi d'importazione e la concorrenza della più importante azienda dello Stato, quella creata nel 1732 da Pasquale Antonibon a Nove presso Bassano, l'impresa di Cozzi riuscì a ritagliarsi una sua nicchia di mercato, facendo perno sul negozio di S. Salvador a Venezia e sulle fiere e i mercati della Terraferma (120). Nel 1785 la ditta gestiva anche una fabbrica a Treviso. Risultava da un attento esame dei bilanci aver incrementato la propria produzione, con un fatturato di 235.000 ducati nei diciassette anni trascorsi (121). Il settore delle porcellane, tra l'altro, fu sicuramente uno di quelli in cui più si esercitò lo spionaggio industriale. Antonibon si vantava, infatti, di aver carpito i segreti di fabbricazione in Francia e il suo successore Pasquali sottrasse operai e disegni alla città di Lodi. Furono del resto proprio alcuni operai della fabbrica di Nove a fornire anche a Giminiano Cozzi alcuni segreti del mestiere (122). Non in grado certamente di stabilire in laguna una vera tradizione produttiva, la fabbrica di ceramiche di Venezia costituì però un tentativo abbastanza riuscito di avviare un'attività completamente nuova.
L'industria laniera e delle tele
Alla fine del Seicento, il lanificio di Venezia era ormai ridotto a un ruolo marginale, dopo avere rappresentato fino alla metà del secolo la più importante attività cittadina. Non si creda tuttavia che nulla venisse tentato per il suo rilancio. Tra gli anni Settanta del Seicento e gli anni Venti del Settecento si dipanarono numerosi i provvedimenti mirati ad avviare produzioni in grado di contrastare la concorrenza estera. Con una certa coerenza ed anche una certa pertinacia, il governo si prodigò per introdurre, grazie all'arrivo di tecnici stranieri, la fabbricazione dei generi più in voga: scotti all'uso di Fiandra, londrine all'olandese, panni mischi cardati all'uso d'Olanda e d'Inghilterra, londrine seconde ad uso di Francia. I nomi del bergamasco Santo Gallicioli, dell'olandese Giovanni Bucheri, del polacco Giovanni Bez, del fiammingo Pietro Comans si legarono ad altrettanti privilegi o privative che avrebbero dovuto consentire una grande ripresa. Fu per questa via che entrarono per la prima volta nel Veneto nuovi processi produttivi, nuovi strumenti e capacità tecniche che poi trovarono nel resto dello Stato, soprattutto nel Trevigiano, Vicentino e Bergamasco, fertile terreno di coltura. Per quel che riguarda Venezia, invece, i risultati furono oltremodo deludenti. Qualche centinaio di pezze all'anno di nuovi tessuti, peraltro assai simili a quelli tradizionali veneziani, nei primi anni del secolo e, dopo il 1716, una produzione per qualche anno promettente di cardati leggeri fu tutto quanto si riuscì ad ottenere. Con gli anni Trenta divenne evidente l'inanità dello sforzo praticato, complici un protezionismo tanto rigoroso nella norma quanto inapplicato nei fatti, l'alto costo delle materie prime e della manodopera e la difficoltà d'imitare i nuovi tipi di tintura (123).
A quel punto, la strada di uno scivolamento lento ma inarrestabile risultava purtroppo tracciata. Mentre anche sotto il profilo qualitativo la produzione andava abbassandosi, le quantità prodotte si riducevano progressivamente, fino alle sole duecentosessanta pezze fabbricate nel 1790 e alla definitiva scomparsa della tessitura in età napoleonica. Indubbiamente, uno dei problemi che potevano sembrare più importanti era costituito dalla resistenza dell'ordinamento corporativo. A prescindere dai costi aggiuntivi rappresentati dal peso fiscale e dai debiti perenti delle diverse Arti laniere, a più riprese vennero sottolineate l'imperizia e la malafede dei maestri veneziani. Su questo si trovarono concordi il savio alla mercanzia Giovanni Dolfin nel 1711, il mercante-imprenditore Elia Alessandri nel 1751, l'inquisitore alle Arti Alvise Zusto nel 1785. Soprattutto il confronto con gli operai delle manifatture del Vicentino risultava del tutto svantaggioso per i Veneziani. Come scriveva Prospero Valmarana, uno dei patrizi più impegnati nel campo delle riforme del sistema economico, la loro laboriosità "non è possibile di conseguirsi principalmente in questa Dominante, per le somme distrazioni dei divertimenti, giochi pubblici, spettacoli e per la scorretta educazione del basso popolo" (124). Moralismi a parte, il più alto tenore di vita dei popolani della capitale e la rete di protezioni di cui potevano godere i membri delle Arti non facilitavano certo la competitività delle aziende. Il risultato fu che gli stessi mercanti veneziani cercarono sempre più di far lavorare i loro panni in Terraferma, a Padova o nel Trevigiano, e di reclutare manodopera femminile e minorile. Non registrate, ad esempio, nella statistica del 1773, le donne occupate nei lanifici, ancora del tutto assenti nel secondo decennio del secolo, divennero duecentoquindici nel 1781, contro venti minori e trecentoventidue uomini iscritti alle diverse Arti, peraltro non tutti effettivamente occupati (125). La teorica autonomia del mondo corporativo risultava a questa data anche inficiata dalla presenza di sei tessiture e sei laboratori di rifinitura "ad uso di fabbrica" (126). Lo smantellamento delle Arti del lanificio e la subordinazione dei lavoratori ai mercanti, voluti da Andrea Tron e portati a compimento nel 1786, dopo la sua morte, non modificarono il quadro di fondo di un progressivo disimpegno e di una decisa svolta nei rapporti di produzione, che si verificarono ben al di fuori della sfera istituzionale. Tanti progetti, inchieste, proposte, aggiustamenti si tradussero in una produzione legislativa che forse ebbe come unico effetto quello di far passare senza eccessivi traumi il ritrarsi del capitale mercantile dalla produzione laniera effettuata in laguna.
L'unica eccezione a questo quadro veramente sconfortante fu rappresentata dalla fabbrica di tende da galera e vestiario per i detenuti, aperta nel 1745 alla Madonna dell'Orto dalla famiglia ebrea dei Gentili, che già dal 1714 aveva ottenuto l'appalto delle forniture allo Stato. Questa azienda si presentava nel 1763 dotata di trentadue telai, dando lavoro a qualche centinaio di popolani (127). Alla produzione delle rasse per i detenuti, si affiancarono quella delle coperte, di alcuni tipi di tessuti leggeri e dei talèd. Purtroppo, il divieto comminato agli Ebrei di gestire attività industriali (1777) provocò il trasferimento o l'interruzione della produzione, tanto che novanta famiglie si lamentarono in una supplica di avere in questo modo perduto il loro sostentamento (128). A questa iniziativa, si sovrappose nel 1754 anche l'appalto per il vestiario delle truppe. Probabilmente, la manodopera impiegata (duecentoquarantasei persone, filatrici escluse, nel 1767, reclutate tra i membri delle varie Arti) e il luogo fisico della fabbrica erano gli stessi. In questo caso, le stesse autorità pubbliche, nella persona di Antonio Zulian, deputato alle fabbriche, dovettero constatare la scarsa economicità della localizzazione in laguna, tanto che più tardi le pezze acquistate dallo Stato vennero prodotte in Terraferma. Ma nella memoria dei poco fortunati lavoratori lanieri, la cosiddetta "fabbrica militare" di Venezia restò l'ultimo mito di un'impossibile ripresa (129).
La fabbricazione delle telerie, contrariamente a quella della lana, conobbe nel Settecento nuove possibilità di espansione. Certo, le tradizionali produzioni veneziane, i fustagni lavorati con trama di lino e ordito di cotone, sembravano già dal tardo Seicento non incontrare più il favore della moda. Il calo delle esportazioni, dalla media di milleottocentoquarantasette pezze nel quinquennio 1691-1695 alle milletrecentoventiquattro del 1701-1705, alle ottocentoottantadue del 1711-1714, alle trecentonovantasette del 1721-1725, metteva in evidenza queste difficoltà, anche se le forniture per l'esercito riuscivano a mantenere in vita il settore (130). Riservata nel 1688 all'Arte dei tessitori da fustagni anche la fabbricazione delle mezzelane, gli indizi di un mutamento di rotta si avvertirono prima di tutto nella composizione della manodopera.
Fin dal lontano 1596, era vietato alle donne l'esercizio autonomo del mestiere, tranne nel caso in cui fossero vedove o orfane di capimaestri. Ciò non impedì nel Settecento il loro ingresso nel mondo produttivo. Nel 1744 erano ventuno le maestre, contro quarantuno maestri maschi ed una cinquantina di altre donne impiegate come lavoranti. Nel 1745 venne consentito ai maestri di assumere garzoni di entrambi i sessi, lasciando piena libertà al regime salariale e consentendo l'iscrizione all'Arte anche ad elementi esterni. La presenza in questa occasione, tra i deputati al commercio, di personaggi del calibro di Niccolò Tron e Andrea Memmo ci fa dire che fu questa una delle operazioni più riuscite dei riformatori veneziani impegnati in campo economico. Veniva così finalmente facilitata l'introduzione di nuove produzioni, più adatte al mercato internazionale, nella considerazione che il settore stava già attraversando un periodo di netta ripresa. Il numero di pezze bollate a Venezia era infatti cresciuto costantemente a partire dagli anni Venti, da poco meno di tremila alle oltre seimila nel 1745 (131). Fu a questo punto che s'inserì l'iniziativa di Francesco Lischiuta che, sulla scorta di quanto stava accadendo in Carnia e a Cividale e grazie alle norme approvate nel 1745, ritenne di avviare in grande stile la fabbricazione di rigadini, a cui poi si affiancò quella delle indiane stampate, dei dimitti e di altri tessuti misti. Dopo una lunga controversia con l'Arte dei fustagneri, il Lischiuta ottenne nel febbraio del 1748 l'esenzione dai dazi di entrata e uscita da Venezia per il biancheggio delle tele, l'esenzione per cinque anni dalle imposte corporative, la possibilità di intraprendere le nuove produzioni apponendovi un proprio bollo a fiamma. Tre anni più tardi ottenne di poter acquistare il cotone greggio senza l'intermediazione dell'Arte dei bombaseri e il transito in esenzione di dazio per far svolgere la filatura in Terraferma (132). Negli anni Cinquanta il Lischiuta trovò una modalità di accordo con l'Arte dei fustagneri, riuscendo tra l'altro ad impedire la concorrenza della grande ditta Linussio di Tolmezzo nel campo della fabbricazione dei rigadini. Nel 1757 venne sciolta l'Arte dei bombaseri con l'esplicita finalità di favorire il libero impiego delle filatrici, con la sola riserva che chi fosse stata istruita "nella nuova maniera di filare" avrebbe dovuto restare a servizio del suo datore di lavoro (133).
Fu così che l'azienda del Lischiuta poté svilupparsi in un regime di totale libertà di movimento. Nel 1763 essa contava ben centoquattro telai attivi, di cui trentadue raccolti nella manifattura di Venezia. La ditta si serviva in buona parte di tessitori a domicilio della Terraferma; il cotone veniva filato a Burano e nel Trevigiano ed il lino in varie zone dello Stato, fino alla lontana Spilimbergo (134). Lavorando assieme cotone, lino e canapa bolognese (per i cavezzoli), e soprattutto attuando una felice strategia d'integrazione tra lavoro a domicilio, manifattura e commercio, l'azienda del Lischiuta poté prosperare. Essa raggiunse negli anni Ottanta un tetto di oltre cinquemila pezze prodotte annualmente, con circa millesettecento mulinelli in funzione presso le famiglie contadine della zona tra Mogliano e Martellago, a nord di Mestre, e trecentoquaranta mulinelli nel territorio coneglianese (135).
L'esempio del Lischiuta non restò senza seguito, perché altri mercanti-imprenditori ne imitarono le mosse, come quel Giuseppe Zopetti, privilegiato nel 1773, che faceva anch'egli tessere in città e filare il lino nel Trevigiano, Padovano e Friuli. A Venezia confluiva, per essere esportata, gran parte della produzione della ditta Mora, produttrice di indiane stampate e di fazzoletti, che aveva il suo centro aziendale nella vicina Mirano (136). Altre importanti aziende furono quelle di Bernardo Beggio e Giovani Bedena, che già nel 1750 facevano girare le ruote rispettivamente di milletrecentosessantanove e quattrocentodiciannove mulinelli. Il mercante Giovan Battista Grego avviò la tessitura di rigadini e dimitti presso l'ospedale di S. Maria Maggiore, dove si contavano trentadue telai battenti, a dodici dei quali provvedevano "povere figlie tolte dall'ozio", e a Campalto. Anch'egli si serviva del lavoro a domicilio di circa trecentocinquanta famiglie, distribuite nella zona della gronda lagunare, tra Gambarare a sud-ovest e Tessera a est(137).
L'industria cotoniera veneta si affermò subito come un settore dove operavano aziende di grande respiro commerciale, capaci di mobilitare una massa notevole di manodopera urbana e rurale e di sollecitare un atteggiamento di sostanziale laissez-faire da parte del governo. I suoi livelli tecnologici e organizzativi purtroppo non ci sono ben noti, dato che finora è stata posta scarsa attenzione verso questo comparto, che pure ebbe in tutta Europa un ruolo di così grande rilevanza nel passaggio al sistema di fabbrica.
Nella sola Venezia la produzione fisica salì costantemente nella seconda metà del secolo: nel 1794 furono ben ottomilanovecentoquattro le pezze di tele miste fabbricate e tremilasettecentoventotto quelle di rigadini. I telai battenti a Venezia salirono da centocinquantadue nel 176o, di cui trenta del Lischiuta, a trecentosettantotto nel 178o, di cui quarantasette del Lischiuta e trentasei all'ospedale della Pietà (138). La manodopera "avventizia", soprattutto donne non inquadrate nella corporazione dei tessitori, divenne in città sempre più numerosa, mentre si mobilitò forza lavoro a basso costo, grazie all'utilizzo di manodopera coatta negli ospedali della Pietà e degli Incurabili e alle Zitelle. Secondo Francesco Battaglia, l'Arte dei fustagneri contava nel 1788 un numero di trecentoquarantasei iscritti tra maestri, lavoranti e garzoni, ma il settore impiegava circa diecimila persone, tra Venezia e la Terraferma, nelle diverse operazioni del ciclo (139). Furono produzioni non di lusso quelle che uscirono dalle telerie veneziane del Settecento, di qualità certo medio-bassa, di basso valore aggiunto, non in grado di contrastare l'importazione di prodotti come le tele battiste. Ma vedere in questo, oggi, un vizio di fondo del settore sarebbe come rammaricarsi che i cotonieri del Lancashire non fossero stati anche degli ottimi artigiani! Probabilmente, il vero differenziale con le industrie più avanzate in campo europeo fu determinato dal livello tecnologico, a sua volta dipendente dai costi comparati della manodopera. L'abnorme dilatazione dell'area del lavoro a domicilio stava forse proprio a dimostrare una scarsa convenienza a passare a forme di meccanizzazione avanzata. Ciò che mancò in questo caso fu dunque non l'espansione dell'offerta, quanto la modernizzazione degli impianti.
Infine, un ramo minore, ma non privo d'importanza, fu quello delle tele cerate "schiette ed a fiori" per la produzione di ombrelli ed altro. La prima ditta fu quella dei fratelli Giovan Andrea e Pietro Bertolini, che ottenne nel 1756 una privativa per tutto lo Stato e l'esenzione dai dazi (140). Dal 1760, la ditta dei fratelli Rocchi produceva circa 10.000 braccia all'anno (oltre 6.800 metri) di tele cerate, riuscendo in tal modo a competere ormai alla pari con le importazioni delle tele bolognesi (141). Anche in questo caso fu possibile lanciare un settore nuovo, in grado quanto meno di far fronte alla domanda cittadina.
Venezia distretto industriale
Il setificio
Fin dal Duecento la lavorazione della seta aveva rappresentato una branca importante dell'industria cittadina. Dopo la flessione del tardo Cinquecento e dell'inizio del Seicento, la produzione di drappi di diversa qualità si andò stabilizzando. Nella seconda metà del Seicento e all'inizio del Settecento la produzione fisica ritornò a diminuire, ma in termini di valore del fatturato rimase probabilmente ancora una volta stabile, dato che Venezia si specializzò in questo periodo nella fabbricazione di pezze tessute con filo di seta e oro (142). Attraverso rigide norme corporative, la difesa della qualità del prodotto e il mantenimento dei segreti di lavorazione vennero tenacemente perseguiti nel tempo. Il blocco delle importazioni e il divieto di produzione dei damaschi e dei tessuti auroserici in altri luoghi dello Stato contribuirono ad assicurare al settore un buon livello di protezione.
Sottoposte al controllo dei mercanti-imprenditori riuniti nell'officio seda, le Arti dei lavoratori del setificio erano quattro: filatori, tessitori, tintori, tira-battiloro. Teoricamente la loro esistenza doveva assicurare una regolare trasmissione del mestiere, garanzia di ordine e di un alto livello qualitativo dei tessuti (143). Ma come nessun altro dei settori manifatturieri veneziani, quello del setificio si trovava attraversato da contrasti d'interesse, da conflitti, da diverse interpretazioni delle norme e da particolari intrecci di natura economica.
La stessa sedimentazione secolare e il linguaggio in cui si esprimevano li rendono oggi di difficile lettura. Già nel secondo Seicento, ad esempio, si aprì un'irrisolvibile vertenza sulla tessitura femminile, che vedeva opposti da un lato i mercanti e dall'altro i maestri tessitori. Nel 1687, i lavoranti tessitori potevano lamentare che loro rovina e rovina del settore erano le donne che venivano impiegate fraudolentemente anche al telaio, mentre avrebbero dovuto solo manovrare i licci per i tessuti operati. Contestualmente, però, c'era chi era pronto a giurare che l'impiego di donne al telaio costituiva cosa usuale, almeno a memoria d'uomo (144). Poco dopo, mentre i mercanti segnalavano una grave carenza di manodopera specializzata, i tessitori denunciavano per converso lo stato di disoccupazione o di sottoccupazione in cui versavano gli iscritti (145).
Purtroppo, tutte le valutazioni sull'andamento globale del setificio veneziano, anche per il Settecento, devono tener conto di queste ineliminabili contraddizioni delle fonti. Adduciamo subito una prova inconfutabile. Nella relazione stesa nel 1769 dall'inquisitore alle Arti Francesco Morosini, che di setificio se ne intendeva essendo stato per ben due volte coinvolto in progetti per il suo riordino, e che è già stata presa in considerazione per dimostrare l'irreversibile decadenza del ramo (146), si trova una sconcertante affermazione. Morosini, dopo aver esposto alcune cifre che dimostrerebbero una contrazione produttiva del 30% in vent'anni, dichiarava candidamente che le carte da lui consultate erano talmente confuse che lui stesso nutriva non pochi dubbi sulla realtà di fatto (147)!
Un primo punto fermo è che il setificio conservò per tutto il Settecento un numero di addetti certamente notevole, tanto che fu il settore produttivo cittadino che contava, e di gran lunga, il maggior numero di occupati. Nel 1750 nell'Arte dei tessitori vennero censiti settecento capimaestri, duemilatrecentodieci tra mogli, figli e vedove di maestri, seicento tra garzoni e lavoranti e circa tremila lavoratori e lavoratrici non iscritti, per un totale di oltre seimilaseicento persone (148). La statistica del 1773 riporta rispettivamente i seguenti dati: quattrocentonovantasette, novecentosettantadue, centoventinove, quattromilasettecentoquarantasei, per un totale di seimilatrecentoquarantaquattro addetti. Infine, il prospetto di del Senno registra un numero complessivo di settemilasessantacinque lavoratori. Altri censimenti apparivano molto meno ottimistici sull'effettiva occupazione, ad esempio: duemilacinquecentocinquantasei persone nel 1752 e millesettecentoquindici nel 1783 (149). La confusione nasceva da un lato dalla sopravvalutazione dell'effettivo impiego degli iscritti all'Arte, che potevano non esercitare di fatto il mestiere; dall'altro, dalla sottovalutazione o addirittura dall'omissione della manodopera femminile impiegata come supporto al lavoro di tessitura: orditrici e incannatrici, rimettine e groparesse, dinaresse e spoline.
Confrontando i dati per la metà del secolo, possiamo azzardare una stima di quattromila persone impiegate, considerando che nel 1752 gli iscritti all'Arte effettivamente al lavoro risultavano millecentoventotto. Vista la crescita numerica della manodopera non corporata, si può presumere che nella seconda metà del Settecento l'occupazione effettiva crescesse forse fino ad oltre cinquemila persone. Analoghe considerazioni si possono fare sul numero dei telai in attività: l'opacità delle fonti, la confusione tra telai in lavoro e non, la necessità di occultare, almeno fino al 1782, l'impiego delle tessitrici, ci inducono a non prestare troppa fede alla documentazione. Una cifra oscillante attorno al migliaio può sembrare plausibile (150).
Non mi sembra, invece, si possano trarre conclusioni definitive circa una presunta diminuzione della capacità produttiva nel corso del secolo, nonostante i dati a suo tempo forniti da Bruno Caizzi, dai quali risulterebbe una media di circa settecento telai nel decennio 1781-1790. A prescindere che il loro numero era per l'epoca ugualmente ragguardevole, si trattava solo dei telai ufficialmente notificati dai mercanti e di quelli regolarmente intestati ai capimaestri, che tra l'altro non potevano tenerne più di sei ciascuno (151). A fortiori, i dati sulla produzione globale nulla possono dire di definitivo, soprattutto considerando che nel corso del Settecento andò sviluppandosi la lavorazione di tessuti alla piana, cioè tessuti coi più semplici intrecci e per lo più colorati a tinta unita: cammellotti, rasi, lustre, lustrini, zendali, damaschini, velluti, droghetti. Diminuiva, invece, la produzione dei preziosi broccati, dei damaschi e dei tessuti con oro. Nell'aprile del 1780, su settecentosessanta pezze ufficialmente in lavorazione solo diciotto risultarono tessute con filo d'oro. Inoltre, la possibilità offerta ai singoli maestri di lavorare in proprio con i due cosiddetti "telai di grazia" sembrava favorire la crescita di un mercato clandestino comandato direttamente dai mercanti levantini (152). Negli ultimi due decenni del secolo i giudizi dei contemporanei sul setificio veneziano, per quanto cauti, erano di solito positivi.
"L'uso dei drappi di seta era un tempo solo dei più doviziosi e dei signori: presentemente è di tutto il popolo e se ne fa smercio nelle città e nei contadi. Anche la qualità più imperfetta si consuma e viene ricercata la sola bilancia [sic] e leggerezza nel prezzo" (153). La produzione veneziana del Settecento va inquadrata in un contesto internazionale di aumento dei consumi, particolarmente vivace per quel che riguarda i generi del setificio. La progressiva affermazione del tessuto serico, magari nelle qualità più grossolane, tra i "lussi dei contadini" e a maggior ragione tra quelli dei ceti urbani spostò l'asse della produzione e della commercializzazione (154). La crescita della domanda internazionale di seta tratta e ritorta, che aveva come perno la Francia, non escludeva la possibilità di conservare o espandere delle nicchie di mercato per i tessuti, attraverso sbocchi tradizionali (il Levante) o meglio ancora facendo leva sulla domanda interna. Abbassando magari la qualità, dirigendo l'offerta verso generi di minore complessità di lavorazione o specializzandosi in generi particolari di largo consumo (ad esempio, le passamanerie nel caso di Padova) era possibile far fronte a una concorrenza estera assai agguerrita. Questo è quanto accadde per le tessiture venete, a Venezia come a Vicenza.
Nel Settecento furono certo le manifatture di Lione a dettare legge, sia per quanto riguarda la moda, sempre più esigente e mutevole, sia per quel che riguarda le stoffe di maggiore prestigio e valore. Incapaci di effettuare la tecnica lionese del point rentré, i Veneziani riuscirono con i loro accostamenti cromatici piatti a produrre delle imitazioni così perfette che indussero il Goldoni a citarle come esempio di un tipo particolare e tanto diffuso di credulità. In Una delle ultime sere di carnovale il mercante Bastian risponde al tessitore Lazzaro, in merito alla qualità dei tessuti da questi fabbricati: "Stupendi: i me li ha magnai dale man. V'arecordeu quel raso con quei finti martori? Tutti lo credeva de Franza" (155).
Un tentativo esemplare d'introdurre a Venezia nuove produzioni, promosso diretta-mente dal governo nel 1727, riguardò la fabbricazione dei veli "ad uso di Bologna". Grazie a un intermediario milanese, tale Giovanbattista Fanelli, sposatosi a Venezia, si cercò di attrarre maestranze specializzate dal capoluogo emiliano, attuando una vera e propria trattativa che si concluse con un privilegio industriale a favore dello stesso Fanelli. L'operazione ebbe un esito piuttosto sfortunato, perché le autorità bolognesi, giustamente preoccupate per la diffusione del segreto industriale, riuscirono a bloccare i cinque colli e la cassa che contenevano diversi strumenti e parti di telaio necessari per avviare la produzione. Approdò comunque a Venezia, pur braccato dal tribunale bolognese, il principale protagonista dell'operazione di spionaggio industriale, Ludovico Aureli, assieme alla moglie, ai figli e ad una lavorante. Sappiamo che questi personaggi ritornarono poi tutti a Bologna e che vennero successivamente perdonati (156). Ma la loro breve presenza in laguna fu forse sufficiente a far decollare una nuova iniziativa. Nel maggio del 1 730 il senato veneziano emanò a favore di Maria Teresa Lorio un privilegio industriale articolato in dieci capitoli che ricalcava i termini degli accordi a suo tempo presi con i Bolognesi e con il Fanelli. All'inizio del 1732 la ditta Lorio fabbricava veli "ad uso di Bologna" a S. Giacomo, facendo battere un centinaio di telai, alcuni dei quali dentro all'ospedale degli Incurabili, e servendosi di un "apparecchiadore" e di due increspatori bolognesi. La ditta utilizzava anche un filatoio idraulico a tre ruote dislocato a Treviso, probabilmente una di quelle macchine particolari che servivano appositamente per ottenere il filato per i veli (157).
La lavorazione dei veli, tuttavia, non si sviluppò in modo significativo a Venezia, se non fu addirittura abbandonata, così che non venne mai menzionata come una delle branche del setificio cittadino. Ancora nel 1783, però, il mercante Basilio Spiro ottenne un privilegio in tal senso, impegnandosi ad effettuare l'increspatura dei veli in gran segreto. Ci si riprometteva d'inserirsi in un giro d'affari che ammontava in totale a 250.000 ducati l'anno, grazie alle riesportazioni verso il Levante e al consumo interno "ad uso dei teatri e delle donne del popolo" (158).
In laguna venivano lavorati anche i cascami di seta, sempre sull'esempio bolognese. Nel 1753 erano circa trecento le "bavellere" impegnate in questa attività('5°). Infine, resisteva pur con difficoltà l'Arte delle calze di seta "all'inglese", tessute a telaio.
Introdotta a Venezia nel 1657, negli anni Settanta del Settecento essa poteva ormai contare solo su poche decine di telai battenti. Il rigido divieto imposto alla tessitura femminile (1704), questa volta puntualmente rispettato, impedì l'abbattimento del costo del lavoro, fino a quando nel 1780 venne deciso di eliminarlo (160).
Tutto questo dimostra che l'industria veneziana della seta poté nel corso del Settecento elaborare ancora diverse risposte, in funzione delle esigenze di mercato e delle possibilità di far leva sulle capacità tecniche e professionali già esistenti. Diversificazione produttiva, imitazione, concentrazione territoriale e concorrenza tra le varie imprese furono gli elementi che consentirono al settore una sopravvivenza forse molto meno stentata di quanto si sia spesso supposto. Scriveva ancora Goldoni: "Xe un pezzo; che i dessegni de sto paese piase, e incontra per tuto. Sia merito dei dessegnadori, o sia merito dei testori, i nostri drapi ha ciapà conceto" (161). Se l'operazione di filatura, con la corrispondente corporazione dei filatori, tese a restringersi sempre di più, in seguito alla diffusione in Terraferma dei filatoi idraulici, non altrettanto si verificò per la tessitura. Francesco Morosini ne segnalò alcuni nuovi aspetti strutturali: la tendenza alla concentrazione delle imprese, la lavorazione di generi meno pregiati rispetto al passato, la distanza sempre più evidente tra una legislazione vincolistica e una realtà variegata, spesso a rigor di termini semi-illegale. Ciò che agli occhi dei contemporanei si presentava come sintomo di "decadenza", d'indisciplina, di confusione, in un'interpretazione evidentemente morale del fatto economico, dev'essere meglio concepito come spia di un mutamento in atto, di un diverso dinamismo degli operatori. Si può pensare che un intero settore fosse in irreversibile declino, se lo stesso Morosini constatava che i mercanti di seta non avevano motivi di lamentela e che gli utili stimati potevano variare da un minimo del 33% a un massimo del 75% (162)?
Fu forse quest'ultimo sacrosanto motivo che indusse un gruppo di capitalisti a finanziare con 24.000 ducati una grande manifattura accentrata, dislocata a S. Chiara, nel "recinto di S. Andrea", per la fabbricazione di rasi "ad uso orientale". La fabbrica risultava dotata nel 1780 già di venticinque telai, "costrutti con le più industriose avvertenze, che superano tutti quelli sinora immaginati dai veneti e dagli esteri manifattori". Questa grande impresa, diretta da Giovan Andrea Zanibon, si trovava nel 1789 in estrema difficoltà, perché i soci avevano sciolto la compagnia e ritirato i capitali conferiti. Ma nessuno avrebbe mai pensato di avviare un'azienda di tali dimensioni, se non ci fosse stato un certo ottimismo nei confronti dei risultati conseguibili (163).
Scontri, cambiamenti, tensioni si tradussero sul piano istituzionale in un lungo e non del tutto sterile confronto su due questioni fondamentali: il lavoro femminile e la possibilità per i mercanti di dirigere direttamente il processo produttivo senza passare per le botteghe dei singoli capimaestri.
Il divieto per le donne di lavorare al telaio venne statuito nel 1680 e ribadito a più riprese, sia dall'Arte dei testori, sia dal magistrato dei consoli dei mercanti, nel 1710, 1718, 1728. Contemporaneamente, lo stesso senato veneziano si trovò a dover regolarizzare singole posizioni, a volte con provvedimenti consistenti, come nel 1688-1689 a favore di ben cinquanta tessitrici (164). La spiegazione di una situazione apparentemente tanto contraddittoria stava nelle retribuzioni più basse che venivano erogate alla manodopera femminile, uno stimolo troppo forte per non lusingare tanti capimaestri. Le donne venivano di norma reclutate tra le lazzaruole, cioè tra le assistenti che avrebbero dovuto soltanto manovrare le corde necessarie per eseguire il disegno della stoffa attraverso il corretto movimento dei licci del telaio. Queste giovani venivano pagate a settimana e non a cottimo come i maestri e i lavoranti legittimi, tanto che si verificava il fenomeno che i maestri privi di telai erano costretti per sopravvivere ad accettare a loro volta l'impiego, scarsamente retribuito, di lazzaruoli. La riduzione del costo del lavoro, la connivenza all'interno dei laboratori e la scarsa capacità dell'Arte di perseguire i numerosi trasgressori facevano sì che il fenomeno fosse "di quel che si sanno, ma che non si può vedere" (165). Mercanti e maestri più facoltosi miravano ad ottenere mano libera in questa materia, ma si trovarono comunque a scontrarsi con una vivace resistenza.
La grande revisione del regolamento dell'Arte dei tessitori, attuata tra il 1753 e il 1755, non fece che spostare quello che si era rivelato il problema più spinoso. L'equiparazione delle donne agli uomini, sottoposte da qui in avanti ad identico curriculum di garzonaggio e lavoranza, con la possibilità di accedere al ruolo di "mistro operaro" o di "capomaestro" con bottega propria, costituiva una soluzione di compromesso che non modificava i rapporti di forza. Il previsto censimento di garzoni e lavoranti già presenti nelle tessiture, dell'uno e dell'altro sesso, doveva preludere ad una sanatoria, a partire dalla quale si sarebbero dovute seguire con il più esatto scrupolo le norme corporative (166).
Venne effettuata tra il febbraio e il marzo del 1754 una grande ricognizione in settecentonovantacinque laboratori di tessitura, senza risultati particolarmente apprezzabili, mentre nello stesso anno l'inquisitore alle Arti Marc'Antonio Dolfin poteva rilevare che il punto dell'iscrizione delle donne all'Arte contrastava con gli interessi di quei maestri che volevano utilizzarle "con poca mercede soggette" (167). Le ragazze continuarono in realtà ad essere assunte come orditrici o lazzaruole, passando ben presto, se capaci, al telaio: "discrete nei prezzi e fedeli" queste lavoratrici erano il vero "sostegno dell'Arte". Mercanti e capimaestri imprenditori non intendevano più sottoporsi al controllo corporativo: il lavoro femminile, preciso e poco costoso, era il perno su cui si reggevano le capacità concorrenziali del settore (168).
Nonostante qualche sporadica denuncia alle magistrature, nel 1761 si stimarono in numero di quattrocento le persone assunte dopo il 1755 in modo del tutto irregolare (169). L'anno successivo si deliberò una nuova sanatoria e più tardi, nel 1776, il senato sollecitò le magistrature competenti a dare attuazione a quel principio di liberalizzazione del settore che era già stato prospettato di massima nel 1769 e nel 1771.
Si pervenne così nel 1782 alla drastica soluzione, tanto caldeggiata da Andrea Tron. L'Arte dei tessitori venne sciolta e il corpo dei mercanti trasformato in Università della seta, col proposito dichiarato di annullare la rappresentanza di quelli che ormai venivano definiti tout court "operai". L'Università stessa doveva provvedere alla registrazione e al controllo della manodopera, secondo il tradizionale curriculum corporativo, senza ormai distinzione tra maschi e femmine. Venivano definiti capimaestri/e solo coloro che tenevano aperto effettivamente un laboratorio, fino a un massimo di sei telai, con la riserva che le donne non avrebbero potuto far tessere seta per proprio conto (170). Il problema fondamentale risultò così superato. Abolita l'Arte dei tessitori, non esistevano più né il controllo sul mestiere, né la possibilità di fissare dei minimi salariali, né il rischio dell'apertura di pericolosi contenziosi.
Dopo molti secoli, la storia della corporazione si concludeva con la più assoluta subordinazione dei lavoratori al capitale mercantile. L'ingresso delle donne nel mondo produttivo aveva finito per scardinare, anche sul piano legale, l'ordine tradizionale nei rapporti di produzione.
Per quanto riguarda le tessiture direttamente gestite da mercanti, si deve innanzi tutto registrare il fenomeno dell'ascesa di alcuni capimaestri, che arrivarono addirittura a tenere bottega in casa propria (171). Fu per questo che il permesso concesso ai mercanti di gestire proprie fabbriche, avendo almeno dodici telai, non fu contestato dall'Arte dei tessitori.
La convergenza d'interessi tra i più facoltosi capimaestri e i mercanti consentì nel 1753 di far passare una norma per certi versi davvero rivoluzionaria. Senza che il processo lasciasse tracce molto evidenti, la stragrande maggioranza dei maestri si ritrovò privata dei mezzi di produzione, prima di tutto nei fatti. Soltanto negli ultimi tre decenni del secolo le rilevazioni registrarono la distinzione nella proprietà dei telai. Nel 1778, ad esempio, i telai denunciati dai mercanti furono cinquecentocinquantadue, contro i soli centosessantotto intestati ai tessitori. Non solo, ma molti di questi battevano in realtà per conto dei capimaestri più abbienti, senza cioè che il tessitore godesse di un'effettiva autonomia produttiva (172). Nel 1780, il rapporto saliva a cinquecentoottantuno telai di proprietà dei mercanti (76%), contro centosettantanove dei capimaestri. La rilevazione, effettuata dall'officio seda, metteva in evidenza l'esistenza di 32 mercanti-imprenditori. La media era di diciotto telai e di dieci maestri impiegati per ciascuna ditta, con alcuni fenomeni di vero e proprio gigantismo: i centotrenta telai di Giuseppe Cavenezia e i cinquantuno di Niccolò Gottardi. Esistevano inoltre cinque ditte di capimaestri-mercanti, dotate complessivamente di quarantasei telai, e ottantasette capimaestri che facevano battere in proprio uno o due telai. Su questi ultimi gravava però il fondato sospetto che la tessitura fosse svolta "per conto di persone per legge proibite" (173). Ben prima che arrivasse la definitiva subordinazione sul piano giuridico, dunque, la dipendenza economica dei tessitori dai mercanti si era spinta fino a livelli assai elevati. Le stesse funzioni dell'organo di autogoverno dei tessitori si erano talmente ridotte che nel 1778 il capitolo generale dell'Arte si radunò alla presenza di soli centoventi capimaestri (174). Sul piano legislativo, l'opera si completava con la libertà d'impresa concessa ai "capitalisti" non veneziani, questione già deliberata nel 1768 (175).
In conclusione, il ramo delle seterie rappresentò nel Settecento il caso più eclatante di una trasformazione radicale dell'assetto corporativo. I fatti economici anticiparono sempre la prassi legislativa, che finì semplicemente con l'adeguarsi alle mutate esigenze del mondo produttivo. L'attenzione si spostò definitivamente dalla tutela del prodotto e dei segreti di fabbricazione al contenimento dei costi e alla ricerca di nuove strategie di mercato.
L'imitazione dei generi più in voga, l'adeguamento alla moda, il tentativo di ottenere prodotti più standardizzati e meno costosi costituirono le preoccupazioni fondamentali dei mercanti-imprenditori veneziani. A pagare il prezzo più salato di queste trasformazioni furono certamente filatori e tessitori, quegli stessi artigiani che avevano nel passato reso grande il setificio veneziano. Al loro posto, però, la manodopera femminile trovò ampie possibilità d'impiego. Maggiormente sfruttate, più docili in virtù della loro supposta inferiorità sul piano giuridico, le donne offrirono a questo settore un contributo decisivo. Ci fu infine anche chi si preoccupò della loro tutela, anticipando un nuovo tipo di legislazione sul lavoro minorile che non aveva più nulla a che fare col sistema delle Arti. L'inquisitore Francesco Morosini, ancora lui, statuì nel 1788 "che da oggi in avvenire non possano esser accettate figlie [ragazze] [...] se non avranno compiuti gli anni dodici almeno" (176).
L'industria tipografica
Come altre attività industriali, l'editoria e la stampa veneziane avevano conosciuto, dopo il 1630, alcuni decenni di drammatico ripiegamento. Le difficoltà iniziate verso la fine di quello che resterà il secolo d'oro, il Cinquecento dei Manuzio e dei Giolito, si aggravarono a causa di una più agguerrita concorrenza estera e della caduta degli investimenti nel settore. Gli stessi meccanismi regolatori del sistema corporativo si disarticolarono, a fronte delle evidenti differenziazioni che stavano emergendo all'interno dell'Arte dei librai e degli stampatori, in conseguenza del periodo di crisi. Tra gli stessi maestri matricolati si contavano non pochi disoccupati, nullatenenti, semplici operai o venditori ambulanti. L'imprescindibile necessità di attrarre capitali freschi e nuove iniziative imprenditoriali si scontrava con lo scadimento delle capacità professionali e con le incertezze determinate dalle scarse aspettative di profitto. A partire dagli anni Settanta del Seicento, però, l'Arte reagì a questo stato di cose varando una normativa diretta a chiudere i ranghi dei maestri, in favore di quei soggetti che apparivano dotati di opportune capacità finanziarie o di un'indiscussa professionalità. Contemporaneamente, si affermò sempre di più il ricorso a manodopera priva di regolare contratto di garzonaggio e di lavoranza, separando di fatto la posizione dei lavoratori dalla gestione d'impresa (177).
Ma sul finire del Seicento, più che le nuove strategie messe in atto dalla corporazione, incisero sulla ripresa della stampa veneziana le nuove opportunità che si presentarono sul mercato iberico e italiano, grazie al periodo di momentanea difficoltà che attraversavano i concorrenti olandesi e francesi. Le scelte produttive degli editori veneziani, di cui meglio renderà conto Marino Zorzi in questo stesso volume, si orientarono opportunamente verso generi di largo consumo, come i testi di devozione, i catechismi, i breviari, i classici latini; libri sempre molto richiesti dai religiosi dei paesi cattolici. Il punto di forza furono proprio i messali e i breviari, stampati in rosso (per le rubriche) e in nero (per il testo), che divennero una vera e propria specialità delle stamperie veneziane. Venezia arrivò a detenere assieme a Parigi il primato europeo nella vendita di queste produzioni di tipo tradizionale e di scarso interesse culturale. La ditta Baglioni, all'inizio del Settecento, superava in questo settore perfino la prestigiosa casa Plantin (178).
Trainate dall'esportazione di questo genere di testi, l'editoria e la stampa veneziane poterono riprendere quota e riproporre nuovamente buone edizioni, opere aggiornate, lavori anche di grande impegno e mole. Negli anni Trenta del Settecento, all'apice di questo periodo di prosperità e di sviluppo, l'itinerario delle Mercerie poteva apparire come "un accademico liceo", dove le numerosissime botteghe dei librai facevano le veci a un tempo di mostra permanente, biblioteca diffusa e luogo di dibattito per un pubblico eterogeneo e appassionato. Apparvero nuove tipografie, mentre aumentava la capacità produttiva delle singole aziende. Nel 1735 vennero censite ventisei stamperie, per un totale di novantasei torchi attivi, forse meno di quelli in attività a metà del Cinquecento, ma la cui produttività era nel frattempo di molto aumentata (179). Questa cifra record era destinata a scendere nei due decenni successivi, ma le esportazioni continuarono a salire fino ad oltre il mezzo milione di libbre grosse di carta stampata all'anno (238 tonnellate) della prima metà degli anni Cinquanta, pari a un valore approssimativo superiore ai 200.000 ducati (180). Nel 1752 vennero censiti ottantatré torchi attivi, distribuiti in trentanove tipografie. Nelle stamperie lavoravano circa cinquecento persone, a cui andavano aggiunti i centotrentasei matricolati dell'Arte (compresi, però, i librai), sessanta commessi di libreria e trecento tra rilegatori e commercianti di carta.
La valenza del network stava proprio in una stretta interrelazione tra commercio e industria e in una specializzazione produttiva che non escludeva fortunate incursioni nel campo dell'industria editoriale più impegnata. Il circuito, che poteva contare anche sull'apporto del fiorente settore cartario della Terraferma, dalla riviera di Salò alle cartiere trevigiane (181), faceva perno sulla forte concentrazione geografica delle aziende che le metteva in grado di scambiarsi prodotti, semilavorati e manodopera specializzata. Rimaneva ormai eccezionale il caso, frequente agli esordi dell'arte della stampa veneziana, in cui editore, tipografo e libraio fossero la stessa persona. L'integrazione verticale nelle varie fasi di elaborazione del libro sempre più aveva lasciato posto ad un complesso di operazioni specializzate e interrelate. Pochi erano ormai gli stampatori-librai che continuavano ad affiancare all'attività tipografica il lavoro di bottega, anche se fra questi spiccavano i nomi delle ditte di più grande peso, come i Baglioni o i Pezzana. Furono proprio i piccoli librai, però, ad avvicinarsi sempre meglio ad un'accezione moderna dell'editoria, elaborando precise strategie editoriali e seguendo con ogni cura la rete di distribuzione. Nel corso del Settecento le piccole tipografie, dal canto loro, riuscirono a far fronte con maggiore successo a una domanda piuttosto imprevedibile, grazie all'elasticità consentita dalla minore pesantezza dell'organizzazione aziendale. Ormai subordinati per la maggior parte alle commesse degli editori erano però proprio i tipografi a dover subire le conseguenze delle congiunture negative. Il comparto industriale ancora una volta cedeva la propria autonomia a fronte dell'investimento finanziario, sempre più spesso effettuato anche da anonimi "capitalisti" che si celavano dietro la ragione sociale dei librai iscritti all'Arte (182).
Una dimostrazione evidente dei molteplici legami e dei comuni interessi di librai, tipografi ed editori è il fatto che le librerie veneziane, già all'inizio del secolo, finirono per proporre nei loro cataloghi anche le opere commercializzate da altri. Il sistema, che Gasparo Gozzi attribuì ad una felice intuizione di Giovanni Manfré, agente della stamperia del Seminario di Padova, prevedeva che ogni libraio veneziano offrisse ai propri clienti tutti i titoli disponibili nei cataloghi e nei magazzini dei colleghi. Il prezzo di vendita delle diverse edizioni risultava pressoché inalterabile, in quanto i librai si impegnavano a scambiarsi i libri tra di loro con un ribasso del 10-20%. Ciò consentiva, oltre che di smerciare con più rapidità i libri senza ricorrere a sconti vertiginosi, l'instaurarsi di forme di comoda compensazione tra i librai e la costituzione di un consorzio di vendita che favoriva il sostegno dei prezzi verso l'esterno (183). In pratica, una certa specializzazione nell'iniziativa editoriale e tipografica non impediva alla singola ditta, grazie a questo stratagemma, di coprire quote di mercato molto più ampie, con un margine di utile sufficiente a remunerare la propria e l'altrui attività. Se il Bettinelli fu impegnato negli anni Cinquanta quasi esclusivamente a far stampare le opere di Carlo Goldoni, altri importanti editori cercarono di affiancare alla prevalente e fiorente industria di messali e breviari opere di carattere scientifico e teologico.
Fino al 1760 circa parve che l'incremento continuo della domanda potesse garantire all'industria tipografica ed editoriale un facile cammino, sulla base delle fondamenta gettate alla fine del secolo precedente.
Da quel momento, invece, una crisi repentina ridimensionò tutte le aspettative. Tra il 1754 e il 1770 il numero delle stamperie si ridusse da quaranta a trenta, quello dei torchi attivi da settantasei a cinquantotto, la percentuale di utilizzo degli impianti calò del 15% (184). Il tracollo ebbe come causa principale l'espulsione dei Gesuiti dal Regno del Portogallo (1759), seguita da quella dai domini dei Borbone, con la conseguente contrazione di quasi un terzo della domanda di opere teologiche e di devozione. Si era arrivati, cioè, a un tornante decisivo nella storia dell'industria culturale: la svolta epocale dell'illuminismo imprimeva una direzione diversa e non del tutto imprevista al mondo editoriale. Tuttavia, questo grande cambiamento trovò il mondo del libro veneziano piuttosto impreparato e, soprattutto, attraversato da inconciliabili conflitti interni. Allo scollamento tra librai e stampatori si era aggiunto il proliferare di piccole iniziative precarie e senza solidità finanziaria, la cui attività era stata stimolata dalle aspettative di profitto che si erano aperte nella prima metà del secolo. Inoltre, lo sviluppo dell'industria editoriale e tipografica nella Terraferma veneta si era materializzato in laguna nell'ammissione all'Arte nel 1750 della grande e spregiudicata firma dei Remondini di Bassano. Il suo arrivo provocò, a partire dal 1761, un lungo e drammatico braccio di ferro, che trovava origine proprio nell'attivismo in materia di nuove edizioni e di ristampe, dimostrato dai Remondini. In questa occasione, l'Arte veneziana si spaccò in due fazioni: da un lato le "vecchie" case, importanti e di più antica tradizione, che avevano come capofila i Baglioni; dall'altro le "nuove" case dei Remondini e dello Zatta, alleate ai piccoli stampatori veneziani('85). Il contrasto si protrasse nei fatti fino al 1789, nonostante le riforme promosse negli anni Sessanta da Gasparo Gozzi e la successiva "chiusura" dell'Arte e il blocco dei privilegi di stampa degli anni 1780-1781. Nella buona sostanza, il tentativo di limitare drasticamente il numero delle ristampe e di escludere dal governo degli interessi dell'Arte i numerosi editori di scarso peso - provvedimenti caldeggiati dal partito dei "vecchi" - fallì miseramente di fronte al dinamismo dei "nuovi" e dei loro accoliti. Così, mentre tendevano a scomparire di scena i protagonisti del primo Settecento, dai Baglioni ai Manfré al Pasquali, emergeva una nuova élite. Il volto del settore si modificava a favore di un'editoria più spregiudicata e libera. Si guardava ormai con più interesse al nuovo gusto dell'epoca e alla diffusione dei periodici, simbolo della nuova era, per i quali Venezia ebbe il primato assoluto in Italia(186).
Su queste basi profondamente mutate, l'industria tipografica conobbe negli ultimi anni della Repubblica una nuova piccola ripresa. Nel 1793 si raggiunse il numero di trentotto stamperie aperte, con quattrocentosette lavoratori impiegati e ottantotto torchi attivi. Il ripiegamento sul mercato interno, o al massimo italiano, e la notevole contrazione delle esportazioni, completavano un quadro che si presentava certamente in chiaroscuro (187). La dissoluzione dei tradizionali istituti corporativi lasciava spazio all'ingresso nell'agone di nuovi stampatori-librai di successo, come Vincenzo Formaleoni, l'editore veneziano di Cesare Beccaria, o Antonio Fortunato Stella, che ritroveremo nel primo Ottocento a Milano come uno dei protagonisti del rilancio dell'editoria italiana in quel secolo. L'ambiente veneziano non aveva ancora perso il suo primato italiano, né aveva smarrito nel secondo Settecento quelle capacità di adattamento di cui necessitava una vera e propria produzione di massa. Fu solo durante la convulsa e difficile età napoleonica che l'industria tipografica ed editoriale entrò in una crisi senza ritorno, come dimostra il drammatico e rapido declino della ditta Remondini (188).
Contemporaneamente alle tormentate vicende sul versante editoriale, all'interno delle tipografie si consumò nel corso del Settecento l'atto finale dello smantellamento del modello corporativo. Dopo l'ingresso nel secondo Seicento di addetti al torchio (torcolieri) assunti senza vincoli di garzonaggio e lavoranza, nel primo Settecento i maestri stampatori estesero questa pratica anche ai compositori, mentre sempre più spesso i garzoni entravano in tipografia senza alcun contratto. Il risultato pratico fu che il lavoro non regolamentato divenne del tutto prevalente e che il tradizionale curriculum garzone-lavorante-maestro perse quasi del tutto il suo significato originario. Già nel 1706, del resto, erano soltanto quarantaquattro i lavoranti "regolari", contro l'infima cifra di quattordici garzoni (189). Si spiega così la controversia, scoppiata all'inizio del 1719 e che si espresse secondo il tipico codice corporativo, che vide opposti lavoranti e stampatori riguardo al rispetto delle norme per l'apprendistato e per l'accesso al grado di maestro. L'obiettivo non dichiarato del ricorso alle magistrature fu certamente quello del sostegno del salario: la libertà di fatto di assumere lavoratori non iscritti contribuiva a far lievitare l'offerta di forza lavoro, fino addirittura a minacciare i livelli occupazionali dei lavoratori corporati. Nonostante le decisioni favorevoli ai lavoranti, ad esclusione del diritto riconosciuto ai maestri di assumere liberamente i torcolieri, continuò a persistere uno iato evidente tra la norma e la prassi. La larga disponibilità di manodopera, anche nella più delicata operazione di composizione, rendeva molto difficile la difesa dell'esercizio esclusivo del mestiere, che aveva come punto fondamentale l'acquisizione di un'alta professionalità garantita dal regolare garzonaggio. Fu proprio manovrando sulla possibilità di assumere garzoni regolarmente registrati e garzoni cosiddetti "in soprannumero" che i maestri librai riuscirono a rintuzzare efficacemente le rivendicazioni dei lavoranti. Il divieto di tenere più di un garzone per stamperia assunto con regolare contratto venne utilizzato per chiudere il ruolo dei maestri, mentre si affermò contemporaneamente l'uso di servirsi di manodopera libera, senza alcun accordo scritto di garzonaggio, che di fatto finì per corrispondere a una vera e propria forma di legale precariato (190).
Il lavoro nelle stamperie risultava particolarmente gravoso, sia in termini di orario giornaliero, una media di circa dodici ore, sia per le necessità imposte dai ritmi di tiratura. Muovere la vite del torchio appariva un mestiere particolarmente duro e pesante, che sottoponeva il fisico a un logoramento tale da indurre ad abbandonare la professione piuttosto presto. I compositori erano invece soggetti a un forte affaticamento della vista, causato dalla necessità di fissare in continuazione i piccoli caratteri tipografici e probabilmente dalle condizioni non sempre ottimali d'illuminazione. Inoltre, gli ambienti chiusi, umidi e surriscaldati delle stamperie favorivano l'insorgere di malattie polmonari e dell'apparato respiratorio (191). Nonostante queste caratteristiche, il lavoro nelle tipografie veneziane settecentesche veniva scarsamente remunerato. Le tariffe salariali fissate dai riformatori allo Studio di Padova potevano essere inferiori a quelle di un semplice gondoliere. Ma soprattutto, la precarietà dell'impiego, spesso affidato ad accordi settimanali, e il mancato rispetto delle tariffe medesime rendevano ben poco attraente il lavoro di stamperia (192). L'altra faccia dell'espansione del primo Settecento e del recupero effettuato a fine secolo era dunque quella della compressione del costo del lavoro, una politica attuata spesso anche a discapito dei livelli qualitativi delle edizioni veneziane. Come nel caso del setificio, il livello di concorrenzialità del settore venne garantito in buona parte scaricandone i costi sulla manodopera salariata, strategia favorita dal venir meno delle protezioni di ascendenza corporativa. Uno stato endemico di tensione, di disagio, d'indisciplina spicciola all'interno dei luoghi di lavoro non poteva che costituire la logica conseguenza dei nuovi rapporti di produzione, ormai orientatisi in senso marcatamente capitalistico (193).
La vetreria
L'arte della lavorazione del vetro era andata via via strutturandosi come un sistema manifatturiero urbano ricco di articolazioni verticali e laterali. La rete produttiva, che faceva perno sul vetro soffiato e sui semilavorati muranesi, si completava a monte con i servizi commerciali e finanziari legati all'acquisto delle materie prime, innanzi tutto il silicato di calcio e le ceneri di soda. A valle, un'ampia e diversificata massa di operatori assicurava il collegamento con il mercato cittadino, nazionale ed internazionale. La presenza di una serie di attività verticalmente integrate e coordinate favoriva una stratificazione di abilità professionali, di legami istituzionali e interpersonali, di pratiche commerciali e di lavoro, che contribuirono a formare all'interno della città una vera e propria cultura industriale del vetro (194). Per lungo tempo, tutta l'Europa restò debitrice del know-how originale veneziano, mentre in laguna si combatteva una sorda lotta di trincea per evitare l'emigrazione della manodopera e dei suoi segreti professionali (195). Nel Settecento, già perduta la pretesa esclusiva su scala internazionale, l'ambiente veneziano riuscì brillantemente a rispondere a una domanda con caratteristiche sempre più di massa. Le sue strutture portanti, ereditate dal passato, ancora una volta riuscirono a flettersi, non senza difficoltà, di fronte a nuove necessità e sollecitazioni.
Il mondo del vetro si suddivideva nel Settecento nell'Arte "madre" di Murano, l'isola dove dovevano obbligatoriamente essere localizzate (già dal 1291) le fornaci e da cui provenivano i membri delle famiglie artigiane registrate nel "libro d'oro" istituito nel 1605, e nelle quattro Arti veneziane di seconda lavorazione: specchieri, fenestreri, margariteri e perleri. Le fabbriche di Murano potevano sia sfornare prodotti finiti, generi di vetro comune o di lusso o altamente specializzati, come le lenti; sia appunto rifornire di canne, lastre o dischi di vetro le quattro Arti "figlie". I semilavorati non dovevano uscire grezzi da Venezia, né naturalmente si poteva importare alcun genere di vetro forestiero. Teoricamente, si trattava di un rigido mercato regolamentato, in cui l'accesso al mestiere e l'iniziativa imprenditoriale risultavano sottoposti a uno stretto controllo, esercitato per i Muranesi addirittura dal consiglio dei dieci. Gli specchieri eseguivano l'operazione di spianare e lucidare le lastre di vetro muranese (dette "quari"), applicando poi su una delle due facce una foglia di stagno. Essi potevano poi vendere liberamente gli specchi finiti, arricchiti di una cornice, a volte anche di grande pregio. I fenestreri, invece, non dovevano far altro che adattare le lastre ai telai delle finestre o assemblare con la caratteristica piombatura i dischetti di vetro ("rui") usciti dalle fornaci. Più complesso era il lavoro dei margariteri, i quali trasformavano le canne forate in perle (oggi indicate col nome di conterie). A seconda del loro diametro, le perle venivano arrotondate a caldo in un'apposita padella ("ferrazza") o infilate su di uno spiedo e in seguito setacciate e lucidate. I perleri o supialume svolgevano una lavorazione analoga, trasformando però la canna massiccia con l'ausilio di una fiamma che fondeva il vetro, facendolo così colare su di un filo di ferro. I perleri ottenevano perle delle dimensioni volute e potevano poi, sempre con lo stesso sistema, eseguire sulle perle stesse dei disegni di smalto (196). Il sistema si completava con l'Arte degli stacioneri da vero, ossia i rivenditori di vetro al minuto sul mercato cittadino, mestiere però di scarso peso economico, a causa del diritto dei Muranesi di esercitare il commercio ambulante (197). In realtà, però, gli intrecci tra le diverse Arti e le differenze al loro stesso interno si rivelavano assai più complessi e meno rigidi di quanto si volesse lasciar trasparire attraverso l'ordinata immagine corporativa.
Le vetrerie muranesi avevano conosciuto nella seconda metà del Seicento alcune importanti novità. I gestori di fornaci, i cosiddetti patroni, che in realtà erano quasi sempre affittuari d'impianti di proprietà non di rado nobiliare, avevano potuto associarsi per breve tempo, tra il 1656 e il 1660, a finanziatori esterni (198). Il divario economico esistente tra i diversi produttori, che andava sempre più precisandosi in base alla partecipazione diretta ai traffici internazionali e alla diversificazione produttiva interna, aveva giustificato una simile deroga. Ciò era stato inizialmente controbilanciato dall'obbligo di pagare ugualmente i maestri iscritti alla corporazione, anche se il loro numero fosse stato eccedente rispetto alla domanda di forza lavoro (soprannumerari). Questo sussidio a favore dei maestri disoccupati venne ripristinato e fu reso stabile nel 1688, nella misura di 70 ducati l'anno, corrispondenti al salario minimo annuale (199). Questa eccezionale garanzia a sostegno del reddito, capace in teoria di gonfiare i costi di produzione, riguardava comunque una parte soltanto dei lavoratori, restando esclusi lavoranti, garzonetti e inservienti vari. Ma molto più importante nel determinare i livelli di redditività delle fornaci fu il passaggio, verso la fine del Seicento, dalla materia prima ricavata dai sassi di fiume alla sabbia bianca delle cave istriane di Pola e Dignano (chiamata saldame), già utilizzata nella smerigliatura degli specchi. Tale mutamento consentiva di saltare l'operazione di triturazione dei ciottoli, garantendo l'approvvigionamento di una materia prima abbondante e a buon mercato. Nel 1734 il magistrato alle miniere concesse lo sfruttamento delle cave direttamente all'Arte dei vetrai, che dall'anno successivo ottenne più opportunamente la concessione dei giacimenti di Lissa. Nel 1743 erano ben undici le cave attive in quest'isola dalmata, più altre quattro già rinvenute e pronte ad essere aperte. È opportuno qui ricordare che sul saldame istriano e dalmata la produzione vetraria muranese si reggerà fino alla seconda guerra mondiale (200).
Fu questa probabilmente la vera risposta dei vetrai all'accresciuta concorrenza internazionale, che si era arricchita nella seconda metà del Seicento di alcune importanti innovazioni. Agli anni Sessanta risaliva, infatti, l'invenzione di Bernard Perrot del sistema di produzione delle lastre "a colata" e agli anni Settanta del cristallo inglese al piombo e del cristallo potassico di Boemia (201). Inoltre, l'emigrazione di molti specialisti muranesi, senza dubbio spinti dalla non facile congiuntura, era culminata con l'apertura nel 1666 della Manifattura Reale degli specchi voluta da Colbert (202). Il tradizionalismo e la difesa del mestiere avevano forse impedito un adattamento dei processi di lavorazione, ma le nuove fonti di approvvigionamento della materia prima avevano riequilibrato la situazione, almeno a livello di costi.
In mancanza di dati attendibili e aggregati sulla quantità e sul valore della produzione, ogni valutazione circa il trend generale del settore risulta arrischiata. Non resta che fare riferimento al numero delle fornaci, peraltro variabile di anno in anno, e alla manodopera impiegata. Dalle scarne notizie del Seicento sappiamo che nel 1661 le fornaci attive risultarono in numero di trentasei, intestate a trentadue titolari, e che nel 1674 i patroni di fornace erano forse ventitré (203). La rielaborazione di alcune fonti settecentesche ci permette di affermare che la capacità produttiva delle fornaci di Murano tese piuttosto a crescere che a contrarsi nel corso del Settecento, toccando forse il livello più alto mai raggiunto (v. Tab. 1). Del resto è già stato osservato che il Settecento fu "il secolo più rappresentativo della versatilità e della fantasia con le quali l'arte vetraria seppe esprimersi" (204).
Per quel che riguarda la manodopera impiegata, dai centosessantadue maestri censiti nel 1674 si passò nel secondo Settecento ad una cifra superiore ai duecento, sempre però compresi quelli momentaneamente disoccupati (così come si può notare nella Tab. 2 cui si rinvia).
L'occupazione salì dunque nel secondo Settecento in modo abbastanza vistoso, con una netta preminenza nel campo delle lastre e degli oggetti di vetro soffiato, mentre la fabbricazione dei tondi per le finestre era virtualmente scomparsa. Il rapporto tra numero di maestri e numero di fornaci attive rimase abbastanza stazionario, com'è naturale, vista la staticità delle tecniche adottate : tre-quattro maestri per le lastre, due-tre per le canne. Altrettanto accadeva per i maestri soprannumerari, mentre aumentava da uno a tre il numero medio per fornace dei "garzoni" (lavoranti) da lastre e da 0,5 a uno per quelli da canna. Nonostante i legittimi dubbi sull'esaustività delle registrazioni della manodopera effettivamente al lavoro, questi dati, proprio per il loro carattere ufficiale, mi sembrano costituire l'indice di una maggiore apertura del mestiere verso l'alto e dunque di un certo ottimismo verso il futuro da parte degli stessi organismi corporativi. Il caso dei vetri soffiati faceva storia a sé, dato l'alto numero di lavoratori per fornace. Nel 1743 era attiva una sola ditta, quella di Giacomo Mazzolà, anche se non è affatto certo che si trattasse di un'unica fabbrica, capace di contenere al suo interno ben sessantanove lavoratori, contro la media di una quindicina a fine secolo. In realtà, la parte preponderante della lavorazione dei soffiati riguardava bottiglie e bicchieri e probabilmente si svolgeva in luoghi diversi. La ditta Mazzolà comprendeva comunque anche una fornace da lastre e due da specchi, rappresentando nel 1743 la più cospicua concentrazione aziendale di Murano con un totale di sessantacinque maestri e ventitré lavoranti impiegati. Anche nel 1790 comparivano aziende di grandi dimensioni, come la fornace di dodici vasi della compagnia Motta-Mestre, che dava lavoro a quarantadue maestri, o ditte che integravano lavorazioni di diverso tipo, come nel caso di Stefano Motta.
Non conosciamo purtroppo la variazione nel tempo della vera misura della capacità produttiva, ossia il numero dei vasi (crogioli) in lavoro. Ogni singolo forno risultava normalmente dotato di quattro o sei vasi e il loro numero complessivo determinava la stessa dimensione aziendale. Le fornaci da quattro vasi erano di più facile gestione e assicuravano mediamente una migliore riuscita del prodotto. Dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, poi, la suddivisione tradizionale tra maestri, lavoranti e garzonetti non rispondeva certo alla completa articolazione interna delle fornaci. Nelle fornaci da canna, ad esempio, si distingueva il maestro "pastoner" da quello "da scagno", addetto quest'ultimo a perfezionare il prodotto e meglio pagato rispetto al primo (207). Inoltre, comparivano nelle fornaci dei "capi operai" che dovevano sovrintendere ai numerosi lavoratori sussidiari: "operai dal ferro", "operai serventi", "operai da calchera", "operai da edificio". Nel 1743 il rapporto tra manodopera corporata e questo tipo di operai avventizi era almeno di uno a uno. Dunque, a fine secolo, nelle vetrerie muranesi lavoravano almeno seicento persone: un universo attraversato però da gerarchie mobili e da contrasti interni di non poco momento.
Lo strumento forse più importante di controllo sul mercato del lavoro era quello della sospensione delle prove per l'ammissione a capomaestro. Si ricorse a provvedimenti di questo genere a più riprese: nel 1695, 1700, 1720, 1724, 1745, bloccando l'accesso da un minimo di tre a un massimo di sei anni. Il problema fondamentale era la pressione che i lavoranti esercitavano, in quanto l'ammissione al grado superiore garantiva loro la piena occupazione, almeno sotto forma del previsto sussidio. Non risultava neppure sufficiente l'obbligo di prestare servizio come lavoranti per almeno sei anni, come statuito nel 1731, mentre si temeva sempre che il personale ben addestrato abbandonasse Murano per impiantare fornaci all'estero, come peraltro accadde di frequente. Inoltre, le sessioni dedicate alle "prove" per l'ammissione assumevano spesso l'aspetto di una vera e propria bagarre, in cui legami clientelari, favoritismi e corruzione avevano la meglio sulle considerazioni di carattere professionale (208). Fu così che, per opera dell'inquisitore alle Arti Polo Querini, il senato approvò il 7 giugno 1766 un nuovo capitolare generale, in trecentodue articoli, sulle quattro classi di fornaci da specchi, lastre, soffiati e canna. Nel 1787 questa regolamentazione venne rivista e aggiornata. Finalmente s'inserì una norma per il controllo sui garzonetti, che dovevano essere originari di Murano e rimanere nel ruolo per almeno dieci anni. Nel gennaio del 1788 seguì però una nuova regolazione per le fornaci da smalti, "forse la più importante", secondo la quale i lavoranti potevano essere assunti all'età minima di dodici anni e rimanere nel ruolo per almeno otto anni (209). Di fatto, la proliferazione di norme a tratti contraddittorie o non coordinate tra loro rendeva palese l'esistenza di scontri e tensioni che ancora una volta avevano origine nei processi in atto. Per le imprese si trattava di contemperare la ricerca di più ampi margini di elasticità con la necessità di un maggiore controllo della manodopera.
Un esempio evidente di questo stato di cose venne proprio dal conflitto che si aprì nella primavera del 1766, in vista della successiva regolamentazione. I due gastaldi e i due aggiunti delle maestranze, in rappresentanza dei circa cinquecento capifamiglia coinvolti, chiedevano interventi decisi contro gli otto-dieci patroni che erano emersi nella gerarchia corporativa negli ultimi trent'anni. Gli obiettivi di questa consorteria erano la riduzione dei salari e la ricerca di ottenere dei privilegi in grado di disarticolare ulteriormente il tradizionale controllo sul mestiere. Dall'altra parte, maestri e lavoranti si trovavano nella necessità di contrastare lo sgretolamento dell'esclusiva professionale, in seguito alla libertà di assunzione di garzonetti e operai di fornace. Nemmeno l'obbligo del "comparto", cioè la dichiarazione sulla manodopera assunta per la stagione lavorativa ottobre-luglio, garantiva il rispetto delle regole fissate perché non ci si faceva scrupolo di ricorrere successivamente ad altri lavoranti e garzoni (210). Tutto lascia credere che la realtà all'interno delle fornaci fosse dominata da regole informali, da forme di contrattazione e di patronage che negavano nei fatti le forme di gerarchia, gli obblighi e le funzioni fissate dalle norme corporative (211). Le tracce dell'intervento sommerso di manodopera femminile muranese nella rivendita dei prodotti o nella vietatissima lavorazione delle perle non fanno che confermare questa realtà fluida e flessibile (212). Ancora, la storia delle numerose fughe di vetrai muranesi, puntualmente spiati, inseguiti, blanditi dal consiglio dei dieci, dalle sue spie e dai suoi sicari, puntualmente seguite da composizioni e da inaspettati ritorni, ci mette di fronte a un quadro di transazioni ancora più ampio. Da Napoli a Graz, da Torino a Cadice, da Roma a Firenze, l'appartenenza alla comunità muranese dei vetrai assicurava lavoro e contratti, protezioni e accordi facilmente rinegoziabili in laguna. Certamente, verso di loro il terribile tribunale dei dieci era più spesso incline ad un perdono tanto più ipocrita quanto spudoratamente offerto, che all'uso di mezzi come il carcere e il veleno. Si mandavano spesso all'estero altri maestri, più o meno fedeli alla Serenissima, a seminar zizzania, o si minacciavano familiari e conoscenti; quasi mai si arrivava a provvedimenti tali da poter compromettere definitivamente ogni rapporto con il reprobo (213). Un occhio alla concorrenza internazionale, l'altro alla fornace ("sapieme dire come la sé del commercio e andé a ricercar in fornasa cosa che ha ditto Pife e il Sordo e i me paroni mone"), l'emigrazione per lo più temporanea dei vetrai muranesi non era che un altro aspetto dei rapporti di produzione, in cui norma ed eccezione finivano per integrarsi in un originale guazzabuglio, a volte persino folcloristico (214). In effetti, l'appartenenza a un gruppo professionale molto ben definito, seppure sottoposto nel Settecento all'assedio di imprenditori, avventizi e immigrati, favoriva la ricerca di strategie diversificate di massimizzazione del reddito. E fino all'ultimo, nonostante tutto, quella del vetro restò un'Arte chiusa e i complessi regolamenti servirono quanto meno a salvaguardare l'immagine di coerenza e coesione che i Muranesi volevano rimandare di sé. Ma perfino la legge finiva per riconoscere che tra patroni e maestri "fini e interessi sono spesso divisi e alcune volte anche contrari" (215).
Le canne massicce e forate prodotte nelle fornaci specializzate di Murano erano il semilavorato da cui nel Settecento venivano ricavati i diversi generi di conterie, rispettivamente le perle a lume (Arte dei perleri o supialume) e le margarite (Arte dei margariteri). Nel primo caso, ad approfondire quanto già più sopra accennato, il maestro perler portava la canna di smalto o di vetro colorato a contatto con la fiamma di una lucerna, spinta in direzione orizzontale dal soffio di un mantice. Le gocce di vetro colavano su di un filo di ferro e il maestro poteva regolarne forma e grandezza a suo piacimento, magari arricchendole di altri ornamenti a smalto, utilizzando lo stesso sistema. Il lavoro delle margarite, che assunsero nel Settecento il nome di conterie per eccellenza, consisteva invece nel tagliare in piccoli segmenti le canne forate per poi arrotondarli opportunamente. La seconda di queste operazioni poteva essere effettuata in due modi diversi. Nel primo caso, i pezzi di canna venivano arrotondati in apposite padelle ("ferrazze"), tramite il loro riscaldamento in fornace e la continua rimestatura. Era questa la cosiddetta "contaria da Lisbona" (216), quella di minor valore, che aveva avuto però fin dal secolo precedente un ruolo di primo piano nel commercio atlantico: il contributo originale veneziano alla tratta degli schiavi. Nell'altro caso, le conterie venivano infilate su di uno spiedo e arrotondate sulla fiamma viva, un procedimento destinato però a cadere quasi in disuso nel corso del Settecento (117).
Lo sviluppo nella produzione e nel commercio di questo tipo di lavorazioni fu senza dubbio portentoso e continuò per tutto il Settecento. Una vera crisi arrivò soltanto negli anni Novanta, quando gli eventi bellici e lo stato diffuso d'incertezza resero problematici gli scambi commerciali (118). Negli anni Cinquanta si parlava di una produzione annua di circa due milioni di pezzi di conterie, per l'esorbitante valore complessivo di cinque milioni e mezzo di ducati, quasi tutti esportati ai quattro angoli del mondo: dal Portogallo al mar Rosso, dalla Barbaria all'Inghilterra (119). Di minor consistenza, ma sempre significativo, era il giro d'affari mosso dalle perle a lume, che prima del 1790 raggiunse un valore attorno ai 240.000 ducati l'anno (220). Fu senza dubbio per questi solidi motivi che le controversie tra le due corporazioni interessate e con la corporazione muranese furono particolarmente vivaci. Nel 1764 il magistrato dei censori aprì un voluminoso fascicolo processuale, cercando di definire una volta per tutte gli ambiti di rispettiva competenza, che poi risultarono quelli tradizionali sopra illustrati (221). Ma il problema reale riguardava in questo caso la concorrenza che i margariteri avevano mosso ai perleri nell'acquisto delle canne di smalto, facendo evidentemente lievitare i prezzi, visto il basso numero di fornaci da smalti. I perleri da lume pretendevano che tutta la canna di smalto fosse loro rivenduta, mentre erano evidentemente la differenza tra canna forata e piena e il differente processo di lavorazione a identificare i diversi prodotti. A un certo momento vi fu dunque una strozzatura nel settore della fabbricazione delle canne di smalto, fino a che negli anni Settanta il numero delle fornaci muranesi non si adeguò all'accresciuta domanda. Risulta molto difficile ottenere un'immagine dell'andamento congiunturale del settore perché la domanda si presentava sostenuta ma alquanto fluttuante, proprio in quanto dipendente da mercati internazionali molto ampi e lontani. Quando la domanda subiva repentine impennate, ad esempio, i margariteri erano indotti ad aumentare rapidamente il numero delle fornaci da "ferrazza". I mezzi di produzione, piuttosto modesti e di basso valore, consentivano un rapido aumento dell'output ed altrettanto improvvise cadute. A ciò si aggiungeva il reale pericolo, molto concreto e sempre in agguato, che i vetrai muranesi fossero indotti illegalmente a fabbricare per loro conto perle e conterie (221).
Questi aspetti strutturali si ripercuotevano ovviamente sulla forza lavoro disponibile. La contraddizione tra ruoli corporativi chiusi e l'elasticità richiesta all'offerta fu la vera chiave di volta degli scontri all'interno delle rispettive Arti. I "disordini" di cui si lamentavano i perleri si riferivano da un lato al contrasto tra maestri/mercanti e semplici artigiani e dall'altro al proliferare del lavoro clandestino. Per questo nel 1764 ben centodiciannove capimaestri perleri pretesero l'osservanza sull'esclusiva del lavoro ("tener canna e follo"), il divieto d'istruzione per chi non fosse figlio di maestro, norme restrittive sul lavoro delle vedove e delle figlie dei maestri. Le statistiche del secondo Settecento non riportavano minimamente la reale situazione occupazionale: i duecentonovantacinque maestri censiti nel 1773 o i cinquecentosessanta iscritti del 1797 costituivano solo una parte della forza lavoro occupata. Fonti più dirette ci parlano di circa ottocento persone impiegate, molto spesso a livello di gruppi famigliari, cui andavano aggiunti quattrocento ragazzi per muovere i mantici. Verso la fine del secolo, si riconosceva apertamente che il controllo sulla manodopera era completamente sfuggito di mano all'Arte (223). Ancor più difficile era il controllo nell'Arte dei margariteri. Per questo nel 1718 venne vietato tassativamente il lavoro femminile. Dopo la metà del secolo, tuttavia, erano le donne e gli immigrati a compiere l'operazione di taglio della canna "giorno e notte", dopo che con un decreto del giugno 1754 si era consentita l'assunzione libera per le mansioni di triturazione del carbone e di lucidatura delle perle (224). Si era stabilito che ogni fornace da ferrazza desse lavoro a tre maestri (fornaser, tagliador, governador), un lavorante e un garzone, ma si riconosceva apertamente che un solo maestro tagliatore non bastava per alimentare la fornace medesima e che le incombenze accessorie erano eccessive per soli due operai non specializzati. Nel 1764, in sede di revisione dei regolamenti, il numero dei laboratori venne fissato in un massimo di ventisei, ma c'era chi lavorava per proprio conto la canna acquistata direttamente a Murano, dentro e fuori dell'Arte (225).
Insomma, ancora una volta la lettera dei regolamenti si rivelava ben poco attinente ai reali rapporti di produzione. Sempre importante risultò invece il rispetto della divisione del lavoro con le vetrerie muranesi che, nonostante i non rari momenti di frizione, rimase un caposaldo di un ruled market in grado di assicurare alti livelli di occupazione e di specializzazione. Infine, sfuggiva ad ogni inquadramento e quantificazione tutto il fiorente ramo del lavoro sommerso, dalla rivendita al minuto delle perle alle centinaia di impiraresse a domicilio, che con i loro lunghi aghi infilavano le perle in collane e mazzi, occupazione che resterà tipica delle popolane del sestiere di Castello nel secolo successivo(226).
Anche il settore della lavorazione degli specchi si presentava nel Settecento ancora vivace; prova ne sia la profusione che se ne fece nei palazzi e nelle case veneziane. L'Arte relativa, staccatasi nel secondo Cinquecento da quella dei marzeri, non controllava tuttavia l'intero ramo della rifinitura e della commercializzazione del prodotto. Probabilmente già dalla fine dello stesso secolo vi si affiancò il lavoro di maestranze friulane, inizialmente assunte come garzoni, che riuscirono a ritagliarsi col tempo la specializzazione della lavorazione in proprio degli specchi più piccoli detti "dell'Ebreo": "un ritrovato nostro, da noi sempre, malgrado le sofferte sciagure, coltivato" (227). Ancora, oltre ai Furlani, o meglio ai loro discendenti che avrebbero dovuto stabilirsi negli stessi quartieri riservati agli specchieri(228), questi ultimi si lamentavano dell'esistenza di "lavoratori furtivi", immigrati recenti che esercitavano clandestinamente il mestiere. Insomma, anche in questo caso l'ordine corporativo era attraversato da contrasti ed eccezioni difficilmente risolvibili. I cinquecentotrentadue membri dell'Arte censiti nel 1773, ventiquattro mercanti-capimaestri, trecentoventotto maestri, centosessanta friulani, venti tra figli e allievi, non rappresentavano certo il totale degli occupati. Nel 1753 si calcolava, infatti, che fossero circa trecento gli addetti alla sola lavorazione degli specchi "dell'Ebreo" e lo stesso numero veniva pressoché confermato nel 1786 (229). Certo, l'andamento dei mercati internazionali, visto che anche gli specchi erano un genere in gran parte oggetto d'esportazione, poteva provocare difficoltà congiunturali di una certa importanza. Ciò accadde, ad esempio, nei primi anni Sessanta, quando si arrivò a studiare l'opportunità di affidare a un'unica compagnia il commercio degli specchi in Levante, allo scopo di facilitare lo smaltimento delle enormi giacenze di magazzino (230).
Ma, indubbiamente, il problema più sentito era quello della regolare fornitura del semilavorato da parte delle fornaci muranesi. Complessivamente, il numero delle fornaci da lastre e specchi era rimasto pressoché stabile nel corso del secolo. Ma delle due fornaci da "quari" grandi (oltre il mezzo metro di lato) della prima metà del secolo, attorno al 1780 ne era rimasta in attività soltanto una, tanto che gli specchieri chiesero a gran voce di farne funzionare almeno altre due (231). Ritengo che una maggiore semplicità nella lavorazione delle lastre piccole, l'agguerrita concorrenza francese, la diffusione degli specchi come genere di largo consumo, infine la domanda di vetro da finestre avessero causato un relativo disimpegno dei Muranesi in questa direzione. Nel 1782-1783 si scatenò così una grave controversia tra l'Arte degli specchieri e l'Arte di Murano, centrata sul problema della regolarità delle forniture, ma i cui punti essenziali erano altri. Prima di tutto la ripartizione degli utili, poi il problema delle eventuali rimanenze e della lavorazione simultanea dei Muranesi delle lastre per gli specchi e per le finestre. La mediazione tentata dal magistrato dei censori prevedeva anche il sostegno all'apertura di due nuove fornaci gestite da Francesco Motta, il quale richiese però una privativa per dieci anni e la libera assunzione dei maestri necessari (232). Fu proprio l'impegno assunto dal Motta a consentire una via d'uscita praticabile. Infatti, nel 1790, egli risultava patrone di una fabbrica di "quari" dotata di ben diciannove vasi, suddivisi probabilmente in tre fornaci, in grado di assicurare la fornitura del semilavorato (233). Rimaneva comunque in essere la questione non semplice delle eventuali rimanenze del semilavorato stesso presso le vetrerie muranesi. La discussione sui limiti temporali di giacenza e sull'assunzione dei rischi connessi allo stoccaggio nascondeva probabilmente il conflitto sulla diretta possibilità dei Muranesi di produrre specchi finiti.
Dal punto di vista tecnico, le novità più importanti del Settecento furono in campo vetrario quelle dell'introduzione del cristallo boemo, a componente potassica, e della lavorazione delle "bottiglie d'Inghilterra".
Il segreto della produzione del cristallo venne introdotto a Venezia da Giuseppe Briati, il quale ottenne all'inizio del 1737 una privativa decennale che venne successivamente prorogata per altri dieci anni. Osteggiato dai Muranesi, il Briati dovette trasferirsi a Venezia in fondamenta Foscarini, davanti a Ca' Zenobio, l'attuale Collegio Armeno (234). A causa dell'alto costo del salnitro sul mercato libero, al Briati venne quasi subito concesso l'utilizzo di 40.000 libbre annue a prezzo di costo, da prelevarsi presso i pubblici depositi (235). La sua iniziativa venne seguita nella seconda metà del secolo da alcuni vetrai muranesi: i fratelli Mestre, Giuseppe Giandolin, la compagnia diretta da Antonio Motta, ai quali venne ugualmente concesso di accedere alle scorte di salnitro della Repubblica (236). Si trattava in questo caso di contrastare un tipo di concorrenza che si era rivelata quanto mai temibile, a causa delle particolari caratteristiche del vetro potassico. La sua resistenza, la facilità di lavorazione a mola, la sua lucentezza lo avevano imposto su tutti i mercati europei, e la città del vetro per eccellenza, cioè Venezia, non poteva esimersi dal consueto sistema dell'imitazione qualitativa (237). Non si può tuttavia concludere che la strada segnata dal Briati conducesse a un rinnovamento sostanziale dei generi prodotti a Murano. Se il Giandolin abbandonò presto la fabbricazione, la produzione del cristallo "ad uso di Boemia" si affiancò, senza soppiantarla, a quella del vetro sodico tradizionale. Dal 1766 al 1792 vennero formati in totale ventiquattro maestri, forse meno di quanti erano necessari alle fornaci Mestre e Motta. Il relativo successo incontrato presso i nobili veneziani ed anche in Inghilterra dagli oggetti di tipo ornamentale prodotti (picandoli, cioccole, ritortole, filigrane, fiori, figure) indusse gli interessati a chiedere addirittura la separazione della classe dei "cristalli fini" da quella dei "supiadi" di vetro comune o di cristallo ordinario (238). Anche in questo caso, le capacità di risposta dell'ambiente produttivo riuscirono ad assicurare ai vetrai muranesi una nuova e non disprezzabile nicchia di mercato.
Di minore portata furono, invece, i tentativi esperiti da Giorgio Barbaria di dar vita a una fabbrica di "bottiglie d'Inghilterra", particolarmente adatte per la loro robustezza a trasportare via mare vini, liquori e acqua minerale. Dopo essere stato in Francia e in Inghilterra, il Barbaria ottenne nel 1791 l'alta protezione del consiglio dei dieci per avviarne la produzione a Venezia, ai Gesuati, servendosi del libero apporto di maestri muranesi. Nonostante la buona riuscita delle bottiglie, certificata dal riscontro fornito da alcuni consoli veneziani, alla fine del 1791 il Barbaria fu costretto a sospendere la fabbricazione, a causa del pessimo stato dell'edificio e della scarsa preparazione dei suoi lavoranti (239). Dopo un nuovo viaggio all'estero, gli venne concessa nel settembre del 1793 l'iscrizione alla corporazione dei vetrai, con una prassi che secondo qualcuno "diede l'ultima spinta all'Arte di Murano" (240). Alla fine, sembra che anche a questo tentativo arridesse un certo successo. Addirittura, venuta meno la possibilità di rifornirsi della cosiddetta "cenere di Scozia" (il kelp, la soda ricavata da un'alga delle Fucacee), Giorgio Barbaria riuscì a sostituirla con una miscela di cenere di fornace da mattoni, salnitro, caolino e saldame, sembra con buoni risultati e risparmiando pure sui costi (241).
1. Carlo Livl - Domenico Sella - Ugo Tucci, Un problème d'histoire: la décadence économique de Venise, in AA.VV., Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII, Venezia-Roma 1961, pp. 289-317; Domenico Sella, Commerci e industrie a Venezia nel secolo XVII, Venezia-Roma 1961, pp. 91-97.
2. Domenico Sella, The Rise and Fall of the Venetian Woollen Industry, in Crisis and Change in the Venetian Economy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, a cura di Brian Pullan, London 1968, pp. 106-126; Gigliola Pagano de Divitiis, Mercanti inglesi nell'Italia del Seicento. Navi, traffici, egemonie, Venezia 1991 (in particolare le conclusioni, pp. 206-209); Walter Panciera, L'arte matrice. I lanifici della Repubblica di Venezia nei secoli XVII e XVIII, Treviso 1996, pp. 59-66.
3. Luigi Dal Pane, Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX), Milano 1940, pp. 25-30 e 43-194; Massimo Costantini, L'albero della libertà economica. Il processo di scioglimento delle corporazioni veneziane, Venezia 1987.
4. Walter Panciera, Emarginazione femminile tra politica salariale e modelli di organizzazione del lavoro nell'industria tessile veneta nel Settecento, in La donna nell'economia. Secc. XIII-XVIII, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze 1990, pp. 588-589 (pp. 585-596); Id., Padova, 1704: "l'antica Unione de' poveri laneri" contro "la ricca Università dell'arte della lana", "Quaderni Storici", n. ser., 87, 1994, pp. 629-653.
5. Ivo M.Attozzi, Un processo di accumulazione di capitale manifatturiero: le cartiere di Ceneda nel primo Seicento, "Studi Veneziani", n. ser., 16, 1988, pp. 93-120; W. Panciera, L'arte matrice, pp. 69-86; Carlo Poni, Archéologie de la fabrique: la diffusion des moulins à soie "alla bolognese" dans les États vénitiens du XVIe au XVIIe siècle, "Annales E.S.C.", 27, 1972, nr. 6, pp. 1475-1496.
6. Bruno Caizzi, Industria e commercio della Repubblica veneta nel XVIII secolo, Milano 1965, pp. 24-28.
7. Frederic C. Lane, Storia di Venezia, Torino 1978, pp. 491-492
8. Vincenzo Fontana, Girolamo Manfrin e la Manifattura Tabacchi di Bernardino Maccaruzzi, "Bollettino dei Musei Civici", 22, 1977, pp. 51-63; Daniela Mazzotta, La Manifattura Tabacchi, in Archeologia industriale nel Veneto, a cura di Franco Mancuso, Milano 1990, pp. 194-195. Sull'importanza della gestione Manfrin nell'appalto dei tabacchi: Marino Berengo, La società veneta alla fine del Settecento, Firenze 1956, p. 121; A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 6, scrittura del 5 maggio 1789.
9. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, ser. II, b. 124, fasc. "parte IV", dispaccio datato aprile 1723. Sul commercio atesino: Tommaso Fanfani, L'Adige come arteria principale del traffico tra nord Europa ed emporio realtino, in Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige, a cura di Giorgio Borelli, Verona 1977, pp. 569-629; Giovanni Faccioli, Verona e la navigazione atesina. Compendio storico delle attività produttive dal XII al XIX secolo, Verona 1956.
10. Cf. Salvatore Ciriacono, L'economia regionale veneta in epoca moderna. Note a margine del caso bergamasco, in AA.VV., Venezia e la Terraferma. Economia e Società, Bergamo 1989, pp. 43-47 e 76 (pp. 43-76).
11. B. Caizzi, Industria e commercio, pp. 201-204 e 238 240; W. Panciera, L'arte matrice, pp. 95-98.
12. Ivana Pastori Bassetto, Crescita e declino di un'area di frontiera: sete e mercanti ad Ala nel XVII e XVIII secolo, Milano 1986; Gilberto Ganzer, Jacopo Linussio. Un manager del Settecento, Udine 1986.
13. Sul concetto di regione economica: Sidney Pollard, La conquista pacifica, Bologna 1984. Cf. Mario Mirri, Formazione di una regione economica. Ipotesi sulla Toscana, sul Veneto, sulla Lombardia, "Studi Veneziani", n. ser., 11, 1986, pp. 47-59.
14. Roberto Berveglieri, Cosmo Scatini e il nero di Venezia, "Quaderni Storici", 52, 1983, p. 167 (pp. 167-179).
15. W. Panciera, L'arte matrice, pp. 79 e 84; Danilo Gasparini, "Fortune negotij et artefici" a Treviso in età moderna (sec. XV-XVIII), in Tessuti antichi. Tessuti, abbigliamento, merletti, ricami. Secoli XIV-XIX, a cura di Doretta Davanzo Poli, Treviso 1994, pp. 340-342 (pp. 325-350); Walter Panciera, Vent'anni di bilanci di una impresa laniera del secondo Settecento, "Studi Veneziani", n. ser., 19, 1990, pp. 128-130 (pp. 125-170).
16. Giovanni Luigi Fontana, Sebastiano Bologna e l'"industria nazionale", in Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica: economia, territorio, istituzioni, a cura di Id. - Antonio Lazzarini, Bari 1992, pp. 281-284 (pp. 265-314); Walter Panciera, Verso la crisi: i lanifici della Repubblica veneziana dalla fine del Settecento alla Restaurazione, ibid., pp. 245-264.
17. I. Mattozzi, Un processo di accumulazione di capitale, pp. 104-111.
18. R. Berveglieri, Cosmo Scatini, p. 175; W. Panciera, L'arte matrice, p. 104.
19. W. Panciera, L'arte matrice, p. 74; B. Caizzi, Industria e commercio, pp. 171-172; Mario Infelise, L'editoria veneziana nel '700, Milano 1989, pp. 282-283.
20. Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, IX, Venezia 1860, pp. 80-115; Giovanni Tabacco, Andrea Tron e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia, Udine 19802, pp. 169-173.
21. C. Poni, Archéologie de la fabrique, p. 1489.
22. B. Caizzi, Industria e commercio, pp. 87-91; Ivo Mattozzi, Produzione e commercio della carta nello stato veneziano settecentesco. Lineamenti e problemi, Bologna 1975, pp. 23-24; G. Ganzer, Jacopo Linussio, pp. 35-36; Walter Panciera, I lanifici dell'alto Vicentino nel XVIII secolo, Vicenza 1988, p. 28.
23. A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 39, scrittura del 9 ottobre 1772.
24. Ivi, Cinque Savi alla Mercanzia, ser. II, b. 140, fasc. 210/I, 12 maggio 1711.
25. Pompeo G. Molmenti, Il contrabbando sotto la Repubblica Veneta, "Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", 76, 1916-1917, pp. 977-1021; Paolo Preto, I servizi segreti di Venezia, Milano 1994, pp. 423-429.
26. Si veda quanto esposto più avanti in merito a questi settori.
27. W. Panciera, L'arte matrice, pp. 102-103.
28. Sulla legislazione veneziana in materia di privative: Giulio Mandich, Privative industriali veneziane (1450-1550), "Rivista di Diritto Commerciale", 34, 1936, pp. 99-143; Id., Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privativa agli inventori, "Rivista di Diritto Industriale", 7, 1958, pp. 99-155.
29. A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 50, fasc. "Miscellanea".
30. W. Panciera, L'arte matrice, p. 138.
31. C. Poni, Archéologie de la fabrique, p. 1486.
32. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, ser. II, b. 127, fasc. 188/II, dispacci del 12 febbraio 1726 e del 16 settembre 1726.
33. Ivi, Senato, Rettori, filza 314, scrittura del 7 gennaio 1765 inserta al decreto 9 marzo 1765.
34. Ibid., filza 319, scrittura del 1º aprile 1767 inserta al decreto 19 dicembre 1767. La serie completa, in copia, delle sette scritture prodotte da Gabriele Marcello trovasi in Venezia, Biblioteca Nazionale Alarciana, ms. it. cl. VII. 1559 (= 8975).
35. La statistica delle Arti del 1773 è stata pubblicata in L. Dal Pane, Il tramonto delle corporazioni, pp. 145-194. Per le altre valutazioni di tipo quantitativo: M. Costantini, L'albero della libertà, pp. 28-29.
36. Giovanni Scarabello, Caratteri e funzioni socio-politiche dell'associazionismo a Venezia sotto la Repubblica, in Scuole di arti mestieri e devozione a Venezia, a cura di Silvia Gramigna - Annalisa Perissa, Venezia 1981, pp. 5-24.
37. Luigi Einaudi, L'economia pubblica veneziana dal 1736 al 1755, "La Riforma Sociale", 14, 1904, pp. 450 e 527-534 (pp. 429-450, 509-537); Giuseppe Felloni, Gli investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione, Milano 1971, pp. 137-138. Su questo punto cf. il saggio di Andrea Zannini in questo stesso volume.
38. M. Cost.Antini, L'albero della libertà, p. 22.
39. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, ser. II, b. 139, fasc. II.
40. Il manoscritto di Apollonio del Senno, Arti di Venezia - 1797, si trova in A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 2. Le informazioni principali sono state sintetizzate e rielaborate da M. Costantini, L'albero della libertà, pp. 34-38.
41. L. Dal Pane, Il tramonto delle corporazioni, pp. 57-59.
42. A.S.V., Censori, b. 39, scrittura dei capi furlani in data 31 maggio 1786.
43. Franco Venturi, Settecento riformatore, V/2, La Repubblica di Venezia (1761-1797), Torino 1990, pp. 117-131.
44. L. Dal Pane, Il tramonto delle corporazioni, pp. 68 ss.
45. Ibid., pp. 46-53.
46. Ibid., pp. 57-62 e 81-130. Sulla figura di Andrea Memmo: Gianfranco Torcellan, Una figura della Venezia settecentesca. Andrea Memmo, Venezia-Roma 1963; F. Venturi, Settecento riformatore, pp. 132-141.
47. L. Dal Pane, Il tramonto delle corporazioni, pp. 118-119.
48. A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 45, scrittura datata 1801.
49. V. in M. Costantini, L'albero della libertà, pp. 34-38. Il manoscritto di Apollonio del Senno venne compilato nel 1798-1799 e reso pubblico soltanto nell'aprile del 1814, dopo il ritorno degli Austriaci, sotto il cui primo governo egli aveva ricoperto incarichi presso la deputazione alle Arti e la commissione camerale: ibid., p. 33; Agostino Sagredo, Sulle consorterie delle arti edi icative in Venezia, Venezia 1856, pp. 229-231.
50. M. Costantini, L'albero della libertà, p. 41.
51. Id., La formazione professionale dal tramonto delle corporazioni di mestiere al sorgere del sistema di fabbrica, in Le corporazioni nella realtà economica e sociale dell'Italia nei secoli dell'età moderna, a cura di Giorgio Borelli, Verona 1991, pp. 131-132 (pp. 129-135).
52. La collocazione archivistica di questa documentazione è la seguente: A.S.V., Giustizia Vecchia, Accordi di garzoni, 1575-1772. Per il Settecento, i contratti di garzonaggio sono raccolti in alcuni casi per corporazione: se ne veda un modello di utilizzo in Andrea Vianello, L'arte dei calegheri e degli zavateri di Venezia tra XVII e XVIII secolo, Venezia 1993.
53. Ugo Tucci, Carriere popolane e dinastie di mestiere a Venezia, in Gerarchie economiche e gerarchie sociali. Secc. XII-XVIII, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze 1990, p. 833 (pp. 817-851).
54. M. Costantini, La formazione professionale, p. 132; Francesca Trivellato, "L'arte madre". Il vetro veneziano nel Seicento, tesi di laurea, Università degli Studi di Venezia, a.a. 1994-1995, pp. 162-163. Ringrazio vivamente la dott.ssa Trivellato per avermi consentito di leggere e utilizzare il dattiloscritto.
55. A.S.V., Censori, b. 38, copia decreto del consiglio dei dieci del 18 agosto 1756.
56. W. Panciera, Emarginazione femminile, p. 593; Giovanni Mariacher, L'arte dei calzolai a Venezia dal XIII al XVIII secolo, in AA.VV., I mestieri della moda a Venezia, Venezia 1988, p. 37 (pp. 31-37).
57. A.S.V., Censori, b. 22, nr. 27, s.d. (ma anni Sessanta del Settecento).
58. Si veda, a titolo di esempio, il fenomeno del lavoro libero nel faubourg Saint-Antoine a Parigi: Steven Kaplan, Les corporations, les "faux ouvriers" et le faubourg Saint-Antoine au XVIIIe siècle, "Annales E.S.C.", 43, 1988, nr. 2, pp. 353-378.
59. U. Tucci, Carriere popolane, p. 851.
60. W. Panciera, Emarginazione femminile, pp. 592-593.
61. Bartolomeo Cecchetti, Monografia della vetreria veneziana e muranese, Venezia 1874, p. 222.
62. A.S.V., Censori, b. 22, nr. 27, s.d. (ma anni Sessanta del Settecento).
63. Niarco Ferro, Dizionario del diritto comune e veneto, Venezia 1778, voce "Femmina" a p. 123 e voce "Maschio" a p. 247. Cf. Simona Laudani, Mestieri di donne, mestieri di uomini: le corporazioni in età moderna, in Il lavoro delle donne, a cura di Angela Groppi, Bari 1996, pp. 183-206.
64. A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 62, supplica del 1° giugno 1798 e scrittura della deputazione alle Arti del 6 settembre 1799. La questione, emersa dopo la caduta della Repubblica, faceva però riferimento a uno scontro già in atto da tempo.
65. Ivi, Censori, b. 39, scrittura del gastaldo dell'Arte degli specchieri del febbraio 1782; ibid., b. 22, nr. 27, scrittura dell'Arte dei perleri del 24 marzo 1764.
66. Ibid., b. 38, fasc. "Gasparin e Provedan", scrittura dell'Arte dei margariteri, s.d. (ca. 1790).
67. Ivi, Senato, Rettori, filza 324, scrittura di Francesco Morosini del 2 marzo 1769 inserta al decreto 9 marzo 1769.
68. Venezia, Museo Correr, Morosini-Grimani, b. 504, nr. 1, dichiarazione di cinque mercanti veneziani del 13 marzo 1760.
69. Alessandra Sambo, Forniture per l'abbigliamento militare in area veneta (secc. XIII - metà XIX), in AA.VV., La moda pronta. Ricerche e problemi di storia della confezione, Firenze 1991, pp. 177-190; W. Panciera, L'arte matrice, pp. 233-234.
70. A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 101, fase. "Ebrei", dichiarazione di Isach Muggia del 28 dicembre 1777.
71. G. Tabacco, Andrea Tron, pp. 185-194. Anche il Tabacco propone un'interpretazione di questa vicenda come un contrasto d'interessi tra gruppi economici rivali, auspicando uno studio specifico e più approfondito sul tema: ibid., p. 190.
72. A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 101, fasc. "Ebrei", dichiarazioni di Salomone Treves del 28 dicembre 1777, di Benedetto Luzzatto del 28 dicembre 1777, dei capi del ghetto di Padova del 26 dicembre 1777.
73. Sul concetto marshalliano di distretto industriale come sistema d'imprese: Mercato e forze locali: il distretto industriale, a cura di Giacomo Becattini, Bologna 1987. Per il suo utilizzo in sede storica cf. Carlo Poni, Per la storia del distretto industriale serico di Bologna (secoli XVI-XIX), "Quaderni Storici", n. ser., 73, 1990, pp. 93-167; AA.VV., Le vie dell'industrializzazione europea: sistemi a confronto. Atti del Convegno del Centro Studi sull'impresa e sul patrimonio industriale di Vicenza, novembre 1994, in corso di stampa (in particolare gli
interventi di Giacomo Becattini, Peter Mathias, Ulrich Pfister, Giovanni Luigi Fontana, Carlo Poni, Luciano Segreto).
74. Daniele Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Padova 1954, pp. 58-59; Andrea Zannini, Un censimento inedito del primo Seicento e la crisi demografica ed economica di Venezia, "Studi Veneziani", n. ser., 26, 1993, pp. 108-112 (pp. 87-116).
75. Angelo Bassani, Il controllo di qualità del sapone nella Repubblica di Venezia, in AA.VV., Atti del Il Convegno Nazionale di storia efondamenti della chimica, Roma 1988, pp. 79-81 (pp. 79-88).
76. A.S.V., Provveditori sopra Olii, b. 181, fasc. "Carte per fabbrica di sapone nelle isole del Levante", pro-memoria datato 19 febbraio 1780.
77. A. Bassani, Il controllo di qualità del sapone, p. 81; A.S.V., Provveditori sopra Olii, b. 181, proclama a stampa in data 7 febbraio 1793; ivi, Inquisitore alle Arti, b. 63, copia decreto in data 11 ottobre 1659.
78. A.S.V., Provveditori sopra Olii, b. 181, fasc. "Carte per fabbrica di sapone nelle isole del Levante", pro-memoria datato 19 febbraio 1780.
79. Ivo Mattozzi, Crisi, stagnazione e mutamento nello stato Veneziano sei-settecentesco: il caso del commercio e della produzione olearia, "Studi Veneziani", n. ser., 4, 1980, p. 203 (pp. 199-276).
80. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, ser. II, b. 145, fasc. "Commercio/I", minuta datata 1707; fasc. "Commercio/II", scrittura della deputazione al commercio del 4 settembre 1709 e scrittura dei capi di piazza del 17 giugno 1715; fasc. 49/III, terminazione del 9 agosto 1715 e scrittura del 2 maggio 1718.
81. Ivi, Provveditori sopra Olii, b. 181, fasc. "Savoneria Bozzini 1726-1741".
82. A. Bassani, Il controllo di qualità del sapone, pp. 84-86.
83. A.S.V., Provveditori sopra Olii, b. 181, fasc. "Inquisizioni sulla qualità e commercio dei saponi", dispacci del 1761; ivi, Inquisitore alle Arti, b. 63, fasc. "venditori olio e saponi", scrittura di Arti e fabbri-canti della Terraferma del 5 gennaio 1788, dell'officio seda di Venezia del 4 febbraio 1788, del lanificio di Verona del 18 febbraio 1788.
84. B. Caizzi, Industria e commercio, pp. 148-149; A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 63, fasc. "venditori olio e saponi", scrittura del 22 aprile 1767 e supplica di Giuseppe Foscari del 29 dicembre 1787.
85. A.S.V., Provveditori sopra Olii, b. 210, relazioni del governatore del dazio olio del 27 luglio 1768 e del 6 agosto 1771.
86. Copia di questo contratto di società ivi, Inquisitore alle Arti, b. 63, fasc. "venditori olio e saponi". Il contratto venne depositato presso il magistrato dei provveditori sopra banchi in data 22 marzo 1785.
87. Ibid., fasc. "fabbricanti di sapone", scrittura del 30 maggio 1788.
88. Ivi, Provveditori sopra Olii, b. 181, proclami a stampa del 7 febbraio 1794 e 11 aprile 1795.
89. Ivi, Inquisitore alle Arti, b. 63, scrittura del 30 giugno 1789 e risposte ai quesiti in data r ° agosto 1797.
90. Ibid., al fascicolo relativo.
91. Giorgio Bellavitis, L'Arsenale di Venezia, Venezia 1983, pp. 135-137.
92. Ibid., p. 147.
93. F.C. Lane, Storia di Venezia, pp. 487-488.
94. Ennio Concina, L'Arsenale della Repubblica di Venezia, Venezia 1984, pp. 213-217; G. Bellavitis, L'Arsenale di Venezia, pp. 155-156. Cf. Ennio Concina, La casa dell'Arsenale, in Storia di Venezia, Temi, Il Mare, a cura di Alberto Tenenti - Ugo Tucci, Roma 1991, pp. 188-191 (pp. 147-210).
95. Bilanci generali della Repubblica di Venezia, ser. II, vol. III, a cura di Fabio Besta, Venezia 1903, pp. 310-311 e 334-335.
96. E. Concina, L'Arsenale della Repubblica, pp. 221-228.
97. Sulle funzioni civiche svolte dagli arsenalotti: Robert C. Davis, Shipbuilders of the Venetian Arsenal. Workers and Workplace in the Preindustrial City, Baltimore-London 1991, pp. 150-182. In generale, sul-l'organizzazione della fase lavoro nell'Arsenale: Maurice Aymard, Strategie di cantiere, in Storia di Venezia, Temi, Il Mare, a cura di Alberto Tenenti-Ugo Tucci, Roma 1991, pp. 259-283.
98. D. Beltrami, Storia della popolazione di Venezia, p. 212.
99. R.C. Davis, Shipbuilders of the Venetian Arsenal, p. 13.
100. Giovanni Caniato, La cantieristica minore veneziana
(secoli XVII-XX), in AA.VV., Arte degli squeraroli, Venezia 1985, pp. 85-95.
101. Franco Brunello, L'arte della Tintura nella storia dell'umanità, Vicenza 1968, pp. 247, 346-347.
102. Roberto Berveglieri, L'arte dei tintori e il nero di Venezia, in AA.VV., I mestieri della moda a Venezia dal XIII al XVIII secolo, Venezia 1988, p. 56 (pp. 55-61).
103. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, ser. I, b. 467, scritture di Giovan Battista Ciassi del 20 e 29 marzo 1691.
104. F. Brunello, L'arte della Tintura, p. 246; W. Panciera, L'arte matrice, pp. 101-104.
105. R. Berveglieri, Cosmo Scatini.
106. F. Brunello, L'arte della Tintura, pp. 244-245; A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 88, risposte di Alvise Rubelli, rettore dell'Arte dei tintori, in data 23 aprile 1773; W. Panciera, I lanifici dell'alto Vicentino, pp. 96-97.
107. A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 7, scritture del 6 settembre 1792, 30 dicembre 1795 e 22 agosto 1796; b. 6, scrittura del 2 dicembre 1784.
108. Ibid., b. 101,, fasc. "Ebrei, fabbriche in Venezia", nr. 4, 28 dicembre 1777.
109. P. Preto, I servizi segreti, p. 395; A.S.V., Provveditori alle Artiglierie, b. 11, scritture del 7 aprile e del 21 maggio 1759.
110. A.S.V., Inquisitori di Stato, b. 816, "Informazione sul sublimato", s.d.; ivi, Senato, Rettori, filza 320, relazione di Gabriele Marcello del 30 aprile 1767 inserta al decreto 4 febbraio 1768.
111. P. Preto, I servizi segreti, p. 395; A.S.V., Provveditori alle Artiglierie, b. 11, scrittura del 7 aprile 1759.
112. Walter Panciera, Ancien Régime e chimica di base: la produzione del salnitro nella Repubblica veneziana (1550-1797), "Studi Veneziani", n. ser., 16, 1988, pp. 74-78 (pp. 45-92).
113. B. Caizzi, Industria e commercio, p. 151; A.S.V., Senato, Rettori, filza 320, relazione del 30 aprile i 767 inserta al decreto 4 febbraio 1768.
114. A.S.V., Provveditori alla Sanità, b. 587, scritture del 13 settembre 1776 e del 22 agosto 1768; ivi, Provveditori alle Artiglierie, b. 14, scrittura del 7 gennaio 1793.
115. Vincenzo Bianchi, Medici, farmacisti, malattie, medicine e cure d'acque nei libretti per musica di Carlo Goldoni, in AA.VV., Atti del II Convegno Internazionale di Storia della farmacia, Pisa 1958, p. 49 (pp. 46-51); Mario Trinchieri di Vernason, La peste e i suoi rimedi a Venezia nel Seicento, ibid., pp. 451-452 (pp. 444-456).
116. Tra i numerosi ingredienti della triaca: oppio, mirra, miele, zafferano, incenso, pepe, cannella, genziana, valeriana, trementina, zenzero, semi d'anice e di finocchio.
117. Giovanni Marangon, Associazioni di mestiere nella repubblica veneta, Venezia 1974, pp. 167-171; Orazio Guarante, Trattato della teriaca, Venezia 1720.
118. B. Caizzi, Industria e commercio, pp. 152-153.
119. A.S.V., Senato, Rettori, filza 320, scrittura di Gabriele Marcello del 30 aprile 1767 inserta al decreto 28 gennaio 1768.
120. B. Caizzi, Industria e commercio, pp. 156-157. Secondo il Caizzi, Giminiano Cozzi avrebbe rilevato l'attività avviata a Venezia dal sassone Federico Hewelche, ma purtroppo la fonte da lui citata non accenna a questo fatto.
121. A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 6, scrittura del 28 giugno 1785.
122. P. Preto, I servizi segreti, p. 384.
123. W. Panciera, L'arte matrice, p. 229.
124. A.S.V., Senato, Rettori, filza 314, scrittura del 7 gennaio 1765 inserta al decreto 9 marzo 1765. Sui rapporti tra Andrea Memmo e Prospero Valmarana: G. Tabacco. Andrea Tron, pp. 180-183.
125. A.S.V., Inquisitore alle Arti, fasc. "Camera del Purgo - quesiti", scrittura di Andrea Tron del 23 giugno 1781 con inserte.
126. Venezia, Museo Correr, Donà dalle Rose, b. 319, nr. 58, risposte dei tessitori ai quesiti.
127. Gino Luzzatto, Storia economica dell'età moderna e contemporanea, II, Padova 1948, p. 173. I mille operai di cui parla il Luzzatto sembrano francamente troppi.
128. A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 40, supplica del 5 gennaio 1778.
129. A. Sambo, Forniture per l'abbigliamento militare; W. Panciera, L'arte matrice, pp. 233-234.
130. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, ser. I, b. 467, supplica dei tessitori del 4 marzo 1727.
131. W. Panciera, Emarginazione femminile, pp. 592-593; Venezia, Museo Correr, Donà dalle Rose, b. 320, fasc. 4, nr. 10; fasc. scritture, nr. 8, scrittura della deputazione al commercio del 30 agosto 1745.
132. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, ser. I, b. 467, copie decreti del 24 febbraio 1748 e 2 gennaio 1751.
133. Ibid., copia decreti del 4 agosto 1753 e 14 aprile 1757. Sulla ditta Linussio: G. Ganzer, Jacopo Linussio.
134. B. Caizzi, Industria e commercio, p. 171.
135. A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 35, stampa dell'Arte dei fustagneri, pp. 49-50.
136. B. Cozzi, Industria e commercio, pp. 172-173; A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, ser. I, supplica di Giuseppe Zopetti del 2 maggio 1785.
137. Venezia, Museo Correr, Donà dalle Rose, b. 320, fasc. scritture, nr. 10; fasc. 4, nr. 14.
138. Ibid., fasc. 4, nrr. 18 e 19.
139. A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 35, fasc. "Fustagneri e Coltreri", scrittura del 28 marzo 1788.
140. Ivi, Cinque Savi alla Mercanzia, ser. I, b. 467, copia decreto del 7 aprile 1756.
141. Ivi, Senato, Rettori, filza 320, scrittura del 30 aprile 1767 inserta al decreto 28 gennaio 1768.
142. D. Sella, Commerci e industrie a Venezia, pp. 128-131.
143. B. Caizzi, Industria e commercio, p. 117; Doretta Davanzo Poli, L'arte e il mestiere della tessitura a Venezia nei sec. XIII-XVIII, in AA.VV., I mestieri della moda a Venezia dal XIII al XVIII secolo, Venezia 1988, pp. 40-42 (pp. 39-53).
144. A.S.V., Provveditori di Comun, b. 7, supplica dei lavoranti del 12 agosto 1687; ivi, Senato, Terra, filza 1091, fede giurata e supplica delle donne inserte al decreto 21 febbraio 1688.
145. Ivi, Arte della Seta, b. 106, nr. 143, informazione s.d. (ma 1792).
146. B. Caizzi, Industria e commercio, pp. 117 e 123.
147. A.S.V., Senato, Rettori, filza 324, scrittura del 2 marzo 1769 inserta al decreto 9 marzo 1769.
148. Venezia, Museo Correr, Donà dalle Rose, b. 330, fasc. IV, nr. 64, nota del 1º giugno 1750.
149. Ibid., b. 331, fasc. III, nr. 18, 19 febbraio 1783; A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 87, fasc. "Tesseri", 15 novembre 1752.
150. Venezia, Museo Correr, Donà dalle Rose, b. 330, fasc. IV, nr. 64, 1º giugno 1750 (seicentoventi telai); A.S.V., Consoli dei Mercanti, b. 55, 25 settembre 1761 (milletrenta telai); ivi, Cinque Savi alla Mercanzia, ser. I, b. 487, 11 dicembre 1765 (millediciassette telai); ivi, Senato, Rettori, filza 320, decreto 13 gennaio 1768 (millesei telai); ivi, Consoli dei Mercanti, b. 56, agosto 1780 (settecentocinquantatré telai).
151. B. Caizzi, Industria e commercio, pp. 118 e 124; A.S.V., Consoli dei Mercanti, b. 57, copia decreto 11 maggio 1782 con inserte.
152. A.S.V., Senato, Terra, filza 2725, inserte al decreto 5 ottobre 1780; ivi, Inquisitore alle Arti, b. 81, scrittura del 26 aprile 1751; ivi, Senato, Rettori, filza 324, scrittura del 2 marzo 1769 inserta al decreto 9 marzo 1769.
153. Ivi, Senato, Rettori, filza 329, scrittura di Francesco Morosini del 12 marzo 1771 inserta al decreto 30 marzo 1771.
154. Paolo Malanima, Il lusso dei contadini. Consumi e industrie nelle campagne toscane del Sei e Settecento, Bologna 1990, pp. 142-146.
155. Carlo Goldoni, Una delle ultime sere di carnovale, in Id., Commedie, II, a cura di Guido Davico Bonino, Milano 1981, p. 1018. Sulla buona riuscita dei tessuti d'imitazione a Venezia, contrariamente al caso bolognese: C. Poni, Per la storia del distretto industriale serico, p. 119.
156. Questa vicenda è stata ottimamente ricostruita da Fabio Giusberti, Impresa e avventura. L'industria del velo di seta a Bologna nel Settecento, Milano 1989, pp. 11-33.
157. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, b. 469, suppliche di Maria Teresa Lorio del 29 gennaio e 15 febbraio 1732 e copia del decreto 1º maggio 1730. È possibile che il falegname bolognese specializzato nei mulini da velo, Antonio Molino, fosse alla fine approdato a Venezia: cl: F. Giusberti, Impresa e avventura, pp. 17-18.
158. Michela Dal Borgo, Nota sulle fabbriche tessili privilegiate nella Repubblica di Venezia (secolo XVIII), in AA.VV., I mestieri della moda a Venezia dal XIII al XVIII secolo, Venezia 1988, p. 75 (pp. 71-77); A.S.V., Inquisitore alle Arti, b. 6, scritture del 23 settembre 1782 e 10 aprile 1783.
159. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, ser. I, b. 467, supplica di Giovanni Paolo Parisi del 20 marzo 1753.
160. Marco Belfanti, Le calze a maglia: moda e innovazione alle origini dell'industria delle maglierie (secoli XVI-XVII), "Società e Storia", 69, 1995, pp. 494-496 (pp. 481-501); B. Caizzi, Industria e commercio, pp. 125-127; W. Panciera, Emarginazione femminile, p. 592.
161. C. Goldoni, Una delle ultime sere, pp. 1025-1026.
162. A.S.V., Senato, Rettori, filza 324, scrittura del 2 marzo 1769 insorta al decreto 9 marzo 1769.
163. Ivi, Inquisitore alle Arti, b. 63, supplica di Giovan Andrea Zanibon del 23 maggio 1789 e copia decreto 7 ottobre 1780; ivi, Consoli dei Mercanti, b. 56, scrittura del 26 settembre 1780; ivi, Senato, Terra, filza 2725, decreto 7 ottobre 1780 con inserte.
164. W. Panciera, Emarginazione femminile, p. 594.
165. A.S.V., Arte della Seta, b. 552, c. 74, parte del 13 ottobre 1718.
166. Ivi, Senato, Terra, reg. 345, decreto 29 dicembre 1753; ivi, Arte della Seta, b. 3, fasc. I, terminazione 31 agosto 1753, in particolare i capp. I, II, III, XIV, XV e terminazione 26 settembre 1755.
167. Ivi, Arte della Seta, b. 3, fasc. I, scrittura del 28 maggio 1754; ivi, Inquisitore alle Arti, b. 85, "Processo informativo testori [...]".
168. W. Panciera, Emarginazione femminile, p. 595.
169. A.S.V., Arte della Seta, b. 3, fasc. I, scrittura del 15 dicembre 1761.
170. G. Tabacco, Andrea Tron, pp. 195-196; Venezia, Museo Correr, Donà dalle Rose, b. 328, fasc. III, nr. 45, scrittura del 27 aprile 1782; fase. II, nr. 33, "Ordini e regole..." (a stampa).
171. A.S.V., Cinque Savi alla Mercanzia, ser. II, b. 175, fasc. 159/2, supplica dei tessitori del 29 gennaio 1703.
172. Venezia, Museo Correr, Donà dalle Rose, b. 318, fasc. I, nr. 53, 19 dicembre 1778.
173. A.S.V., Senato, Terra, filza 2725, decreto 5 ottobre 1780 con inserto.
174. Ivi, Consoli dei Mercanti, b. 56, terminazione 28 marzo 1778.
175. Ivi, Senato, Rettori, filza 321, terminazione 16 aprile 1768 inserta al decreto 26 maggio 1768.
176. Ivi, Inquisitore alle Arti, b. 40, terminazione 18 febbraio 1788.
177. Ivo Mattozzi, "Mondo del libro" e decadenza a Venezia (1570-1730), "Quaderni Storici", n. ser., 72, 1989, pp. 752-757 (pp. 743-786).
178. M. Inpelise, L'editoria veneziana, pp. 10-17.
179. Ibid., pp. 48-51
180. Ibid., pp. 220 e 276-277.
181. Sull'industria cartaria nello Stato veneto settecentesco: I. Mattozzi, Produzione e commercio della carta; Id., Il distretto cartario dello Stato veneziano. Lavoro e produzione nella Valle del Toscolano dal XIV al XVIII secolo, in AA.VV., Cartai e stampatori a Toscolano. Vicende, uomini, paesaggi di una tradizione produttiva, Brescia 1995, pp. 37-59.
182. M. Infelise, L'editoria veneziana, pp. 132-133, 138-140, 181-183.
183. Ibid., pp. 26-27.
184. Ibid., pp. 280-281.
185. Ibid., pp. 281-295. Sulla ditta Remondini: Mario Infelise, I Remondini di Bassano. Stampa e industria nel Veneto del Settecento, Bassano 1980.
186. Giornali veneziani del Settecento, a cura di Marino Berengo, Milano 1962; Rosanna Saccardo, La stampa periodica veneziana fino alla caduta della Repubblica, Trieste 19822.
187. M. Infelise, L'editoria veneziana, pp. 337-338 e 341-342.
188. Id., I Remondini, pp. 195-210.
189. I. Matozzi, "Mondo del libro", pp. 777-779.
190. Ibid., pp. 769-773.
191. Giorgio Montecchi, Lavoro e salute nelle botteghe tipografiche di antico regime: analisi, osservazioni e consigli del medico Bernardino Ramazzini, "La Bibliofilia", 89, 1987, pp. 196-198 (pp. 179-202).
192. M. Inpelise, L'editoria veneziana, pp. 204-208.
193. Ibid., pp. 209-210.
194. Per un'ampia panoramica sul tema, seppure non sistematica, si veda la raccolta degli scritti di Luigi Zecchin, Vetro e Vetrai di Murano, I-III, Venezia 1987-1990. Inoltre: Astone Gasparetto, Il vetro di Murano dalle origini ad oggi, Venezia 1958.
195. P. Preto, I servizi segreti, pp. 403-421.
196. Sulla lavorazione delle conterie: L. Zecchin, Vetro e Vetrai, I, pp. 85-90.
197. F. Trivellato, "L'arte madre", p. 157.
198. Ibid., pp. 36-37.
199. L. Zecchin, Vetro e Vetrai, II, p. 62.
200. Ibid., I, pp. 342-343.
201. James Barrelet, La verrerie en France de l'époque gallo-romaine à nos jours, Paris 1953, pp. 81-82; Robert J. Charleston - L.M. Angus-Butterworth, Vetro, in AA.VV., Storia della tecnologia, III, Torino 1963, pp. 229-230.
202. L. Zecchin, Vetro e Vetrai, I, pp. 297-308; II, pp. 129-156. Più in generale sulle iniziative francesi per contrastare la concorrenza italiana nel settore dei beni di lusso: Salvatore Ciriacono, Per una storia dell'industria di lusso in Francia. La concorrenza italiana nei secoli XVI e XVII, "Ricerche di Storia Sociale", 14, 1978, pp. 181-202.
203. F. Trivellato, "L'arte madre", p. 159. Secondo Salvatore Ciriacono le fornaci attive alla fine del Seicento erano ventiquattro: Salvatore Ciriacono, Manifatture e mestieri in laguna. Equilibri ambientali e sviluppo economico, in AA.VV., La laguna di Venezia, Verona 1995, p. 382 (pp. 357-383).
204. Attila Dorigato, Il Settecento, in AA.VV., Mille anni di arte del vetro a Venezia, Venezia 1982, p. 45 (pp. 45-46).
205. A.S.V., Inquisitori di Stato, b. 819, note del 14 ottobre 1743, 19 settembre 1789 e 23 settembre 1790; b. 826, nota del 5 agosto 1743; ivi, Censori, b. 38, nota del 19 maggio 1780.
206. Ibid.
207. Ivi, Censori, b. 39, scrittura dell'Arte da canna dell'11 agosto 1783; b. 38, scrittura dell'Arte dei vetrai del 22 agosto 1781.
208. L. Zecchin, Vetro e Vetrai, II, pp. 112-113; I, pp. 91-96; P. Preto, I servizi segreti, p. 409.
209. Luigi Zecchin, II capitolare dell'arte vetraria muranese del 1766, Venezia 1954; Id., Vetro e Vetrai, III, pp. 231-287 (si v. in particolare i capp. XLV e LXXI del vol. II); A.S.V., Censori, b. 39, proclama 4 gennaio 1788.
210. A.S.V., Censori, b. 38, scritture del 28 aprile 1766 e del 31 luglio 1780.
211. Cf. Michael Sonenscher, Work and Wage: Natural Law, Politics, and the Eighteenth-Century, France Trades, Cambridge 1989, pp. 22-26.
212. F. Trivellato, "L'arte madre", pp. 133- 135.
213. P. Preto, I servizi segreti, pp. 409-417; L. Zecchin, Vetro e Vetrai, I, pp. 91-96.
214. Le citazioni sono tratte da: A.S.V., Inquisitori di Stato, b. 826, lettera di Giovanni Antonio Gazabin e compagni da Trieste del 29 giugno 1745 e lettera di Pietro Fuga da Napoli del 3 maggio 1779.
215. L. Zecchin, Vetro e Vetrai, III, p. 231.
216. Per questa definizione: A.S.V., Censori, b. 38, scrittura di Pietro Pedrosin del 1° settembre 1764. 217. L. Zecchin, Vetro e Vetrai, I, pp. 88-92.
218. A.S.V., Censori, b. 40, scrittura dell'Arte dei margariteri del 29 aprile 1795 e scrittura dell'Arte dei perleri del 4 dicembre 1793.
219. L. Zecchin, Vetro e Vetrai, I, p. 97; A.S.V., Censori, b. 38, scrittura dell'Arte dei margariteri del 10 gennaio 1761.
220. B. Caizzi, Industria e commercio, p. 146; A.S.V., Censori, b. 40, scrittura dell'Arte dei perleri del 4 dicembre 1793.
221. A.S.V., Censori, b. 22, nr. 27.
222. Ibid., b. 38, scrittura dell'Arte dei margariteri del 10 gennaio 1761 e scrittura dell'Arte dei perleri del 26 gennaio 1768.
223. Ibid., b. 22, scrittura dell'Arte dei perleri del 24 marzo 1764; b. 38, fasc. "perleri contro verieri", 1767; b. 40, scrittura dell'Arte dei perleri del 4 dicembre 1793 e scrittura s.d. (ma 1794).
224. Ibid., b. 22, nr. 27, supplica dei capimaestri margariteri, s.d.; b. 38, scrittura del 1719.
225. ibid., b. 38, scrittura dell'Arte dei margariteri del 26 febbraio 1766 e scrittura dei censori, s.d. (ma 1789).
226. B. Cecchetti, Monografia della vetreria, p. 222; Anna Bellavitis, In fabbrica e in casa. Il lavoro femminile nelle "conterie" a Venezia, in AA.VV., Perle e impiraperle. Un lavoro di donne a Venezia tra '800 e '900, Venezia 1990, pp. 9-21. Si veda anche l'illustrazione di Giovanni Grevembroch, Gli abiti de' Venetiani di quasi ogni età con diligenza raccolti e dipinti nel secolo XVIII, III, Venezia 1981, p. 149.
227. A.S.V., Censori, b. 39, scrittura dei capi friulani del 31 maggio 1786. Gli "specchi dell'Ebreo" misuravano fino a un massimo di mezzo braccio per lato, cioè circa 35 centimetri.
228. I quartieri erano S. Felice, S. Sofia, SS. Apostoli, S. Cassian, S. Maria Nuova, S. Marina, S. Maria Formosa, S. Giuliano: ibid., b. 38, terminazione 26 marzo 1768.
229. Ibid., copia decreto del consiglio dei dieci del 18 agosto 1756 e scrittura dei capi friulani del 31 maggio 1786.
230. B. Caizzi, Industria e commercio, pp. 140-141.
231. A.S.V., Censori, b. 39, scrittura dell'Arte degli specchieri del febbraio 1782.
232. Si veda l'incartamento relativo ibid., in particolare le scritture dell'Arte degli specchieri del 7 ottobre 1783 e dei censori del 31 dicembre 1785.
233. Ivi, Inquisitori di Stato, b. 819, comparto fornaci 1790-1791, in data 23 settembre 1790.
234. Roberto Gallo, Giuseppe Briati e l'arte del vetro a Murano, Venezia 1953, pp. 11-16.
235. W. Panciera, Ancien Régime e chimica di base, p. 74.
236. Ibid., pp. 76-78; R. Gallo, Giuseppe Briati, pp. 17-19, 22, 28-29.
237. Rosa Barovier Meniasti, Il Vetro veneziano, Milano 1982, pp. 134-141.
238. A.S.V., Censori, b. 40, supplica del 2 dicembre 1791, scrittura dell'Arte dei vetrai del 14 maggio 1792.
239. Ivi, Inquisitori di Stato, b. 818, fasc. "fabbrica di bottiglie", in particolare suppliche del 28 luglio 1791 e del 20 settembre 1791, scrittura del 12 gennaio 1792.
240. Ibid., scrittura del gennaio 1795 e testimonianza di Luigi Zuffo, s.d.
241. Ibid., scrittura del Barbaria del 17 settembre 1796. Si vedano anche i due fascicoli ivi, Censori, b. 40. Quest'ultimo evento non fa che confermare la perdurante "versatilità" del settore: Astone Gasparetto, Dalla realtà archeologica a quella contemporanea, in AA.VV., Mille anni di arte del vetro a Venezia, Venezia 1982, p. 31 (pp. 15-38).