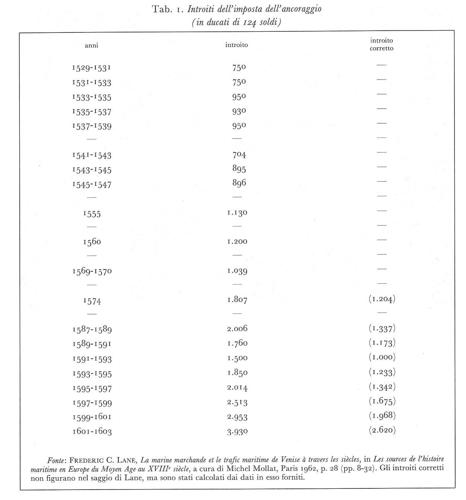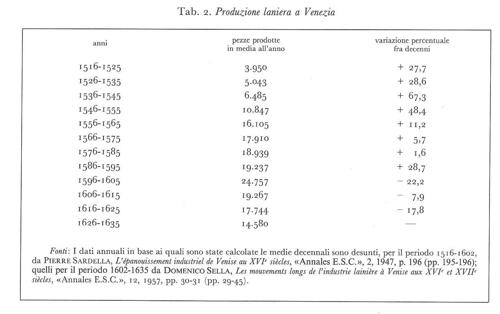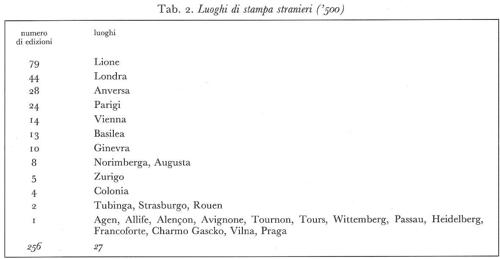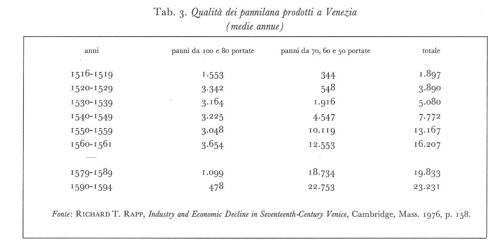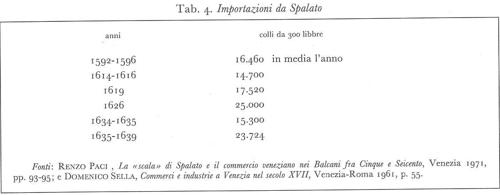L'economia
L'economia
Crisi e rilancio
Per Venezia e la sua economia il Cinquecento iniziò sotto cattivi auspici. Mentre la Repubblica era impegnata nella guerra contro l'impero ottomano (1499-1503) una guerra culminata nella disfatta navale di Zonchio e che, oltre ad un grande sforzo finanziario, costò a Venezia la perdita delle basi strategiche e commerciali di Modone e Corone in Morea - giungeva, nel 1501, la notizia che a Lisbona erano arrivate dalla rotta del Capo di Buona Speranza le prime navi portoghesi cariche di spezie. Di lì a qualche anno Venezia si trovò nuovamente impegnata nella guerra, questa volta in Terraferma, per fronteggiare la Lega di Cambrai; dopo la sconfitta di Agnadello (1509) e lo smembramento dei domini di Terraferma, ci vollero otto anni di dura lotta per riconquistarli. Nel 1517, d'altra parte, la conquista ottomana della Siria e dell'Egitto metteva a repentaglio gli interessi commerciali veneziani in Levante.
Questa serie di rovesci e di sciagure colpiva le basi stesse della prosperità di Venezia, una prosperità che ancora nel 1501 Marin Sanudo aveva rievocata in termini forse eccessivi, ma non del tutto ingiustificati: "In nessun tempo mai più s'era trovata la veneta nazione in maggior grado di prosperità, di potenza e di forza [...]. Il suo porto era sempre frequentato da innumerabile quantità di mercantili bastimenti, o nazionali o forastieri, che da ogni parte concorrevano in esso [...]. Il traffico che si faceva per essi in tutti gli empori dei quattro punti cardinali del globo era immenso" (1).
Base di tanta prosperità era stato, se non proprio il monopolio, certamente il primato che Venezia, superata la prova decisiva del duello con Genova (1381) e conquistata o riconquistata nei decenni successivi una catena di basi navali e commerciali in Dalmazia, in Morea e nell'Egeo, aveva affermato nei traffici tra l'Europa e il Levante. Primo fra tutti, quello particolarmente lucroso delle spezie provenienti dall'oceano Indiano attraverso l'Egitto o la Siria: secondo stime attendibili, già intorno al 1400 i suoi mercanti controllavano il 60% di tutte le spezie destinate ai mercati europei e questa imponente quota di mercato salì alla fine del secolo a oltre il 70% (2). D'altra parte, la conquista della Terraferma dall'Adige all'Adda, compiuta essenzialmente tra il 1404 e il 1434, aveva fatto di Venezia la capitale di uno dei maggiori stati italiani, le aveva aperto ampi sbocchi per le proprie merci e aveva messo a disposizione dell'erario nuove, cospicue fonti di entrata; ma soprattutto le aveva assicurato il controllo delle vie d'accesso ai passi alpini del Brennero e di Pontebba essenziali per gli scambi con i mercati tedesco e austriaco.
I drammatici avvenimenti del primo quindicennio del secolo XVI scossero per un momento le basi stesse della potenza e della ricchezza della città di S. Marco e, tra il 1536 e il 1540, una nuova dura prova si profilò con il rinnovarsi della guerra contro il Turco e la disastrosa sconfitta navale della Prevesa. E tuttavia Venezia si era ripresa e per un sessantennio la sua economia darà prova di un forte dinamismo e, fatto per noi non meno interessante, di una singolare capacità di adattamento di fronte a un'economia mondiale in rapida trasformazione. Tanto che uno scrittore e uomo politico veneziano, Nicolò Contarini, potrà rievocare gli ultimi anni del secolo XVI in termini non molto diversi da quelli usati da Marin Sanudo cent'anni prima. Venezia, scriverà Contarini, "era all'hora [...] abondante di tutte le cose le quali la fertilità del paese, l'industria degl'huomeni et l'opportunità del sito suole apportare ne governi ben regolati [...]. Il commercio mercantile [...] per ogni parte confluiva tanto che [...] al presente si considerava Venezia forse maggiore che in altri tempi si fusse stata" (3). Dati precisi tali da consentirci di seguire da vicino le vicende dell'economia veneziana nel Cinquecento non ne abbiamo, a dir il vero, molti. Ma quei pochi dati sicuri di cui disponiamo sono sufficienti, in prima approssimazione, a darci un idea del suo evidente dinamismo.
Nel 1509 la città contava 115.000 anime circa. Nel 1563 un censimento ne registrava 168.627: nel giro di un cinquantennio dunque c'era stato un aumento di quasi il 50% a un tasso medio annuo dell' 1%. La peste, abbattutasi sulla città nel 1576-77, distrusse forse un terzo della popolazione, riportandola bruscamente ai livelli dell'inizio del secolo (120.000 anime circa). Ma dopo la peste la ripresa fu rapida: nel 1586 Venezia contava infatti 148.637 abitanti, con un incremento di oltre il 20% in dieci anni o del 2% in media all'anno, e cioè con un ritmo di accrescimento veramente eccezionale (4).
La crescita demografica di un centro urbano non è, in sé, indice di espansione economica e tanto meno di crescente benessere. Ma va tenuto presente che l'incremento del 50% che si verificò nel periodo 1509-1563 ben difficilmente può essere attribuito al solo movimento naturale, all'eccedenza cioè delle nascite sui decessi; ad esso contribuì anche l'immigrazione che, come si dirà più avanti, è fenomeno documentato per quel periodo (5). E all'immigrazione va attribuita, a maggior ragione, la rapida ascesa dei totali demografici dopo la peste. Il che sta a indicare che per tutto il secolo Venezia esercitò un forte richiamo su gente che presumibilmente vi si trasferiva nella speranza di trovar lavoro nelle svariate attività - commerci, navigazione, artigianato - che fiorivano in un grande centro di traffici quale era Venezia.
Qualche dato basterà, del resto, a spiegare la forte attrattiva della città di Rialto nel Cinquecento. Fra il 1540 e il 1570 circa, come vedremo, la consistenza della flotta mercantile veneziana raddoppiò e incremento forse anche maggiore ebbe la marina militare. Nell'ultimo trentennio del secolo, è vero, la marina mercantile entrò in una fase di rapido declino, ma ciò non si tradusse affatto in una contrazione del movimento di navi e di merci nel porto, perché anzi proprio in quel periodo tale movimento toccò i livelli più alti di tutto il secolo, e ciò grazie al crescente afflusso di navi straniere. È quindi possibile che l'intensificarsi dei servizi portuali (carico e scarico di merci, riparazioni di navi, vettovagliamento delle ciurme in transito) sia valso a compensare in parte il declino degli armamenti e delle costruzioni navali. Ma richiamo anche più forte esercitarono le industrie. Su di esse ritorneremo più in là, ma fin da ora giova ricordare che nel corso del Cinquecento Venezia si impose come uno dei massimi centri manifatturieri d'Europa. Mentre infatti continuavano a fiorire industrie tradizionali come quelle del vetro e della seta, si svilupparono anche industrie di più recente origine quali la stampa e il lanificio. La prima, insediata a Venezia fin dal 1470 circa, conobbe la sua massima fioritura nel secolo XVI durante il quale un centinaio di stampatori-librai avrebbero pubblicato un totale di 15-20 milioni di volumi, ponendo Venezia nettamente in testa a tutte le maggiori città italiane sedi dell'industria della stampa (6). Quanto al lanificio, i suoi inizi risalgono anch'essi probabilmente alla seconda metà del secolo XV, ma la sua età d'oro fu il secolo successivo quando, nel giro di ottant'anni, la produzione di pannilana salì da poche migliaia a un massimo di 28.000 pezze (7).
Allo sviluppo delle manifatture si accompagnò anche quello delle attività finanziarie. È ben vero che, in conseguenza della paralisi dei traffici e degli enormi prelevamenti compiuti dallo Stato in occasione della guerra di Cipro (1570-1573) e della peste seguita di lì a poco, una gravissima crisi investì i banchi privati che da tre secoli avevano svolto una funzione di primo piano nell'economia dell'emporio realtino (8). Ma la creazione nel 1587 di un ente pubblico, il Banco della Piazza di Rialto, che assume le funzioni dei banchi di scritta privati e in particolare il pagamento delle lettere di cambio, ristabiliva la fiducia del mondo degli affari (9). Fiducia che si rafforza mano a mano che la Repubblica estingue l'enorme debito pubblico accumulatosi durante la guerra di Cipro e un'imponente massa di denaro torna in mano ai privati (10). Il risultato fu che all'aprirsi del secolo XVII dei mercanti potevano affermare che "in Italia e forse in Europa non si trovava una piazza più comoda di quella di Venezia per avere denaro e pagare i debiti dei cambi da ogni parte del mondo" (11).
In sintesi, si può dunque affermare che nel corso del Cinquecento Venezia, superata la crisi iniziale, conservò o ritrovò la sua attrattiva per uomini, navi e merci. Il che non significò tuttavia che, superate le sventure dell'inizio di secolo, tutto, nell'economia veneziana, ritornò al punto di prima. L'analisi delle sue principali componenti mostrerà infatti che il rilancio cinquecentesco fu attuato grazie a profonde trasformazioni e adattamenti.
Il movimento del porto
Per conoscere un'economia come quella di Venezia che da secoli aveva la sua ragion d'essere nella raccolta e la redistribuzione di merci provenienti per mare soprattutto dal Levante (spezie, cotone, seta, zucchero, grano, pellami, vini) e di merci europee destinate per lo più al Levante (fustagni tedeschi e lombardi, pannilana italiani e inglesi, rame, argento e articoli di vetro), il movimento del porto costituisce un metro prezioso. Purtroppo non disponiamo, fino ai primi decenni del Seicento, di dati relativi al volume o al valore complessivi di merci annualmente smistate a Venezia. Disponiamo però, grazie alle ricerche di Frederic C. Lane, di una fitta serie di dati relativi alle concessioni in appalto del dazio "dell'ancorazo", vale a dire dell'imposta pagata da tutte le navi che gettavano l'ancora nella laguna. Grosso modo proporzionale alla portata di ciascuna, esso gravava maggiormente sulle navi straniere in ossequio alla tradizionale politica della Repubblica che mirava a favorire i propri armatori rispetto a quelli stranieri.
A proposito di questi dati (tab. 1) va osservato in primo luogo che, trattandosi di somme versate anticipatamente all'erario dagli appaltatori dell'imposta, essi non rispecchiano anno dopo anno quanto costoro effettivamente riuscirono a riscuotere dalle navi in arrivo, ma piuttosto le loro previsioni circa il traffico portuale nel successivo anno o triennio. In secondo luogo va tenuto presente che l'imposta subì un aumento del 50% circa nel 1574: per renderli omogenei con i precedenti, i dati dal 1574 in avanti sono stati pertanto "corretti", vale a dire ridotti di un terzo. Infine c'è da ricordare che il gettito dell'ancoraggio poteva venire sensibilmente modificato da un maggiore o minore afflusso di navi straniere, dato che esse erano tenute a pagare un'imposta più elevata. E tuttavia, pur entro questi limiti, la serie di dati della tab. I costituisce, a detta di Lane che la ha criticamente vagliata, un indice prezioso, anche se inevitabilmente grossolano, per conoscere le tendenze di fondo del movimento del porto nel corso di un secolo.
I dati parlano chiaro. Dal 1529 al 1547 il movimento di navi, pur fra alti e bassi, segnò un tendenziale, anche se lento, aumento dell'ordine del 20%; dalla metà del secolo l'aumento si fece più rapido tanto che nel 1574, all'indomani della guerra di Cipro, il gettito dell'ancoraggio (al netto dell'aumento del 50%) risultava di un buon 30% maggiore che nel 1547; e dopo una sensibile flessione negli anni Ottanta in concomitanza con la crisi finanziaria di quegli anni (12), il moto ascendente riprese nell'ultimo decennio del secolo, sì che nel 1601, con un gettito di 2.600 ducati, si era ad un livello più che raddoppiato rispetto a quello del 1574. E che quello di fine secolo non fosse soltanto un aumento illusorio dovuto al fatto che in quegli anni una quota crescente delle merci che affluivano a Venezia era trasportata da mercantili stranieri, da navi cioè sulle quali gravava un'imposta maggiore, è provato dall'andamento fortemente ascendente dei principali dazi doganali in quegli anni (13); ed è provato altresì da dati parziali sul movimento di merci in arrivo: dai porti dalmati infatti giunsero 11.000 colli di merci in media all'anno tra il 1586 e il 1591, e 17.000 circa tra il 1592 e il 1595; dalla Siria vennero importate I.800 balle di seta nel 1590-91 e 2.400 circa cinque anni dopo; e le importazioni di olio dalla Puglia e da Candia salirono da circa 10 milioni di libbre nel quinquennio 1580-85 a circa 15 milioni nel quinquennio 1592-98 (14).
Sulla scorta dei dati dell'ancoraggio si è pertanto autorizzati a concludere che tra il 1530 e il 1600 circa il movimento del porto andò intensificandosi, lentamente dapprima e poi con ritmo più rapido via via che ci si avvicina alla fine del secolo.
La marina mercantile
La lenta crescita del movimento del porto protrattasi fino al 1570 circa fu accompagnata da una forte ripresa del naviglio mercantile battente bandiera veneta. Ma, paradossalmente, l'opposto avvenne negli ultimi decenni del secolo quando il traffico portuale si fece più intenso: in quel periodo infatti la marina mercantile veneziana appare in fase di netto ripiegamento.
Nel 1498 essa risultava costituita di 34 unità di forte tonnellaggio (e fra esse erano comprese le "galere da mercato") per un complesso di 26.800 botti (16.000 tonnellate circa). Sei anni dopo, al termine della guerra contro il Turco e in conseguenza delle dure perdite subite anche dal naviglio mercantile, Venezia disponeva di sole sedici unità (15). Mancano dati per il lungo periodo 1504-1560, un periodo che oltre ai drammatici avvenimenti connessi con la guerra della Lega di Cambrai, comprende anche la guerra contro i Turchi (1536-1540) che fu particolarmente deleteria per i traffici veneziani. Sappiamo però che nel 1560 la flotta mercantile aveva ritrovato la consistenza di un tempo: 37 unità per un complesso di 29.000 botti (17.000 tonnellate circa), e si trattava per lo più di "navi rotonde" a propulsione interamente velica anziché di galere da mercato ormai cadute in disuso (16). La crescita della flotta mercantile continuò negli anni Sessanta tanto che alla vigilia della guerra di Cipro essa poteva vantare un tonnellaggio forse mai raggiunto in passato, qualcosa come 40.000 botti (24.000 tonnellate circa) (17). Nel trentennio successivo, invece, movimento del porto e tonnellaggio navale seguirono traiettorie divergenti: mentre il primo, come si è detto, raggiungeva livelli massimi proprio alla fine del secolo, la flotta mercantile, decimata durante la guerra di Cipro, non si riprese più: nel 1576 era ridotta a 12.750 botti; nel 1590, a sole 10.000; se nel 1605 il tonnellaggio era risalito a quasi 20.000 botti e anche tenuto conto dell'aumento del naviglio minore che non è compreso nei dati testé citati, si trattava pur sempre di una flotta molto ridotta rispetto alla consistenza raggiunta nel 1570 (18).
Il significato di questo divario tra attività del porto e attività armatoriale è evidente: durante il "boom" di fine secolo i Veneziani furono via via meno presenti come fornitori di noli marittimi; quote sempre maggiori delle merci che entrarono o uscirono dalla laguna viaggiavano su navi straniere (19).
Quali furono le cause del parziale abbandono, dopo il 1570, di un settore di attività - quello dei trasporti marittimi - che da secoli sembrava connaturale alla città di S. Marco?
Per rispondere non mi sembra necessario fare appello a un presunto collasso dello spirito imprenditoriale dei Veneziani e ad un loro ripiegamento verso investimenti meno rischiosi quali la proprietà fondiaria e il prestito a interesse, perché in altri settori vitali dell'economia la partecipazione veneziana rimase, come vedremo, molto attiva fino alla fine del secolo. Converrà piuttosto tener presenti tre sviluppi collegati fra loro che caratterizzarono il tardo Cinquecento e modificarono radicalmente il mercato dei noli nel Mediterraneo.
La concorrenza delle marine nordiche
Ci fu, in primo luogo, l'avvento massiccio di nuovi concorrenti, e segnatamente dei velieri nordici (francesi, inglesi, anseatici e olandesi) nelle acque mediterranee. I nuovi venuti non si limitarono a soppiantare le navi venete sulle rotte che collegavano i porti mediterranei a quelli atlantici, ma offrirono condizioni di noleggio tali che gli stessi mercanti veneziani preferirono spesso affidare le proprie merci alle navi nordiche anche sulle rotte interne del Mediterraneo e in particolare su quella tra Venezia e il Levante.
L'occasione propizia che si offerse ai cosiddetti "Ponentini" per intervenire ed affermarsi nei traffici del mare interno fu la guerra di Cipro in quanto essa, per tre anni, paralizzò l'attività marinara veneziana e inflisse perdite gravi al naviglio mercantile veneziano impegnato nel logorante e rischioso compito di rifornire le forze navali e terrestri della Repubblica che difendevano l'isola di Cipro (20).
Di questa temporanea paralisi si avvantaggiarono innanzitutto i mercanti e gli armatori marsigliesi che fin dalla metà del secolo erano comparsi nei porti del Levante ed erano riusciti a sottrarre ai Veneziani una parte delle forniture di merci orientali al mercato francese. La loro presenza si fece più incisiva al tempo della guerra di Cipro, al punto che in quegli anni Marsiglia rifornì parte del mercato tedesco. Ma si trattò di un successo effimero: per tutto il resto del secolo XVI, quando la Francia fu sconvolta dalle guerre di religione, la concorrenza marsigliese non costituì più una seria minaccia per la marina mercantile veneziana (21).
Non così quella inglese che, delineatasi negli anni della guerra di Cipro, si accentuò fino alla fine del secolo e oltre. Nel Mediterraneo le navi inglesi si erano saltuariamente avventurate prima del 1570, ma, salvo brevi intervalli, le forniture di prodotti levantini e mediterranei (spezie, seta, cotone, zucchero, vino e uva passa) al mercato inglese erano state assicurate per due secoli dai Veneziani, sia con le "galere di Fiandra" o con grossi velieri che da Venezia si spingevano fino a Southampton, sia per via terrestre attraverso la Germania fino ad Anversa (22). La paralisi dei trasporti veneziani all'inizio degli anni Settanta e il saccheggio di Anversa nel 1576 indussero gli Inglesi a salpare in forza alla volta del Mediterraneo e da quel momento la loro presenza sarà determinante tanto nell'attività strettamente commerciale quanto in quella dei trasporti marittimi. Le navi inglesi riuscirono infatti non soltanto a soppiantare quelle veneziane sulle rotte di Ponente (dal Mediterraneo al mare del Nord), ma anche su quelle di Levante (tra Venezia e i porti siriani ed egiziani). Nel 1596 il console veneto ad Aleppo riferiva che gli Inglesi "tentano et presumono [...] di condurre essi quelle mercantie in questa città [Venezia] che dalle [navi] venetiane sono sempre state condotte, poiché hanno ritrovato de mercanti nostri che [...] hanno caricato sopra le navi loro" (23). Sei anni dopo una "scrittura" dei savi alla mercanzia, dell'organo cioè preposto alla politica commerciale della Repubblica, confermava il sopravvento del naviglio inglese rispetto a quello veneziano in termini anche più espliciti: "Li forestieri et stranieri de lontanissimi paesi si sono fatti patroni affatto di tutte le maestranze et marinarezze, et gl'Inglesi in particolare, havendo discacciato del tutto li nostri dalla navigatione et viaggio di Ponente, si sono anco introdotti in quello di Levante e di tutte le Isole et Stato della Repubblica" (24). Del resto, qualche anno prima le marine nordiche avevano clamorosamente dimostrato la loro forza e la loro capacità di rapido intervento nei traffici mediterranei in occasione delle grandi carestie che afflissero tutto il mondo mediterraneo tra il 1587 e il 1593: i massicci invii di grano dai paesi baltici furono effettuati non già da navi mediterranee, ma da navi nordiche - anseatiche, olandesi e inglesi (25).
Alla base del successo dei nordici c'era in primo luogo il minor costo delle loro navi rispetto a quelle costruite negli "squeri" della Laguna. "La molta spesa che fa bisogno nella fabricatione di una nave in questa città", afferma un documento governativo del 1594, fa sì che "pochi per l'avvenire saranno che vi voglino attender, ritrovandosi maggior avantaggio d'ogni cosa nel fabricarle in luoghi alieni di quello si faccia a Venezia" (26). L'affermazione non stupisce se si tiene presente sia la crescente carenza (e pertanto l'alto costo) del legname in tutto il bacino mediterraneo in conseguenza dell'esaurirsi del patrimonio forestale, sia il rincaro della manodopera in seguito alla peste del 1576 (27).
Problemi di costo affliggono in quegli anni, oltre che la cantieristica, anche i trasporti marittimi veneziani. Nella seconda metà del secolo XVI, in un periodo cioè di generale rialzo dei prezzi e dei salari, i noli marittimi mediterranei si mantennero infatti essenzialmente stabili in valore nominale e declinarono pertanto in termini reali (28). Stretti fra costi crescenti e incassi essenzialmente stazionari, gli armatori si videro costretti o a lesinare in fatto di equipaggi (anche se ciò poteva tradursi in un deterioramento dei servizi di trasporto) o a cercare di migliorare la produttività dei servizi stessi. A detta del commissario veneto all'Armata, non pochi armatori veneziani, "spinti dall'ingordiggia dell'utile", imboccarono la prima strada reclutando "marinari di pochissima esperienza, fanti, puttazzi, timidi et non avvezzi al mare" (29), con il risultato che i loro servizi di trasporto si fecero via via meno soddisfacenti e che gli stessi mercanti veneziani si rivolsero sempre più frequentemente altrove per ottenerne di migliori. A soddisfare questa esigenza si fecero avanti gli armatori nordici che si dimostrarono capaci di offrire servizi più efficenti e, tutto sommato, meno costosi, e ciò fecero puntando essenzialmente su una più elevata produttività. La loro strategia si imperniava su tre cose: viaggi più rapidi, più intensa utilizzazione del capitale fisso e maggior sicurezza.
Nel 1584 i savi alla mercanzia svolsero un'inchiesta presso i mercanti veneziani che in passato erano stati impegnati nel commercio dei vini e dell'uva passa destinati all'Inghilterra, per conoscere le cause del declino di quel commercio. In quell'occasione gli interpellati sottolinearono non soltanto i dazi più elevati che gravavano sulle merci importate in Inghilterra dai mercanti non inglesi, ma anche il fattore velocità: nel viaggio di andata e ritorno, affermarono, calcando forse un po' le tinte, "i nostri vi spendono fin duoi anni et gl'Inglesi mesi quatro overo cinque al più" (30). E qualche anno dopo il console veneto in Siria dirà che gli Inglesi "hanno navigli presti e molto spediti" e i savi alla mercanzia ne loderanno "la prestezza di viaggio" (31).
A detta di un loro compatriota, la maggiore velocità era ottenuta dagli Inglesi grazie all'impiego di "navi agili e veloci", mentre le navi veneziane erano "grandi, pesanti e lente alla vela" (32). E un viaggiatore francese, da parte sua, osservava che le navi veneziane "non possono uscire dal porto se non con determinati, venti"; per di più, "durante i loro viaggi trascorrono più tempo alla fonda che in alto mare e in tal modo non fanno strada" (33). Né era mero sciovinismo a dettare queste parole a osservatori stranieri: nel 1601 un armatore veneziano notava che le navi inglesi "stanno continuamente sopra il mare et navigano ancora [...] con vento contrario, avanzando molto di cammino: cosa che non lo possono fare i nostri vasselli né lo sanno fare i nostri marinari" (34). Tonnellaggi minori dunque e altresì velatura più efficiente: queste sarebbero state le caratteristiche vincenti dei velieri atlantici. Di fronte a loro stavano le navi venete, più grandi e più lente. Adatte ad un'età ancora vicina quando la concorrenza sul mercato dei noli non era stata così intensa e la possibilità di trovare merci da caricare nei porti mediterranei era stata meno aleatoria, esse risultavano poco competitive nel clima ben diverso che si era venuto creando fin dagli anni Settanta.
Oltre a tradursi in più elevate velocità, la superiorità tecnica del naviglio atlantico consentiva anche di affrontare il mare nei mesi invernali, mentre le navi veneziane erano tenute per legge a navigare soltanto nella buona stagione (35). In tal modo i rivali nordici, eliminando i "tempi morti" durante i quali la nave restava inutilizzata in porto, ottenevano una migliore utilizzazione degli impianti e, in ultima analisi, costi minori.
La pirateria
A favore delle navi nordiche, e soprattutto di quelle inglesi, giocava infine, a detta dei contemporanei, il fattore sicurezza, un fattore che divenne decisivo dal 1570 in poi quando nel Mediterraneo la pirateria assunse un'intensità e una diffusione senza precedenti (36).
Nel Mediterraneo la pirateria non era certamente una novità, ché anzi essa era stata endemica fin da quando quel mare era diventato teatro di lotta tra l'Oriente islamico e l'Occidente cristiano. Ma essa si era accentuata nel corso del secolo XVI in seguito all'avanzata ottomana in Grecia, in Siria, in Egitto e lungo tutto il litorale nordafricano. La clamorosa sconfitta della flotta turca a Lepanto nel 1571 ad opera delle forze congiunte di Spagna, Venezia e papato, se aveva arginato ogni ulteriore espansione ottomana verso Occidente, non aveva però risolto una volta per sempre la secolare questione dell'egemonia - cristiana o islamica - nel Mediterraneo (37). Anzi, proprio perché Lepanto non aveva eliminato, se non temporaneamente, la potenza navale turca, la lotta per il controllo dei mari continuò a svolgersi accanita, se non nella forma di guerra aperta, certamente in quella di una guerriglia i cui protagonisti furono i pirati - turchi, albanesi, barbareschi da un lato e spagnoli, maltesi (i cavalieri di S. Giovanni Gerosolimitano), toscani (i cavalieri di S. Stefano), napoletani e siciliani dall'altro. A peggiorare le cose intervennero poi altri contendenti e altre ragioni d'urto. Nell'Adriatico, a partire dal 1540 circa, ma con particolare forza nell'ultimo quarto di secolo, comparvero gli Uscocchi, profughi cristiani dell'entroterra balcanico che, rifugiatisi lungo le coste frastagliate della Dalmazia settentrionale, si dedicarono, con piccole imbarcazioni e molta audacia, a dar la caccia non soltanto al naviglio turco ma anche (e ciò nocque gravemente a Venezia) a navi cristiane dirette ai porti ottomani o recanti a bordo merci provenienti dai paesi degli infedeli. Non diversamente dagli altri corsari, gli Uscocchi godevano del tacito appoggio di uno Stato - l'impero asburgico - che vedeva di buon occhio la loro azione di disturbo a danno dei Turchi.
Ma tra i nuovi protagonisti della guerra di corsa che divampò nel tardo Cinquecento ben più importanti degli Uscocchi furono i corsari provenienti dall'Atlantico, e soprattutto gli Inglesi e gli Olandesi (spesso indicati nelle fonti come "fiamenghi"). Il fatto nuovo qui non fu soltanto la loro origine extramediterranea, ma altresì la loro religione: come protestanti, essi si sentirono autorizzati a inseguire tanto le navi degli infedeli quanto quelle dei cattolici, spagnoli o italiani che fossero. La guerriglia sul mare rientrò in tal modo nel quadro più ampio della grande lotta che, negli ultimi decenni del secolo, vide alle prese la Spagna di Filippo II, l'Inghilterra di Elisabetta Tudor, le Province Unite di Guglielmo il Taciturno e la Francia in preda alle guerre di religione. Ne risultò una lotta feroce e per così dire multilaterale, senza risparmio di colpi, alla quale parteciparono Albanesi e Barbareschi, Uscocchi e Cavalieri di Malta, Inglesi e Olandesi, Napoletani e Spagnoli; una lotta che si tradusse, come si è detto, nella crescente insicurezza dei trasporti marittimi in tutto il Mediterraneo.
In essa, man mano che ci si avvicina alla fine del secolo, i corsari inglesi e olandesi acquistano un posto di sempre maggior rilievo. Essi si distinguono dagli altri corsari innanzitutto per l'eccellente qualità del loro naviglio i cosiddetti "bertoni", cioè velieri di media grandezza, a tre alberi, con alte fiancate che rendono praticamente impossibile l'abbordaggio da parte di un attaccante e consentono, d'altra parte, la sistemazione di decine di bocche da fuoco; ma si distinguono anche per la bravura e l'audacia degli equipaggi (38). Si distinguono anche perché svolgono tanto la guerra di corsa quanto il pacifico trasporto di merci per sé o per conto di terzi ai quali sono in grado di offrire non soltanto servizi di trasporto rapidi e relativamente a buon mercato, ma anche la protezione contro gli attacchi di altri pirati. Riferendosi a loro, alcuni mercanti veneziani desiderosi di "nolizar navi forestiere" facevano notare che "il corsaro non combatte navi ponentine" (39).
Fra le varie nazioni che nel tardo Cinquecento presero parte a questa diffusa, implacabile, quotidiana guerriglia non figurò quella veneziana. Essa anzi fu forse quella che maggiormente ebbe a soffrire della piaga della pirateria. "Non è alcuno che non conosca [affermava nel 1607 Cristoforo da Canal] esser irreparabile il danno e direi quasi la dessolatione che prova questa piazza da pochi anni in qua per tanti vasselli e tanti tesori depredati da bertoni, li quali [...] concorrono da molte parti ad assalire senza alcun riguardo particolarmente i vasselli venetiani per levar loro afatto quella navigatione et quel comercio che per molti secoli ha notabilmente agrandito le cose di questo serenissimo Dominio" (40).
L'atteggiamento in apparenza passivo e la conseguente vulnerabilità di Venezia di fronte alla pirateria rispecchiavano soltanto in parte, come si dirà, carenze tecniche e umane. Non meno gravi ne erano le cause politico-diplomatiche. Nel conflitto, logorante e diuturno, fra la Spagna e i paesi protestanti e fra la Spagna e l'impero ottomano, la Repubblica di S. Marco, che perseguiva sempre più una difficile politica di neutralità fra gli opposti blocchi, ebbe infatti le mani legate. Questa sua politica era, a sua volta, dettata non soltanto dalle limitate forze militari di cui disponeva nei confronti dei due colossi mediterranei, ma altresì dalla necessità di salvaguardare la sua tradizionale funzione di intermediaria negli scambi tra l'Europa e il Levante. La sua libertà di manovra ne risultava quindi molto circoscritta. Se ne ha un esempio negli anni Ottanta quando numerosi bastimenti veneti che trasportavano grano dalla Morea (grano turco quindi) a Candia vennero intercettati da corsari maltesi per i quali l'origine del carico era giustificazione sufficiente per attaccare e far preda. La Repubblica protestò invano, e nemmeno l'appoggio del pontefice (che, in linea di diritto, avrebbe potuto dettar legge ai Cavalieri di Malta) valse a ottenere la restituzione delle navi e del carico. Venezia, d'altra parte, non osò compiere rappresaglie contro i Maltesi, perché questi ultimi erano legati al carro spagnolo e la Spagna non avrebbe tollerato nessuna azione militare contro di essi - tanto meno l'avrebbe tollerata contro i sudditi del Re cattolico (Spagnoli, Napoletani, Siciliani) che pure, tra il 1585 e il 1605 circa, intensificarono gli attacchi contro il naviglio veneziano.
Anche di fronte ai corsari musulmani (albanesi e barbareschi soprattutto) la linea di condotta di Venezia fu improntata a grande cautela e anzi timidezza: la Repubblica infatti, dopo il trattato di pace con la Porta stipulato nel 1573, volle evitare, per quanto possibile, occasioni di urto e spiacevoli incidenti. Con quel trattato, infatti, essa aveva ottenuto che le navi da guerra turche non penetrassero nell'Adriatico, ma in compenso si era impegnata a garantire che il naviglio mercantile turco vi potesse accedere indisturbato. Ciò comportava la rinuncia da parte veneziana ad ogni atto ostile nei confronti dei mercantili turchi, ed escludeva pertanto la guerra di corsa. Comportava altresì per Venezia l'impegno di proteggere il naviglio turco contro i corsari cristiani che operavano nell'Adriatico e segnatamente gli Uscocchi che proprio in quegli anni intensificarono la loro azione in quel mare. Nel 1615 Venezia finirà bensì per muovere guerra contro questi pericolosi vicini e riuscirà, se non ad eliminare del tutto, perlomeno a contenere la loro minaccia, ma ciò avverrà soltanto dopo decenni durante i quali gli Uscocchi avevano spadroneggiato nel "Golfo di Venezia" e si erano spinti in certi momenti fin quasi alle soglie della Laguna.
La ragione di una così tardiva risposta alla sfida uscocca va ricercata, ancora una volta, nella delicata posizione diplomatica della Repubblica: nonostante le pressioni ottomane e la minaccia del Gran Signore di mandare la propria flotta nell'Adriatico, Venezia temporeggiò per timore di complicazioni con l'imperatore asburgico, che proteggeva gli Uscocchi, e del suo cugino, il re di Spagna, che lo spalleggiava.
Anche più ambiguo e vacillante l'atteggiamento di Venezia verso i temutissimi pirati "ponentini": proprio perché sudditi di stati come l'Inghilterra e le Province Unite ostili alla Spagna e la cui amicizia andava pertanto coltivata per evitare l'isolamento diplomatico della Serenissima, i Ponentini bisognava trattarli con riguardo, e tanto più in quanto, come si è detto, essi spesso alternavano alla corsa il pacifico trasporto di merci e tra i loro clienti figuravano sempre più gli stessi mercanti veneziani (41).
La politica dei trasporti marittimi
Il precipitoso declino della marina mercantile veneziana dal 1570 in poi appare quindi come la risultante non soltanto di fattori economici (elevati costi del legname e della manodopera, ritardo tecnologico, metodi di navigazione antiquati), ma anche e soprattutto di fattori extraeconomici che rispecchiano la posizione sempre più debole della Serenissima in campo internazionale. Ma si sbaglierebbe a concludere da tutto ciò che Venezia assistette inerte a questo declassamento di una marina mercantile che per secoli era stata il suo vanto. Tentativi di risalire la corrente o di arginare il declino ce ne furono ed è doveroso passarli brevemente in rassegna, anche perché è probabile che senza di essi la cantieristica e i trasporti marittimi veneziani avrebbero subito perdite anche più gravi di quanto in effetto non avvenne.
E cominciamo dalle costruzioni navali. Per incoraggiare l'attività dei cantieri privati (gli "squeri" della città) la Repubblica, fin dalla metà del Quattrocento, aveva vietato ai propri sudditi tanto l'acquisto quanto il noleggio di naviglio estero; aveva cioè eretto intorno alla cantieristica della città una barriera protettiva che, se si traduceva inevitabilmente in prezzi più elevati per gli acquirenti di navi, assicurava però l'esistenza di un'industria che già a quei tempi era alle prese con il costo crescente del legname d'opera e della manodopera. Queste misure protezionistiche, più volte reiterate nel tardo Quattro e per gran parte del Cinquecento, si dimostrarono evidentemente insufficienti, se è vero che già negli anni Ottanta del secolo XV e nuovamente nel 1502, nel 1533, nel 1559 e nel 1581 il governo offrì sussidi e prestiti particolarmente favorevoli ai costruttori di naviglio mercantile, con risultati che, a giudicare dalla forte ripresa delle costruzioni navali tra il 1502 e il 1530 circa e nuovamente tra il 1535 e il 1570, Si dovrebbero ritenere molto positivi (42). Senonché analoghe misure adottate nell'ultimo quarto del secolo in piena espansione del movimento del porto realtino, non diedero l'effetto sperato: fu quello, come si ricorderà, un periodo particolarmente sfavorevole sia per l'industria delle costruzioni navali sia per quella dei trasporti marittimi veneziani alle prese con la concorrenza del naviglio nordico e con la recrudescenza della pirateria.
Non senza tentennamenti e ripensamenti, il governo veneto mutò allora strada: negli anni Settanta frequenti furono le autorizzazioni concesse a singoli mercanti di noleggiare navi straniere; nei due decenni successivi, salvo brevi periodi durante i quali venne ripristinata la vecchia normativa, fu consentito l'acquisto e la naturalizzazione di mercantili costruiti all'estero (43). L'effetto congiunto di queste misure liberistiche appare evidente in un elenco di navi attraccate a Venezia dal settembre 1598 al settembre 1599: su un totale di 60 navi un terzo erano straniere (e per lo più nordiche); delle rimanenti 40 unità battenti bandiera veneta 15 soltanto erano uscite dai cantieri della laguna. Sei anni dopo, su un totale di 27 navi appartenenti a Veneziani, ben 14 risultavano di costruzione estera (44). L'assoluta necessità di ricorrere a navi costruite all'estero per sopperire alle carenze della cantieristica veneziana è del resto pienamente avvertita in un memorandum dei savi alla mercanzia stilato nel 1597. Dopo aver lamentato il declino delle costruzioni navali provocato, a parer loro, "dalla molta spesa che fa bisogno nella fabricatione d'una nave in questa città", i savi concludevano: "Considerando noi il necessario bisogno che ha questa città delle navi et li molti beneficii che sempre si ha ricevuto con il mezzo d'esse et essendo il numero loro ristretto al presente in poche, fa bisogno per nostra opinione dar modo a' suoi cittadini che possino comprarne di forestiere et quelle far navicar come venetiane" (45).
Le autorizzazioni a noleggiare o ad acquistare naviglio straniero non esauriscono tuttavia la gamma dei provvedimenti presi per fronteggiare la crisi dei trasporti marittimi. Di fronte alla crescente concorrenza straniera e all'allarmante insicurezza dei mari, la Repubblica si preoccupò anche di proteggere merci e navi in arrivo o in partenza da Venezia. Un esempio di questa politica è offerto dall'apertura nel 1590 della "scala" di Spalato e dalla istituzione di un regolare servizio di linea tra Venezia e la città. Su proposta del mercante dalmata e console della nazione ebrea di Spalato, Daniele Rodriga (o Rodriguez), il porto cittadino venne opportunamente ampliato e attrezzato e una galera da mercato ben armata venne destinata ad effettuare sei volte l'anno la spola tra Venezia e Spalato (46). In tal modo si sperò di raggiungere due scopi: in primo luogo ricuperare un importante ramo di commercio che dai tempi della guerra di Cipro era passato in mano alla rivale Ragusa; in secondo luogo, mettere quel commercio al riparo dalle insidie degli Uscocchi (47). L'iniziativa fu coronata da successo anche perché, da parte loro, le autorità ottomane riattarono e migliorarono le strade nell'entroterra di Spalato: mentre nel 1590 alla rotta Venezia-Spalato era stata adibita una sola galera, tre anni dopo se ne ebbero due e ben quattro dal 1611 in poi (48); nel 1626 ben 25.000 colli (quasi 4.000 tonnellate) di merci giunsero in Laguna in provenienza dal porto dalmata (49).
Ma se l'impiego di galere di mercato debitamente armate poteva costituire una soluzione soddisfacente al problema della sicurezza dei trasporti marittimi in qualche caso particolare e su brevi rotte come quella di Spalato, restava pur sempre l'esigenza di proteggere l'insieme del naviglio veneziano dall'offesa dei pirati. A questo scopo, nel tardo Cinquecento la Repubblica prese tutta una serie di provvedimenti che attestano sia la gravità del problema, sia lo sforzo costante per affrontarlo. Uno di questi provvedimenti fu di adibire permanentemente una trentina di navi da guerra (le "galere sottili") divise in cinque squadre al pattugliamento delle acque più frequentate dai mercantili veneziani, e cioè il golfo d'Istria, l'Adriatico, il mar Ionio e le acque intorno a Candia (50). Misura, questa, che poteva sembrare e in parte fu adatta allo scopo, perché la galera sottile - agile, veloce, carica di gente armata e, come tale, ideale per l'inseguimento e l'abbordaggio - continuava ad essere un temibile strumento di guerra, tant'è vero che, come ha osservato Alberto Tenenti, "mai le triremi della Repubblica (se non impedite dalla mancanza di ciurme, di vettovagliamento o da altri accidenti) rifiutarono la lotta contro i corsari e tutte le volte che riuscirono ad ingaggiarla ne sortirono, materialmente e moralmente, vincitrici" (51). In pratica però le galere sottili poterono svolgere soltanto compiti limitati, sia perché il loro raggio d'azione era circoscritto dalla necessità di vettovagliare una numerosa ciurma (160 rematori oltre ai soldati), sia perché i servizi logistici veneziani si dimostrarono spesso carenti (52). Per di più, nelle galere gli uomini da remo erano sistemati a cielo aperto e pertanto esposti alle intemperie, il che praticamente escludeva il loro impiego nei mesi invernali (53). Se questo inconveniente non era grave nei confronti delle fuste e delle galeotte degli Uscocchi e dei Barbareschi che presentavano le stesse caratteristiche costruttive, esso era motivo di grave inferiorità nei confronti dei bertoni nordici che, muniti di due ponti e meglio protetti dalle intemperie, potevano navigare in qualsiasi stagione dell'anno. Senza contare che i velieri nordici, con le loro alte fiancate, erano praticamente al riparo da qualsiasi tentativo di abbordaggio (54).
Alle carenze delle galere sottili si cercò di sopperire nel 1601 con l'impiego di galeazze che erano unità di maggiore stazza e dotate di più alte fiancate e di un numero doppio di pezzi d'artiglieria. Ma i risultati furono deludenti, sia perché si riuscì ad allestire due sole di queste unità, sia perché le galeazze si dimostrarono troppo lente nell'inseguimento dei bertoni (55). Miglior esito ebbero invece altri provvedimenti presi per fronteggiare la minaccia dei corsari, e segnatamente quello che istituiva la navigazione in convoglio di mercantili di almeno 300 botti debitamente forniti di artiglieria e recanti a bordo un congruo numero di soldati. Ma l'efficacia di questo provvedimento fu limitata dal fatto che la spesa aggiuntiva per i cannoni venne accollata agli armatori privati (e, in ultima analisi, ai mercanti utenti) e costoro spesso preferivano lesinare in fatto di bocche da fuoco anche se ciò si traduceva in più alti premi di assicurazione (56).
Di fronte ad una situazione che, nonostante gli sforzi compiuti dal governo, andava peggiorando, nei primi anni del secolo XVII le autorità veneziane finirono per convincersi, molto tardivamente, che il solo mezzo valido per fronteggiare il nemico era "di fare proprio come i corsari: armare, cioè, contro i bertoni, altri bertoni". Dopo lunghi dibattiti, nel 1607 il senato decise di armare quattro bertoni, ma si trattò di un gesto velleitario, perché a Venezia non si trovavano navi di questo tipo.
Soltanto dieci anni dopo venne compiuto il passo piuttosto umiliante di assumere bertoni inglesi e olandesi al servizio della Serenissima e già nel 1618 ne erano stati assunti otto inglesi e dodici olandesi (57).
Tutto sommato, gli sforzi compiuti dal governo veneto dopo il 1570 per incoraggiare la cantieristica e per proteggere i mercantili battenti le insegne di S. Marco (fossero essi costruiti o meno a Venezia) si dimostrarono poco efficaci: tanto le costruzioni navali quanto i trasporti marittimi veneziani registrarono, dal 1570 circa in poi, una continua contrazione. La responsabilità di questi insuccessi non va tuttavia addossata interamente al governo veneziano: problemi di costo delle materie prime, carenza di manodopera, difficile situazione internazionale ebbero tutti il loro peso. Ma non ci si può sottrarre all'impressione che le esitazioni, i ripensamenti, i provvedimenti tardivi o malamente eseguiti aggravarono le cose e impedirono che due settori importanti dell'economia veneziana - la cantieristica e i trasporti marittimi - beneficiassero della favorevole congiuntura di fine secolo.
L'abbandono dei grandi tonnellaggi
Nonostante tutto, non mancarono a Venezia armatori privati capaci di trarre vantaggio in qualche modo da una congiuntura tanto favorevole e di tener testa ai concorrenti nordici. Ce lo dice innanzitutto il fatto già ricordato che ancora all'inizio del secolo XVII erano in attività navi veneziane di media o grossa portata per un complesso, tutt'altro che disprezzabile, di 20.000 tonnellate circa. Ce lo dice anche il fatto che in quel periodo la composizione della flotta mercantile veneziana subì delle modifiche importanti che testimoniano una notevole sensibilità, da parte almeno degli armatori e dei costruttori più avveduti o più intraprendenti, alle mutate esigenze del mercato dei noli e in particolare al bisogno, che fu sentito nel Mediterraneo non meno che nell'Atlantico, di valersi di naviglio meno grande che per il passato (58). L'intensificarsi della concorrenza internazionale nel settore dei trasporti marittimi e la recrudescenza della pirateria consigliavano infatti l'impiego di navi più piccole che erano più veloci e maneggevoli e che consentivano anche di meglio ripartire i rischi.
Anche a Venezia ci fu chi avvertì questa esigenza. Se ancora nel 1567 si contavano a Venezia nove mercantili di oltre 1.500 botti (900 tonnellate circa) di stazza, dopo di allora questi colossi del mare non figureranno più nella sua marina mercantile (59). Un raffronto tra il tonnellaggio medio delle navi da carico veneziane nel 1558 e nel 16o6 conferma la tendenza: 550 tonnellate in un caso contro 420 nell'altro (60). Un'ulteriore conferma è fornita dalla crescente fortuna che ebbero nel tardo Cinquecento le cosiddette "marciliane" costruite a Venezia o in Dalmazia. Si trattava di bastimenti da carico di varie dimensioni che potevano raggiungere, in qualche caso, anche le 500 botti (300 tonnellate), con fiancate basse e fondo piatto, prive di pesanti sovrastrutture, dotate di semplice velatura quadra e con pochi uomini d'equipaggio (61). Per dirla con le parole di un documento secentesco, "le qualità poi specifiche di questa sorte di bastimenti sono il poco fondo che pescano, e perciò sono habilitati ad avvicinarsi in ogni luogo; la proprietà di resistere nelle spiagge all'ingiurie del mare [...], et la modesta spesa si ricerca della fabbrica, degli armizi e della poca ciurma" (62). Da lungo tempo, precisa il documento, le marciliane erano state adibite alla "navigazione del Golfo", cioè dell'Adriatico, e in particolare al carico di "ogli, mandole et altre merci" della Puglia. Costi di costruzione e costi d'esercizio relativamente bassi facevano quindi delle marciliane una soluzione ideale per un'industria armatoriale come quella veneziana nel tardo Cinquecento, che era alle prese con utili decrescenti. E infatti risulta che all'inizio del Seicento erano in servizio ben 78 marciliane e che spesso esse si spingevano fino a Candia a caricare vino. Senonché le marciliane, sprovviste com'erano di bocche da fuoco, erano indifese contro i corsari: la loro unica difesa, vien fatto di pensare, era costituita dal fatto che l'esigua ciurma e il carico di merci relativamente ingombranti e di basso valore unitario (olio, vino) non rappresentavano una preda allettante per pirati in cerca di schiavi o di merci pregiate. Perdite comunque ce ne furono, tanto che nel 1602 il senato vietò loro di spingersi oltre Zante in vista dei "tanti naufragi et mali incontri" di cui erano cadute vittime (63).
Dietro a questo divieto c'erano, in realtà, anche altre considerazioni: non tanto, come è stato affermato (64), quella di favorire a tutti i costi, in omaggio alla tradizione, i grossi tonnellaggi; ma piuttosto quella di incoraggiare l'impiego di caracche e di galeoni che potessero all'occorrenza essere adibiti a scopi bellici (65). Il divieto del senato ottenne l'effetto voluto: da 78 che erano alla vigilia del decreto, le marciliane erano ridotte a sole 38 nel 1619; d'altra parte, tra il 1602 e il 1606 la marina mercantile si arricchì di 8 nuove unità (per lo più costruite all'estero) per un totale di 5.500 botti (3.300 tonnellate) (66).
Il commercio delle spezie
Anche se, dal 1570 in avanti, i Veneziani parteciparono sempre meno con capitali e gente propria alla costruzione di navi e ai trasporti marittimi, non per questo diminuì l'attività del loro porto, la quale anzi risultò in tendenziale aumento fino alla fine del secolo XVI. A questo punto, si tratta di spostare l'indagine dal movimento portuale nel suo complesso alla composizione merceologica dello stesso. Questa indagine è tanto più necessaria in quanto la gamma delle merci smistate nell'emporio realtino subì nel corso del Cinquecento delle modifiche importanti rispetto ai secoli precedenti.
E qui il pensiero corre subito alle importazioni di spezie e droghe dall'Oriente, a quella corrente di traffico cioè sulla quale avevano poggiato la fama e la fortuna di Venezia medievale e che proprio nei primi anni del Cinquecento venne bruscamente interrotta. È ben vero che, in termini di tonnellaggio, le spezie contavano poco: alla vigilia della scoperta portoghese della rotta del Capo di Buona Speranza, quando Venezia godeva ancora di una posizione di schiacciante superiorità in quel lucroso commercio, una decina di galere erano bastate per il trasporto di 1.800 tonnellate circa di pepe e altre spezie all'anno; d'altra parte, nello stesso periodo ben 35 navi rotonde con una portata complessiva di circa 15.000 tonnellate erano adibite al trasporto di carichi "poveri", ma ben più ingombranti, quali il cotone, il grano, la soda, l'olio e così via (67). Ma l'importanza del commercio delle spezie era costituito non soltanto dall'alto valore unitario delle merci trattate, ma altresì dal fatto che Venezia, quale massimo centro di raccolta e di distribuzione dei preziosi carichi, aveva esercitato per secoli un forte richiamo sui mercanti di tutta Europa che vi portavano merci d'ogni genere - argento e rame tedeschi, carisee inglesi, fustagni dell'alta Germania - destinate in gran parte alla riesportazione in Levante ad opera dei Veneziani. La perdita del commercio delle spezie avrebbe pertanto potuto mettere a repentaglio altre correnti di traffico facenti capo a Rialto - e nei primi anni del Cinquecento non pochi Veneziani lo credettero. In realtà tale perdita non fu né completa né irreversibile nel corso del Cinquecento (68) e anche negli anni in cui di spezie a Venezia ne arrivarono poche o niente i mercanti stranieri, come vedremo, non disertarono affatto Rialto.
Le prime notizie del celebre viaggio compiuto da Vasco da Gama nel 1498 non giunsero a Venezia se non due anni dopo e furono accolte con molto scetticismo: la rotta del Capo, si disse allora, non poteva costituire una seria minaccia al primato veneziano perché le distanze da percorrere erano troppo grandi, il lungo viaggio troppo rischioso. Venezia dormisse pure sonni tranquilli. Il vero pericolo era semmai costituito in quegli anni dalla guerra in corso contro i Turchi e dalla paralisi che essa aveva creato nel commercio veneziano di Levante: a quella guerra andava pertanto rivolta l'attenzione e urgeva cercare alleati nell'Europa cristiana per respingere il nemico.
A tal fine, nel settembre 1500 l'ambasciatore veneto in Spagna, Domenico Pisani, venne inviato a Lisbona per trattare con il sovrano portoghese non già il problema delle spezie, bensì una possibile partecipazione portoghese a una coalizione antiturca. Soltanto nel marzo 1501, a tre anni dal viaggio di da Gama, giunse a Venezia il primo resoconto ufficiale dei successi marinari portoghesi e soltanto allora si pensò di mandare a Lisbona un inviato speciale, Pietro Pasqualigo, per esaminare da vicino la nuova situazione (69).
Le cattive notizie non si fecero attendere: in giugno Pasqualigo comunicava infatti che a Lisbona erano giunti ingenti carichi di spezie e a Venezia si avvertì tutta la gravità della situazione (70). Il senso di allarme, anzi di sgomento, diffusosi a Rialto nell'estate del 1501 ci è stato efficacemente tramandato nelle pagine del diario di Girolamo Priuli, pagine ben note, ma che vale la pena di richiamare qui:
Fino alli 24 di questo [luglio 1501] vi foronno littere da Portogallo da un nuntio dela Signoria Veneta mandato in quello locho aposta per intender minutamente la veritade del viagio de l'India principiato da quello Re [...] la qual cossa importava piui al Statto Veneto che la guerra turchescha et ogni altra guerra li potesse achadere. [...] Et se questo viazo seguirà [continuerà], come già mi par ῾l sia facile, il Re di Portogallo se potrà chiamar il Re deli danari, perché tutti conchoreranno in quello paese per aver le spetie, et li danari rimaniranno in Portogallo. [...] Intexa veramente questa nova a Venetia, tuta la citade se ne risentite grandemente et chadauno rimaxe stupefatto che a questi tempi nostri fusse stato trovato uno novo viagio et mai piui ali tempi doli antiqui et progenitori auditto né vedutto, et fo tenuto questa nova per li sapienti che la fusse la pegior nova che mai la Republica Veneta potesse avere avuto dal perdere la libertà in fuori. [...] Siché concludo che, stante questo viazo de Lisbona in Cholochut come ha principiato, debia manchar le spetie alle gallie venete et alli mercadanti loro, et manchando questo trafego de merchadantia a Venetia, se pol reputar manchar il lacte et nutrimento ad un putino. Et per questo vedo chiaramente la ruina dela citade veneta, perché manchando il trafego, mancharanno li danari dali quali he proceduto la gloria et reputatione veneta (71).
In realtà le fosche previsioni del Priuli si rivelarono solo parzialmente esatte, perché la scoperta di una nuova rotta non ne assicurava automaticamente la superiorità rispetto alle strade tradizionali. Il successo dei Portoghesi non dipendeva dal fatto che il trasporto per mare lungo la rotta del Capo era più economico di quello attraverso il Medio Oriente, né dal fatto che, passando per il Capo, le spezie evitavano i pesanti balzelli che su di esse gravavano in Levante; dipendeva invece dalla capacità dei Portoghesi di impedire, con le navi da guerra di stanza nell'oceano Indiano, al naviglio arabo e indiano di far affluire le spezie sia nel Mar Rosso sia nel golfo Persico (72). Ma questa strategia, fondata com'era sullo spiegamento di navi da guerra nell'oceano Indiano e sulla creazione e il rifornimento di basi navali (Ormuz, Goa, Socotra, Malacca) lungo tutta la periferia di quel mare per fronteggiare l'implacabile ostilità degli Stati e dei mercanti arabi, questa strategia si rivelò molto costosa e, per tutto il secolo XVI, fu contestata da quanti erano stati estromessi con la forza o la minaccia dal lucroso commercio delle spezie (73).
Per quanto frammentari, i dati relativi alle importazioni di spezie ad opera dei Portoghesi nel corso del secolo XVI (74) dimostrano bensì che fin dal secondo decennio del secolo essi importavano circa 1.500 tonnellate di pepe e 400 di spezie in media all'anno, vale a dire dei quantitativi grossomodo pari a quelli importati a Venezia un ventennio prima; ma dimostrano altresì che gli arrivi di spezie a Lisbona registrarono delle forti fluttuazioni: agli anni più prosperi (1513-19, 1547-48, 1571-80) nei quali giunsero a Lisbona oltre 1.700 tonnellate delle preziose merci, fanno riscontro gli anni magri, quali, per esempio, quelli tra il 1526 e il 1531, quando le importazioni furono di appena un migliaio di tonnellate, o gli anni Novanta quando di spezie a Lisbona ne giunsero appena 700 tonnellate in media all'anno. Altro periodo di crisi per Lisbona furono gli anni 1560-66: se per essi mancano i dati portoghesi, le fonti veneziane ci parlano di una forte ripresa del commercio delle spezie che, dirette a Venezia, transitavano per l'Egitto (75).
Le alterne vicende del commercio portoghese delle spezie rispecchiano sia la capacità dell'impero ottomano, dopo la conquista dell'Egitto nel 1517 e dell'Iraq nel 1534, di intervenire con navi da guerra proprie nell'oceano Indiano e di contrastare con esse il controllo portoghese dei mari, sia l'inefficienza e la corruzione dei funzionari portoghesi incaricati di gestire il monopolio regio. Ne conseguì che in certi anni le spezie rifluirono in parte verso le antiche carovaniere e l'emporio realtino poté, per brevi periodi, riprendere la sua antica funzione di centro del commercio delle spezie (76). Tale ripresa, come si è detto, fu particolarmente vivace negli anni 1560-66, ma di lì a poco le grandi rivolte arabe contro la dominazione turca scoppiate nel 1568 e protrattesi per cinque anni, nonché la guerra di Cipro (1570-73) interruppero nuovamente i traffici levantini e consentirono a Lisbona di riacquistare il predominio nel commercio delle spezie a scapito della rivale Venezia (77), un predominio che, a giudicare dai dati sulle importazioni a Lisbona, fu mantenuto anche negli anni Ottanta. E proprio allora, e precisamente nel 1585, si ebbe la curiosa offerta fatta da Filippo II (ma in realtà sollecitata da membri influenti del senato veneziano) di cedere a Venezia l'appalto delle spezie in arrivo a Lisbona; le galere veneziane avrebbero quindi trasportato il ricco carico a Venezia sotto la scorta di navi da guerra spagnole e i Veneziani avrebbero provveduto alla distribuzione della merce in Europa (78).
Per Filippo II che dal 1576, dopo il saccheggio di Anversa da parte delle truppe spagnole e il blocco navale olandese, non poteva più contare su quella città quale centro di smistamento delle spezie nel Nordeuropa e le cui navi erano sempre più frequentemente bersaglio dei corsari inglesi e olandesi nell'Atlantico, l'accordo con Venezia sarebbe stato un buon affare in quanto avrebbe assicurato al tesoro spagnolo introiti sicuri e al tempo stesso avrebbe sollevato la Spagna di ogni preoccupazione circa lo smercio delle spezie. Per Venezia, invece, la proposta, se per un lato si presentava indubbiamente allettante, era anche irta di insidie: insidie politiche in quanto l'appalto offerto da Filippo II l'avrebbe legata finanziariamente, e pertanto politicamente, alla Spagna e l'avrebbe esposta alle ritorsioni dell'impero ottomano; e insidie economiche in quanto Venezia, una volta versato alla Spagna il prezzo d'appalto pattuito, avrebbe potuto vedersi costretta a smaltire le spezie a un prezzo anche inferiore a quello pagato se altri concorrenti fossero riusciti a incrinare il suo monopolio. Eventualità, quest'ultima, da non sottovalutare perché, come si è visto, le vie commerciali di Levante erano capaci di inattese riprese. Venezia pertanto respinse l'offerta di Filippo II, così come aveva respinto, ottant'anni prima, un'analoga offerta del re del Portogallo (79), e giocò la carta del Levante contro quella atlantica.
Nell'ultimo decennio del Cinquecento quella di Venezia si dimostrò una scelta felice. Conclusasi nel 1590 la guerra tra l'impero ottomano e quello persiano che era iniziata nel 1577, si ristabilirono nel golfo Persico e nel Medio Oriente condizioni favorevoli ai pacifici scambi. D'altra parte, l'intensificarsi sulle rotte atlantiche degli attacchi inglesi e olandesi contro le navi battenti bandiera spagnola rese via via più precaria la navigazione dalle Indie a Lisbona. La conseguenza fu il tracollo degli arrivi di spezie nell'emporio lusitano e la vigorosa ripresa del commercio levantino facente capo ad Aleppo in Siria (80). Nel 1599 il console veneto in quella città poteva riferire con evidente compiacimento che "il negotio [...] è grandissimo, poiché del continuo vi vengono caravane [...] con quantità grande di spetiarie, droghe, telami et altre robbe che vengono dall'India, che sono di grande valsente", e precisava che tra le "nazioni" europee che commerciavano ad Aleppo, quella veneziana superava tutte le altre e controllava quasi due terzi degli scambi su quella piazza, mentre Francesi, Inglesi e Olandesi si spartivano il resto (81).
Altre merci di Levante
Per quanto lucroso, il commercio delle spezie non costituisce un sufficiente termometro dell'economia veneziana nel suo complesso e tanto meno dell'attività del porto, sia perché esso era soltanto una tra le tante correnti che facevano capo alla laguna, sia (e soprattutto) perché, come si è detto, esso comportava quantità relativamente modeste di merci e di conseguenza una esigua domanda di tonnellaggio. Non stupisce pertanto che gli alti e bassi di quel pur ricco traffico non coincisero sempre con le tendenze di fondo del movimento del porto: quest'ultimo fu, come si ricorderà, in fase di lenta ascesa tra il 1530 e il 1570 circa nonostante il fatto che di spezie a Venezia ne arrivarono in forti quantità soltanto negli anni Sessanta; nell'ultimo decennio del secolo, d'altra parte, commercio delle spezie e movimento furono all'unisono. Evidentemente le fortune commerciali di Venezia e l'animazione del suo porto erano legate anche ad altre correnti di traffico e segnatamente ad altre merci d'oltremare destinate per lo più alla riesportazione.
Tra queste vanno ricordate innanzitutto le importazioni di cotone e di seta greggi. Quanto alla seta di provenienza siriana o persiana, i primi dati sicuri li abbiamo per il quinquennio 1590-95 quando ne giunsero a Rialto a 1.000 balle circa (300 tonnellate); nel quinquennio successivo ne giunsero 1.700 balle (82). Trattandosi di una materia prima destinata per lo più alle manifatture della Germania sorte e sviluppatesi nel corso del Cinquecento (83), è assai probabile che i dati testé riportati rappresentino i vertici di una curva ascendente.
Alla riesportazione era destinato anche il cotone che le galere o le grandi navi rotonde riportavano dai porti della Siria, della Turchia e soprattutto di Cipro. Era questo un commercio nel quale i mercanti veneziani si erano affermati in gara con i Genovesi fin dal secolo XIV e nel quale, alla fine del secolo successivo, avevano ottenuto una posizione di primato, un primato favorito dall'annessione di Cipro (1489) e dall'impulso che, sotto il dominio veneto, ebbe la coltura del cotone nell'isola (84). Provenisse dalla Siria, dall'Anatolia o da Cipro, il cotone importato a Venezia serviva da secoli ad alimentare le industrie tessili della Valpadana (Milano, Cremona, Bologna) e, in misura crescente, quelle della Germania meridionale (Ulm, Augusta, Ravensburg), e la domanda congiunta di queste due regioni si tradusse nel secolo XV in massicci arrivi di cotone levantino a Venezia qualcosa come 1.500-2.000 tonnellate in media all'anno (85).
Intorno a questi livelli ritroviamo le importazioni di cotone alla fine del Cinquecento quando dal Levante giungevano in media 6.000 sacchi da Cipro e 8.000 dalla Siria per un complesso cioè di 1.700 tonnellate circa (86). Tra le merci di Levante che avevano tradizionalmente animato l'emporio realtino va ricordata anche la soda destinata alle vetrerie di Murano e ai saponifici di Venezia. Su di essa ritorneremo in seguito. A questo punto giova invece soffermarci su una merce che agli effetti delle tariffe doganali veniva considerata "di Levante", ma che in effetti proveniva dalle isole venete di Zante e Cefalonia: l'uva passa. Essa rappresentava, a differenza del cotone, della seta e della soda, una novità cinquecentesca nella gamma dei prodotti smistati a Venezia. Secondo un viaggiatore inglese che soggiornava a Zante nel 1609, la produzione di uva passa per l'esportazione avrebbe preso l'avvio una sessantina d'anni prima, vale a dire intorno al 1550, il che, egli osservava, era avvenuto "a causa della golosità degli Inglesi, i quali a stento mangiano pane, dolciumi e pudding se non sono confezionati con uva passa" (87). In realtà, gli inizi della coltura viticola nelle isole Ionie risale a parecchi anni prima, perché già nel 1550 il provveditore a Zante si preoccupava della diffusione dei vigneti al punto da vietare di piantarne di nuovi, e ciò allo scopo di arginare l'allarmante contrazione delle colture cerealicole necessarie al sostentamento della popolazione isolana; e analogo fenomeno veniva segnalato a Cefalonia di lì a pochi anni (88). Ma nonostante questi divieti la produzione annua di uva passa raggiunse i 3-4 milioni di libbre piccole (900-1.200 tonnellate) nel 1578, i 5 milioni nel 1584 e i 7,5 milioni (2.200 tonnellate) nel 1604 (89).
Fin dalla metà del secolo, come osservava il citato viaggiatore inglese, lo sbocco principale per l'uva passa fu l'Inghilterra. Su questo punto le fonti veneziane sono esplicite e concordi e trovano conferma in alcuni dati relativi al commercio inglese: tra il 1560 e il 1622 le importazioni di uva passa quadruplicarono (90). Per i mercanti e gli armatori veneziani l'esportazione di questa merce verso l'Inghilterra, sommandosi a quella dei vini e dell'olio di Candia, rappresentò un'opportunità molto allettante. E infatti fino al 1570 cinque o sei grandi navi veneziane salpavano annualmente alla volta di Antona (Southampton) con ingenti carichi di uva passa (91). Questa nuova corrente di traffico si sarebbe certamente intensificata nei successivi decenni con l'espandersi della produzione e della domanda di uva passa, se ad arrestarla non fossero intervenute la guerra di Cipro e l'arrivo dei mercantili inglesi nel Mediterraneo (92). Non solo: nel 1573 il governo inglese "diede privilegio ad Acervo Velutelli luchese che potesse scuoder [riscuotere] nuova gravezza sopra le uve passe et ogli che pur andavano in Inghilterra con navi forestiere, a tal [punto] che li mercanti venetiani convennero abandonar quasi del tutto quel negotio" (93).
Questa misura tariffaria diretta contro il naviglio veneziano e intesa a favorire quello inglese ebbe l'effetto voluto. Nel 1581 il senato prendeva atto dell'arresto dei trasporti veneziani verso l'Inghilterra :
Solevano li mercanti nostri di questa città li anni finanzi l'ultima guerra [di Cipro] essercitarsi nella mercantia et trafico del viaggio di Ponente, nolizando nostre navi per le Isole della Ceffalonia, Zante et Candia dove caricavano uve passe et vini per il viaggio di Ponente [...]. Hora il detto viaggio è del tutto levato, né navigano più nostre navi [...] per le gravezze de datij poste in Inghilterra a noi insoportabili; che si può dire che per questa cagione il negotio de nostri sia bandito da quell'isola, massime essendosi introdotto che navi e vascelli forestieri capitano nelle isole nostre di Levante aducendo carisee, panni, stagni et danari et levando uve passe et vini (94).
Per ritorsione il senato creava allora una "nuova imposta" che avrebbe pesantemente gravato sull'uva passa e sul vino provenienti dalle isole Ionie e diretti oltre Gibilterra a bordo di navi non veneziane (95). Ma a tre anni dalla creazione della "nuova imposta", le cose non erano affatto migliorate: a detta dei savi alla mercanzia, gli Inglesi, in combutta con i mercanti di Zante, trovavano modo di evadere l'imposta sia dirigendosi alle vicine "rive turchesche" (cioè alle coste della Morea) dove venivano raggiunti da imbarcazioni zantiote cariche di uva passa, sia prendendo accordi con i locali appaltatori della "nuova imposta" in modo da "levar questo dacio senza concorenza", con il risultato che invece del previsto gettito di 42.000 ducati il fisco ne cavava a malapena 9.000 (96).
Soltanto nel 1600 il governo veneto prese definitivamente atto dell'insuccesso della "nuova imposta", del fatto cioè che da ormai un trentennio il florido commercio dell'uva passa era completamente passato in mani inglesi e contemplò la possibilità di adottare misure ben più drastiche, e in particolare quella di vietare del tutto l'approdo di navi straniere alle isole Ionie e di imporre che tutti i prodotti delle isole venissero inoltrati a Venezia su navi venete, così che "se gl'Inglesi et Fiamenghi vorranno cargar dei vini, uve passe et ogli conveniranno venir in questa Città" (97). Di lì a due anni un decreto del senato adottava questa proposta limitatamente all'uva passa e stabiliva che "nell'avvenir non possano esse uve passe che nascono nelle Isole della Ceffalonia et Zante esser estratte da esse isole per condurle in altri luoghi che per questa città di Venetia solamente et con vasselli venetiani o de sudditi della Signoria Nostra" (98), Nonostante le vivaci proteste inglesi (99), il decreto fu applicato alla lettera e con risultati eccellenti: dal 1 giugno 1603 a tutto maggio 1604, da Zante e Cefalonia giunsero a Venezia 2.200 tonnellate circa di uva passa (100).
Accanto alle importazioni di merci relativamente costose quali le spezie, la seta, il cotone e l'uva passa, vanno ricordate anche quelle di due merci di basso valore unitario - il sale e i cereali - che, trattate in quantità ben più ingenti, ebbero un posto di grande rilievo nella domanda di tonnellaggio navale e nel movimento del porto.
Il sale, prodotto nella Laguna stessa o lungo le spiagge del delta padano, aveva costituito una delle prime merci di esportazione con le quali Venezia aveva allacciato rapporti commerciali con l'entroterra ottenendo in cambio cereali, legname, ferro e così via (101). Dal Duecento in poi la Repubblica aveva mirato ad ottenere il monopolio di questa merce, essenziale per l'alimentazione e in minor misura per la lavorazione del cuoio, sia imponendo il proprio dominio sulle saline del litorale ravennate (Cervia) e istriano (Pirano), sia offrendo alle proprie navi che, di ritorno da Cipro, dalla Puglia, dalla Sicilia e dalle Baleari, riportassero sale, la possibilità di cederlo a prezzi particolarmente vantaggiosi alla camera del sale, la quale poi provvedeva a smaltirlo in città, nella Terraferma e, se possibile, a esportarlo negli Stati italiani e segnatamente nel ducato di Milano. Politica costosa, questa, in quanto equivaleva a sussidiare la marina mercantile tenendo artificialmente alto il prezzo del sale versato agli armatori; ma era una politica che si giustificava con la necessità, fortemente avvertita dalle autorità veneziane, di tenere in attività un congruo numero di navi di grosso tonnellaggio che potessero essere mobilitate in tempo di guerra per servire da appoggio alle galere da combattimento e, in tempo di carestia, per far affluire a Venezia grossi quantitativi di grano (102).
Il tentativo di monopolio non era mai completamente riuscito, ma non c'è dubbio che nella seconda metà del Quattrocento Venezia si era affermata come il massimo centro di distribuzione del sale mediterraneo (103). La disfatta veneziana durante la guerra di Cambrai inflisse duri colpi a questo commercio e comportò, fra l'altro, l'esclusione del naviglio veneziano dalle saline della Romagna e della Puglia, nonché dalla navigazione del Po il cui accesso era ormai controllato dallo Stato della Chiesa, con la conseguente perdita dei ricchi mercati della Valle Padana (104). Ciononostante il commercio del sale registrò una vigorosa ripresa: a metà del Cinquecento giungevano annualmente a Venezia 4.500 moggia di sale, vale a dire poco meno delle 5.000 moggia in arrivo alla fine del secolo precedente; intorno al 1560 ne giunsero oltre 6.000 e, tra il 1576 e il 1582, ben 7.500 (105).
Non è facile stabilire le ragioni dell'incremento delle importazioni di sale nel Cinquecento, ma è plausibile attribuirlo al crescente fabbisogno di una popolazione che, tanto a Venezia quanto in Terraferma, fu in aumento fino alla peste del 1576. È ben vero che le massime importazioni si ebbero poco dopo il flagello (106), ma si può supporre che la peste stessa, nella misura in cui paralizzò i normali traffici, provocasse un forte calo nelle giacenze di sale; naturale quindi che si provvedesse a colmarli non appena cessata l'epidemia. Ma quali che siano state le cause della crescita del commercio del sale tra il 1550 e il 1580 circa, resta il fatto che esso contribuì in misura sensibile al movimento del porto: tenuto conto che un moggio equivaleva grosso modo a una tonnellata, l'incremento da meno di 5.000 a oltre 7.000 tonnellate di carico fu tutt'altro che trascurabile.
Negli anni 1587-93 le importazioni di sale calarono bruscamente a sole 3.800 moggia in media all'anno (107) in concomitanza con la temporanea flessione del gettito dell'ancoraggio (tab. 1) che si ebbe proprio in quegli anni. Quanto alle ragioni di questo calo delle importazioni di sale, esse vanno probabilmente ricercate nel fatto che gli anni 1587-93 furono segnati dalla grande carestia che investì tutto il mondo mediterraneo: in quelle condizioni, l'affannosa ricerca di cereali anche in paesi lontani (primi fra tutti quelli baltici) impegnò quote eccezionalmente elevate di naviglio a tutto scapito di altre merci ingombranti quali il sale (108). Mancano dati per gli ultimi anni del Cinquecento, ma se è lecito supporre che le importazioni di sale ricuperassero parte del terreno perduto, un completo ritorno ai livelli raggiunti negli anni Settanta appare piuttosto improbabile. E ciò non soltanto perché il fabbisogno complessivo di sale per una popolazione decimata dalla peste non era più quello di un tempo, ma anche perché, con l'affermarsi, sul finire del secolo, di nuovi importanti centri di raccolta e di smistamento a Fiume, Trieste e Goro, l'antico "monopolio" veneziano del sale venne definitivamente infranto (109).
Se le crescenti importazioni di sale contribuirono, almeno fino al 1580 circa, all'intensificarsi dell'attività del porto di Venezia, lo stesso dovrebbe valere, a maggior ragione, anche per quelle di cereali, un'altra merce ingombrante e di basso valore unitario che per secoli aveva avuto un posto di grande rilievo nel commercio marittimo facente capo a Venezia. È noto infatti che, anche dopo la conquista della Terraferma nel primo Quattrocento, il fabbisogno cerealicolo della città era stato soddisfatto attingendo a fonti di rifornimento anche molto distanti (Puglia, Sicilia, Grecia, Mar Nero) ed era stato assicurato da navi veneziane. Né si era trattato di poca cosa: una città di 115.000 anime (quante ne contava Venezia all'inizio del Cinquecento) esigeva rifornimenti annui dell'ordine di 25.000 tonnellate, cifra veramente imponente se rapportata alle dimensioni delle marine mercantili del tempo (110). Se si tiene poi presente che alla fine degli anni Sessanta, quando la popolazione veneziana raggiunse quasi le 170.000 unità, tale fabbisogno dovette aggirarsi sulle 37.000 tonnellate, si sarebbe tentati di concludere che le importazioni di cereali diedero un contributo decisivo e ben più importante di quelle di sale alla crescita del movimento del porto.
Senonché tale conclusione è valida soltanto per la prima metà del secolo, perché già nel 1566 su un totale di 585.000 staia (35.000 tonnellate circa) di grano entrate a Venezia, quasi un terzo risultava proveniente dalla Terraferma veneta; e trent'anni dopo su un totale di 530.000 staia, l'80% (e cioè 430.000 staia) proveniva di lì (111). Agli effetti della domanda di grandi navi da trasporto, ciò implica che il grano importato via mare scese dalle 25.000 tonnellate circa del 1566 a meno di 7.000 sul finire del secolo.
Le ragioni di questo rovesciamento di posizioni tra grano estero e grano dell'entroterra veneto sono state analizzate molto bene da Maurice Aymard che ha messo in risalto un duplice fenomeno: da un lato l'inaridirsi delle esportazioni dalla Grecia e dal Mar Nero per volere del governo ottomano sempre più preoccupato di riserbare la produzione interna di grano all'approvvigionamento di una popolazione in aumento e soprattutto di una capitale, Costantinopoli, che nel corso del Cinquecento, "esplode" fino a raggiungere i 700.000 abitanti; d'altro lato, la messa a coltura, dal 1540 in poi, di estensioni via via crescenti di terreni nel Padovano, nel Trevisano e nel Polesine in seguito a grandi lavori di bonifica e di dissodamento (112). L'importanza di questa sostituzione di grano importato con grano nazionale non può essere sottovalutata: in un periodo nel quale la marina mercantile veneziana si dibatteva in gravi difficoltà e la città fu costretta a dipendere sempre più dall'estero in fatto di trasporti marittimi, non fu vantaggio da poco non dover ricorrere a questi ultimi per assicurare anche il grosso del fabbisogno di cereali; senza contare che, attingendo in misura crescente alle risorse agricole del suo entroterra, Venezia ridusse drasticamente una pesante voce passiva nella sua bilancia commerciale.
11. Lo sviluppo industriale
L'andamento delle importazioni di merci levantine, di sale e di grano non danno pienamente ragione del tendenziale aumento del movimento del porto, aumento che, a giudicare dai dati dell'ancoraggio, si protrasse fino ai primi del Seicento. Si è constatato infatti che, mentre le importazioni di tutte queste merci, eccettuate le spezie, furono in aumento fino al 1570 circa (o al più tardi fino al 1580), dopo tale data quelle di grano e di uva passa prima e di sale poi persero quota, e ciò proprio nella fase di massima attività del porto. È ben vero che nell'ultimo decennio del secolo il traffico delle spezie ritrovò inaspettatamente l'antica floridezza e che quello della seta di Levante raggiunse punte massime, ma va ricordato che né l'uno né l'altro contavano molto in fatto di tonnellaggio impiegato. E quindi evidente che altre merci, altre correnti di traffico contribuirono ad animare l'emporio e che ciò fecero con particolare intensità nell'ultimo quarto del secolo.
Per individuare queste correnti è necessario spostare lo sguardo dalla tradizionale funzione di Venezia come centro di transito e di smistamento negli scambi tra Europa e Levante (funzione sulla quale da sempre si sono appuntate di preferenza l'ammirazione dei contemporanei e l'attenzione degli storici) alla funzione di Venezia come centro industriale, perché questa funzione acquistò crescente peso nel corso del Cinquecento al punto da far ombra forse a quella tradizionale (113).
Non che la presenza di attività industriali nella laguna fosse una novità cinquecentesca. Venezia vantava da secoli una gloriosa tradizione in fatto di costruzioni navali - quelle di stato concentrate nell'Arsenale e quelle private disseminate negli "squeri". Si trattava di un'industria che aveva generato e continuava a generare un largo flusso di materie prime - legname della Dalmazia e dell'arco alpino, canapa e lino dell'entroterra padano, ferro, pece e così via. Ma si trattava anche di un'industria che, come si ricorderà, fu in fase di forte regresso dal 1573 circa in avanti quella di stato per i ridotti impegni militari dopo la guerra di Cipro, quella privata per la concorrenza delle marine nordiche.
Non meno antica e gloriosa era l'edilizia, privata o pubblica. È un'industria i cui prodotti sono in gran parte ancora visibili oggi e continuano a formare l'oggetto della nostra ammirazione e degli appassionati studi degli storici dell'arte. Ma è anche un'industria poco studiata dagli storici dell'economia nonostante la sua evidente importanza ai fini dell'occupazione di manodopera, dei capitali in essa investiti e del contributo che essa diede al movimento del porto con la domanda di legname d'opera, laterizi, calcina, pietre da taglio e marmi fatti venire per via fluviale dall'arco alpino, dal Padovano e Trevigiano e per via marittima dall'Istria. Non è facile, data la mancanza di ricerche specificatamente economiche sull'argomento, valutare l'importanza dell'edilizia nell'ambito dell'economia veneziana nel Cinquecento, ma non si può fare a meno di pensare che l'incremento demografico di oltre il 40% tra l'inizio del secolo e la peste del 1576 abbia dato un forte impulso alla costruzione di comuni case di abitazione. D'altra parte, siamo nel secolo di Sansovino, Scamozzi, Palladio e Antonio da Ponte, in un secolo cioè in cui a Venezia si costruì molto e con magnificenza. Basti pensare al fondaco dei Tedeschi ricostruito in modo grandioso dopo l'incendio del 1505; al complesso delle fabbriche di Rialto, anch'esse distrutte dalle fiamme nel 1514 e riedificate nel decennio successivo con nuova larghezza di vedute; al palazzo Corner (Ca' Granda) ricostruito dal Sansovino negli anni Trenta; ai numerosi palazzi cinquecenteschi che fiancheggiano il Canal Grande; alla sistemazione della piazzetta di San Marco con la Biblioteca, la Zecca e la Loggetta compiuta negli anni Quaranta; alle Procuratie vecchie che risalgono ai primi decenni del secolo e a quelle nuove sorte, su disegno di Scamozzi, negli anni Ottanta; alle palladiane chiese del Redentore e di S. Giorgio Maggiore anch'esse di quel periodo e al ponte di Rialto completato tra il 1587 e il 1591. Va infine notato che, in termini di manodopera impiegata, l'edilizia (con quasi 1.500 iscritti alle corporazioni nel 1595 oltre ad un numero imprecisato, ma certamente molto consistente di operai ad essa legati, quali i "cavacanali" addetti ai lavori di fondazione e ai "burchieri" addetti al trasporto dei materiali) si collocava tra le maggiori industrie della città (114). Tutto sommato, siamo in presenza di una grossa industria e non si può escludere che l'intensificarsi del traffico portuale nel tardo Cinquecento rispecchi in parte il fervore dell'attività edilizia, un fervore testimoniato dalle due grandi chiese palladiane, dalle Procuratie nuove e dal ponte di Rialto, ma suggerito altresì dal forte rialzo dei salari edilizi in quel periodo: nonostante che i vuoti creati dalla peste nei ranghi della manodopera fossero stati rapidamente colmati dall'immigrazione, il salario medio giornaliero dei maestri muratori salì da 38 soldi nel 1580 a 61 soldi vent'anni dopo (115).
Tra le industrie di antica data va anche annoverata quella vetraria che, inizialmente ubicata a Venezia, era poi stata trasferita nella vicina isola di Murano. Celebre fin dal tardo medioevo, essa raggiunse nuovi vertici e crescente fama nel Cinquecento con una straordinaria gamma di prodotti che andava dagli articoli d'arte più pregiati, quali i vasi e le caraffe di vetro colorato o bianco (cristallo), agli specchi, alle clessidre, alle semplici perline per collane, monili e rosari, e ai vetri da finestra (116). Famosi in Levante non meno che in Europa, i prodotti dell'industria vetraria muranese costituivano una voce importante nel commercio veneziano di esportazione (117). Ma non va peraltro dimenticato che l'industria vetraria comportava anche un'importazione tutt'altro che trascurabile di materie prime: legna da ardere, calce, silice e soda (detta "cenere"). Se legna, calce e silice provenivano dal vicino entroterra, la soda bisognava procurarsela in Siria o in Egitto dove veniva ottenuta con la combustione di un arbusto (salsola) ricco di sostanze alcaline (118). Né si trattava di cosa da poco: nel 1592 i 40 forni da vetro in attività a Murano avrebbero consumato quasi 600 tonnellate di soda (119).
La soda costituiva anche una materia prima indispensabile per un'altra grande e rinomata industria veneziana, quella del sapone che, all'inizio del secolo XVII, ne assorbiva 3 milioni di libbre grosse all'anno (1.000 tonnellate circa). Ma oltre alla soda il saponificio assorbiva anche forti quantitativi di olio proveniente "dalle province di Terra d'Otranto e Bari, cioè Puglia, Abbruzzo, Romagna, Marca et altri luochi alieni": 4.800.000 libbre grosse all'anno (2.200 tonnellate circa) all'inizio del secolo XVII (120).
Alle industrie veneziane erano destinati anche forti importazioni di zucchero e di cera. Nel tardo medioevo lo zucchero raffinato proveniente dall'Egitto, dalla Sicilia o da Cipro (I2') aveva occupato un posto di grande rilievo nelle importazioni veneziane e a Venezia stessa era sorta una fiorente industria dove il prodotto levantino subiva ulteriori lavorazioni per la confezione di medicinali, canditi e dolciumi vari. Il commercio veneziano dello zucchero, già ben avviato nel secolo XIV, ricevette nuovo impulso nel secolo successivo in seguito alla penetrazione veneziana a Cipro, penetrazione culminata con l'annessione dell'isola al dominio veneto nel 1489. A quella data però già cominciava a farsi sentire la concorrenza dello zucchero portoghese prodotto nelle isole atlantiche di recente scoperta e Venezia, non meno degli altri maggiori centri europei, già alla fine del Quattrocento ne importava forti quantitativi (122). Ne seguì che la coltura della canna da zucchero a Cipro andò perdendo piede e cedette via via il passo a quella del cotone (123). Non per questo venne meno la lavorazione dello zucchero a Venezia: ancora intorno al 1622 ne giungevano 1.300 tonnellate all'anno (I24). Altra importante industria di trasformazione fu quella delle candele ottenute con cera importata soprattutto dai Balcani: nel 1591 erano in attività 23 "cerarie"; trent'anni dopo esse erano salite a 30 e in esse venivano lavorate 2.300.000 libbre sottili (700 tonnellate circa) di cera (125).
Tra le industrie tradizionali va annoverato anche tutto un complesso di attività artigianali legate all'abbigliamento e all'arredamento e orientate per lo più ai consumi di lusso: nastri e frange, veli e berretti, bottoni, calze di seta, pettini, forbici e coltelli, borse, cinture e foderi da spada. Erano tutte merci che venivano vendute nelle botteghe dei merciai ("marzeri"), un folto gruppo di commercianti che già nel 1446 non esitava a definirsi "la più nobile e ricca arte di Venezia". Forte di 446 iscritti nel 1567 e di ben 964 distribuiti in 400 botteghe vent'anni dopo, la corporazione dei merciai costituiva un gruppo molto eterogeneo che annoverava nelle sue file, accanto a modesti bottegai, anche un centinaio di membri con capitali ragguardevoli - tra i 1.000 e i 5.000 ducati (126). Non è possibile stabilire quali dei numerosi articoli trattati dai merciai erano confezionati a Venezia stessa e quali provenivano da fuori. È probabile tuttavia che forbici e coltelli venissero dalla Terraferma e segnatamente dal Bresciano, sede a quei tempi di fiorenti industrie metallurgiche (127). Le pellicce e gli articoli in pelle più pregiati, quali le borse e le cinture finemente lavorate, erano invece prodotte a Venezia stessa. Ce lo dice il fatto che alla lavorazione delle pelli e delle pellicce erano addette ben sette corporazioni per un complesso di oltre mille iscritti (128). Del resto sappiamo che a Venezia l'importazione di pelli era un grosso affare: ai primi del Seicento ogni galera di Spalato ne importava, al termine dei sei viaggi annuali, qualcosa come 3.600.000 libbre grosse (17.000 quintali circa) all'anno (129): le quattro galere adibite a quella linea avrebbero pertanto fatto affluire a Venezia circa 60.000 quintali di pelli all'anno, destinate in parte alle concerie della Terraferma (130), ma in parte anche alle numerose botteghe degli artigiani del cuoio residenti a Venezia.
Quanto agli articoli di seta di cui traboccavano le botteghe dei merciai, non c'è dubbio che si trattava di roba prodotta a Venezia. Il setificio, infatti, vi si era saldamente insediato ad opera di profughi lucchesi fin dagli inizi del Trecento e un secolo dopo la città, con ben 3.000 telai in attività, era diventata uno dei maggiori centri dell'industria serica in Italia e in Europa (131). Alquanto decaduto nel tardo Quattrocento e forse anche più durante gli anni difficili del primo Cinquecento, il setificio veneziano si era ripreso in seguito: tra la fine del Quattro e la metà del Cinquecento le sue maestranze erano salite da 500 a 1.200 addetti (132) e l'espansione continuò fino alla fine del secolo quando di soli tessitori se ne contavano 1.500 (133): a quel tempo si producevano circa 700.000 metri di tessuto in media all'anno e una gamma di prodotti che andava dal semplice ormesino ai più costosi rasi, damaschi e velluti fino ai preziosi panni auroserici (134). Era questa un'industria che, oltre a rifornire le botteghe della città, alimentava anche una forte esportazione tanto verso l'Europa quanto verso il Levante e soprattutto verso Costantinopoli, l'enorme metropoli che un viaggiatore italiano descriveva nel 1573 come "ricchissima, poiché, oltre alle infinite ricchezze del Signore [il Sultano], delli suoi serragli, di quello della Sultana et di molti Bascià, vi è una grandissima quantità d'oro nelli mercanti et in molta gente privata". Sbocco ideale quindi per i costosi tessuti veneziani: a Costantinopoli, scriveva un osservatore inglese nel 1606, "il veneziano commercia più di ogni altro [...] le merci che manda qui sono panni alti, seterie di ogni genere, drappi di argento e d'oro" (135).
12. L'ascesa dell'industria laniera
A industrie tradizionali come la lavorazione del vetro, del cuoio e della seta se ne affiancarono anche di nuove. Una fu l'arte della stampa che, sorta a Venezia intorno al 1470, ebbe nel Cinquecento, come si ricorderà, uno straordinario sviluppo. Nuova può anche considerarsi l'industria della lana: presente a Venezia, è vero, fin dal tardo Trecento, ma rimasta di dimensioni modeste fino alla fine del secolo XV, essa vide la propria produzione salire da meno di 4.000 pezze all'anno in media intorno al 1520 a oltre 24.000 alla fine del Cinquecento (tab. 2).
L'importanza che l'ascesa del lanificio ebbe nel commercio veneziano d'esportazione non può essere sottovalutata. I pannilana prodotti a Venezia, non diversamente dai tessuti serici, erano destinati per lo più ai mercati levantini e anzi costituirono il nerbo del commercio con il Levante.
Lo constatavano i savi alla mercanzia nel 1585, quando era in discussione la già ricordata proposta di Filippo II di affidare a Venezia l'appalto della vendita delle spezie in Europa: "Se mancheranno le spezie in Levante, come mancano tuttavia, et se non veniranno, come già molti anni non vengono, di Soria o d'Alessandria, non saranno manco i negotii di questa città con Levante di quello che al presente sono, né minor il lanificio o l'arte della seta di quello che siano, perché [...] le nostre pannine sono contrattate con sete, zambellotti, cotone, galle [...]" (136). A quella data dunque il commercio di Levante era considerato, nonostante la mancanza di spezie, in piena fioritura e le industrie tessili di Venezia ne costituivano un po' la chiave di volta in quanto i loro prodotti fungevano da principale merce di scambio per ottenere i prodotti levantini.
Ma la crescita del lanificio comportò altresì lo sviluppo su larga scala delle importazioni di materie prime indispensabili per la fabbricazione del tessuto: in primo luogo, ovviamente, la lana pregiata spagnola; poi anche l'olio proveniente dalla Puglia per la preparazione dei filati; e infine le materie tintorie e l'allume di rocca necessario per il fissaggio dei colori. Nei tre casi si trattò di quantitativi crescenti che, trasportati a Venezia via mare, contribuirono senza dubbio ad animare il suo porto. Ma in che misura? "A fabricar un panno alto [...] gli vole pesi quatro et megio di lana", si legge in un documento della fine del Cinquecento (137). Se l'informazione è esatta e tenuto conto che un "peso" equivaleva a 8 kg circa, si dovrebbe concludere che le importazioni di lana greggia salirono da 150 tonnellate nel secondo decennio del secolo quando la produzione media annua fu di 4.000 panni alti a quasi 900 tonnellate alla fine del secolo quando essa superò le 24.000 unità. Di olio, secondo una stima di fine secolo, il lanificio ne avrebbe assorbito 800.000 libbre grosse all'anno (400 tonnellate circa) (138). Mancano notizie in fatto di materie coloranti; per l'allume invece Jean Delumeau ci ha fornito cifre precise sulle esportazioni via mare da Civitavecchia, fonte principale di rifornimento, a Venezia. Si passa da circa 3.000 cantari (150 tonnellate) in media all'anno nel primo decennio del secolo a oltre 6.000 nell'ultimo, con forti fluttuazioni intermedie. Evidentemente tali cifre non rispecchiano, se non in misura molto grossolana, il crescente fabbisogno del lanificio veneziano, e ciò per ragioni che lo stesso autore ha messo in luce: una era che parte dell'allume che giungeva a Venezia era poi inoltrata verso i lanifici della Terraferma; un'altra era che, in anni nei quali la navigazione nello Ionio e nel basso Adriatico si rivelò particolarmente rischiosa, grosse partite di allume vennero spedite da Civitavecchia a Pesaro per via di terra e da lì poi inoltrate via mare fino alla Laguna (139). È comunque chiaro che, nel corso del Cinquecento, l'allume romano figurò in quantità crescenti tra le importazioni veneziane e si può forse affermare che, nel loro insieme, lana, olio e allume rappresentarono poche centinaia di tonnellate all'inizio del secolo e qualcosa come 1.600 alla fine. Quantitativi, questi, che possono sembrare modesti, ma che vanno rapportati alle dimensioni delle flotte mercantili del tempo; quantitativi anche che, sommati a quelli delle materie prime (cotone, cera, soda, calce, pelli e così via) destinate ad altre industrie veneziane, contribuirono all'espansione del traffico portuale cinquecentesco.
Ma il lanificio va anche ricordato per l'importanza che ebbe agli effetti della formazione del reddito, dei livelli di occupazione e della bilancia commerciale.
Qualche cifra varrà a dare un'idea del posto di primo piano che questa nuova industria venne ad occupare nell'economia della città. Alla fine del Cinquecento la produzione media annua di oltre 24.000 pezze di panno fino rappresentava un valore complessivo di circa 1.900.000 ducati (140): era questa una cifra grosso modo pari all'intero gettito delle imposte della Repubblica e dieci volte superiore al valore della merce prodotta nelle celebri vetrerie di Murano (141). Con più di 3.000 addetti il lanificio peraltro gareggiava, quanto a manodopera impiegata, con l'Arsenale (2.500-4.000 addetti) e superava tanto il setificio (2.000 addetti circa) quanto l'industria edilizia (1.500 addetti circa) (142). Esso costituiva inoltre l'asse portante del commercio di Levante nell'ultimo periodo - gli anni Novanta - della sua ritrovata floridezza: nel 1592 infatti Aleppo assorbì 10-12.000 pezze di panno veneziano, Alessandria 4.000, i paesi balcanici 5.000 e Costantinopoli 3.000 (143), per un complesso di 22-24.000 pezze, pari cioè al 90% dell'intera produzione di quegli anni. Un raffronto poi con i massimi centri italiani dell'industria laniera ci fornisce un metro per valutare la posizione relativa di Venezia: alla fine del Cinquecento Firenze, che pure aveva prodotto 33.000 pannilana nel 1561, ne produceva soltanto 13.000 (144), vale a dire la metà circa di quanti ne produceva Venezia; Bergamo, da parte sua, con 26.500 pezze prodotte nel 1596 (145), gareggiava bensì con la Dominante per il primato, ma va tenuto presente che i tessuti bergamaschi erano per lo più "panni bassi", e cioè tessuti di qualità andante e di prezzo di gran lunga inferiore a quello del "panno alto" di Venezia.
Tutto sommato, è lecito affermare che il lanificio veneziano, ancora insignificante all'inizio del secolo, venne a costituire, alla fine di esso, l'attività più saliente nell'ambito dell'economia cittadina, un'attività che, sommandosi alle altre industrie quali la cantieristica, il vetro, la lavorazione del cuoio, il setificio e la stampa, fece di Venezia uno dei centri manifatturieri più dinamici dell'Europa del tempo. È quindi opportuno soffermarsi brevemente sulle vicende del lanificio per capire le ragioni della sua straordinaria fortuna.
Gli inizi del lanificio veneziano sono mal note. La produzione di panni scarlatti ottenuti con le migliori lane inglesi (lane dette "francesche") è attestata fin dal secolo XIII (146), ma è possibile che, in seguito, essa si fosse estinta o quasi: una delibera del senato del 1433 ci informa infatti che "est impossibile quod in hac civitate possint laborari panni 3.000 et ultra [...] qui sunt necessarii pro nostra draparia" (147). Affermazione ambigua in quanto può significare sia che la produzione non raggiungeva le 3.000 unità, sia che essa, inesistente o quasi, lasciava insoddisfatto il fabbisogno locale valutato a 3.000 panni all'anno circa. Propendo per la seconda ipotesi alla luce di un decreto del senato del 1458 secondo il quale "se ha principiado adesso el mester de la lana in questa città et lavorase a grandissima furia de ogni sorta de panni" (148). Quale esito abbia avuto, a lungo andare, questa "grandissima furia" non ci è dato conoscere. Ad ogni modo nel secondo decennio del secolo XVI, quando veniamo in possesso di dati precisi (tab. 2), la produzione media annua si aggirava sulle 4.000 pezze.
L'assenza totale o le modeste dimensioni dell'industria laniera a Venezia nel Quattrocento contrastano nettamente con l'importanza che ebbe in quel secolo la riesportazione da Venezia verso il Levante di tessuti di lana di varia qualità provenienti dalle città lombarde (panni pregiati da Milano, di media qualità da Como, Monza e Brescia, ordinari da Bergamo e così via) per un complesso che il doge Tommaso Mocenigo faceva ammontare nel 1423 a 48.000 pezze all'anno, alle quali si aggiungevano ben 16.000 pezze di panno pregiato fiorentino (149). Per Venezia transitavano anche, diretti in Levante, grossi quantitativi di tessuti inglesi di tipo corrente, le carisee, che una fonte veneziana dei primi del Cinquecento definiva, non senza iperbole, "una delle voci più importanti del commercio in qualsiasi parte del mondo" (150).
Nel secondo decennio del secolo XVI ebbe inizio la rapida ascesa del lanificio veneziano e l'affermazione dei suoi prodotti sui mercati levantini: da massimo centro di smistamento di tessuti stranieri, Venezia assurse allora a uno tra i maggiori centri europei della produzione tessile. In questa trasformazione si è voluto scorgere una conseguenza del declino dei traffici tradizionali (e in particolare di quello delle spezie) e "la necessità di sviluppare le industrie veneziane in grado di offrire attività sostitutive ai ceti popolari che prima trovavano impiego nelle imprese mercantili, nella marineria e nell'industria cantieristica" e il lanificio sarebbe stato appunto la principale "attività sostitutiva" ottenuta "per mezzo di una rigida politica protezionistica che avviava verso un rapido declino il lanificio delle città soggette della terraferma veneta" (151). Ma è, questa, una spiegazione che non persuade. Innanzitutto perché i tessuti prodotti in quantità crescente a Venezia nel Cinquecento non presero affatto il posto di quelli della Terraferma che, come si è detto, erano per lo più di tipo scadente e a buon prezzo, mentre il lanificio veneziano si specializzò fin dall'inizio in articoli di alto pregio o perlomeno di buona qualità. In secondo luogo va tenuto presente che, per tutto il Quattro e Cinquecento, la politica economica della Repubblica in materia di lanificio non fu mai improntata a un rigido protezionismo, ma si limitò a vietare la vendita a Venezia di quelle stoffe che "facevano pregiuditio alla pannina venetiana" e fra queste non figuravano quelle, piuttosto scadenti, prodotte in Terraferma. Finalmente va osservato che nel corso del Cinquecento, le manifatture laniere di Terraferma, lungi dall'essere soffocate da una presunta politica discriminatoria nei loro confronti, si svilupparono con ritmo intenso, prova ne sia il lanificio bergamasco la cui produzione passò da 7-8.000 pezze nel 1540 a oltre 26.000 alla fine del secolo (152).
In realtà, l'ascesa del lanificio veneziano nel Cinquecento fu possibile perché esso riuscì a conquistare una quota crescente del mercato levantino sostituendosi non già ai prodotti della Terraferma, bensì a quelli di alta qualità che in passato erano il vanto di Milano e soprattutto, nella seconda metà del Quattrocento, di Firenze. Quest'ultima, approfittando della crescente ostilità tra Venezia e l'impero ottomano dopo la caduta di Costantinopoli nonché della guerra aperta tra quelle due potenze dal 1463 al 1479, aveva infatti allacciato più stretti rapporti commerciali con la Porta e, tramite Ancona, aveva collocato sui mercati ottomani crescenti quantitativi sia di panno di lusso (detto "di S. Martino" e confezionato con le migliori lane inglesi) sia di panno di buona qualità (noto come "garbo" e fatto con lana fine spagnola). I risultati furono, per Firenze, quanto mai soddisfacenti: la produzione complessiva di tessuti fiorentini salì dalle 12.000 pezze intorno al 1430 alle 23.000 alla fine del secolo XV; di queste ultime forse 7.000 erano panni di S. Martino destinati alla corte del Sultano (e in parte a Roma), mentre i panni garbi erano destinati a una più larga clientela di consumatori abbienti nell'impero ottomano (153).
La presenza del tessuto veneziano cominciò a farsi sentire in Levante negli anni Ottanta del secolo XV, e si trattò di modesti quantitativi di panni scarlatti di lusso, "panni da 80 e 100 portate ", "li più fini che si facia in tuta Italia" a detta del Paxi, e come tali capaci di tener testa ai migliori articoli milanesi e fiorentini (154). Ma era evidente che ulteriori progressi su larga scala sarebbero stati possibili soltanto se Venezia fosse riuscita a soppiantare i concorrenti sul terreno dei tessuti di buona qualità, ma non di lusso, quali erano i panni garbi. E ciò è quanto avvenne dal 1520 in avanti: mentre la produzione veneziana di panni da 100 e da 80 portate rimase pressoché stazionaria fino al 1560 circa e declinò in seguito, quella dei panni di qualità intermedia (da 70, 60 e 50 portate) aumentò da circa 500 a oltre 23.000 pezze (tab. 3) (155).
L'occasione propizia per conquistare il grosso mercato levantino dei tessuti di qualità intermedia fu offerta a Venezia dalle sventure che si abbatterono sulla penisola in occasione delle guerre d'Italia e degli sconvolgimenti politici che ad esse seguirono. Milano, Como e Firenze, per non parlare che dei maggiori centri di produzione laniera, furono tutte vittime, fin dai primi anni del secolo XVI, di invasioni straniere, devastazioni o assedi e le loro industrie si trovarono praticamente paralizzate (156).
Ancora nel 1533, nonostante fosse stata ristabilita la pace in Italia, l'ambasciatore veneto a Firenze poteva scrivere che quella città "solea fare facende grandi: inter alia, solea fare a l'anno panni de San Martino, che così si chiamano i fini, da 4.000 in più; panni garbi, che sono di lane spagnole, da 18 fin 20.000, ed ora ne fanno pochissimi " (157).
Protetta dalle lagune e in grado di rifornirsi di materie prime via mare, Venezia poté invece trarre vantaggio dalle sciagure altrui e fare breccia sui mercati levantini dai quali erano praticamente scomparsi i tessuti milanesi e fiorentini: tra il 1520 e il 1570 la produzione del lanificio veneziano crebbe al ritmo eccezionale dell'8% in media all'anno, e cioè da circa 4.000 a 18.000 pezze (tab. 2).
Quel cinquantennio fu l'età d'oro del lanificio veneziano. Nel successivo trentennio esso continuò bensì la sua ascesa, ma a ritmo più lento: dalle 18.000 pezze prodotte in media intorno al 1570 si giunse alle 24.000 intorno al 1600, con un tasso di incremento medio annuo di meno dell' %. A questo brusco rallentamento può aver contribuito in parte il ritorno sulla scena dei vecchi concorrenti italiani e in primo luogo di quello fiorentino. A Firenze infatti il lanificio si era ripreso dopo la paralisi degli anni Trenta: nel 1553 vennero prodotte 14.000 pezze, nel 1561 ben 33.000 (X58). Questa risorta concorrenza venne avvertita dai Veneziani in Levante e tanto più acutamente in quanto, con un curioso rovesciamento di posizioni, il tessuto fiorentino si presentava ora come un'imitazione di quello veneziano. Scriveva in proposito il bailo veneziano a Costantinopoli nel 1578: "Sono cominciate a comparire fuori dei panni alla Venetiana che questi fiorentini hanno portato et sono roba bonissima et bei i colori, si che si può temere che con questo concorso vadano diminuendo grandemente le nostre fabriche [...] e i mercanti nostri sono turbati" (159). Accanto a quella dei tessuti fiorentini destava preoccupazione anche la crescente concorrenza dei tessuti lombardi e in particolare di quelli di Como che raggiungevano il Levante passando per Ferrara e Ancona. Sul finire del secolo se ne segnalava la scomoda presenza in Levante: era roba ottima e a prezzi più convenienti della merce veneziana (160).
Ma le preoccupazioni dei Veneziani erano probabilmente eccessive. Dopo tutto nell'ultimo quarto di secolo il lanificio fiorentino perdette rapidamente quota (intorno al 1600 la sua produzione era calata a sole 17.000 pezze, vale a dire si era quasi dimezzata rispetto al 1561) (161) ed è improbabile che il vuoto venisse interamente colmato dai tessuti lombardi. Qualche grossa preoccupazione destò, è vero, nel 1583 la concorrenza inglese in seguito alla conclusione di un trattato commerciale tra l'Inghilterra e la Porta. In quell'anno un osservatore fiorentino a Venezia segnalava che, "gionto in Constantinopoli il galeone et ambasciatore inglese [...] con si gran quantità di panni, non si trovava chi volesse comprare di quelli di Venetia se non a molto minor prezzo di quello si vendevano per innanzi" (162). Ma si trattò di un allarme prematuro: le esportazioni inglesi di stoffe capaci di competere con quelle veneziane non si svilupperanno, come vedremo, se non dopo il 1600, e proprio nel 1602 la produzione veneziana raggiunse la sua punta massima con 28.729 pezze (163).
Se nell'ultimo terzo del secolo XVI, nonostante il forte calo della produzione fiorentina e l'assenza di nuovi temibili concorrenti, il ritmo di crescita del lanificio veneziano fu molto più contenuto di quanto non era stato nel periodo 1530-1570, la ragione ne va probabilmente cercata nelle mutate condizioni della domanda levantina di pannilana. Sappiamo infatti che in Turchia alla crescita demografica in atto fino al 1570 circa tenne dietro un cinquantennio di forte declino (164) e ciò può essersi tradotto in una flessione della domanda di beni di consumo. Ma forse non meno importante fu il disagio economico che colpì l'impero ottomano in conseguenza della lunga guerra con la Persia combattuta dal 1577 al 1590. Alle enormi spese militari si fece fronte sia con l'inasprimento della pressione fiscale sia con la svalutazione dell'aspro di un buon 40% nel 1584 (165). Ne derivò che le importazioni rincararono bruscamente in termini di moneta turca ed è verosimile che la svalutazione monetaria, sommandosi al crescente prelievo fiscale, abbia ridotto la capacità di importazione dei mercati levantini.
13. I protagonisti
"The marvelous affluence and exuberancy of all things": questa l'impressione che, all'aprirsi del secolo XVIII, Venezia faceva su un viaggiatore inglese che vi soggiornava brevemente (166). L'esame dei vari settori dell'economia compiuto nelle pagine precedenti giustifica largamente questa impressione: alle soglie del Seicento, lo si è visto, movimento del porto, gettito dei principali dazi doganali, commercio di Levante, produzione manifatturiera toccarono livelli quali non erano stati raggiunti nei cento anni precedenti. E non esagerava quindi Nicolò Contarini quando, rievocando quegli anni, scriveva che Venezia era "abondante di tutte le cose" e poteva considerarsi allora "forse maggiore che in altri tempi si fusse stata" (167).
Era una prosperità, questa di Venezia intorno al 1600, che testimoniava il dinamismo e la capacità di ricupero di una città che pure era stata duramente provata da guerre, epidemie, rovesci economici e politici. Ma era una prosperità ottenuta non già con un ritorno puro e semplice all'assetto economico dell'età d'oro quattrocentesca, bensì in forza di trasformazioni e adattamenti in risposta alle mutate condizioni economiche e politiche internazionali: mentre taluni settori di attività quali la navigazione e, salvo brevi momenti di rilancio, il commercio delle spezie si erano venuti atrofizzando, altri, come l'edilizia, la tipografia, l'artigianato di lusso e il lanificio, avevano avuto un vigoroso sviluppo. A costo di semplificare un processo assai complesso, le vicende di un settantennio di espansione economica si possono riassumere dicendo che si era venuta accentuando la funzione di Venezia come grande centro industriale, mentre si era ridimensionata quella di emporio internazionale.
L'espansione e le trasformazioni dell'economia veneziana nel Cinquecento comportarono evidentemente crescenti investimenti, la presenza di un ceto imprenditoriale capace di scelte innovatrici e la formazione di maestranze altamente qualificate - ed è su questi aspetti dell'economia e della società veneziana che vorremmo fermare brevemente l'attenzione.
Quando si parla di investimenti e di imprenditorialità veneziani, il pensiero corre subito al patriziato, quel ceto ristretto e chiuso di duemila nobili-mercanti che da secoli deteneva a Venezia le leve del potere tanto politico quanto economico e le cui proverbiali ricchezze, come osservava Machiavelli, erano "fondate in su la mercanzia e cose mobili" anziché, come quelle di altri ceti nobiliari, sulla proprietà fondiaria (168). Quale parte ebbe questo patriziato nell'espansione cinquecentesca?
Ben poca o addirittura nulla, se dobbiamo prestar fede a quanto asseriva un contemporaneo di Machiavelli, il veneziano Girolamo Priuli. Agli inizi del Cinquecento, secondo lui, "li merchadanti veneti, visto li viagii restrecti et senza spetie et cum pocha utilitate, se sono ritirati dali viagii et li loro danari posti in posessione [...]. Donde he seguito che cadhauno se ha atachatto a questi solazi, piaceri, delichatezze et morbidi della teraferma senza utilitate alchuna, et hanno abandonato il exercitio maritimo, la navigatione et li viagii" (169). Se il Priuli aveva ragione, si dovrebbe quindi ritenere che la ripresa cinquecentesca dei traffici e delle manifatture avvenne senza l'apporto di un ceto che aveva rinunciato all'antica vocazione mercantile e si era trasformato in ceto di pigri o gaudenti rentiers. Senonché la stessa accusa di defezione verrà mossa al patriziato un secolo dopo, quando Venezia sarà preda, come vedremo, di una gravissima crisi economica: la nobiltà, dirà in senato Leonardo Donà nel 1610, "non vuol aver parte nella mercantia" (170). E due anni dopo l'ambasciatore inglese a Venezia Dudley Carleton gli farà eco con queste parole: "in passato il loro costume era la mercatura, la quale adesso è molto trascurata ed essi si volgono alla terra comprando case e fondi, mentre [...] erano soliti mandare i propri figli sulle galere di Levante per impratichirsi nella navigazione e nel commercio" (171). A circa un secolo di distanza dunque, si riparla del fenomeno già denunciato dal Priuli, e se ne riparla come di fatto recente capace di spiegare almeno in parte la crisi in atto; il che starebbe ad indicare che, se realmente il patriziato aveva abbandonato la mercatura e la navigazione agli inizi del Cinquecento, in seguito esso era ritornato alle attività di un tempo per distaccarsene nuovamente agli inizi del Seicento. Non si può, del resto, escludere che le cose siano effettivamente andate così: tanto il Priuli quanto il Donà scrivevano nel bel mezzo di una crisi economica, in anni cioè di grave disagio e di diffusa sfiducia quando la terra dovette sembrare un bene-rifugio quanto mai attraente per dei ricchi nobili-mercanti desiderosi di porre in salvo le proprie sostanze.
Ma a noi preme di sapere come si comportò il patriziato durante la lunga fase di rilancio economico compresa tra la crisi del primo Cinquecento e quella del primo Seicento. E qui bisogna ammettere che le nostre cognizioni sono molto frammentarie e in apparenza contraddittorie. Consta da un lato che tra il 1540 circa e la fine del secolo i Veneziani più facoltosi (patrizi in testa), oltre ad investire larghe somme nel debito pubblico e in prestiti livellari a privati (172), effettuarono imponenti acquisti di terreni agricoli in Terraferma e soprattutto nel Trevisano, nel Padovano e nel Polesine, tanto che intorno al 1590 ben 150.000 ettari risultavano intestati a loro (173). Sappiamo anche che alcune famiglie patrizie abbandonarono del tutto la mercatura, che pure era stata la base sulla quale avevano edificato la loro fortuna, e investirono la maggior parte dei loro averi nella proprietà fondiaria (174). E particolarmente vistoso fu il ritiro del patriziato dal settore dei trasporti marittimi: tra i proprietari di naviglio mercantile i nomi del patriziato si andarono rarefacendo - da forse due terzi all'inizio del secolo 10% alla fine (175).
D'altra parte, numerosi sono gli esempi, lungo tutto il secolo, di patrizi che continuarono a partecipare, sia personalmente sia tramite agenti o fattori, a lucrosi affari commerciali soprattutto in Levante (176). Né mancano esempi di nobili che non esitarono a vendere terreni agricoli precedentemente acquistati allo scopo di disporre dei fondi necessari per effettuare qualche grossa operazione commerciale, salvo poi a ricomprare altre terre di lì a qualche anno (177). Ma nonostante il carattere frammentario e contraddittorio della documentazione finora emersa, dal Settecento in poi la storiografia su Venezia ha largamente accolto il concetto di una radicale e irreversibile trasformazione del patriziato da ceto di mercanti a ceto di possidenti all'inizio del Cinquecento (178). E lo ha accolto, vien fatto di pensare, perché ha implicitamente dato per scontato che i fondi disponibili per gli investimenti erano una quantità sostanzialmente fissa e che pertanto ogni ducato investito in terre era sottratto ai commerci (179). Accettata questa premessa, è sembrato logico concludere che gli enormi acquisti di terre effettuati dal patriziato nel corso del secolo XVI ebbero come contropartita dei disinvestimenti dal commercio grosso modo proporzionali e comunque tali da privare questo settore dei capitali indispensabili per il suo funzionamento.
A ben guardare, però, questa premessa sarebbe valida soltanto nell'ipotesi che i redditi del patriziato fossero rimasti essenzialmente stazionari nel corso del secolo. Se, invece, tali redditi aumentarono, i patrizi avrebbero potuto destinarne una quota anche crescente agli acquisti fondiari senza per questo dover necessariamente ridurre la propria partecipazione nelle attività commerciali. In altre parole, se per ipotesi il Cinquecento fu un periodo di redditi crescenti, nulla ci vieta di ipotizzare che il patriziato nel suo complesso mirasse non tanto a rinunciare alla mercatura quanto piuttosto a diversificare la composizione dei propri patrimoni, aggiungendo ai tradizionali investimenti commerciali quelli immobiliari.
Come siano effettivamente andate le cose può essere soltanto materia di prudenti congetture, dati i limiti della documentazione oggi a nostra disposizione. Ma la congettura più verosimile è che durante il Cinquecento, o perlomeno dal 1540 in avanti, i redditi veneziani furono in tendenziale aumento. "Le ricchezze private crescevano", scriveva Nicolò Contarini rievocando appunto le condizioni del tardo Cinquecento (180), e le notizie riferite nelle precedenti pagine relative ai principali settori di attività ci presentano un'economia in espansione - e sarebbe strano che il patriziato non avesse beneficiato della generale euforia. D'altra parte, mentre commerci e industrie prosperavano, lo stesso avveniva nel settore agricolo e anche lì si profilarono occasioni allettanti di investimento.
Non era sempre stato così. Ancora agli inizi del Cinquecento il Priuli aveva considerato la proprietà fondiaria essere "senza utilitade alchuna" e qualche anno prima l'annalista Domenico Malipiero aveva osservato che "comprando stabeli, i compra beni che ghe da spesa senza intrada" (181). Ma dal 1540 circa la redditività della terra andò certamente migliorando, perché i prezzi dei cereali, a lungo depressi, iniziarono una rapida scalata al termine della quale, sessant'anni più tardi, risultavano più che triplicati (182). In queste condizioni è verosimile che il possesso della terra abbia offerto l'occasione di elevati, crescenti guadagni per chi aveva derrate agricole da immettere sul mercato - e i patrizi più facoltosi (e, come vedremo, non soltanto loro) non se la lasciarono certamente sfuggire (183). Fra di loro troviamo infatti uomini che si occupano attivamente del commercio delle derrate agricole (184); e troviamo anche chi non si limita ad acquistare terre, ma, assecondato anche dall'intervento dello Stato, investe grosse somme nella messa a coltura di terreni incolti e in opere di irrigazione e di bonifica anche su larga scala - e tutto ciò evidentemente non per amor del quieto vivere, ma con lo sguardo fisso su redditi crescenti o su eventuali grossi guadagni in conto capitale via via che i terreni acquistavano valore (185). I risultati di questi investimenti non si fecero peraltro attendere: nella seconda metà del secolo, come si ricorderà, la produzione cerealicola in Terraferma crebbe al punto da coprire non soltanto il fabbisogno di una popolazione rurale in aumento, ma altresì gran parte di quello di una città come Venezia che in passato aveva dovuto dipendere dall'estero per i rifornimenti di grano; senza contare che proprio in quel periodo ebbe inizio l'esportazione di riso dalla Terraferma (186).
Ammesso dunque che nel Cinquecento tirasse buon vento tanto nel commercio e nell'industria quanto nell'agricoltura, non deve stupire se il patriziato nel suo complesso distribuì via via i propri investimenti tra i diversi settori dell'economia e poté farlo senza necessariamente sacrificare un tipo di investimento a vantaggio di un altro. Il che ovviamente non esclude che singole famiglie optassero interamente o quasi per la proprietà fondiaria, mentre altre rimasero fedeli alla mercatura. È anzi probabile che all'interno del patriziato si sia verificata una differenziazione tra famiglie sempre più impegnate nell'agricoltura e famiglie ancora prevalentemente legate all'attività commerciale o che ad essa si volgevano per la prima volta, subentrando a quelle che se ne erano allontanate. Questa differenziazione non è soltanto probabile, ma altresì del tutto prevedibile, perché gli investimenti fondiari, e segnatamente le bonifiche e le opere di irrigazione, richiedevano inizialmente larghi mezzi finanziari che soltanto i più facoltosi erano in grado di fornire, mentre nel commercio poteva avventurarsi, nella speranza di far fortuna, anche chi disponeva di mezzi limitati (187).
Ma qualunque sia stato l'apporto del patriziato alle vicende economiche della Venezia cinquecentesca (e giova ribadire che, allo stato attuale delle ricerche, un giudizio definitivo non è ancora possibile), esso non fu il solo, perché consta che alla ripresa del commercio e allo sviluppo di nuove industrie diedero un contributo importante e crescente anche altri gruppi sociali.
Tra di essi figurava certamente quello dei "cittadini", quel ristretto ceto (7.000 individui circa alla fine del Cinquecento) a metà strada tra patriziato e popolo. Esclusi dalle cariche di governo ad eccezione di quelle subalterne, i cittadini godevano però per antica tradizione di larghi privilegi in fatto di navigazione e di commercio ed erano sempre stati presenti in questi settori chiave dell'economia della città. Nel clima di espansione che caratterizzò il Cinquecento veneziano è certo che essi ebbero un ruolo rilevante e forse anche crescente (188). Nell'anno 1600, per esempio, in un elenco "delli principali mercanti che negotiano d'oglio in questa città", dei grossisti cioè che controllavano una delle importanti correnti di traffico facenti capo a Venezia, compaiono 19 nomi: di essi 14 sono di cittadini e 5 di "forestieri"; assenti invece i patrizi (189). Nel 1622, a detta dei savi alla mercanzia, al ceto dei cittadini apparteneva la quasi totalità dei proprietari di navi mercantili (190).
A differenza del patriziato che era ceto chiuso e numericamente statico se non addirittura in lento declino (191), quello dei cittadini era un ceto aperto nel senso che, a determinate condizioni (nascita, lunga residenza, censo), era possibile accedervi, con il risultato che i ranghi dei cittadini furono continuamente rinvigoriti da gente nuova e da energie fresche. "Nel Cinquecento", è stato scritto, "l'elenco delle concessioni [di cittadinanza] è lunghissimo e comprende gente di ogni provenienza, perché Venezia è ancora un grande polo di attrazione", e in quell'elenco figurano mercanti genovesi, francesi e soprattutto, dopo il sacco di Anversa nel 1576, fiamminghi che, stabilitisi a Venezia dove fecero fortuna, ottennero la cittadinanza di pieno diritto (192).
Anche maggiore fu l'afflusso di gente della Terraferma veneta e in particolare di gente proveniente dalle province bergamasca e bresciana, terre di emigrazione per eccellenza, ma anche regioni di antiche tradizioni industriali e mercantili specialmente in fatto di tessitura laniera e di siderurgia. Bresciano d'origine fu quel Bartolomeo Bontempelli (1538-1616), oriundo della Val Sabbia, che, emigrato tredicenne a Venezia, nel giro di pochi anni fu in grado di metter su, in pieno centro cittadino, una bottega di merciaio alla quale più tardi ne aggiunse una seconda. Con il passar degli anni questo parvenu, oltre a commerciare in tessuti pregiati, prese in appalto una miniera di mercurio presso Agordo e investì grosse somme tanto in titoli del debito pubblico quanto in prestiti livellari a privati. Grazie a queste molteplici attività riuscì ad ammassare un patrimonio imponente che comprendeva anche una villa e quattro poderi rustici a Conegliano; nel 1579 poi ottenne il privilegio della cittadinanza de intus et extra (193). Imprenditore di vaglia, dunque, il Bontempelli la cui ascesa sta a dimostrare quali prospettive si aprivano nella Venezia cinquecentesca a uomini intraprendenti e capaci; ma che sta anche a dimostrare come gente del suo stampo si curava, non diversamente dai patrizi, di ripartire le proprie sostanze tra settori diversi dell'economia - commercio, miniere, debito pubblico e agricoltura.
La presenza di "forestieri" si fece sentire anche nelle industrie manifatturiere. Nel settore della tessitura serica e laniera, per esempio, Venezia beneficiò dell'arrivo, nella prima metà del secolo, di numerosi artigiani specializzati fiorentini, spesso fuoriusciti politici costretti a lasciare la patria dalla repressione medicea, ma anche gente attirata dalle opportunità offerte da un'economia in fase di rilancio (194). Conosciamo anche parecchi nomi di immigrati che fecero fortuna a Venezia come stampatori e librai - da un Giolito piemontese a un Tremezzino romano, da un Rusconi milanese a un Ciotti senese - e sembra anzi che nell'editoria veneziana gli immigrati costituissero una maggioranza (195). E lo stesso vale per i maestri artigiani addetti alla lavorazione dei metalli - fabbri, calderari, spadai, fonditori di campane e così via. Raggruppati in un'unica corporazione (l'arte dei fabbri), essi erano in gran parte reclutati tra i "forestieri": secondo un elenco degli appartenenti a questa corporazione nel 1531, su un totale di 176 iscritti soltanto 33 risultano veneziani; tutti gli altri erano immigrati, e segnatamente dal lago di Como (116 nomi) e dal Bergamasco (18 nomi), vale a dire da zone di antiche tradizioni siderurgiche (196). Questa massiccia presenza di immigrati nei vari mestieri che animavano l'economia veneziana va sottolineata non soltanto perché ci aiuta a capire il dinamismo di questa economia, ma anche perché indica che a Venezia le corporazioni non erano corpi chiusi e refrattari a influenze esterne, ma organismi ancora aperti e vitali (197).
Un posto di particolare rilievo ebbe nella Venezia cinquecentesca la comunità ebraica che, praticamente inesistente alla fine del secolo XV, acquistò nei cent'anni successivi una notevole consistenza numerica e un ruolo crescente nella vita economica della città (198). Se infatti fino ai primi anni del Cinquecento la Repubblica aveva rifiutato di concedere agli Ebrei, pur numerosi nelle città di Terraferma (e segnatamente a Mestre e a Padova), il diritto di residenza stabile e continuativa a Venezia, le cose cambiarono in occasione della guerra di Cambrai quando molti Ebrei della Terraferma cercarono ed ottennero temporaneo rifugio nella città lagunare. Da temporaneo il loro soggiorno si trasformò di lì a pochi anni in permanente con la istituzione del primo ghetto (Ghetto nuovo) nel 1516 e la concessione di un'autorizzazione quinquennale rinnovabile a risiedervi. Nonostante l'umiliante segregazione coatta, le periodiche vessazioni del fisco e i severi limiti imposti all'attività economica, la comunità ebraica crebbe di numero: dalle 700 anime circa del 1516 si passò alle 1.694 censite nel 1586, con un ritmo di accrescimento ben superiore a quello della popolazione cittadina nel suo complesso (199).
Questo rapido aumento numerico rispecchiava sicuramente una forte immigrazione e in particolare quella, iniziata nel 1541, degli Ebrei "levantini", vale a dire di Ebrei che, cacciati dalla penisola iberica nel 1492, si erano rifugiati in un primo tempo nell'impero ottomano. Agli immigrati levantini, sistemati nel Ghetto vecchio adiacente a quello già esistente, si aggiunsero poi negli anni Ottanta gli Ebrei "ponentini", cioè discendenti di Ebrei provenienti dalla penisola iberica che in un primo tempo avevano evitato l'espulsione ricevendo il battesimo, ma erano poi stati braccati dall'Inquisizione spagnola e portoghese che li sospettava di praticare segretamente la religione dei padri e si erano rifugiati sia in terra ottomana sia in alcune città italiane.
L'apporto dei levantini prima e dei ponentini poi non fu soltanto numerico. A differenza dei correligionari venuti dalla Terraferma all'inizio del secolo (e noti come "ebrei todeschi") la cui attività economica era stata per legge circoscritta al piccolo prestito su pegno e al commercio degli abiti usati, ai nuovi venuti fu concesso di dedicarsi al grande commercio con il Levante e in particolare con i Balcani e Costantinopoli. La decisione di accoglierli a Venezia e di ammetterli ad un'attività tradizionalmente riservata ai patrizi e ai cittadini di pieno diritto non fu certo dettata da un nuovo senso di tolleranza religiosa, ma dalla necessità di fronteggiare la concorrenza di Ancona e Ferrara dove numerosi Ebrei ponentini si erano insediati fin dagli anni Quaranta e dove, grazie ad una vasta rete di corrispondenti e conoscenti sparsi in Dalmazia (Ragusa), nei Balcani (Sarajevo) e a Costantinopoli, avevano allacciato intensi rapporti commerciali con il Levante (200). Attirandoli a sé, Venezia riuscì pertanto a controllare delle importanti correnti di traffico che minacciavano di sfuggirle e fu grazie ad essi (e particolarmente per iniziativa di quel Daniele Rodriga del quale si è già avuto modo di parlare) che nel 1590 venne creata la "scala" di Spalato e si stabilirono, con grande successo, nuovi proficui collegamenti con i mercati balcanici e la capitale ottomana (201). Ma la presenza ebraica nei traffici di Levante non si limitò alla felice iniziativa spalatina: tra il 1592 e il 1609 li troviamo impegnati nel commercio con Durazzo, Cattaro, Valona e Costantinopoli (202) e nel 1595 il bailo a Costantinopoli affermava che ben due terzi del commercio tra Venezia e la capitale ottomana erano in mano a mercanti ebrei (203) - una stima forse eccessiva, ma che attesta inequivocabilmente l'importanza assunta dagli Ebrei nei traffici che animarono il porto realtino alla fine del Cinquecento. Del resto, alcuni anni prima il Sansovino aveva detto degli Ebrei di Venezia che "per il negotio sono opulentissimi" (204).
Tutte queste notizie relative a diversi gruppi di immigrati sono ovviamente incomplete, ma esse vanno collocate nel quadro generale della demografia di Venezia nel secolo XVI: come è stato detto all'inizio del capitolo, la nota dominante fu la crescita della popolazione fino alla peste del 1576 e, dopo di essa, la straordinaria ripresa grazie alla quale i vuoti creati dal flagello vennero in buona parte colmati nel giro di appena un decennio. Sappiamo che tanto prima del 1576 quanto, e soprattutto, dopo tale data la crescita demografica fu favorita dall'immigrazione. Gli esempi qui ricordati ci assicurano che si trattò, almeno in parte, dell'afflusso di gente qualificata in grado di dare un apporto decisivo, con le proprie capacità imprenditoriali, con la conoscenza dei mercati di esportazione, con la perizia tecnica, all'espansione dell'economia veneziana. Ma questi esempi ci assicurano anche che la società veneziana, nonostante la rigida divisione in ceti e un fitto ordinamento corporativo, si dimostrò capace di assorbire un largo numero di immigrati e poté così valersi dell'apporto di uomini e idee nuove senza le quali sarebbe difficile spiegare il dinamismo e la capacità di adattamento e di trasformazione che caratterizzarono la sua economia durante il secolo XVI (205).
14. Crisi e declino
La prosperità di fine secolo non era destinata a durare. Fin dai primi anni del Seicento si assiste infatti ad una brusca inversione di tendenza in tutti gli indici economici che ci hanno fatto da guida fin qui. L'imposta dell'ancoraggio - quel metro grossolano, ma pur sempre utile, dell'attività del porto - venne appaltata per il triennio 1603-1605 a più di 6.000 ducati, somma finora insuperata; ma già nel triennio successivo l'appalto fu di soli 4.720 ducati e negli anni Venti raggiunse a mala pena i duemila ducati (206). Tra il 1602 e il 1610 il gettito dei principali dazi doganali riscossi a Venezia subì un calo di oltre il 50% (207). In piena crisi, fin dai primi del secolo, risulta anche il commercio delle spezie passato ormai definitivamente in mani inglesi e olandesi, e la stessa sorte tocca anche a quello della seta persiana e siriana destinata alla riesportazione: di fronte a 1.733 balle giunte a Venezia nel 16o I se ne ebbero appena 300 nel 1613, e in forte ribasso furono anche le importazioni di cotone dall'Anatolia e da Cipro. Duramente colpite risultano anche le due massime industrie di esportazione: in quella della seta il numero dei telai attivi scese da 2.400 nel 1602 a 1.700 circa vent'anni dopo, con un calo del 25%; quella della lana, che aveva toccato dei massimi di produzione nel 1601 e 1602 con oltre 28.000 pezze, iniziava dopo tali date una lunga parabola discendente e si portava a un livello di 15.000 pezze in media all'anno nel terzo decennio del Seicento (208). Quanto alla popolazione, non disponiamo di dati se non per il 1586 e il 1624, ma tra queste due date si osserva un lieve calo (da 148.637 a 141.625 anime) che contrasta fortemente con il dinamismo che aveva caratterizzato il Cinquecento (209).
Varie le cause che, proprio nei primi anni del Seicento, concorsero ad avviare una crisi così generalizzata e di così lunga durata. Ci fu innanzitutto l'intervento degli Olandesi, presto seguiti dagli Inglesi, nell'oceano Indiano. Già nel 1599, a quattro anni dal primo viaggio olandese in quel mare, il pericolo costituito dalla loro presenza in Oriente era stato avvertito ad Aleppo, l'emporio siriano che da qualche anno aveva ritrovato l'antica prosperità come epicentro del commercio delle spezie. Scriveva di lì il console veneto: "Si crede che [i mercanti veneziani] converranno tralasciare questo trafficho per occasione delli molti vascelli olandesi che sono andati in India, quali haverano portato di quelle parti quantità di spetiarie et droghe che questi compravano in Aleppo, et hora non li farà più bisogno comprar che qualche poca seta, Bottoni et filladi" (210). E un agente della Compagnia inglese di Levante in servizio ad Aleppo confermava i timori del console veneto quando scriveva, a proposito delle prime voci relative ai successi olandesi: "Temo sarà la completa rovina di questo commercio" (211). Timori e fosche previsioni che si rivelarono anche troppo vere mano a mano che le due grandi compagnie, inglese e olandese, delle Indie orientali fondate di lì a poco presero in mano il commercio delle spezie dirottandolo definitivamente dalle carovaniere del Medio Oriente e dai porti mediterranei. Venezia stessa non tarderà a doversi rifornire di spezie in Occidente: "L'antico uso di portare le merci dell'India ad Alessandria, da lì a Venezia e da Venezia in altre parti [si legge in un documento inglese del 1612] fu la causa della loro grandezza nei commerci. Ora che queste merci sono portate nel nostro paese, le cose sono così mutate che, mentre eravamo soliti acquistare il pepe e le altre spezie a Venezia, oggi vengono portate dal nostro paese a Venezia e qui vendute" (212). In bocca a un inglese era questa, a dir il vero, un'affermazione un po' ottimista, perché di più in più, e specialmente dopo la sconfitta inflitta loro dagli Olandesi ad Amboina nel 1623, saranno questi ultimi ad imporsi in Europa come i massimi fornitori di spezie. Ma era un'affermazione esatta nel senso che ormai le preziose merci orientali erano, per i Veneziani, "merci di Ponente" e che l'antica funzione di intermediari in quel lucroso traffico era tramontata per sempre (213).
Al dirottamento delle spezie si accompagnò in quegli stessi anni anche quello delle merci del Medio e Vicino Oriente (seta persiana e siriana e cotone della Siria, dell'Anatolia e di Cipro) destinate per lo più alla riesportazione verso la Germania. Ma in questo caso non si trattò, come per le spezie, dell'inaridimento di tradizionali correnti di traffico in Levante, bensì del fatto che in Levante i mercanti veneziani vennero rapidamente soppiantati da quelli di altre nazioni quali intermediari tra il Medio Oriente e l'Europa. Il forte calo del gettito del fondaco dei Tedeschi, si lamentava a Venezia già nel 1608, "si stima derivi dalla navigazione presa da fiamenghi, inglesi et francesi, perché vanno con li proprij vascelli in levante a comprar sedde, speciarie, gottoni et altre merci et quelle poi conducono a Marsilia, Fiandra et Inghilterra di dove sono poi condotte nelle fiere di Franco Forte et altri lochi d'Alemagna" (214).
Il regresso dei Veneziani di fronte ai concorrenti occidentali fu particolarmente sensibile ad Aleppo, una piazza dove, accanto alle spezie, i Veneziani si erano riforniti di seta e di cotone e dove ancora nell'ultimo decennio del Cinquecento essi avevano occupato, con una cifra d'affari annua di due milioni di ducati, il primo posto tra le nazioni europee, mentre la cifra d'affari dei Francesi e degli Inglesi si aggirava sul mezzo milione. Ma già nel 1605 il commercio dei Veneziani era calato a un milione di ducati, mentre quello dei Francesi aveva quasi raggiunto questa cifra. Dieci anni dopo le posizioni risulteranno nettamente capovolte: in testa i Francesi, seguiti a distanza dai Veneziani e poi dagli Inglesi. Nel 1622 la presenza veneziana in Aleppo sarà ridotta a poca cosa: cinque "case" commerciali contro le sedici di un ventennio prima (215).
In fase di ripiegamento risultava altresì il commercio veneziano del cotone. Anche qui furono i mercanti occidentali a soppiantare i Veneziani. "Havendo li detti Inglesi [si legge in un documento del 1602] cominciato a metter piede e in Cipro e alla Smirne [...] di dove caricano gottoni et altre mercantie [...], facil cosa sarà che si mettano di condurli in Fiandra et nei Paesi Bassi per via di Ponente per mare [...] et di là poi potendo commodissimamente essere distribuiti per tutta la Germania, indarno credemo che si affaticheranno li nostri per via del Fontegho" (216). Accanto agli Inglesi, gli Olandesi e i Francesi. Nel 1610 i mercanti veneziani interessati al commercio del cotone destinato "per questa città, per la Lombardia e per l'Allemagna" affermavano che "mentre prima de Cipro ne capitava sacchi 6.000 et de Smirne sacchi 8.000 in circa all'anno [...], di presente non ne capita tanta summa [...] perché fiamenghi, enghlesi et francesi vanno a caricar a dette scale et li portano con loro vasselli alli loro paesi, che prima li compravano qui" (217).
Per spiegare questo generale ripiegamento veneziano in Levante e la conseguente perdita della tradizionale funzione di mediazione tra Oriente ed Europa che per secoli era stata il vanto e la ragion d'essere dell'emporio realtino, è necessario distinguere nettamente il caso delle spezie da quello della seta e del cotone.
Nel primo caso fu decisivo il fatto che Olandesi e Inglesi intrapresero la navigazione della rotta del Capo approfittando della debolezza dei Portoghesi e, per giunta, crearono - gli Inglesi nel 1600 e gli Olandesi due anni dopo - le rispettive Compagnie delle Indie orientali, due organismi cioè capaci di mettere insieme capitali ingenti e di coordinare l'operato di mercanti e armatori. Ma il successo delle due Compagnie delle Indie fu facilitato anche dal crescente disordine amministrativo e dall'inasprimento di dazi e gabelle nell'impero ottomano, nonché dalle rivolte che lo scossero nel primo ventennio del Seicento (218). Tutto ciò si tradusse sia in costi più elevati per le merci orientali che transitavano in territorio turco, sia nella crescente insicurezza delle carovaniere che collegavano il golfo Persico al Mediterraneo. La situazione si presentava quindi quanto mai propizia per un rilancio in grande della rotta del Capo. Ma le due Compagnie delle Indie orientali, oltre a beneficiare delle difficoltà in cui versavano i paesi del Levante, adottarono anche misure monopolistiche allo scopo di agire sul livello dei prezzi in Europa. Tra il 1613 e il 1623, per esempio, la Compagnia inglese praticò il dumping del pepe e dell'indaco nell'area mediterranea al preciso scopo di mettere fuori gioco quanto restava del commercio levantino (219). Anche più efficace, a lungo andare, fu la strategia olandese: ridotti alla condizione di vassalli i piccoli sovrani dell'arcipelago indonesiano, gli Olandesi riuscirono, entro certi limiti, a controllare la produzione di spezie e di conseguenza a imporre all'Europa prezzi di vendita per loro particolarmente remunerativi (220).
Ben diverso fu il caso delle merci levantine. Tre fatti di natura eterogenea concorsero a indebolire gravemente la posizione dei mercanti veneziani impegnati nel commercio della seta e del cotone: in primo luogo, la nuova politica adottata nel 1602 dalla Repubblica veneta in fatto di trasporti marittimi; in secondo luogo, la caduta della domanda levantina di quei tessuti di lana e di seta che, come avevano osservato i savi alla mercanzia nel 1585, costituivano da quasi un secolo gli assi portanti del commercio veneziano in Levante; e infine la mutata situazione internazionale che, nei primi anni del Seicento, consentì a temibili concorrenti stranieri - Francesi, Inglesi, Olandesi - di far breccia negli empori dell'impero ottomano.
Nel 1602, nel clima di euforia che prevaleva allora a Venezia, il senato aveva rimesso in vigore le antiche restrizioni, cadute in disuso nel tardo Cinquecento, relative all'impiego di naviglio straniero sulle rotte che collegavano la città ai porti del Vicino Oriente. Allo scopo di stimolare un'industria armatoriale che, come sappiamo, da tempo versava in gravi difficoltà, il decreto del 1602 assicurava alle navi appartenenti a nobili o a cittadini veneti e con equipaggi formati da sudditi della Repubblica la priorità del carico rispetto alle navi straniere; a queste ultime veniva riconosciuto soltanto il diritto di effettuare trasporti tra Venezia e il paese di origine: "Ponentini per Ponente e Levantini per Levante", per dirla con le parole del decreto (221). In pratica ciò significava che l'impiego di navi nordiche che, come si ricorderà, era stato largamente tollerato nella seconda metà del Cinquecento, veniva precluso d'ora in poi ai mercanti veneziani che inviavano merci in Levante o le importavano di lì, salvo il caso di riconosciuta mancanza, in un dato momento, di navi venete atte allo scopo. In tal modo si imponeva ai mercanti di valersi di trasporti marittimi notoriamente meno efficienti e più costosi.
Le conseguenze di questo "atto di navigazione" ante litteram non sarebbero state necessariamente gravi, se di lì a poco non si fosse profilata una forte contrazione della domanda di manufatti veneziani. "La Turchia [scriveva in tono allarmato il console veneto in Siria nel 1611] è tanto per le guerre diminuita di genti e di ricchezze che non consuma un terzo del suo solito" (222). La stima del crollo della domanda era probabilmente esagerata, ma non c'è dubbio che le condizioni economiche nell'impero ottomano, già da tempo precarie, andarono rapidamente deteriorando nel primo ventennio del secolo XVIII (223). Dal 1593 al 1606 la Sublime Porta fu infatti impegnata in una dura lotta contro gli Asburgo d'Austria e dal 1602 al 1618 contro la Persia, e ciò aveva portato con sé una serie di svalutazioni monetarie e uno schiacciante onere fiscale. Nel 1596 era poi scoppiata la sanguinosa rivolta dei Celali che si protrarrà per ben dodici anni seminando devastazioni e lutti soprattutto in Siria.
Mentre lamentavano l'impoverimento dei tradizionali mercati di esportazione, i Veneziani prendevano atto dell'avanzata dei loro rivali: "Le nazioni inglese, francese e fiamenga [riferiva il console veneto dalla Siria nel 1610] portano così gran copia di reali e altre monete che da questo ne riceviamo importantissimi danni: prima perché questo concorso innalza il prezzo di tutte le cose; poi con li contanti vengono da questi levate le mercanzie per ordine che vanno giungendo in Aleppo, sicché ai veneziani resta roba rifiutata e trista la quale, contrattandosi a baratto, si convien pagare molto più che la buona, e con molta fatica ancora [...]. Onde non è meraviglia se, restando le altre piazze abbondantemente provvedute di ogni sorte di mercanzia, quella poca la quale giunge in salvamento in questa città non ha esito o si convien vendere con evidente perdita" (224). Gli faceva eco una fonte coeva: "Nel paese turchesco gran parte della pannina [veneziana] è rimasta inespedita" mentre "li mercanti di Marsilia, d'Astradan [Amsterdam] et altri parti della Fiandra [...], havendo gran copia di contanti, si sono impatroniti di sete, gottoni et altre più vive merci tratte da quelli paesi privandone la natione venetiana, la quale, non potendo comperare in concorso con le altre abondantissime di contanti, se ne sta languendo" (225). In altre parole, mentre i mercanti veneziani assistevano impotenti al deterioramento delle ragioni di scambio tra i loro tessuti e le materie prime di Levante, i loro concorrenti, muniti di buona valuta d'argento e avvantaggiati dalle svalutazioni ottomane, allargavano via via le proprie quote di mercato. E a nulla valse la decisione presa dal senato nel 1610 di sospendere le vigenti restrizioni in materia di esportazione di valuta (226): ancora dieci anni dopo, secondo fonti turche, quel tanto che restava del commercio veneziano in Levante risultava prevalentemente fondato sullo scambio di merci contro merci (227).
Negli anni stessi in cui i mercanti veneziani andarono incontro a crescenti difficoltà negli scambi con il Levante, la situazione internazionale in Europa si modificò radicalmente - e a tutto vantaggio dei loro concorrenti. Conclusa nel 1598 la pace con la Spagna, ebbe inizio per la Francia di Enrico IV un periodo di forte ripresa economica e, in particolare, di nuove iniziative commerciali nel Mediterraneo orientale, iniziative coronate nel 1604 da un nuovo trattato con la Porta che assicurava ai mercanti francesi ampie agevolazioni fiscali (228). Sempre nel 1604 l'Inghilterra di Giacomo I faceva pace con la Spagna e ciò comportò non soltanto la fine del blocco navale spagnolo (per la verità mai completo, ma pur sempre scomodo) a Gibilterra, ma altresì la possibilità per le sue navi dirette in Levante di fare scalo nei porti spagnoli e siciliani (229). Nel 1609 infine, firmata la Tregua dei Dodici anni, l'Olanda vedeva anch'essa riaprirsi i porti del Re cattolico e tre anni dopo, grazie ad un trattato commerciale con il Sultano, quelli turchi (230). Nei tre casi si presentò non soltanto la possibilità di una più attiva presenza in Levante, ma anche quella di più intensi scambi con la Spagna - e per chi avesse merci da esportare adatte al mercato spagnolo, quella era la fonte migliore per procurarsi i bei reali da otto che il ricordato decreto del senato del 1610 definiva "vagliuta conosciuta et abbraciata da tutte le genti orientali". Di fatto, dal 1598 alla ripresa della guerra franco-spagnola nel 1635, presero slancio le esportazioni francesi di grano, telerie, chincaglieria e pellami verso la Spagna e le sue colonie americane (231). Gli Inglesi, da parte loro, svilupparono in quegli anni le esportazioni di un nuovo tipo di tessuto verso la penisola iberica, le cosiddette new draperies (232), mentre gli Olandesi si procurarono buona valuta spagnola vendendo spezie a quel paese, ma soprattutto imponendosi come massimi fornitori di trasporti marittimi tra la Spagna e i porti italiani (233). Largamente provvisti di reali spagnoli, i mercanti francesi, inglesi e olandesi ebbero quindi buon gioco in Levante dove la svalutazione monetaria offriva occasioni di ottimi affari a chi si presentava, contanti alla mano, a fare acquisti di seta e di cotone.
I documenti testé citati trattano i nuovi rivali ponentini in blocco come se tutti indistintamente effettuassero in moneta sonante il grosso dei loro acquisti di materie prime levantine. In realtà i mercanti inglesi si distinguevano da quelli francesi e olandesi in quanto erano i soli in grado di esportare manufatti in Levante a parziale copertura delle loro importazioni. Quella delle esportazioni di manufatti inglesi in Levante non era del resto una novità, perché anzi, come si è avuto occasione di osservare in precedenza, fin dal tardo medioevo gli Inglesi avevano collocato in quella regione ingenti quantitativi di carisee, vale a dire di tessuti di lana di qualità scadente e a buon mercato destinati "alla gente comune" e che, come tali, non avevano mai fatto concorrenza al panno fine veneziano che era invece destinato ad una clientela agiata. La novità fu invece che dall'inizio del Seicento in avanti le esportazioni di carisee calarono rapidamente, mentre si svilupparono quelle di un tessuto di miglior qualità, il cosiddetto broadcloth. Nel 1598 erano infatti giunte in Levante 18.031 carisee e soltanto 750 broadcloths; otto anni dopo le esportazioni di carisee erano scese a 10.349 unità, mentre quelle del nuovo tessuto erano salite a 2.776; dal 1621 al 1625 la media annua fu di un migliaio appena di carisee contro 6-7.000 pezze di broadcloth (234). Il nuovo articolo prodotto dal lanificio inglese otterrà i suoi massimi successi nella seconda metà del secolo XVII quando ne giungeranno in Levante fino a 20.000 pezze all'anno, ma già nel secondo e terzo decennio del secolo esso costituì un elemento importante nel commercio inglese in Levante.
Lo spostamento delle esportazioni inglesi dalle carisee a tessuti di maggior pregio quali i broadcloths va visto nel contesto, delineato in precedenza, dell'impoverimento dei mercati levantini. Da un lato "la gente comune", che in passato si era servita di carisee, fu costretta a ripiegare su succedanei locali più scadenti e, in particolare, su "tele imbottite di cotone", come riferiva un console veneto (235). D'altro lato, i consumatori più abbienti che erano stati soliti acquistare stoffe veneziane pregiate si videro costretti dalle crescenti strettezze economiche a ridurre i propri acquisti o a ripiegare su articoli meno costosi anche se di qualità meno buona. Il broadcloth inglese rispondeva a queste loro esigenze: era simile al buon panno veneziano (al punto che spesso si cercò di farlo passare per tale), ma era di qualità nettamente inferiore (236), tanto che ancora alla fine del Cinquecento esso era stato sdegnato dai consumatori turchi più esigenti che lo consideravano un povero succedaneo di quello veneziano (237). Ma con il deteriorarsi della situazione economica nei paesi ottomani nei primi decenni del Seicento, quei consumatori dovettero ridurre le proprie pretese e ripiegare almeno in parte sul prodotto inglese. Lo constatava nel 1628 il console veneto in Egitto: "Seben non possono né nel colore né nella bontà esser comparati ai [panni] veneziani, con tutto ciò [...], vendendoli a minor prezzi, [i panni inglesi] sono accettati e compri dai sartori e da Turchi grandi per dar il vestimento alla lor corte" (238).
Il calo della produzione di pannilana veneziani da una media annua di quasi 25.000 pezze negli anni 1596-1605 a meno di 15.000 trent'anni dopo (tab. 2) va pertanto attribuita sia alla contrazione dei consumi dei ceti agiati nei paesi del Levante, sia allo spostamento della domanda verso succedanei meno costosi, anche se più scadenti, quali erano appunto i broadcloths inglesi.
A questo punto non si può fare a meno di domandarsi perché mai l'industria laniera veneziana non cercò di seguire l'esempio inglese immettendo sul mercato un tessuto meno pregiato ma di minor prezzo. Non credo si sia trattato di semplice inerzia mentale e nemmeno penso che Venezia, per un gretto senso di orgoglio, si sia rifiutata di compromettere il buon nome del suo lanificio con prodotti più scadenti. In realtà, anche se avesse voluto provarcisi, Venezia ben difficilmente avrebbe potuto competere con l'industria inglese. Non soltanto perché non disponeva di una materia prima a buon mercato come la lana inglese, ma anche perché gli Inglesi si fecero largo in Levante con metodi che Venezia non era in grado di mettere in pratica. In proposito è stato osservato che la Compagnia inglese di Levante poteva accontentarsi di bassissimi margini di profitto sulle vendite di pannilana o, all'occorrenza, anche di venderli sottocosto, perché, in forza dei privilegi ottenuti dalla Corona, godeva del diritto esclusivo di importare in Inghilterra le merci di Levante e di conseguenza poteva largamente rifarsi di eventuali perdite o di bassi guadagni sulle merci esportate imponendo prezzi monopolistici su quelle importate (239). Strategia, questa, che era preclusa ai mercanti veneziani i quali non solo non erano organizzati in compagnie privilegiate come gli Inglesi, ma, lungi dall'avere dietro le spalle un mercato nazionale delle dimensioni di quello inglese, dovevano collocare gran parte delle proprie importazioni dal Levante su mercati esteri, come quello tedesco, in concorrenza con altri fornitori.
15. Un'occasione perduta
Nonostante le gravi perdite subite nei primi anni del Seicento, Venezia aveva tuttavia una carta molto forte da giocare: quella della geografia. Per far giungere la seta o il cotone levantini ai centri manifatturieri della Germania meridionale la via adriatica e transalpina non era certo meno conveniente della lunga rotta marittima che per Gibilterra raggiungeva i porti atlantici dai quali la merce doveva essere poi inoltrata per via terrestre o fluviale fino a Ulm, Augusta o Norimberga. La via adriatica passante per Venezia era anzi, tutto sommato, preferibile e lo dimostra il fatto che gli stessi mercanti inglesi e olandesi l'avrebbero volentieri utilizzata almeno per quanto riguardava le forniture al mercato tedesco. Agli inizi del Seicento furono proprio loro a chiedere alla Repubblica di aprire l'emporio realtino alle navi e ai mercanti stranieri, abrogando le vigenti leggi restrittive che consentivano bensì ai "ponentini" di far scalo a Venezia, ma soltanto per scaricarvi le merci del paese d'origine e caricarvi merci levantine fatte affluire a Rialto da mercanti veneziani su legni veneti.
Un primo tentativo in tal senso fu compiuto da un gruppo di mercanti inglesi nel 1604 (240). Per bocca del loro ambasciatore Sir Henry Wotton essi chiesero alle autorità veneziane di essere autorizzati a esercitare la mercatura nell'emporio realtino e dal tenore delle loro richieste, come pure da quello della risposta che ad esse diede il governo veneziano, appare chiaro che essi avevano di mira gli scambi con il Levante. Una delle loro richieste era infatti di poter riesportare liberamente da Venezia le merci inglesi (o comunque "di Ponente") che non fossero riusciti a smaltire sul posto a prezzi convenienti. Una seconda era di essere autorizzati a "mandar lor denari contanti in ogni parte dove li tornerà più commodo [...] in caso non si trovi in questa città [Venezia] da investir quelli capitali che li detti mercatanti [inglesi] se trovassero havere".
In sostanza essi miravano all'abrogazione di quelli che erano stati da sempre i capisaldi della legislazione commerciale veneziana, e cioè l'esclusivo diritto riservato ai patrizi e ai cittadini veneti di commerciare tra Venezia e il Levante, il conseguente obbligo fatto ai mercanti ponentini che venivano a Venezia di vendere le proprie merci a mercanti veneziani e di acquistare da essi soltanto le merci levantine, e infine il divieto di esportare valuta da Venezia. Nell'opporsi alle richieste inglesi i savi alla mercanzia osservarono infatti che il loro accoglimento "altro non sarebbe che il concederli la cittadinanza et darli libertà et auttorità di contrattar in Levante". Le richieste dei mercanti inglesi furono quindi respinte. Né ebbe miglior fortuna un'altra richiesta inglese, quella cioè che venisse abrogata la già ricordata parte del senato del 1602 con la quale, allo scopo di proteggere e stimolare l'attività armatoriale veneziana, erano state riesumate le antiche norme che vietavano il noleggio di naviglio straniero tra Venezia e il Levante. Come si è già avuto modo di vedere, la legge del 1602 aveva in effetti stabilito che sulle rotte di Levante le navi appartenenti a Veneziani avessero assoluta priorità di carico e che il naviglio straniero potesse operare soltanto tra Venezia e il paese di origine: "Ponentini per Ponente e Levantini per Levante".
La revoca di queste disposizioni avrebbe quindi consentito agli Inglesi che operavano a Venezia di impiegare "vasselli lor proprij [...] così in Levante come in Ponente" senza esser costretti a caricare su navi venete da loro giudicate pessime ("their shipping is bad and navigation worse" diranno in quell'occasione gli Inglesi a proposito della marina mercantile veneziana) (241). Anche questa richiesta si urtò a un netto rifiuto da parte di un governo ben deciso a proteggere le sorti pericolanti della propria marina mercantile: se fosse stata abrogata la legge del 1602, si fece osservare, "non è dubbio alcuno et si tocca con mano che tutto ciò redondaria a grandissimo beneficio loro, ma a maleficio universale della navigatione, marinarezza et navi di questa città" (242).
Nel 1610 furono dei mercanti olandesi a farsi avanti per ottenere "libera la scala di Venezia", per fare cioè di Venezia una delle basi delle loro operazioni commerciali tanto in direzione di levante quanto in direzione di ponente. Il che, a sentir loro, avrebbe rianimato i traffici nella laguna allora gravemente depressi: "Quando fussero accettadi [...] et admessi alla navigatione di Levante per il Golfo [l'Adriatico] che è navigatione sicura e breve [facevano osservare i postulanti] al sicuro desviarano quelle piazze che sono hora frequentate et ritornerà in pristino il negotio di questa piazza per esser più commoda di tutte le piazze del mondo" (243).
Nel 1610 le probabilità che una richiesta del genere venisse accolta potevano sembrare migliori che non nel 1604. Da un lato, la crisi che aveva colpito tanti settori dell'economia veneziana qualche anno prima rendeva urgente la ricerca di soluzioni anche drastiche. Dall'altro, ai vertici del governo veneto (il collegio) erano appena stati eletti ben cinque senatori che, ostili al papato (la vicenda dell'Interdetto era ancora fresca nella memoria), erano propensi a stabilire più stretti rapporti con i paesi protestanti. Furono questi senatori che, facendo propria la proposta dei mercanti "forestieri", presentarono in senato un disegno di legge secondo il quale "cadaun forestiero di qualunque natione et patria che al presente habita et venirà per lo avvenir ad habitar in questa città possa navegar et negotiar li suoi cavedali et mercantie in Levante" (244).
In un celebre discorso pronunciato in difesa del disegno di legge uno dei proponenti, il senatore Leonardo Donà, tratteggiava a fosche tinte il quadro del declinante commercio veneziano e in particolare di quello di Levante ormai "capitado tutto in man dei inglesi, francesi e olandesi [...] con accrescimento delle piazze di Livorno, di Amsterdam, di Marsegia e del Inghilterra" e caldeggiava, quale unico mezzo per rianimare l'emporio, "l'admetter li forestieri ancora alla abilità della navigatione e del commercio del mar", sottolineando i vantaggi naturali di cui Venezia, grazie alla sua posizione geografica, godeva rispetto ad altri porti e la convenienza di far transitare per essa le merci di Levante evitando "la navigation lunghissima e assai pericolosa" per lo stretto di Gibilterra (245). Contro la proposta caldeggiata dal Donà l'opposizione in senato fu tuttavia vivissima e si concretò in un emendamento che, pur riconoscendo la gravità della crisi economica, mirava a risolverla in altro modo, e cioè con misure intese a rendere più sicura la navigazione e con l'autorizzazione ai mercanti veneziani di esportare valuta per i loro acquisti in Levante (246). L'emendamento ottenne la maggioranza dei voti e la proposta di fare di Venezia un libero porto aperto a tutti venne respinta come era stata respinta quella inglese di sei anni prima (247).
Da un punto di vista strettamente economico quello del senato fu probabilmente un grosso errore: la prosperità del porto franco di Livorno in quegli anni starebbe a dimostrarlo. Ma come ha giustamente osservato Gaetano Cozzi, a decidere la questione non furono in ultima analisi considerazioni economiche, ma piuttosto considerazioni politiche e religiose. Giocò il timore che si stabilissero a Venezia nutriti gruppi di mercanti non soltanto stranieri, ma protestanti per giunta, con l'evidente pericolo che idee eterodosse si diffondessero tra la popolazione cittadina. Giocò anche il timore che l'ammissione alla piena cittadinanza di gente di lingua e di costumi tanto diversi da quelli veneziani, ma prevedibilmente munita di larghi mezzi finanziari, avrebbe introdotto elementi di discordia e scosso la compagine sociale della Dominante. Meglio quindi non correre rischi anche se ciò significava lasciarsi sfuggire un'occasione economicamente allettante (248).
16. Epilogo
Nel discorso pronunciato in senato nell'estate del 1610 per difendere la proposta di aprire Venezia ai mercanti e alle navi straniere Leonardo Donà aveva dato un quadro drammatico della crisi che da qualche anno aveva colpito l'economia veneziana e ne aveva tratto conclusioni allarmanti per l'avvenire. "De qua avvien [aveva detto] che, cessando il concorso de mercanti forestieri che venivano a provedersi qua, cessano l'arte; cessando l'arte manca la popolazione; non vi essendo populo cessa il consumo de viveri; e per conseguenza li dazi si sminuiscono, le publiche entrate si estenuano [...]" (249). In realtà, nonostante la proposta di legge venisse respinta, la diagnosi del Donà si rivelò troppo pessimista. È ben vero che, come si è detto in precedenza, i principali settori di attività (movimento del porto, gettito dei dazi, produzione laniera e così via) furono tutti improntati al ribasso nel primo trentennio del secolo XVII, ma sarebbe un errore concludere che l'economia veneziana si stesse avviando inesorabilmente verso la paralisi e il disfacimento.
Con i suoi 140.000 abitanti la Venezia del primo Seicento figurava ancora tra le maggiori città europee e godeva, e continuerà a godere per molto tempo, fama di città ricca e vivace. Senza dubbio il gettito dei dazi sul commercio che ancora alla fine del Cinquecento aveva rappresentato il 37% delle entrate complessive della Repubblica, non ne rappresentava più che il 25% nel terzo decennio del secolo XVII, ma anche in queste proporzioni ridotte il commercio costituiva pur sempre una fonte cospicua di entrate (250). Nel 1625 entrarono a Venezia quasi 100.000 colli (12.000 tonnellate circa) di merci (251): si tratta di un dato isolato che non è possibile raffrontare con analoghi dati per i decenni antecedenti alla crisi, ma nella prima età moderna anche 12.000 tonnellate di merci erano quantità tutt'altro che trascurabili. Altro indice di un'economia che rimane vitale ci è fornito da quel tanto che ci è dato conoscere in fatto di retribuzioni operaie: esse rimasero stabili nel primo trentennio del Seicento nonostante la flessione dei prezzi dei generi alimentari (252), il che sarebbe perlomeno strano se la città fosse stata in preda a una diffusa disoccupazione quale la presagiva il Donà quando parlava della "cessazione dell'arte".
Sia pure a ritmo molto ridotto, dunque, l'economia veneziana del primo Seicento continuava a pulsare, e il nostro compito è di individuarne le componenti ancora vive. Alcune di esse sono ovvie: la città continua infatti a produrre per l'esportazione tanto nel settore laniero quanto in quello serico. Con 15.000 pezze prodotte in media all'anno negli anni Venti del secolo XVII il suo lanificio è certamente molto decaduto rispetto alla fine del secolo precedente, ma è ancora un'industria ragguardevole che continua a generare grossi movimenti di materie prime in arrivo e di prodotti finiti in partenza. Quanto al setificio, sappiamo che i telai in attività erano 1.700 circa nel 1624 contro i 2.400 di un ventennio prima. E tuttavia anche con 1.700 telai e una produzione annua che può essere ragionevolmente valutata a mezzo milione di metri di tessuto, Venezia è ancora un grande centro dell'industria serica, tanto più che il calo del 30% circa registrato nel numero dei telai derivò quasi interamente dall'abbandono della lavorazione degli articoli di minor pregio e in particolare degli "ormesini bassi" che dovettero cedere di fronte alla concorrenza della nascente industria del basso Trentino. I telai adibiti alla manifattura degli articoli più pregiati (damasco, raso, velluti a oro e così via) subirono per contro un calo del 9% soltanto; ne conseguì che, in termini di valore della merce prodotta, il declino del setificio fu meno grave di quanto non lo fu in termini strettamente quantitativi (253).
Su altre industrie le notizie precise sono rare per questo periodo. Ma è sintomatico che le poche cifre di cui disponiamo relative alle importazioni da Spalato denunciano la buona tenuta di quella corrente di traffico (tab. 4).
Se si tiene presente che il grosso delle merci provenienti di lì era costituito da pellami (12.000 colli su un totale di 17.520 nel 1619) e che in direzione di Spalato uscivano annualmente da Venezia circa 1.500 quintali di sapone (254), è lecito concludere che due importanti industrie veneziane - la lavorazione del cuoio e il saponificio - non perdettero quota nei primi decenni del secolo. E importante continuò ad essere anche l'industria dolciaria: nel 1622 giunsero a Venezia 4.300.000 libbre sottili (13.000 quintali circa) di zucchero greggio e ne uscirono 2.500.000 di lavorato.
Mancano dati per stabilire dei raffronti con il secolo precedente, ma ciò che preme di sottolineare è la sopravvivenza di un ramo di attività evidentemente sostanzioso: parecchie navi salpavano ogni anno alla volta di Alessandria d'Egitto per caricare zucchero, "unico fondamento del presente negozio" in quello che era stato uno dei massimi centri del commercio delle spezie (255).
A tener vivo il movimento del porto realtino contribuì senza dubbio anche la domanda di materie prime destinate alla Terraferma e, in particolare, al lanificio delle valli bergamasche tuttora florido: ne fanno fede i forti quantitativi di lana pugliese che continuavano a prendere la via di Venezia per essere inoltrate a Bergamo (256). Più difficile dire quanto, nel primo trentennio del secolo, restasse a Venezia dell'antico commercio di transito tra il Levante e i paesi tedeschi, quel commercio che per secoli aveva costituito un po' la spina dorsale dell'economia realtina, ma che, fin dai primi anni del Seicento, aveva rapidamente perso quota via via che Francesi, Inglesi e Olandesi avevano soppiantato i Veneziani come fornitori di seta e di cotone al mercato tedesco. Senza contare che con lo scoppio della guerra dei Trent'anni la posizione di Venezia fu ulteriormente compromessa dalla caduta della domanda in un paese devastato e impoverito. Ma anche nel caso degli scambi con l'area tedesca sarebbe affrettato concludere che dopo il 1600 essi si avviarono inesorabilmente verso la paralisi. Il loro andamento dipendeva in larga misura dalla capacità dei rivali ponentini di assicurare i contatti tra il Levante e l'area tedesca, e negli anni Venti uno di questi rivali e forse il più temibile, l'Olanda, si trovò in difficoltà in seguito al riaccendersi, nel 1621, della guerra con la Spagna, alla conseguente chiusura dei porti spagnoli e siciliani e all'interruzione del traffico fluviale tra i Paesi Bassi e la Germania dal 1625 al 1629. In queste condizioni una parte dell'antico traffico di cotone, seta e zucchero destinati al mercato tedesco rifluì verso Venezia (257). Nel 1626, d'altra parte, il governo veneto che nel 1610 aveva creduto di poter rianimare la marina mercantile e l'attività commerciale dei propri sudditi riaffermando le antiche norme protezioniste contro i concorrenti occidentali, modificò in parte la propria politica allo scopo di attirare questi ultimi nella laguna. Ciò fece in due modi: in primo luogo ridusse drasticamente i dazi di importazione sulle merci (spezie, materie tintorie, pesce salato) che le navi ponentine avevano scaricato a Venezia, e ciò allo scopo di impedire che queste merci si diffondessero nell'entroterra padano per via di Genova e di Livorno; in secondo luogo impose un nuovo pesante dazio ("imposta novissima") sull'uva passa esportata dalle isole Ionie su navi straniere, esentandone però quelle navi che avessero fatto scalo prima a Venezia sbarcandovi l'intero carico di origine.
Con questi provvedimenti si sperava di ovviare al "grave pregiudizio che ogn'hora maggiore s'andava facendo con l'accrescimento de negotij nelle scale di Genova et Livorno"; si sperava cioè di "deviar da esse scale il concorso delle navi di Ponente et tirarle in questa città". Né si trattò di speranze vane: a quattro anni dalla nuova legislazione si constatava che ben 45 navi ponentine erano approdate a pieno carico; nel 1634 i savi alla mercanzia potevano affermare con evidente compiacimento che "questi esperimenti hanno partorito buoni effetti, essendosi migliorato il negotio di Ponente in questa città [...] et vedesi che le navi di Ponente frequentano questo porto" (258). E avrebbero potuto aggiungere che tra il 1622 e il 1634 era quasi raddoppiata l'esportazione dell'uva passa dalle isole Ionie verso l'Inghilterra (259).
Dai documenti relativi al primo trentennio del secolo XVII traspare quindi un'economia fortemente ridimensionata rispetto ai giorni più prosperi della fine del Cinquecento, ma al tempo stesso risulta chiaro che il vecchio emporio non è privo di vitalità ed è anzi capace di inattese riprese. Una più oculata politica doganale quale fu adottata nel 1626, sommandosi alla temporanea eclissi olandese nel Mediterraneo, consente ancora a Venezia di essere presente nel grande commercio internazionale, sia pure su scala ridotta, e di esercitare un notevole richiamo sulle navi e le merci dei concorrenti nordici. Né va dimenticato che Venezia è pur sempre un importante centro di industrie artistiche e di lusso e che in essa risiede una classe agiata le cui ricchezze, ancorate in parte alla proprietà fondiaria e al commercio delle derrate agricole, alimentano un alto livello di consumi. Va tenuto presente infine che, in quanto capitale, Venezia continua a beneficiare di un cospicuo flusso di reddito prelevato dai suoi dominii. Siamo in presenza dunque di un'economia in fase di ripiegamento, ma non certo di disfacimento; un'economia assestata su livelli più bassi di produzione, ma che gode ancora di un notevole benessere. Alla fine degli anni Venti, in altre parole, i giorni più neri per l'economia della Dominante non sono ancora venuti. Verranno di lì a poco con la terribile peste del 1630 e, più in là, con la lunga estenuante guerra di Candia.
1. Citazione in Giuseppe Gullino, I patrizi veneziani e la mercatura negli ultimi tre secoli della Repubblica, in AA.VV., Mercanti e vita economica nella Repubblica veneta, Verona 1985, p. 412 (pp. 403-451). Sulla prosperità di Venezia alla fine del Quattrocento cf. Frederic C. Lane, Storia di Venezia, Torino 1978, pp. 279-282; Gaetano Cozzi-Michael Knapton, La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517, Torino 1986, pp. 161-176.
2. C.H.H. Wake, The Changing Pattern of Europe's Pepper and Spice Imports, ca. 1400-1700, "Journal of European Economie History", 8, nr. 2, 1979, p. 392 (pp. 361-403).
3. Nicolò Contarini, Historie Venete, I, in appendice a Gaetano Cozzi, Il Doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, Venezia-Roma 1958, p. 312 (pp. 308-380).
4. Daniele Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Padova 1954, p. 59.
5. Dai quozienti generici di natalità e di mortalità a Venezia nel 1581 e nel 1586 forniti da D. Beltrami, ibid., p. 155, si desume un incremento naturale di 0,2 e 0,4% rispettivamente, molto meno quindi dell'effettivo incremento della popolazione in quel periodo. Cf. anche Richard T. Rapp, Industry and Economic Decline in Seventeenth-Century Venice, Cambridge, Mass. 1976 (trad. it. Industria e decadenza economica a Venezia nel XVII secolo, Roma 1986), pp. 34 e 37. Va osservato che nelle popolazioni urbane della prima età moderna il tasso di natalità era in tempi normali di poco superiore a quello di mortalità: ciò implicava che aumenti medi annui dell'ordine dell' 1% o più erano possibili soltanto grazie all'apporto dell'immigrazione. Per i dati in proposito cf. Roger Mols, Population in Europe 1500-1700, in Fontana Economic History of Europe, a cura di Carlo Maria Cipolla, II, Glasgow 1974, pp. 66-67 (pp. 15-82); e Carlo Maria Cipolla, Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000-1700, New York 1976, pp. 284-285.
5. Paul F. Grendler, The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605, Princeton 1977 (trad. it. L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia. 1540-1605, Roma 1983), p. 12; e F.C. Lane, Storia di Venezia, p. 358.
7. Pierre Sardella, L'épanouissemenl industrie) de Venise au XVIe siècle, "Annales E.S.C.", 2, 1947, p. 196 (pp. 195-196).
8. Cf. Aldo Stella, La crisi economica veneziana nella seconda metà del secolo XVI, "Archivio Veneto", 58-59, 1956, pp. 20 e 53-56 (pp. 17-69); Brian Pui.I.An, The Occupations and Investments of the Venetian Nobility in the Middle of the Sixteenth Century, in Renaissance Venice, a cura di John R. Hale, London 1973, pp. 382-383 (pp. 379-408); e Gici Corazzol, Livelli stipulati a Venezia nel 1591. Studio storico, Pisa 1986, p. 30.
9. Gino Luzzatto, Les banques publiques de Venise: siècles XVIe-XVIIIe, nei suoi Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, pp. 230-232; A. Stella, La crisi economica, p. 61; F.C. Lane, Storia di Venezia, pp. 380-382; e Ugo Tucci, Il Banco della Piazza di Rialto, prima banca pubblica veneziana, nel suo Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano, Bologna 1981, pp. 231-244.
F.C. Lane, Storia di Venezia, pp. 374-375; e G. Corazzol, Livelli stipulati, pp. 62-63.
U. Tucci, Il Banco, p. 248.
Per la quale cf. supra, n. 8.
13. Il gettito del dazio "delle sei percento" (dazio d'entrata) salì da 65.000 ducati nel 1584 a 118.000 nel 1602 (F.C. Lane, Storia di Venezia, p. 13 n.); quello dell'uscita da 208.532 ducati nel 1587 a 264.724 nel 1602, e quello del fondaco dei Tedeschi, fra le stesse date, da 45.998 a 63.168 (Bilanci generali della Repubblica di Venezia, a cura di Fabio Besta, I, 1, Venezia 1912, p. 365).
14. Domenico Sella, Commerci e industrie a Venezia nel secolo XVII, Venezia-Roma 1961, p. 2.
15. I dati relativi al 1498 in Ruggiero Romano, La marine marchande vénitienne au XVIe siècle, in Les sources de l'histoire maritime en Europe, du Moyen Age au XVIIIe siècle, a cura di Michel Mollat, Paris 1962, p. 33 (pp. 33-68); quello del 1504 in Jeanclaude Hocquet, Le sel et la fortune de Venise, I-II, Lille 1978-79: II, Voiliers et commerce en Médi terranée, 1200-1650, p. 532.
16. R. Romano, La marine marchande, p. 33; circa il declino delle galere cf. Alberto Tenenti - Corrado Vivanti, Le film d'un grand système de navigation. Les galères marchandes vénitiennes, XIVe-XVIe siècles, "Annales E.S.C.", 16, 1961, pp. 83-86; e Frederic C. Lane, Venetian Ships and Shipbuilders of the Renaissance, Baltimore 1934, capp. I e II; e dello stesso Storia di Venezia, pp. 402-408.
17. Secondo R. Romano, La marine marchande, p. 34, il tonnellaggio globale nel 1567 sarebbe stato di 53.400 botti; J.-C. Hocquet, Le sel et la fortune, II, p. 581, propone, più realisticamente, un totale di circa 40.000 botti.
18. R. Romano, La marine marchande, p. 34.
19. Il divario è stato sottolineato da Ugo Tucci, Venetian Shipowners in the XVIth Century, "Journal of European Economic History", 16, 2, 1987, p. 295 (pp. 277-296).
20. Sull'arrivo dei velieri nordici al tempo della guerra di Cipro cf. Fernand Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, I-II, Torino 1976: I, pp. 667 ss.; e J.-C. Hocquet, Le sel et la fortune, II, p. 590.
21. Sulla presenza dei Marsigliesi in Levante cf. D. Sella, Commerci e industrie, pp. 5-6 e la bibliografia ivi citata.
22. Per i collegamenti marittimi cf. Alwyn A. Ruddock, Italian Merchants and Shipping in Southampton, 1270-1600, Southampton 1951, pp. 231-232; per quelli terrestri, Wilfrid Brulez, L'exportation des Pays-Bas vers l'Italie par voie de terre au milieu du XIVe siècle, "Annales E.S.C.", 14, 1959, pp. 461-491.
23. Guglielmo Berchet, Relazioni dei consoli veneti nella Siria, Torino 1896, p. 87.
24. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, Risposte, reg. 141, c. 3, al 15 luglio 1602.
25. F. Braudel, civiltà e imperi, I, pp. 645-648.
26. Citazione in R. Romano, La marine marchande, p. 48.
27. Sulla crisi del legname cf. F.C. Lane, Venetian Ships, pp. 230-233; sul rincaro della manodopera, Brian Pullan, Wage-Earners and the Venetian Economy, 1550-1630, in Crisis and Change in the Venetian Economy in the 16th and 17th Centuries, a cura dello stesso, London 1968, p. 160 (pp. 146-176).
28. Cf. Maurice Aymard, Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVIe siècle, Paris 1966, p. 68.
29. Citazione in Alberto Tenenti, Venezia e i corsari, Bari 1961, p. 142. I1 documento citato è del 1605.
30. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, b. 836b, reg. 56.
31. Per queste testimonianze cf. D. Sella, Commerci e industrie, p. 17; e A. Tenenti, Venezia e i corsari, p. 83.
32. Fynes Moryson, An Itinerary, IV, Glasgow 1908, pp. 92-93. Il Moryson scriveva nei primi anni del Seicento.
33. Louis Deshayes, Voyage du Levant fait en l'année 1621, Paris 1624, p. 91.
34. Citazione in A. Tenenti, Venezia e i corsari, p. 137.
35. Cf. Ugo Tucci, Sur la pratique vénitienne de la navigation au XVIe siècle, "Annales E.S.C.", 13, 1958, p. 77 (pp. 72-86); e A. Tenenti, Venezia e i corsari, p. 137.
36. Per quanto segue ho attinto essenzialmente alla fondamentale opera di A. Tenenti, Venezia e i corsari.
37. Dopo Lepanto la flotta turca venne ricostruita nel giro di pochi anni e continuò a costituire una presenza temibile nel Mediterraneo orientale. Cf. Stanford Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, I, Cambridge 1976, p. 178.
38. In un discorso pronunciato in senato probabilmente nel 1603 o 1604 si legge: "Non si può negar che non sia gravissimo il pregiuditio ch'è sta fatto et tuttavia viene inferido da Bertoni inglesi alle navi, alle persone e ai dacij di questa Ser.ma Rep.ca dal primo principio che s'introdussero nel commercio del Levante fin all'hora presente, e ad ogn'un con infinito dolor è manifesto quanto questa barbara et pessima nation habbi nosudo a questo stado nel privarlo in gran parte dell'abondante negotio d'Alessandria, de Soria, de Ci-pro e de Costantinopoli, con il diminuirghe per più della metà l'utile della mercantia". Il documento è in Venezia, Museo Correr, Cod. Donà dalle Rose 217, c. 1.
39. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, Risposte, reg. 142, c. 52, al 5 febbraio 1607 m.v.
40. Citazione in A. Tenenti, Venezia e i corsari, p. 121.
41. Le precedenti notizie sulla pirateria sono desunte dal citato lavoro di Tenenti (in particolare pp. 13-27, 29-30, 52-57, 64-65, 88) al quale si rinvia per una più ampia trattazione dell'argomento.
42. R. Romano, La marine marchande, pp. 37-38. Sulla politica veneziana a favore della cantieristica e sul problema dell'alto costo del lavoro cf. anche Gino Luzzatto, Per la storia delle costruzioni navali a Venezia nei secoli XV e XVI, nei suoi Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, pp. 37-51.
43. R. Romano, La marine marchande, pp. 46-47.
44. Per i dati del 1598-99 cf. A. Tenenti, Venezia e i corsari, pp. 125-126; per quelli del 1605 cf. R. Romano, La marine marchande, p. 33.
45. Citazione in A. Tenenti, Venezia e i corsari, p. 125.
46. Cf. Renzo Paci, La "scala" di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani fra Cinque e Seicento, Venezia 1971, pp. 49-64.
47. Ibid., pp. 64, 73-76.
48. R. Romano, La marine marchande, p. 53.
49. R. Paci, La "scala" di Spalato, p. 94.
50. A. Tenenti, Venezia e i corsari, p. 158.
51. Ibid., p. 168.
52. Ibid., p. 160.
53. Ibid., p. 94: le galere, dice un documento del 1603, "non sono bastevoli a resister alle onde o fortune del mare e del cielo in tempo d'inverno [...] perché, essendo vasselli scoperti, impossibil è che le gienti si possano reggier dall'infruentie [sic] del cielo e del mare".
54. Ibid., p. 170.
55 Ibid., pp. 174-179.
56. F.C. Lane, Storia di Venezia, p. 449; e A. Tenenti, Venezia e i corsari, p. 140.
57. A. Tenenti, Venezia e i corsari, pp. 182-187.
58. Cf. F. Braudel, civiltà e imperi, I, pp. 317 ss.
59. M. Aymard, Venise, Raguse, p. 60.
60. Medie desunte dai dati globali in Frederic C. Lane, Venetian Shipping during the Commercial Revolution, "American Historical Review", 38, 1933, p. 235 (pp. 219-239).
61. Cf. l'ampia trattazione di J.-C. Hocquet, Le sel et la fortune, II, pp. 97-99 e 512-513; e F.C. Lane, Storia di Venezia, p. 445.
62. Citazione in D. Sella, Commerci e industrie, p. 106.
63. Ibid., e A Tenenti, Venezia e i corsari, p. 138.
64. R. Romano, La marine marchande, p. 51.
65. J.-C. Hocquet, Le sel et la fortune, II, p. 513.
66. D. Sella, Commerci e industrie, p. 106.
67. F.C. Lane, Venetian Shipping, pp. 221-222 e 228.
68. Cf. Id., Storia di Venezia, pp. 328-340 e 544 per un'efficace sintesi delle ricerche sugli alti e bassi del commercio delle spezie compiute, oltre che dallo stesso Lane, da Vitorino Magalhaes-Godinho, Ruggiero Romano, Alberto Tenenti e Fernand Braudel. Cf. anche Gino Luzzatto, Storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo, Venezia 1961, pp. 240-242 e 255-256.
69. Cf. Donald Weinstein, Ambassador from Venice; Pietro Pasqualigo in Lisbon, 1501, Minneapolis 1960, pp. 10-11.
70. Ibid., pp. 22-26.
71. Girolamo Priuli, I diarii, in R.I.S.2, XXIV, 3, vol. II, a cura di Roberto Cessi, 1933-1937, pp. 153-156, citato in parte in D. Weinstein, Ambassador from Venice, pp. 29-30.
72. Cf. John H. Parry, Transport and Trade Routes, in Cambridge Economic History of Europe, IV, Cambridge 1967, p. 164 (pp. 155-219); e F.C. Lane, Storia di Venezia, pp. 329, 336-337. Niels Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East Indian Companies and the Decline of the Caravan Trade, Chicago 1974, p. 40, osserva invece che "il trasporto per mare [lungo la rotta del Capo] costava di più di quello effettuato dalle carovane", ma che la differenza era più che compensata dal fatto che la rotta del Capo consentiva di evitare le gravose imposte ("i costi di protezione") nel Medio Oriente.
73. Cf. Frederic C. Lane, National Wealth and Protection Costs, in Venice and History. The Collected Papers of Frederic C. Lane, Baltimore 1966, pp. 376-380 (pp. 373-382); N. Steensgaard, The Asian Trade, p. 101, riconosce che il vantaggio iniziale dei Portoghesi si assottigliò via via che crescevano le spese militari nell'Oceano Indiano. Cf. anche J.H. Parry, Transport and Trade, pp. 165-166.
74. C.H.H. Wake, The Changing Pattern, p. 377.
75. Frederic C. Lane, The Mediterranean Spice Trade:
Its Revival in the Sixteenth Century, "American Historical Review", 45, 1940, pp. 581-590.
76. Oltre a ibid., cf. S. Shaw, History of the Ottoman Empire, pp. 99-100 e 106-107; e F. Braudel, Civiltà e imperi, I, pp. 584 ss.
77. J.H. Parry, Transport and Trade, p. 166.
78. Su questo episodio cf. F. Braudel, Civiltà e imperi, I, pp. 601 ss.; F. C. Lane, Storia di Venezia, pp. 339-340; J.H. Parry, Transport and Trade, pp. 166-167; e per un'analisi delle lunghe trattative diplomatiche fra Venezia e Spagna, Innocenzo Cervelli, Intorno alla decadenza di Venezia. Un episodio di storia economica, ovvero un affare mancato, "Nuova Rivista Storica", 50, 1966, pp. 596-642.
79. Sull'offerta portoghese fatta nel 1503 e sulle ragioni del rifiuto veneziano, cf. G. Luzzatto, Storia economica di Venezia, p. 241 e D. Weinstein, Ambassador from Venice, p. 74.
80. N. Steensgaard, The Asian Trade, pp. 177-178.
81. Guglielmo Berchet, Relazioni dei consoli veneti nella Siria, Torino 1896, pp. 102-103.
82. D. Sella, Commerci e industrie, p. 111.
83. Va tenuto presente che, come ha osservato F.C. Lane, Storia di Venezia, p. 351, il setificio veneziano non utilizzava la seta di Levante, bensì quella più fine della Terraferma veneta. La seta di Levante era destinata alle manifatture tedesche. Circa lo sviluppo di queste ultime nel corso del Cinquecento, cf. Hermann Kellenbenz, Le déclin de Venise et le relations économiques de Venise avec les marchés au nord des Alpes, in AA.VV., Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII, Atti del convegno 27 giugno - 2 luglio 1957, Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia-Roma 1961, pp. 113-114 (pp. 109-183).
84. Cf. F. C. Lane, Storia di Venezia, p. 342.
85. Cf. Maureen F. Mazzaoui, The Italian Cotton Industry in the Later Middle Ages, 1100-1600, Cambridge 1981, pp. 51 e 139-153.
86. D. Sella, Commerci e industrie, p. 28. Anche dopo la perdita di Cipro i mercanti veneziani continuarono a operare nell'isola acquistandovi soprattutto cotone: cf. Suraya Faroqhi, The Venetian Presence in the Ottoman Empire (1600-1630), "Journal of European Economic History", 15, 2, 1986, pp. 350 e 369 (pp. 345-384).
87. William Lithgo, Rare Adventures and Painfull Peregrinations [1609], citato in Michael Pratt, Britains's Greek Empire. Reflections on the History of the Ionian Islands from the Fall of Byzanthium, London 1978, p. 27.
88. M. Aymard, Venise, Raguse, p. 21.
89. Dati ricavati da A.S.V., V Savi alla Mercanzia, b. 836b, docc. 1 (23 dicembre 1578), Q (13 agosto 1584) e 52 (s.d.).
90. Christopher G.A. Clay, Economic Expansion and Social Change: England, 1500-1700, II, Cambridge 1984, p. 124; cf. anche F.C. Lane, Storia di Venezia, p. 305, e F. Braudel, Civiltà e imperi, I, pp. 376, 661, 670.
91. A. Tenenti, Venezia e i corsari, p. 81.
92. F. Braudel, Civiltà e imperi, I, p. 670.
93. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, b. 836b, reg. 56, al 15 novembre 1587.
94. Ivi, Senato Mar, f. 77, "parte" del 26 gennaio 1580 m.v.; il documento è citato in parte in F. Braudel, Civiltà e imperi, I, p. 670.
95. La "nuova imposta" fu adottata dal senato con la "parte" citata alla n. precedente.
96. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, b. 836b, reg. 1, doc. Q al 13 agosto 1584.
97. Ibid., Risposte, reg. 140, c. 101, al 26 agosto 1600.
98. Ivi, Senato mar, reg. 62, c. 80, parte del 16 agosto 1602.
99. London, British Museum. Lans. Mss. 140, cc. 304 ss., "The greyvances of the English Merchants trading in the Seignorie of Venice" (1602): i mercanti inglesi che operavano a Zante e Cefalonia lamentavano, fra l'altro, di essere "forced to shipp their goods first to Venice in Venetian shipps which being leakie and rotten there was cast away in one of those shipps 120 tonnes of corrinthes within the Gulfe ".
100. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, b. 836b, fasc. 1, doc. 52/13.
101. Sull'argomento cf. l'esauriente trattazione di J.-C. Hocquet, Le sel et la fortune.
102. Ibid., II, pp. 14-18 e 539-540.
103. Ibid., p. 14.
104. Ibid., p. 625.
105. Ibid., p. 307. Un moggio di sale pesava all'arrivo, a seconda della qualità, da 800 a 1.200 kg (ibid., I, p. 78).
106. Ibid., II, p. 301: nel 1579 ne giunsero a Venezia oltre 11.000 moggia.
107. Ibid., p. 307.
108. Ibid., p. 308.
109. Ibid., p. 686.
110. M. Aymard, Venise, Raguse, p. 14, stima a poco più un quintale il consumo medio pro capite di cereali nel secolo XVI. Ma a p. 17 accenna a stime cinquecentesche che collocano tale consumo tra i 200 e i 250 kg. Da parte sua Dante Zanetti, Problemi alimentari di un'economia preindustriale: cereali a Pavia dal 1398 al 1700, Torino 1964, pp. 60-62, ha proposto, con argomenti che mi sembrano del tutto convincenti, la cifra di 220 kg, che è quella adottata qui. Un consumo medio procapite di 220 kg equivale a circa 25.000 tonnellate per una città di 115.000 anime e di 37.000 circa per una città di 170.000 anime. E infatti nel 1566, quando Venezia contava 168.000 abitanti, entrarono in città 585.000 staia di grano, pari a 35.000 tonnellate circa.
111. M. Aymard, Venise, Raguse, pp. 112-113 e 117.
112. Ibid., pp. 45-46, 134, 150-151.
113. Cf. in proposito le penetranti osservazioni di F. C. Lane, Storia di Venezia, pp. 341, 382 e 463.
114. R.T. Rapp, Industry and Economic Decline, pp. 58-63: nel 1595 gli iscritti alle corporazioni dei calcineri, depentori, marangoni da casa, mureri, sabbioneri, tagliapietra e terrazzieri erano 1.423. Cavacanali e burchieri non avevano corporazione propria.
115. B. Pullan, Wage-Earners, pp. 160 e 174.
116. Cf. Astone Gasparetto, Il vetro di Murano dalle origini ad oggi, Venezia 1958, in partic. p. 97 per alcune testimonianze cinquecentesche e pp. 107-108 per cenni ai mercati di esportazione; e anche F.C. Lane, Storia di Venezia, p. 356, e U. Tucci, Mercanti, navi, monete, p. 103.
117. Gino Corti, L'industria del vetro di Murano alla fine del secolo XVI in una relazione al Granduca di Toscana, "Studi Veneziani", 13, 1971, pp. 649-654, pubblica una stima effettuata nel 1592 delle esportazioni di vetro di Murano: su un valore totale di 182.000 ducati, Venezia e la Terraferma ne avrebbero assorbito 40.000 (22% circa), i paesi ottomani (Siria in testa) 35.000 (19%), la Spagna e le sue colonie 52.000 (28%); ben 40.000 ducati rappresentavano poi il valore degli specchi muranesi esportati "per tutto il mondo".
118. Eliyahu Ashtor-Guidobaldo Cevidalli, Levantine Alkali Ashes and European Industries, "Journal of European Economic History", 12, 1983, pp. 479-495 (pp. 475-522).
119. G. Corti, L'industria del vetro, p. 654; la relazione cinquecentesca ivi pubblicata parla di "un milione 200 mila migliara di sode"; e cioè a 470 kg circa, si avrebbe un consumo annuo di 564.000.000 kg. Evidentemente si tratta di una svista: l'autore della relazione certamente intendeva parlare di 1.200.000 libbre, pari a 600 tonnellate circa.
120. D. Sella, Commerci e industrie, p. 132: intorno al 1 600 una quarantina di "caldiere" produceva 13 milioni di libbre sottili di sapone (3.900 tonnellate); il rapporto tra peso di sapone e peso di soda era di 4 a 1, il che comporterebbe un consumo di quasi 1.000 tonnellate di soda. Il dato sul consumo d'olio è tratto da Venezia, Museo Correr, Cod. Donà dalle Rose 42, c. 28.
121. Cf. Wilhelm Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen age, II, Amsterdam 1967, pp. 684-692.
122. F. Braudel, Civiltà e imperi, I, p. 656.
123. F.C. Lane, Storia di Venezia, p. 341.
124. D. Sella, Commerci e industrie, p. 4.
125. Ibid.
126. Sui merciai cf. Richard Mackenney, Tradesmen and Traders: The World of the Guilds in Venice and Europe, c. 1250-1650, London-Sidney 1987, pp. 90, 94, 95, 103, 106 e 111.
127. Alfredo Giarratana, Brescia industriale al principio del Seicento, "Commentari dell'Ateneo di Brescia", 134, 1935, pp. 41-48 (pp. 9-56).
128. Desumo il totale dai dati relativi alle corporazioni dei calegari (calzolai), centurieri, conzacurami (conciatori), cordovaneri (mercanti di cuoio), pellicceri, scorzeri (lavoranti di pellami), varoteri (specialità dei pellicciai), vazineri (fabbricanti di foderi da spada): i dati sono in R.T. Rapp, Industry and Economic Decline, pp. 58-62.
129. Il dato è fornito da R. Paci, La "scala" di Spalato, p. 93. Altre notizie in U. Tucci, Mercanti, navi, monete, p. 124.
130. U. Tucci, Mercanti, navi, monete, e A. Giarratana, Brescia industriale, p. 34, per cenni a spedizioni di cuoio da Venezia a Brescia.
131. Romolo Broglio d'Ajano, L'industria della seta a
Venezia [1893], ristampato in Storia dell'economia
italiana, a cura di Carlo Maria Cipolla, I, Torino
1959, p. 262 (pp. 209-262).
132. F. C. Lane, Storia di Venezia, p. 361.
133. R.T. Rapp, Industry and Economic Decline, p. 62.
134. D. Sella, Commerci e industrie, pp. 125-127.
135. London, British Museum, Add. 8647, "Commentarij delle cose di Costantinopoli [...] di Costantino Garzoni dell'anno 1573", c. 64v; e Sir Thomas Sherley, Discours of the Turkes [1606], a cura di Edward Denison Ross, "The Camden Miscellany", 16, 1936, p. 10 (pp. V-IX, 1-47).
136. Il documento è citato in A. Stella, La crisi economica veneziana, p. 57 n. Gli zambellotti (o carnelotti) erano tessuti a pelo lungo fatti con lana di cammello o di capra prodotti in Turchia (W. Heyd, Histoire du commerce, II, p. 703). Le "galle" si riferiscono alla noce di galla, cioè a un'escrescenza delle querce che veniva utilizzata nella concia delle pelli.
137. A.S.V., Sindici Inquisitori di Terraferma, b. 63, "Descrizione di Bergamo fatta da Zuan Da Lezze" (1596), c. 114.
138. La notizia è desunta dal documento citato alla n. 120.
139. Jean Delumeau, L'alun de Rome, XVe-XIXe siècle, Paris 1962, pp. 303, 310, 311.
140. Secondo R.T. Rapp, Industry and Economic Decline, p. 140, intorno al 1600 un panno veneziano valeva in media 79 ducati; se ne deduce che 24.000 panni rappresentavano un valore di 1.896.000 ducati.
141. Nel 1594 il gettito totale delle imposte fu di 2.087.000 ducati (ibid., p. 141). Due anni prima, secondo il documento citato supra, n. 117, il valore della produzione muranese sarebbe stato di 182.000 ducati.
142. Cifre desunte da ibid., pp. 58-63.
143. U. Tucci, Mercanti, navi, monete, p. 99.
144. Paolo Malanima, La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII, Bologna 1982, pp. 298 e 302.
145. Domenico Sella, Les mouvements longs de l'industrie lainière à Venise aux XVIe et XVIIe siècles, "Annales E.S.C.", 12, 1957, p. 37 (pp. 29-45).
146. Cf. Nella Fano, Ricerche sull'arte della lana a Venezia nel XII e XIV secolo, "Archivio Veneto", ser. V, 18, 1936, pp. 73-213.
147. Citazione in D. Sella, Les mouvements longs, p. 33 n.
148. Citazione in F. Braudel, Civiltà e imperi, I, p. 467 n.
149. G. Luzzatto, Storia economica di Venezia, pp. 166-167.
150. Citazione in F. Braudel, Civiltà e imperi, I, p. 217. Sulla riesportazione di carisee in Levante ad opera dei Veneziani cf. Eliyahu Ashtor, The Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton 1983, p. 464 e Edmund Fryde, The English Cloth Industry and the Trade with the Mediterranean, c. 1370-c. 1480, in Produzione, commercio e consumo dei panni di lana nei secoli XII-XVIII, a cura di Marco Spallanzani, Firenze 1976, pp. 349 e 352 (pp. 343-367).
151. Angelo Ventura, Le trasformazioni economiche nel Veneto tra Quattro e Ottocento, "Bollettino del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio", 18, 1976, pp. 131-132 (pp. 127-142).
152. D. Sella, Les mouvements longs, pp. 34 nn. e 37.
153. Hidetoshi Hoshino-Maureen F. Mazzaoui, Ottoman Markets for Florentine Woolen Cloth in the Late Fifteenth Century, "International Journal of Turkish Studies", 3/2, 1985-86, pp. 18-19 (pp. 17-31); e Hidetoshi Hoshino, L'arte della lana in Firenze nel basso medioevo. Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV, Firenze 1980, pp. 239-246.
154. H. Hoshino, L'arte della lana, pp. 274-275.
155. Una portata era costituita da 20 fili di ordito; la qualità del tessuto era tanto più fine quanto maggiore era il numero delle portate. Cf. R.T. Rapp, Industry and Economic Decline, p. 157 n.
156. D. Sella, Les mouvements longs, pp. 33-34.
157. "Relazione su Firenze di Antonio Suriano, del 1533", in Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, a cura di Angelo Ventura, II, Bari 1976, p. 198. Per un'altra testimonianza nello stesso senso, cf. Renzo Pecchioli, Dal "mito" di Venezia alla "ideologia" americana, Venezia 1983, pp. 34-35.
158. P. Malanima, La decadenza di un'economia cittadina, pp. 295 e 298.
159. D. Sella, Les mouvements longs, p. 37.
160. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, Risposte, reg. 139, al 5 dicembre 1597.
161. P. Malanima, La decadenza di un'economia cittadina, p. 302.
162. Citazione in A. Tenenti, Venezia e i corsari, p. 83.
163. P. Sardella, L'épanouissement industriel, p. 196.
164. Suraya Faroqhi, Population Rise and Fall in Anatolia, 1550-1620, ristampato nel suo Peasants,
Dervishes, and Traders in the Ottoman Empire, London 1986.
165. Cf. Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, London 1961, pp. 29-30.
166. Thomas Coryat, Crudities, I, Glasgow 1905, p. 395. La prima ediz. è del 1611.
167. N. Contarini, Historie, pp. 3 11-312.
168. Citazione in U. Tucci, Mercanti, navi, monete, p. 43.
169. Citazioni ibid., p. 55 e in Amintore Fanfani, Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII, Milano 19592, p. 19.
170. Citazione in Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, VII, Venezia 1858, p. 332.
171. Citazione in G. Cozzi, Il Doge Nicolò Contarini, p. 15 n.
172. Sugli investimenti nel debito pubblico cf. F.C. Lane, Storia di Venezia, pp. 373-375; e B. Pullan, The Occupations and Inveslrnents, pp. 380 e 388; per i prestiti livellari, ibid., pp. 388-389, e l'ampia trattazione di G. Corazzol, Livelli stipulati.
173. Daniele Beltrami, La penetrazione economica dei Veneziani in Terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete nei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 1961, pp. 48-51. L'argomento degli acquisti fondiari è ampiamente trattato in un altro capitolo del presente volume.
174. Un esempio è quello della famiglia Donà acutamente studiato da James C. Davis, A Venetian Family and Its Fortune, 1500-1900. The Donà and the Conservation of their Wealth, Philadelphia 1975 (trad. it. Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza. I Donà dal'500 al '900, Roma 1980). Vedi in particolare pp. 32-37 per il graduale abbandono, tra il 1466 e il 1602, della mercatura a favore della proprietà fondiaria.
175. R. Romano, La marine marchande, pp. 42-43.
176. Cf. A. Stella, La crisi economica veneziana, pp. 40-41, 49, 51, 52 e 64; U. Tucgi, Mercanti, navi, monete, pp. 66-67; Peter Burke, Venice and Amsterdam. A Study of Seventeenth-Century Elites, London 1974 (trad. it. Venezia e Amsterdam. Una storia comparata delle élites del XVII secolo, Ancona-Bologna 1988), p. 50; e G. Gullino, I patrizi veneziani e la mercatura, p. 413.
177. A. Stella, La crisi economica veneziana, pp. 18 n. e 43 n.
178. Sul tema della rinuncia della mercatura nella storiografia veneziana cf. Carlo Livi - Domenico Sella - Ugo Tucci, Un probleme d'histoire: la décadence économique de Venise, in AA.VV., Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII, Atti del Convegno 27 giugno - 2 luglio 1957, Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia-Roma 1961, pp. 294-298 (pp. 289-317).
179. Lo ha acutamente sottolineato B. Pullan, The Occupations and Investments, p. 381: "Gli investimenti fondiari e quelli commerciali sono stati spesso considerati come derivanti da una riserva fissa di ricchezza", con il risultato che "qualsiasi aumento degli uni doveva necessariamente effettuarsi a scapito degli altri. Pochi scrittori sostennero, con Paolo Paruta, che i due tipi di investimenti potevano essere complementari". Pullan tuttavia conclude essere "probabile" che ci fu spostamento a favore di quelli fondiari nella seconda metà del Cinquecento. Cf. anche G. Gullino, I patrizi veneziani e la mercatura, p. 413: "il volgersi del patriziato alla terra non fu fenomeno plebiscitario né irreversibile, perlomeno nel secolo XVI, giacché sovente convisse con altri interessi".
180. Citazione in G. Cozzi, Il Doge Nicolò Contarini, pp. 312 ss.
181. Citazione in G. Gullino, I patrizi veneziani e la mercatura, pp. 412-413.
182. Per i dati sui prezzi dei cereali a Udine e Chioggia cf. Fernand Braudel, La vita economica di Venezia nel secolo XVI, in AA.VV., La civiltà veneziana del Rinascimento, Firenze 1958, p. 91 (pp. 81-102); e per quelli a Padova, Gigi Corazzol, Fitti e livelli a grano: un aspetto del credito rurale nel Veneto del Cinquecento, Milano 1979, pp. 109-112. Analogo fu l'andamento dei prezzi del carbone di legno, per il quale cf. R. Mackenney, Tradesmen and Traders, p. 102.
183. Cf. F.C. Lane, Storia di Venezia, p. 354, per un "giudizio positivo" sugli investimenti fondiari del patriziato, investimenti che Lane considerava "intelligente iniziativa imprenditoriale di fronte ai bisogni e alle opportunità del tempo". Cf. anche B. Pullan, The Occupations and Investments, p. 381.
184. G. Gullino, I patrizi veneziani e la mercatura, pp. 426 e 447.
185. Oltre all'importante volume di Daniele Beltrami, Saggio di storia dell'agricoltura nella Repubblica di Venezia durante l'età moderna, Venezia-Roma 1955, cf. Stuart J. Woolf, Venice and the Terraferma: Problems of the Change from Commercial to Landed Activities, "Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano", 4, 1962, pp. 415-441; e A. Stella, La crisi economica veneziana, pp. 20-26. Angelo Ventura, Considerazioni sull'agricoltura veneta e sulla accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII, "Studi Storici", 9, 1968, pp. 674-722, ha dato particolare rilievo al ruolo svolto dallo Stato nei lavori di bonifica (pp. 689-690; dello stesso cf. anche Le trasformazioni economiche nel Veneto, p. 133. Sui caratteri e i limiti delle opere di irrigazione cf. infine Salvatore Ciriacono, Irrigazione e produttività agraria nella Terraferma veneta tra Cinque e Seicento, "Archivio Veneto", 112, 1979, pp. 73-135. Notevoli anche gli investimenti in nuovi mulini e seghe azionati da ruote idrauliche nella prima metà del Cinquecento per cui cf. Raffaello Vergani, Energia dall'acqua: ruote idrauliche e mulini nel territorio monte-bellunese nei secoli XV-XVIII, "Studi Trevisani", 7, 1988, pp. 95-96.
186. D. Sella, Commerci e industrie, p. 12.
187. Esempi in G. Gullino, I patrizi veneziani e la mercatura, pp. 413-414. Il subentrare nel commercio di patrizi di mediocri fortune è, del resto, quanto Luzzatto aveva intuito quando scriveva: "Fosse anche vero che la maggior parte dei vecchi patrizi-mercanti avessero già preferito trasformarsi in ῾rentiers', questo non implicherebbe come conseguenza necessaria la decadenza del commercio", perché "di solito al posto di chi si ritira subentrano elementi nuovi". Aggiungeva però che "una delle maggiori debolezze dell'economia veneziana è derivata appunto dagli ostacoli che la tenacia dei vecchi privilegi di classe hanno opposto alla piena attuazione di una tale rotazione" (Storia di Venezia, pp. 253-254). Come si dirà in seguito, tali ostacoli si fecero particolarmente sentire nei primi anni del Seicento.
188. Cf. U. Tucgi, Mercanti, navi, monete, pp. 90-94.
189. Venezia, Museo Correr, Ms. Donà dalle Rose 42, c. 30v, "Li nomi delli principali mercanti che negotiano d'oglio in questa città".
190. U. Tucci, Venetian Shipowners, p. 283.
191. Secondo James C. Davis, The Decline of the Venetian Nobility as a Ruling Class, Baltimore 1962, pp. 135-137, il numero dei patrizi adulti calò da un massimo di 2.620 nel 1527 a 2.000 nel 1609.
192. U. Tucci, Mercanti, navi, monete, pp. 74-75; H. Kellenbenz, Le déclin, p. 129; e R. Mackenney, Tradesmen and Traders, p. 107.
193. Ugo Tucci, Bontempelli, Bartolomeo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XII, Roma 1970, pp. 426-427. Qualche ulteriore notizia in G. Corazzol, Livelli stipulati, pp. 85-86.
194. Renzo Pecchioli, Uomini d'affari fiorentini a Venezia nella seconda metà del Cinquecento, nel suo Dal "mito" di Venezia alla "ideologia" americana, Venezia 1983, pp. 74-85.
195. P.F. Grendler, The Roman Inquisition and the Venetian Press, pp. 15-17.
196. R. Mackenney, Tradesmen and Traders, p. 112.
197. Cf. ibid.
198. Cf. F.C. Lane, Storia di Venezia, pp. 344-347; e Brian Pullan, Rich and Poor in Renaissance Venice: The Social Institutions of a Catholic State, to 1620, Cambridge, Mass. 1971 (trad. it. La politica sociale della Repubblica di Venezia. 1500-1620, I-II, Roma 1982), pp. 421-620.
199. Benjamin C.I. Ravid, Economics and Toleration in Seventeenth-Century Venice: the Background and Context of the Discorso of Simone Luzzatto, Jerusalem 1977, p. 75 n; cf. anche Sergio Della Pergola, Aspetti e problemi della demografia degli ebrei nell'epoca preindustriale, in Gli Ebrei e Venezia, a cura di Gaetano Cozzi, Milano 1987, p. 204 (pp. 201-210).
200. Cf. Bernard D. Cooperman, Venetian Policy towards Levantine jews in Its Broader Italian Context, in Gli Ebrei e Venezia, a cura di Gaetano Cozzi, Milano 1987, pp. 65-77 (pp. 65-84).
201. R. Paci, La "scala" di Spalato, pp. 31-50 e 134-141; B.C.I. Ravid, Economics and Toleration, pp. 30-38; e Jonathan I. Israel, European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750, Oxford 1985, pp. 34-48. L'ammissione degli Ebrei ponentini al commercio veneziano e la trasformazione del porto di Spalato sono magistralmente inquadrati nel contesto della politica veneziana del tempo da Gaetano Cozzi, Società veneziana, società ebraica, in Gli Ebrei e Venezia, a cura di Id., Milano 1987, pp. 333-343 (pp. 333-374).
202. Alberto Tenenti, Naufrages, corsaires et assurances maritimes à Venise, 1592-1609, Paris 1959, pp. 14-15; e Bernard Blumenkranz, Les juifs dans le commerce maritime de Venise, "Revue des Études Juives", 119, 1961, pp. 148-149 (pp. 143-151).
203. B.C.I. Ravid, Economics and Toleration, p. 67.
204. Citazione ibid., p. 89 n. Sull'attività dei mercanti ebrei veneziani nel Mediterraneo orientale cf. anche B. Pullan, Rich and Poor, pp. 570-573.
205. Circa la flessibilità dell'ordinamento corporativo in particolare cf. R. Mackenney, Tradesmen and Traders, pp. 4, 80 e 122.
206. Frederic C. Lane, La marine marchande et le trafic maritime de Venise à travers les siècles, in Les sources de l'histoire maritime en Europe du Moyen Age au XVIIIe siècle, a cura di Michel Mollat, Paris 1962, pp. 28 e 31 (pp. 8-32): l'appalto del 1603 (6.647 ducati) si rivelò eccessivo e causò grosse difficoltà agli appaltatori i quali evidentemente si erano illusi che il trend ascendente degli anni precedenti sarebbe continuato.
207. D. Sella, Commerci e industrie, p. 23 n.: il dazio delle sei per cento calò da 150.000 a 60.000 ducati; quello dell'uscita da 264.000 a 119.000.
208. Ibid., pp. 23-24. Si noti che il tracollo dell'economia veneziana precede di alcuni anni il generale declino dell'economia italiana sul quale cf. Carlo Maria Cipolla, Il declino economico dell'Italia, in Storia dell'economia italiana, a cura di Id., I, Torino 1959, pp. 605-623. E precede anche la crisi di dimensioni europee apertasi con lo scoppio della Guerra dei Trent'anni, per la quale cf. Ruggiero Romano, Tra XVI e XVII secolo. Una crisi economica: 1619-1622, "Rivista Storica Italiana", 74, 1962, pp. 480-531.
209. D. Beltrami, Storia delle popolazione, p. 59.
210. G. Berchet, Relazioni dei consoli veneti, p. 103.
211. Citazione in P.R. Harris, The Letter-Book of William Clarke, Merchant in Aleppo (1598-1602), tesi di M.A., University of London, 1953, p. 227.
212. Citazione in D. Sella, Commerci e industrie, p. 26.
213. Sull'importazione di spezie nel Mediterraneo ad opera di Inglesi e Olandesi e sul definitivo arresto del commercio levantino cf. N. Steensgaard, The Asian Trade Revolution, pp. 172-173 e 184-185.
214. A.S.V., Arte della Seta, b. 109, fasc. 203, c. 28v, scrittura dell'8 agosto 1608. Cf. anche H. Kellenbenz, Le déclin de Venise, p. 112: nel 1610 Au-gusta si riforniva di cotone dai Paesi Bassi e dalla Francia anziché da Venezia; e p. 117: nello stesso anno Venezia acquista spezie a Francoforte.
215. D. Sella, Commerci e industrie, p. 27; e N. Steensgaard, The Asian Trade Revolution, pp. 177-183.
216. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, Risposte, reg. 141, c. 4, al 15 luglio 1602.
217. Ivi, Senato mar, f. 187, scrittura del 24 luglio 1610 inserita alla "parte" del 6 agosto 1610.
218. Sui gravi disordini nell'impero ottomano cf. Bruce Masters, The Origins of Western Dominante in the Middle East: Mercantilism and the Islamic Economy, New York 1988, pp. 18-20; e N. Steensgaard, The Asian Trade Revolution, pp. 75-76 e ivi la testimonianza di un viceconsole olandese ad Aleppo nel 1626: "La situazione è giunta a un punto tale che ciascuno fa quel che gli pare e piace, specialmente i potenti [...]. Non ha ceduto soltanto uno dei pilastri dello stato, ma han ceduto tutti e quattro: religione, giustizia, politica e finanze [...]; c'è da chiedersi come si può andare avanti così".
219. N. Steensgaard, The Asian Trade Revolution, p. 173.
220. J.H. Parry, Transport and Trade Routes, pp. 196-197; e N. Steensgaard, The Asian Trade Revolution, pp. 133-152.
221. D. Sella, Commerci e industrie, p. 35. La parte del senato è stata pubblicata da Giuseppe Stefani, Le assicurazioni a Venezia dalle origini alla fine della Serenissima, II, Trieste 1956, p. 376. Su questa legge cf. anche A. Tenenti, Venezia e i corsari, pp. 20-21, e F.C. Lane, Storia di Venezia, p. 449.
222. G. Berchet, Relazioni dei consoli veneti, p. 131.
223. F.C. Lane, Storia di Venezia, pp. 464-465.
224. G. Berchet, Relazioni dei consoli veneti, p. 132.
225. A.S.V. Senato Zecca, f. 11, scrittura non datata
inserta al decreto 3 gennaio 1609 m.v.
226. Su questo momento di storia commerciale e sulle misure valutarie adottate dal senato cf. Frank C. Spooner, Venice and the Levant: An Aspect of Monetary History (1610-1614), in AA.VV., Studi in onore di Amintore Fanfani, V, Milano 1962, pp. 645-657 (pp. 643-667). Il decreto del 1610 è riprodotto a p. 656.
227. S. Faroqhi, Venetian Presence, p. 377.
228. Cf. Louis Bergasse, Histoire du commerce de Marseille de 1599 à 1660, Paris 1954, p. 74.
229. Helmut Koenigsberger, English Merchants in Naples and Sicily in the Seventeenth Century, "English Historical Review", 63, 1947, p. 307 (pp. 304-326).
230. Jonathan I. Israel, The Phases of the Dutch ῾Straatvart' (1590-1713), "Tijdschrift voor Geschiedenis", 99, 1986, pp. 8-10 (pp. 1-30). L'autore sottolinea che gli Olandesi furono particolarmente impegnati nel commercio del cotone cipriota e siriano, gli Inglesi e i Francesi in quello della seta levantina.
231. L. Bergasse, Histoire du commerce, pp. 113-116.
232. Frederic J. Fisher, London's Export Trade in the Early Seventeenth Century, "Economic History Review", ser. II, 3, 1950, pp. 151-157 (pp. 151-161); e C.G.A. Clay, Economic Expansion, pp. 148-149.
233. J.I. Israel, The Phases, p. 9.
234. Ralph Davis, Influences de l'Angleterre sur le déclin de Venise au XVIIe siècle, in AA.VV., Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII, Atti del Convegno 27 giugno - 2 luglio 1957, Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia-Roma 1961, p. 205 (pp. 185-235). Cf. anche Barry E. Supple, Commercial Crisis and Change in England, 1600-1642, Cambridge 1959, p. 160. All'inizio del Seicento un viaggiatore inglese in Levante aveva osservato che le carisee erano destinate alla "gente comune", il panno alto (broadcloth) "ai mercanti e alla gente di miglior condizione". Samuel Purchas, His Pilgrimes, III, Glasgow 1905, p. 83.
235. G. Berchet, Relazioni dei consoli veneti, p. 131. Circa lo spostamento della domanda verso prodotti più scadenti e i suoi effetti sulle industrie tessili all'interno dell'impero ottomano, cf. Suraya Faroqhi, Textile Production in Rumeli and the Arab Provinces: Geographical Distribution and Internal Trade (1560-1650), nel suo Peasants, Dervishes and Traders in the Ottoman Empire, London 1986.
236. Su questo punto cf. l'importante articolo di Richard T. Rapp, The Unmaking of the Mediterranean Trade Hegemony: International Trade Rivalry and the Commercial Revolution, "Journal of Economic History", 35, 1975, specialmente pp. 508-522 (499-526).
237. In proposito si leggano due testimonianze inglesi. Intorno al 1605, Fynes Moryson scriveva: "I veneziani portano in Turchia pannilana che chiamano alti [broad] [...] i quali sono così forti e ben lavorati che durano a lungo, sì che i Turchi li preferiscono ai panni inglesi. E dato che i veneziani gliene forniscono in grande quantità, i Turchi ne adoperano pochi altri di quel tipo" (An Itinerary, IV, Glasgow 1908, p. 123). E da Aleppo un mercante inglese scriveva nel 1598 a proposito dei pannilana veneziani: "essendo molto buoni e di bei colori, si vendono meglio di quelli che portiamo noi" (P.R. Harris, The Letter-Book, p. 141).
238. A.S.V., Collegio relazioni, b. 31, relazione dell'Egitto, 31 marzo 1628.
239. Cf. C.G.A. Clay, Economic Expansion, p. 127; e Murat Çizakça, Price History and the Bursa Silk Industry: a study in Ottoman industrial decline, 1550-1650, in The Ottoman Empire and the World Economy, a cura di Huri Islamoglu-Inan, Cambridge 1987, p. 257 (250-264).
240. Su questa proposta mi sia consentito di rinviare
il lettore al mio Commerci e industrie, pp. 35-40.
241. London, Public Record Office, S.P. 14/10/28, doc. non datato, ma dei primi anni del Seicento.
242. A.S.V., V Savi alla Mercanzia, Risposte, reg. 141,
c. 119, al 9 dicembre 1604.
243. Scrittura di Paolo Santonini, in ivi, Senato mar, f. 187, inserta alla parte del 6 agosto 1610.
244. Cf. G. Cozzi, Il Doge Nicolò Contarini, pp. 139-147 per un'approfondita analisi di questa proposta e del dibattito che ne seguì in senato. La citazione è a p. 141.
245. Il discorso del Donà è in S. Romanin, Storia documentata, VII, pp. 530-535.
246. Cf. supra, n. 226
247. Incorse in errore il Romanin quando scrisse (Storia documentata, VII, p. 535) che "venne dunque deliberato che si concedesse anche agli esteri il commercio di Levante".
248. G. Cozzi, Il Doge Nicolò Contarini, pp. 146-147.
249. S. Romanin, Storia documentata, VII, p. 530.
250. R.T. Rapp, Industry and Economic Decline, p. 141.
251. D. Sella, Commerci e industrie, p. 72.
252. B. Pullan, Wage-Earners, p. 173.
253. Cf. D. Sella, Commerci e industrie, pp. 125-127; sullo sviluppo del setificio trentino cf. ora Ivana Pastori Bassetto, Crescita e declino di un'area di frontiera. Sete e mercanti ad Ala nel XVII e XVIII secolo, Milano 1986.
254. R. Paci, La "scala" di Spalato, p. 93 e D. Sella, Commerci e industrie, p. 55 n.
255. D. Sella, Commerci e industrie, pp. 4 e 54.
256. V. John A. Marino, Pastoral Economics in the Kingdom of Naples, Baltimore 1988, p. 229.
257. J.I. Israel, The Phases, pp. 15-16.
258. Sulla politica commerciale in questo periodo e per i documenti citati cf. D. Sella, Commerci e industrie, pp. 91-93.
259. C.G.A. Clay, Economic Expansion, p. 156.