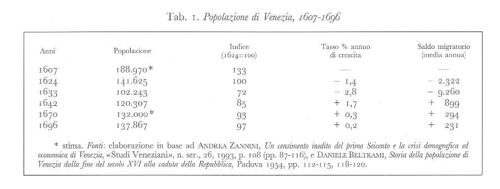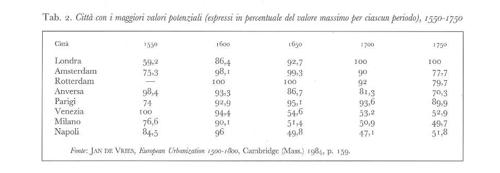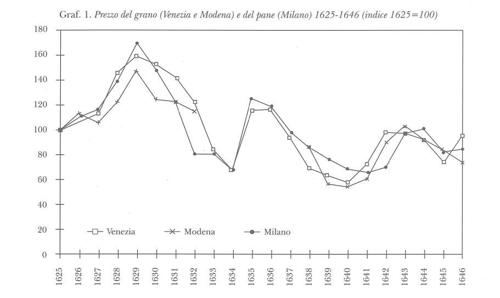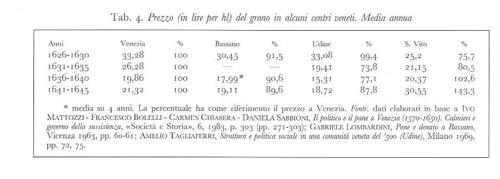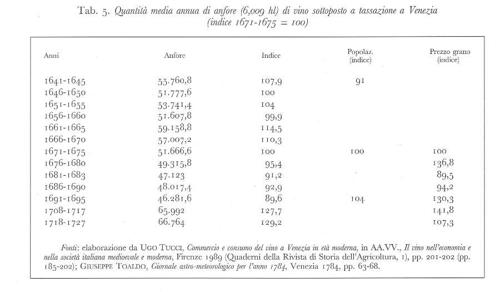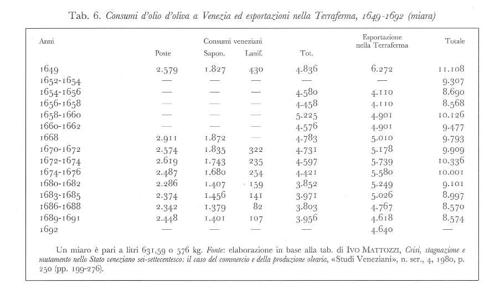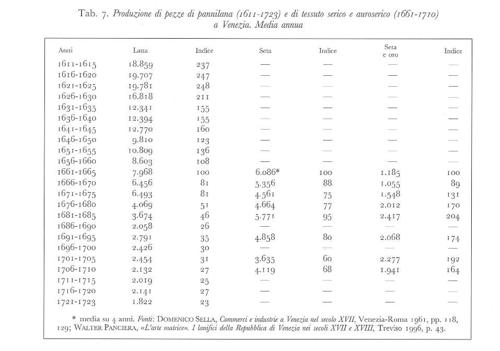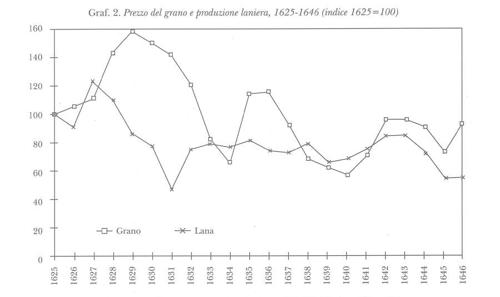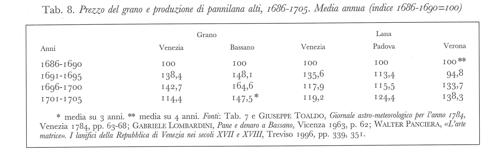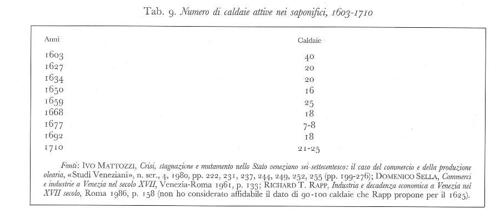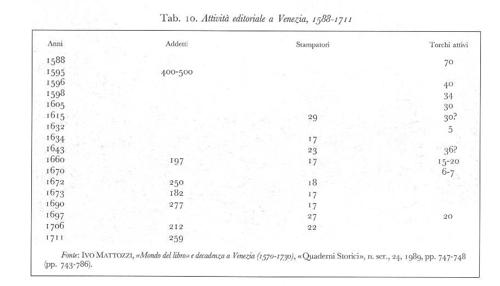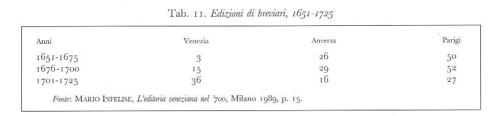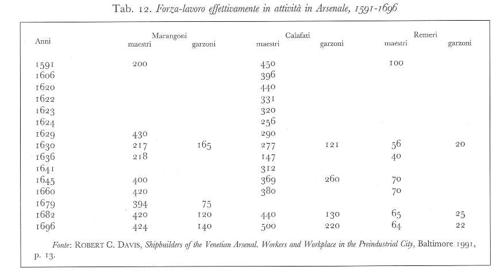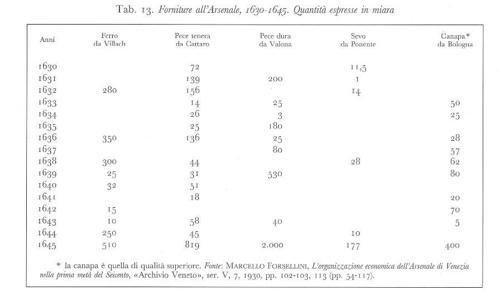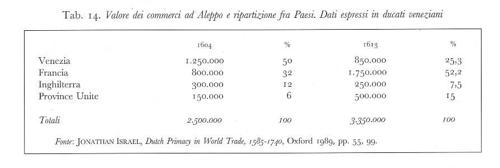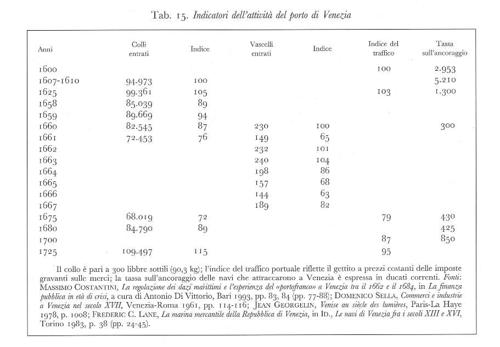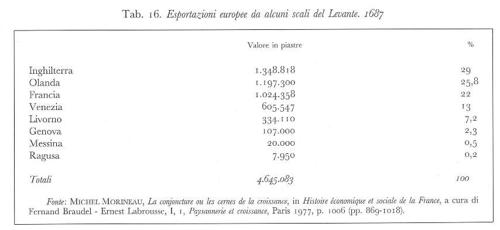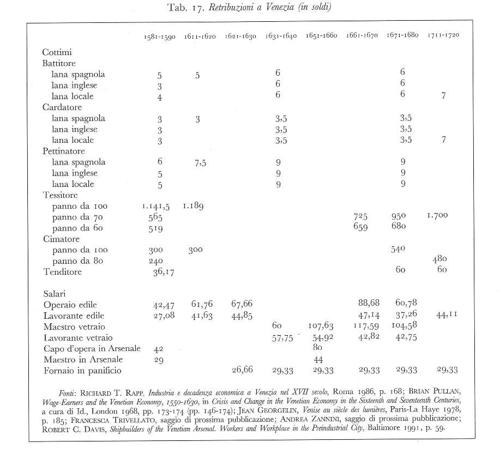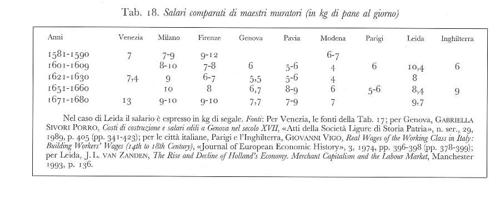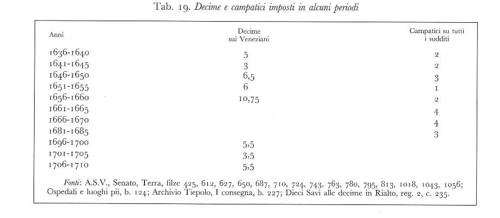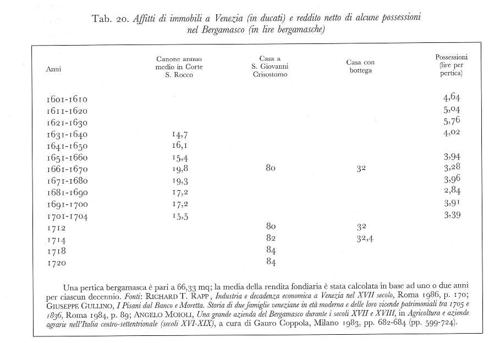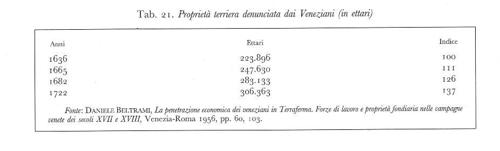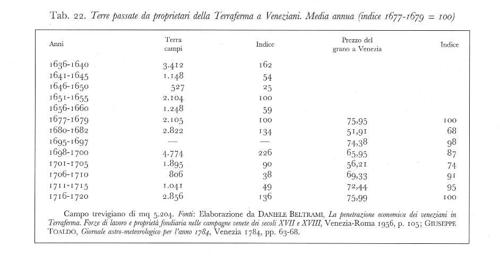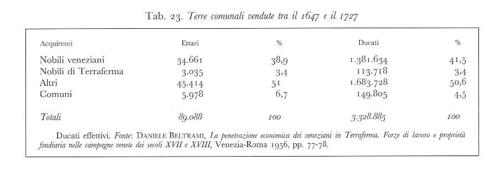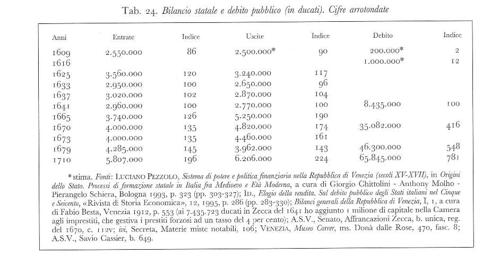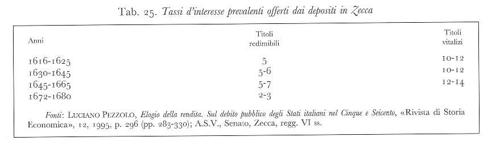L'economia
L'economia
Strano secolo, il Seicento: dimenticato per lungo tempo da una storiografia attenta alla grande politica e distolta dalle luci del Rinascimento; etichettato come il secolo della dominazione straniera, del ritiro degli intellettuali dall'impegno politico, delle ombre della Controriforma, si è portato addosso sino a poco tempo fa un giudizio negativo. Secolo di crisi, di decadenza, di spiriti intorpiditi. E ciò valeva a maggior ragione per l'Italia, che stava perdendo il suo primato economico di fronte all'aggressivo incalzare di Francesi, Inglesi e Olandesi. L'Italia, infatti, era destinata ad occupare quella fascia semiperiferica dell'economia-mondo che vedeva al centro l'Olanda e la Zelanda, l'area attorno a Londra e l'East Anglia, la Francia settentrionale e occidentale (1). Fascia, quella della semiperiferia, adattatasi a rifornire il centro di prodotti semilavorati e materie prime, e a subirne la dipendenza commerciale. Ed esempio paradigmatico è la parabola di Venezia: centro luminoso del Mediterraneo, dove si erano incrociate le grandi correnti commerciali sino a tutto il Cinquecento, la sua luce si sarebbe lentamente affievolita nel secolo barocco, vivendo una drammatica decadenza che colpì i suoi traffici marittimi per poi estendersi alle manifatture e alle basi stesse della struttura economica.
I termini della questione, tuttavia, sono assai più complessi: accanto ad indubbi segni di difficoltà si possono riscontrare elementi di tenuta e, in alcuni casi, di crescita. Contrazione e crescita, pertanto, sembrano convivere in un medesimo spazio e tempo. Ed è proprio per questa complessità e per talune apparenti contraddizioni che - rischiando di provocare la noia del lettore - si è scelto di presentare una nutrita serie di dati quantitativi che, benché non debbano essere considerati con feticistica fede, possono aiutare ad individuare tempi e meccanismi della congiuntura, o meglio, delle congiunture. Non esiste infatti un unico Seicento: se volessimo tracciare su un grafico le curve dei prezzi cerealicoli, della popolazione, dei traffici commerciali, dei consumi, delle diverse produzioni, ne uscirebbe un quadro complesso e di difficile interpretazione. Un secolo breve, se considerassimo il dato della crisi profonda; un secolo lungo, invece, leggendolo nell'ottica della ristrutturazione di un sistema. Si è tentato di collocare, poi, il Seicento veneziano in un contesto più ampio, confrontando - dove possibile - i dati e le performances dell'economia veneziana con alcuni casi europei. Un veloce sguardo oltre la laguna, così, permetterà di valutare il reale significato della congiuntura nella Venezia del Seicento.
1. La popolazione
La popolazione di uno Stato, di una città, la sua variegata composizione, la presenza di stranieri, il modo di vestire, le abitudini quotidiane erano tra gli elementi considerati più interessanti dai viaggiatori e dagli osservatori politici per fornire una prima valutazione del carattere e della ricchezza di un Paese. Nel caso di Venezia, la febbrile attività di mercanti, mediatori, piccoli negozianti, gente comune affaccendati a Rialto o in piazza S. Marco colpiva fortemente l'immaginazione degli stranieri che giungevano in città. Un centro popolato presupponeva scambi di merci e di ricchezza, nonché una vasta area di consumi, tra i più svariati, da quelli primari - gli alimenti e i tessuti meno pregiati - a quelli considerati di lusso - sete e preziosi, opere d'arte e spezie orientali; tra questi estremi vi era un'ampia gamma di domanda di beni e servizi, stimolata dalla presenza di uomini e capitali in un medesimo, circoscritto, luogo. A Venezia - osserva verso il 1685 il francese G. Burnet - "c'è una ricchezza incredibile e una grande abbondanza di ogni cosa" (2). Anche all'occhio dello storico il fattore demografico riveste un'importanza fondamentale per analizzare il sistema di un'economia preindustriale. L'andamento della popolazione riflette, spesso, le congiunture economiche ed è a sua volta causa ed effetto di mutamenti strutturali. E ciò vale a maggior ragione per il mondo urbano, sensibile mercato che registra le variazioni della congiuntura ma che, nello stesso tempo, dispone di strumenti che gli permettono di fronteggiarla attingendo alle risorse che giungono dall'esterno. Risorse economiche, certo, ma che vengono incanalate e sostenute anche - e talvolta soprattutto - in virtù del controllo politico che la città esercita sul territorio circostante, sia esso una ristretta fascia del contado o un'estesa area territoriale.
Esaminando i dati demografici, dunque, dovremo sempre tener presente che Venezia è la capitale politica ed economica di uno Stato e che, inoltre, è inserita in un complesso sistema economico che si allarga dalle coste mediterranee all'Europa settentrionale, per abbracciare con le sue ramificazioni l'intero mondo allora conosciuto. Vediamo, anzitutto, le cifre esposte nella Tab. 1 (3).
Risulta evidente il drammatico impatto della peste del 1630, anche se occorre sottolineare che - ammettendo sia affidabile il dato relativo al 1607 - la tendenza al declino della popolazione veneziana sembra manifestarsi ben prima dello scoppio epidemico. In effetti, nel 1586 risultarono censiti 148.097 abitanti: una cifra pur sempre superiore a quella registrata nel 1624, nonostante nel frattempo la città non fosse stata colpita da seri eventi epidemici. C'è da chiedersi se la flessione, o perlomeno la tendenza stagnante, non sia legata al declino della produzione laniera, che iniziò a manifestarsi nella seconda decade del Seicento, culminando proprio a ridosso del 1624. Raggiunto l'apice della produzione nel 1602 con 28.792 pannilana, infatti, si verificò un calo medio annuo dell'1,1 per cento sino al 1620, per scendere sensibilmente a 14.778 pezze nel 1622 e a 12.976 l'anno successivo (4). Forse le difficoltà del settore attenuarono quella forza d'attrazione per i lavoratori emigranti e le loro famiglie (Tab. 1) che Venezia esercitava tradizionalmente. Una testimonianza, pur limitata, dei mutamenti che stavano avvenendo lungo il Seicento è offerta dall'analisi della provenienza di coloro che stipularono un contratto di garzonato registrato presso la magistratura della giustizia vecchia (5). Gli anni considerati sono il 1598, 1662 e 1707, mentre i contratti effettivamente utilizzati sono rispettivamente 908, 929 e 460. Ebbene, la percentuale di garzoni veneziani balza dal 9,1 del 1598 al 27,4 del 1662 per arrivare al 46,7 nel 1707; nello stesso momento, tradizionali aree d'immigrazione, quali il Bergamasco e il Bresciano, diminuiscono sensibilmente il loro contributo, e cresce in percentuale l'apporto dal Bellunese e da alcune zone del Friuli. Nel caso specifico dei garzoni calzolai e ciabattini, la percentuale di Veneziani crebbe dal 12,5 per cento negli anni 1698-1702 al 25,1 nel periodo 1718-1722 (6). È probabile che la diffusione di attività protoindustriali nelle province d'Oltremincio - emersa in maniera evidente tra Sei e Settecento - abbia per un verso trattenuto forza-lavoro locale e limitato i flussi migratori verso la Dominante, la quale, dall'altro lato, aveva perso un po' della sua carica seduttiva. Confrontata con altre situazioni, in effetti, quella di Venezia mostra i segni della stanchezza: città come Torino, ad esempio, proprio fra Sei e Settecento si affermarono come centri politici e demografici tali da ridimensionare duramente le altre città dello Stato (7).
L'analisi di indici demografici assume altresì una particolare importanza per definire il potenziale economico di una determinata città. Il concetto di potenziale urbano, preso a prestito dai geografi, permette infatti di valutare la capacità di un centro nel contesto della rete di interrelazioni tra le città vicine. In estrema sintesi, è possibile assegnare un valore quantitativo al potenziale di una località in funzione dell'entità della popolazione, la vicinanza ad altri centri, le sue attribuzioni urbane ed i mercati d'accesso. In un saggio che abbraccia gran parte dell'Europa moderna, Jan de Vries ha raccolto una notevole serie di dati demografici sulle città europee ed ha tentato di misurare gli andamenti di lungo periodo utilizzando appunto la chiave offerta dal potenziale urbano (8). Il quadro che emerge non sembra sconvolgere le conoscenze già da tempo acquisite. Se assegnamo il valore di cento alle città del continente che esprimono il più alto potenziale, notiamo (Tab. 2) che viene evidenziato chiaramente lo spostamento del baricentro economico dall'Europa mediterranea alle rive del mare del Nord. Un mutamento, questo, che si palesò lungo il Seicento.
Lo scenario risulta chiaro. La preminenza di Venezia nel sistema economico internazionale si spinse sino al tramonto del Cinquecento, per poi lasciare spazio, in maniera netta, all'area olandese prima e inglese poi. Ma non si trattava solamente della città lagunare: il declino del potenziale indica che la rete di mercati che aveva in Venezia il suo punto privilegiato di riferimento aveva subito un brusco ridimensionamento nel più ampio sfondo dei mutamenti economici registrati nell'Europa seicentesca. La peste del 1630 inferse profonde ferite nel tessuto demografico di molte città venete; ferite che, diversamente da quanto avvenne nella grave epidemia del 1576, non furono facilmente rimarginate. Il drammatico ciclo di carestia ed epidemia tra la fine degli anni Venti e l'inizio degli anni Trenta del Seicento rappresentò solamente il punto culminante di una tendenza negativa i cui elementi erano già affiorati negli anni precedenti. Se Venezia era riuscita a superare le difficoltà provocate dalla pesante congiuntura agraria dei primi anni Novanta del Cinquecento (9), un quarantennio dopo il quadro generale sarà profondamente diverso. Cos'era cambiato?
Per tentare di valutare i mutamenti intervenuti nel sistema economico veneziano è necessario prendere in considerazione non solo la città ma anche il suo vasto dominio di Terraferma e il più ampio sfondo europeo, che proprio in quei decenni stava registrando movimenti strutturali. Il tratto saliente che denota la storia della popolazione dell'Italia settentrionale a cavallo tra Cinque e Seicento è la tendenza, quasi generale, alla diminuzione della popolazione urbana in rapporto alla crescita del numero di persone che vivevano in centri minori sparsi nei distretti rurali (10). Questo fenomeno è interpretato come il segnale della ruralizzazione del sistema economico a scapito dell'ambiente urbano. Le difficoltà erano vissute non solo da Venezia ma dall'intera struttura economica tradizionale che aveva nelle città i suoi centri propulsori. La nascita o il trasferimento di attività manifatturiere dall'interno delle mura cittadine ai centri del distretto sarebbero stati provocati dall'esigenza dei mercanti e degli imprenditori di svincolarsi dai controlli corporativi e di impiegare manodopera a costi inferiori rispetto ai salari urbani. Si trattava di una risposta agli stimoli esercitati dal mercato internazionale, specie quello relativo ai tessuti. La tradizionale preminenza italiana in questo settore, infatti, venne messa a repentaglio dalle produzioni inglese, olandese e francese, che al tramonto del Cinquecento iniziarono a conquistare sempre più ampi spazi nei mercati del Mediterraneo. I consueti sistemi produttivi si dimostrarono poco efficaci nel trovare rapidamente una risposta alla concorrenza "nordica", e nel volgere di qualche decennio i livelli denunciarono drammatici decrementi in molte città (11). L'attrazione dei centri urbani per la manodopera, almeno per quanto riguarda la lavorazione dei tessuti, venne meno, con gravi conseguenze sui livelli della domanda aggregata e sui settori connessi al tessile, e la ripresa demografica all'indomani della grande peste si fece attendere ancora a lungo. Il "gran contagio", dunque, s'abbatté su una struttura economica che stava vivendo una complessa serie di aggiustamenti, di mutamenti, di palesi difficoltà che colpivano anzitutto la tradizionale economia urbana.
I cambiamenti strutturali che stavano verificandosi nell'economia-mondo, tuttavia, non costituivano le uniche cause della congiuntura negativa patita dalle città. Paul M. Hohenberg e Lynn H. Lees hanno proposto di collegare altresì il declino urbano seicentesco alla diminuzione delle rendite agrarie, fenomeno che caratterizzò quel secolo (12); il surplus agricolo estratto dalle campagne e diretto in città diminuì lungo il Seicento, e questo limitò le capacità di sviluppo urbano. L'andamento declinante o tutt'al più stagnante dei prezzi cerealicoli mise in difficoltà i proprietari cittadini mentre, d'altro canto, le campagne godettero di una situazione relativamente meno critica. I due studiosi propongono un modello per cui ad una fase di espansione economica caratterizzata dalla crescita della popolazione, dei prezzi e delle rendite agrarie, corrisponde una congiuntura favorevole ai mercanti e proprietari cittadini, mentre in presenza di un ciclo depressivo o di ripresa sono le campagne ad avvantaggiarsi.
Questo modello, sebbene possa risultare troppo meccanico e non sempre facilmente applicabile alle diverse situazioni, ha tuttavia il pregio di proporre un quadro di riferimento assai utile, e soprattutto spinge ad analizzare le vicende urbane in stretta relazione con il mondo rurale. Si tratta di due ambiti che si influenzano reciprocamente e interagiscono in un movimento di azioni e reazioni, sui vari livelli economico, sociale e istituzionale, sino a costituire, talvolta, un sistema in sé, dotato di un relativo coordinamento interno. Nel caso specifico di Venezia, il quadro è ancor più complesso. I piani urbano (locale) e regionale (caratterizzato comunque da un forte tasso d'urbanizzazione) s'intersecano con quello internazionale, con le grandi correnti dei traffici, con i conflitti militari, con quell'economia-mondo di cui Venezia aveva rappresentato il centro sino all'alba del Seicento (13). Nell'analizzare l'economia di Venezia, dunque, cercheremo di tener presente che la città va collocata in un ambito, spaziale ed economico, che va ben oltre la laguna e che coinvolge un ampio dominio territoriale nonché la più vasta area dell'economia internazionale.
2. Una città che consuma
L'immagine che la Tab. 2 ci aveva offerto - un deciso declino lungo il Seicento dell'area urbana veneziana in rapporto all'imperiosa ascesa olandese e di Londra - non deve tuttavia far dimenticare che Venezia, nonostante il duro ridimensionamento, era ancora tra le più popolose città d'Europa. Se fino agli inizi del Seicento essa si collocava in quarta posizione nella graduatoria dei centri maggiori, dietro a metropoli quali Parigi, Londra e Napoli, a metà Settecento Venezia si piazzava attorno ad un onorevole ottavo posto - in contesa con Roma - essendo stata superata da Amsterdam, Lisbona e da grandi capitali come Mosca e Vienna (14). Un centro assai popolato, dunque, che necessitava di quantità enormi di cibo, tessuti, materie prime, combustibile; che attirava flussi di denaro che si disperdeva tra i mille rivoli della città, tra le piccole botteghe e i grandi fondaci, in quel variegato settore terziario che caratterizza la vocazione economica della città nel Seicento.
Quanto e cosa consumavano i cittadini veneziani? Ovviamente non disponiamo di notizie precise a riguardo, e ancor meno di dati diacronici che possano fornirci l'andamento dei consumi nel tempo. Ci limiteremo pertanto a fornire un'immagine assai grossolana e statica, tentando di cogliere qualche elemento e di azzardare alcuni livelli quantitativi. Iniziamo anzitutto considerando l'entità del consumo calorico di un veneziano medio. È oramai opinione diffusa che l'uomo dell'età preindustriale necessitasse di circa 2.500 calorie al giorno, e perciò adotteremo questa indicazione di massima anche per un cittadino di Venezia. Del resto, questo dato emerge anche da un modello di dieta di un lavoratore dell'Arsenale verso il 1650 proposto da Robert C. Davis (15). Ecco il dettaglio:
La struttura della dieta non è certo inusuale: l'apporto dei cereali è preponderante, mentre il vino (talvolta annacquato) e il pesce (o formaggio o carne) contribuiscono a fornire una discreta quota calorica (16). Verdura, frutta e olio completavano poi il ventaglio degli alimenti che generalmente venivano consumati sulle tavole dei Veneziani. È ovvio che se usciamo dalle case dei lavoratori dell'Arsenale o dei lavoranti tessili ed entriamo in una fastosa dimora patrizia l'immagine acquista una sorprendente varietà di colori e di sapori. Alla tavola di un ricco veneziano non potevano mancare dolci e frutta varia, uova, legumi, formaggi, saporiti vini mediterranei che accompagnavano carni ben speziate, oltre al rinomato pane bianco, cui difficilmente un veneziano benestante poteva rinunciare. Rimanendo comunque nell'ambito di un consumo medio, la dieta del nostro arsenalotto può essere assunta come modello. All'incirca 10 soldi (ovvero mezza lira) costituivano pertanto la spesa dedicata al vitto quotidiano. A ciò occorre inoltre aggiungere i costi per il riscaldamento e il combustibile per cucinare (la stima del consumo di legna, non considerando le attività cantieristiche, l'edilizia ecc., è di circa 4 quintali annui pro capite (17)), il vestiario, le calzature, la cera per l'illuminazione, l'affitto dell'abitazione. Considerando che pressappoco il 70 per cento dell'intero budget era devoluto in spese alimentari (18), possiamo ipotizzare che il nostro veneziano tipo spendesse all'incirca 260 lire all'anno per i bisogni della propria vita quotidiana. Nel 1691 la confraternita dei lavoranti calzolai stimava un aiuto di 6 lire e 4 soldi alla settimana (ossia 300 lire annue) a favore di un associato malato per mantenersi e curarsi. Nel 1697 la somma fu elevata a 8 lire e 10 soldi, e a 10 lire nel 1701 (19).
È necessario riaffermare che le stime proposte, al di là del valore puramente indicativo, riguardano il veneziano medio: la gamma e la struttura dei consumi riflettono la gerarchia sociale, e sarebbe sin troppo facile opporre a quello del popolano un bilancio di un benestante, patrizio o borghese che fosse. Nel 1620, ad esempio, i costi di mantenimento di tre orfani di un mercante, due maschi ed una femmina, erano devoluti per il 57 per cento al vitto e alloggio, il 21 per cento all'abbigliamento, ben il 15 per cento all'istruzione, e il 7 per cento ad altre voci (20). A casa del nobile Piero Pisani Moretta, poi, le spese per il vitto incisero per un misero 10 per cento delle uscite correnti nel 1705, e in media del 13,8 per cento nel periodo 1705-1735. Ma occorre dire che il nobile Pisani rappresentava un esempio estremo di parsimonia. Più allineata sul modello generale, invece, la struttura delle spese correnti dei Pisani dal Banco, che nei medesimi anni spendevano il 30 per cento in alimenti (21). In base ad una ferrea legge, all'aumento del reddito corrisponde una diminuzione della quota di spese destinata all'alimentazione.
Più saliamo lungo la scala sociale, dunque, meno si fa pressante la preoccupazione per il vitto quotidiano, ed acquistano maggior importanza voci quali l'abbigliamento, il personale domestico, l'abbellimento della dimora. Non crediamo perciò di allontanarci di molto dal verosimile se attribuissimo ad una famiglia benestante un'incidenza dei costi alimentari ben al di sotto del 50 per cento (22). Ma quanti erano questi "benestanti" che potevano permettersi di non essere assillati dalle preoccupazioni del bisogno primario? Purtroppo le ricerche sulla struttura economica e sociale della popolazione veneziana sono assai scarse e si limitano per lo più ad analisi di casi specifici. La documentazione fiscale - che solitamente costituisce la fonte più importante per questo genere di studi - non è ancora stata sfruttata adeguatamente, e pertanto saremo costretti a proporre stime ancora assai vaghe. Uno dei pochi dati certi è che nel 1661 furono 5.922 i Veneziani che presentarono le proprie dichiarazioni fiscali in cui comparivano possedimenti fondiari in tutto lo Stato; in questo numero rientravano anche gli enti laici ed ecclesiastici, ma sembrerebbe con percentuali piuttosto ridotte. Circa 6.000 Veneziani, dunque, traevano redditi da fondi rurali, botteghe, affitti di case: qualunque fosse stata la via per la quale ne fossero venuti in possesso (acquisto, eredità, dote), è presumibile che essi avessero manifestato una capacità di risparmio o un reddito integrativo tale da vivere al di sopra del livello minimo di sussistenza. Ora, attribuendo un coefficiente di 4 componenti per la famiglia di ogni contribuente, potremmo ipotizzare che almeno 24.000 persone costituissero una sorta di fascia superiore (che consumava meno della metà del budget in alimenti) al di sotto della quale viveva la popolazione ai confini del minimo di sussistenza (70 per cento in viveri). Se consideriamo che su una popolazione totale di 120.000 persone a metà Seicento circa 24.000 consumavano un cifra di 360 lire annue pro capite in varie voci (metà per il vitto) e 96.000 spendevano 260 lire (di cui il 70 per cento in alimenti), risulterebbe un consumo globale di Venezia per un valore attorno ai 34 milioni di lire (5.400.000 ducati di conto) in un anno, vale a dire 280 lire (45 ducati e mezzo) pro capite; 1.120 lire per un nucleo familiare di 4 persone. Si tratta - lo ripetiamo - di una soglia minima: l'impressione è che a Venezia il tenore di vita generale fosse relativamente più elevato che altrove, pur prescindendo dalla sfarzosa ostentazione delle famiglie doviziose o dalle comodità dei ceti agiati. Allorché nel 1680 il cardinale Pietro Ottoboni, a seguito di alcune pendenze familiari, decise di destinare un vitalizio ai nipoti Antonio e Marco, assegnò una somma di 5.735 lire annue che permettesse loro di vivere "moderatamente" (23). Una cifra, questa, che poteva essere sufficiente per il sostentamento annuo di 5 famiglie.
Che valore assumono i 5.400.000 ducati stimati in precedenza? Vediamo qualche termine di confronto fiscale: è lecito supporre che verso metà secolo le entrate globali della Repubblica si aggirassero sui 3.500.000 ducati, quindi per un valore ben oltre la metà dei consumi della sola Venezia, che rappresentava pressappoco il 10 per cento della popolazione della Terraferma. Si tratta di un rapporto assai elevato, che tuttavia fa risaltare da un lato la notevole pressione fiscale esercitata durante gli anni della guerra di Candia (1645-1669), e dall'altro la rilevante capacità di consumo della capitale. Questo livello, poi, corrisponde al salario annuale (calcolato in 200 giornate lavorative a 15 soldi) di 224.000 maestri tessitori (24). Ancora, calcolando in 530 lire il salario annuale di un maestro operaio in Arsenale (25), il valore della domanda privata dei Veneziani equivaleva al monte salariale di oltre 64.000 maestri. L'entità dei bisogni della popolazione veneziana, insomma, era ragguardevole: per l'alimentazione, in primo luogo, per l'abbigliamento, il combustibile, le dimore, e poi per il consumo vistoso, ambito ristretto al ceto agiato. Si trattava di un complesso che mobilitava un indotto articolato, dai trasporti alla rete distributiva, e che attirava altresì le preoccupazioni del governo, impegnato anzitutto ad assicurare il vettovagliamento alla città e a controllare i prezzi dei generi più richiesti, nonché ad esercitare il proprio influsso sulla domanda aggregata tramite la politica di bilancio.
Pur essendo assai difficile quantificare i bisogni primari della città, tenteremo di proporre qualche cifra riguardante il problema dell'approvvigionamento urbano. Continuiamo a considerare una popolazione di 120.000 unità, di cui un quinto - ed è una stima assai prudente - può essere ritenuto vivere ben al di sopra del livello di sussistenza. Attribuendo il consumo annuo di 4 staia (uno staio è uguale a 83,3 litri) di "biave" ai benestanti e di 3 alla gran parte della popolazione (26), ne consegue che verso la metà del Seicento Venezia necessitava di 384.000 staia di cereali, ovvero all'incirca 192.000 quintali di pane (27). La quantità è senz'altro rilevante, e a ciò s'aggiunga che i Veneziani tendevano a disdegnare, salvo in periodo di gravi carestie, il pane confezionato con cereali inferiori. Il primo problema è sapere se il sistema annonario urbano riuscisse a fronteggiare la domanda. Una domanda che, in parte, veniva soddisfatta dalle granaglie inviate a titolo di canone dalla Terraferma ai proprietari veneziani, ma che richiedeva in primo luogo l'intervento e il controllo governativo. Era il governo, infatti, che periodicamente promulgava delle tariffe di calmiere cui i "pistori" dovevano attenersi per la vendita del pane. Inoltre, in particolari momenti di difficoltà, il senato poteva decidere d'immettere sul mercato le granaglie depositate in appositi magazzini per gli equipaggi della flotta allo scopo di agire sul lato dell'offerta e calmierare i prezzi. Occorre rilevare che, a differenza di altre situazioni, a Venezia il problema del vettovagliamento fu trattato con una certa efficienza; efficienza che evitò l'insorgere di gravi tumulti di carattere annonario. Il ruolo di capitale politica di un vasto Stato permise alla città di convogliare verso di sé, più o meno forzatamente, grani dalle diverse aree della Repubblica; la crescente espansione della proprietà veneziana nelle campagne venete favorì questo movimento; la posizione nel sistema commerciale internazionale permise ulteriori opportunità di rifornimento; i meccanismi tariffari, poi, consentirono da un lato di smussare l'incidenza delle crisi annonarie, assicurando nel medio periodo margini di profitto ai "pistori", e dall'altro di salvaguardare gli interessi dei mercanti di grano e la rendita fondiaria a favore del patriziato lagunare, soprattutto durante i periodi di prezzi bassi. I prezzi cerealicoli, dunque, dovrebbero essere considerati come la risultante di un complesso di fattori politici ed economici che complicano il confronto tra domanda e offerta.
L'andamento generale del prezzo del grano, comunque, non manifestò particolari differenze rispetto alla tendenza di altri mercati, sia veneti che dell'Italia settentrionale. Da notare, piuttosto, come il Graf. 1 evidenzi, nel periodo considerato, un'onda che addolcisce i picchi registrati in altre situazioni. In questo caso, il carattere mediatorio del calmiere veneziano viene sottolineato dalla sua capacità di attenuare le brusche impennate dei prezzi cerealicoli, sottoposti ai capricci delle stagioni. A Vicenza, di contro, durante la drammatica congiuntura del 1648 la popolazione urbana si rivoltò a causa dell'assenza di un controllo annonario e delle incette di mercanti che preferivano inviare i grani sul mercato realtino (28). Mentre nella città berica la tensione era cresciuta a seguito delle continue notizie di "estrationi" di cereali verso la capitale, a Venezia gli arrivi di granaglie dalla Terraferma contribuivano ad attutire l'impatto della crisi annonaria. Se confrontiamo i prezzi unitari del grano, esposti nella Tab. 4, questa favorevole posizione di Venezia deve essere riesaminata.
Salvo che nel caso di S. Vito al Tagliamento, dove per motivi che ci sfuggono le quotazioni tra gli anni 1630 e 1640 raggiunsero punte assai elevate, i cittadini veneziani pagavano un prezzo maggiore che nelle piazze del Dominio. È assai verosimile che in genere il costo della vita nella capitale fosse più alto che nella Terraferma. Non solo la pressione esercitata dalla domanda e la qualità superiore dei grani richiesti sul mercato veneziano incidevano sul prezzo, ma è anche probabile che fosse mantenuto artificialmente su quotazioni elevate per convogliare in città grani dall'entroterra. In effetti, la maggior remunerazione che i mercanti di grano di Terraferma potevano ottenere a Venezia attirava i carichi a detrimento dei mercati locali. Questo flusso, inoltre, non veniva frenato dai costi di trasporto, che generalmente costituivano uno dei maggiori elementi della formazione del prezzo, poiché il sistema fluviale che si sviluppava nel Veneto permetteva ai barconi di raggiungere agevolmente la laguna a costi contenuti. Nel quadro del sistema policentrico di approvvigionamento granario, dunque, Venezia giocava un ruolo assai importante: i suoi prezzi relativi più elevati attiravano i grani dalle zone più prossime alla laguna, vale a dire da quelle aree dove la presenza della proprietà fondiaria veneziana era consistente e l'autorità del governo era più pressante, e nello stesso tempo la capitale, importando derrate dai mercati del Mediterraneo orientale e del Mezzogiorno italiano, poteva ridistribuire una parte delle granaglie meno pregiate verso i centri della Terraferma (29). Nonostante il contributo delle campagne della Terraferma ai rifornimenti di Venezia fosse sensibilmente aumentato dalla fine del Cinquecento, i rapporti con le aree di produzione mediterranea non cessarono. La Repubblica, ad esempio, importò direttamente dal porto di Barletta 30.680 tomoli di grano e orzo negli anni 1657-1668, per non parlare dei rifornimenti privati che giungevano sul mercato realtino. Ed è altresì verosimile che continuassero, benché ridotti, i commerci granari con la Sicilia. Vi sono indizi, d'altro canto, che fanno ritenere che un altro tradizionale porto d'imbarco di grani per Venezia, Senigallia, abbia perso molta importanza nel Seicento (30). I piani che si intersecano, dunque, sono diversi: Venezia si trova al crocevia di flussi a breve e lunga distanza che ne fanno, ancora nel Seicento, un centro rilevante del commercio granario. Ciò che più importa rilevare, ad ogni modo, è che la Signoria sembrerebbe dipendere assai meno dagli scambi granari internazionali rispetto al secolo precedente e svolgere un ruolo rilevante come centro di consumo per la produzione del Veneto orientale e probabilmente del Friuli occidentale (31).
Accanto al grano l'altro elemento fondamentale della dieta di una persona dell'età preindustriale era il vino. Esso forniva un considerevole apporto calorico e costituiva uno dei generi più presenti nella vita quotidiana a Venezia. Una stima del 1730 attribuiva un consumo giornaliero di litri 1,34 per ciascun maschio adulto (32), e poco più di un litro in media (vale a dire 4 ettolitri all'anno) considerando le altre componenti per età e sesso (bambini, anziani, donne). Un livello piuttosto elevato, invero, se teniamo presente che a Madrid tra Sei e Settecento il consumo medio era attorno ai 65 litri annui e che nella Parigi prerivoluzionaria si calcolava un fabbisogno di un centinaio di litri; ma è un livello, quello veneziano, che risulta assai vicino alla quantità consumata dagli studenti del Collegio Borromeo di Pavia agli inizi del Seicento, e non molto superiore alla razione giornaliera di un operaio edile qualificato nella Genova del secondo Seicento (33). Un consumo giornaliero di poco più di un litro pro capite, ad ogni modo, corrisponderebbe - per una Venezia di 120.000 abitanti - ad un fabbisogno annuo complessivo di 481.800 ettolitri: una quantità enorme. Questo dato ci propone tuttavia un'immagine statica della domanda urbana di vino; consumo, questo, che invece è legato ad almeno due variabili, alla struttura della popolazione, anzitutto, e all'andamento dei prezzi dei cereali. La domanda di vino, data la sua relativa elasticità, dipendeva infatti dalla disponibilità della quota di reddito non impiegata nell'acquisto di cereali. Ad un innalzamento del prezzo del grano, quindi, corrispondeva una diminuzione del consumo di vino. Questo meccanismo comunque, come mostra la Tab. 5, non è sempre automatico: poteva accadere che la concomitanza di un cattivo raccolto sia di grano che di vino facesse innalzare i prezzi di entrambi. Il dati sul vino sottoposto al dazio, ad ogni modo, dimostrano che giungevano a Venezia cospicue quantità di vino. Anche in questo caso, come per il grano, è probabile che solo una parte della produzione dell'intero Dominio di Terraferma fosse convogliata verso la capitale. Il Veronese e il Bresciano, ad esempio, rifornivano i carri destinati alla Germania, mentre i Veneziani preferivano i vini romagnoli e pugliesi giunti via mare (34).
Gli andamenti delineati dalla Tab. 5 non sembrano sempre chiari. A fronte di una certa stabilità della popolazione nel secondo Seicento si rileva viceversa una netta diminuzione della quantità di vino transitato per i posti di controllo daziario, mentre il prezzo del grano segna variazioni sensibili, soprattutto durante la grave congiuntura cerealicola dei primi anni Novanta. Il secondo e terzo decennio del Settecento, d'altro canto, sono segnati da una crescita della quantità di vino sia in presenza di un netto rialzo del prezzo del grano che in un periodo di diminuzione. È assai difficile trarre qualche conclusione valida per tutto il periodo considerato; tanto più che i dati relativi al vino provengono da una fonte fiscale, che se appare affidabile per delineare l'andamento di lungo periodo del consumo e del commercio del vino a Venezia lascia ampio margine, viceversa, alla quota di prodotto contrabbandato e sfuggito ai controlli dei ministri del dazio. In base alla nostra serie, infatti, si potrebbe ritenere che il consumo pro capite di vino tra i Veneziani fosse diminuito da quasi 3 ettolitri nel 1642 a quasi 2 nel 1696. Tuttavia è lecito supporre che una cospicua quantità di prodotto - tra il 30 e 50 per cento? - non venisse tassata. Un'ulteriore complicazione è data dal fatto che i mercati d'approvvigionamento vinicolo di Venezia erano numerosi, e quindi anche i prezzi dipendevano dalle diverse annate. Vini dal Mediterraneo orientale, dal Mezzogiorno d'Italia, dalla Romagna e dalla Terraferma veneta erano sottoposti a differenti congiunture e pertanto sarebbe arbitrario individuare nel prezzo di una sola qualità di vino una variabile che influenzi sensibilmente la serie esposta nella Tab. 5.
Un altro prodotto il cui consumo era rilevante a Venezia è l'olio d'oliva. Nel Cinquecento la principale area di rifornimento era costituita dalle Puglie, dai cui porti salpavano ogni anno decine d'imbarcazioni per raggiungere lo scalo veneziano. Qui, il prodotto - come mostra la Tab. 6 - veniva in parte riesportato verso la Terraferma ed i mercati dell'Europa centrale ed era in parte consumato in città tramite le rivendite (le poste) sia per l'alimentazione che, soprattutto, per i saponifici e la lavorazione delle lane (35). L'olio d'oliva del Mezzogiorno d'Italia, infatti, era particolarmente richiesto dai consumatori per la sua purezza, perché migliorava la qualità del sapone e contribuiva a mantenere elevata la qualità dei tessuti di lana prodotti a Venezia.
L'andamento dei dati, tratti da fonti fiscali, denuncia un tendenziale declino, sia per quanto riguarda i consumi in città che per il settore manifatturiero, che era entrato in una fase negativa già da parecchi anni. L'incremento dell'imposizione fiscale sul prodotto decretato nel 1625 causò una contrazione del consumo interno con gravi ripercussioni sull'intero mercato oleario. È interessante notare, piuttosto, come in Terraferma il consumo di olio transitato da Venezia cresca in proporzione rispetto alla capitale. Se tra gli anni Cinquanta e Sessanta Venezia assorbiva il 48-52 per cento dell'olio importato, pochi decenni dopo la percentuale scendeva attorno al 45 per cento. Anche se occorre tener sempre presente il diffuso fenomeno del contrabbando, i dati ufficiali starebbero ad indicare che la domanda della Terraferma manteneva una certa vivacità a fronte di una diminuzione, o perlomeno di una stagnazione, di quella veneziana. La diminuzione veneziana del consumo d'olio viene ulteriormente sottolineata se consideriamo altri Paesi. Mentre i carichi d'olio che giungevano a Venezia non tendevano ad aumentare, a Londra, viceversa, le importazioni olearie conoscevano un netto incremento: il valore del prodotto venne stimato a 22.000 sterline nel 1622, una media di 37.000 negli anni 1634 e 1640, mentre s'impennò sino a 151.000 sterline in media negli anni 1663 e 1669, per stabilirsi a 105.000 nel periodo 1699-1701. In termini quantitativi, le importazioni furono di 3.037 tonnellate nel 1663 e di 5.081 nel 1669 (36). La traiettoria segnata dall'olio d'oliva, prodotto fondamentale per la lavorazione dei tessuti e dei saponi, potrebbe essere presa a modello dell'andamento dell'economia veneziana. Dagli anni Venti del Seicento il commercio dell'olio, al centro di scambi e di produzioni, passò gradualmente in mano degli Inglesi a scapito dei mercanti veneziani (37). Le importazioni lagunari dalla Puglia diminuirono e dalla fine del secolo crebbe la percentuale di prodotto importata dalle isole dello Stato da mar. La Signoria, così, ricercava nelle proprie risorse la possibilità di limitare le perdite che i "nordici" stavano infliggendo alle attività commerciali e manifatturiere dello Stato. Se la capitale continuava a detenere un ruolo di prim'ordine come centro di consumo, nei settori produttivo e distributivo era costretta a ridimensionarsi sotto la spinta di forze esterne, troppo potenti perché potesse contrastarle con speranza di successo.
3. Una città che produce
Una delle caratteristiche più rimarchevoli della Venezia cinquecentesca fu la sua trasformazione in centro industriale, tra i più rilevanti nell'Europa d'allora (38). Si trattava di lavorazioni per lo più destinate all'esportazione (pannilana, sete, vetri, sapone, stampe), che attiravano manodopera dall'esterno e che sostenevano i tradizionali commerci marittimi dei Veneziani. Manifatture e mercatura costituirono così una felice simbiosi che fu alla base della prosperità veneziana sino ai primi anni del Seicento. In seguito, la città avrebbe mutato nuovamente volto, pur mantenendo ancora aree destinate alla produzione.
La curva delle vicende industriali della città è stata tracciata, ed ha assunto un valore emblematico, dall'andamento della produzione di pannilana e di tessuti serici. La Tab. 7 mostra la parabola dagli inizi del Seicento sino ai primi del Settecento.
La netta discesa della produzione laniera risulta evidente, tanto che - è stato affermato - "il crollo del mercato laniero fu il più grave colpo subito dall'economia veneziana nel corso del Seicento" (39). Ed in effetti è innegabile che quello che fu il settore trainante della manifattura cinquecentesca conobbe dal secondo decennio del Seicento un inarrestabile declino. Se nel 1607 si potevano contare 1.032 capimaestri tessitori (dei quali 624 occupati), a metà secolo il numero totale era sceso a 730 (con solo 180 occupati); e ancora nel 1716 vi erano appena 27 occupati a fronte di 105 capimaestri inoperosi. Anche per quanto riguarda il numero dei telai operativi i segni della crisi sono evidenti: 258 nel 1630, ma il numero risale successivamente alla peste sino a 292 nel 1644; si scende a 160 nel 1656, 119 nel 1661, 102 nel 1676, 96 verso il 1698, e addirittura si precipita a 33 nel 1716 (40). Oramai la lavorazione della lana era divenuta un'attività marginale nella Venezia del giovane Vivaldi.
Eppure il Cinquecento aveva visto la produzione della città lagunare procedere in controtendenza, almeno per certi versi, rispetto ai maggiori centri manifatturieri della Penisola. A Firenze i livelli produttivi avevano raggiunto l'apice di 30.000 pezze di media annua nel periodo 1560-1572, ma già nel ventennio a cavallo tra Cinque e Seicento si erano portati attorno a 13.000, diminuendo a 6.200 negli anni 1630-1645, sino a toccare il fondo di 1.590 pezze nel 1717-1724. I telai da lana battenti nella città sull'Arno erano passati da 1.420 nel 1604 a 782 venticinque anni dopo e ad appena 224 nel 1684 (41).
Le lane fiorentine avevano rappresentato, almeno verso la metà del Cinquecento, un serio concorrente per quelle veneziane nei mercati levantini; ma successivamente pare che la capacità produttiva e di adeguamento della produzione lagunare avesse avuto la meglio. Certo è, comunque, che la parabola del lanificio fiorentino manifestò una caduta anticipata rispetto all'andamento veneziano. Per quanto riguarda lo Stato di Milano, pur non avendo a disposizione serie continue di dati sull'esempio veneziano e fiorentino, è altresì chiaro che il Seicento vide una drammatica diminuzione della produzione laniera in ambiente urbano (42). Anche Venezia, ad ogni modo, partecipò del generale declino della manifattura laniera dell'Italia centro-settentrionale lungo il Seicento. Se quest'affermazione è inoppugnabile, il drastico giudizio dovrebbe essere soppesato prendendo in considerazione, oltre alla produzione fisica, anche quella in termini di valore monetario. Purtroppo non disponiamo di una serie dei prezzi dei pannilana a Venezia, ma osservando i dati relativi al mercato di Milano si nota che il prezzo dei panni alti si mantenne su quotazioni piuttosto elevate sino agli anni Trenta del Seicento, per poi diminuire notevolmente in seguito. Sebbene sia ardito sovrapporre il trend dei prezzi milanesi a quello ipotizzabile per Venezia, ciononostante è opportuno chiedersi se la caduta quantitativa del lanificio lagunare non possa essere stata in parte controbilanciata da ricavi maggiori (43).
Giova inoltre chiedersi in che termini il declino della produzione laniera a Venezia fosse collegato con i diversi mercati, locale e internazionale. È noto che la gran parte dei pannilana veneziani era diretta verso i mercati orientali (44): infatti una delle cause della crisi - come vedremo - è rintracciabile nel mutamento della domanda levantina a favore dei concorrenti "nordici". Ora, è interessante verificare se in concomitanza con l'attenuarsi della domanda estera si sia verificato uno spostamento verso il mercato interno. Allo scopo di valutare la relazione tra domanda interna e produzione laniera abbiamo preso in esame l'andamento dei prezzi del grano in città (Graffi. 2 e 3). La scelta di presentare i dati in due grafici è stata resa necessaria dalla diversa natura delle fonti. Per quanto riguarda i prezzi cerealicoli, infatti, il Graf. 1 si basa sulle quotazioni di calmiere disponibili, mentre il Graf. 2 è stato costruito considerando il prezzo medio annuale d'acquisto dei grani da parte del governo; si tratta, dunque, di un prezzo che è significativo per la tendenza ma che non può essere affiancato ai prezzi di mercato. L'analisi del rapporto tra prezzi cerealicoli e produzione risulta utile in quanto è generalmente riconosciuto che al variare del prezzo dei primi, essendo la domanda anelastica, corrisponde un mutamento anche nella domanda di prodotti non di prima necessità, in questo caso i pannilana. Un incremento del prezzo del grano sottraeva a gran parte della popolazione quote di reddito che potevano essere impiegate nell'acquisto di beni e servizi; la domanda di pannilana sarebbe caduta e di conseguenza anche la produzione avrebbe conosciuto un momento depressivo, sinché un buon raccolto non avesse provocato un abbassamento dei prezzi cerealicoli, ridando così ossigeno ai consumi e stimolando la produzione (45). Questo modello, comunque, necessita di ulteriori precisazioni ed elementi per poter essere applicato al caso veneziano. Poiché la manifattura dei pannilana - come si è già ricordato - si rivolgeva principalmente ai mercati esteri, l'influenza delle congiunture dei prezzi alimentari dovrebbe essere assai ridotta. Il meccanismo del calmiere veneziano, inoltre, visto che tendeva a smussare le impennate dei prezzi del grano e a mitigarne gli effetti, potrebbe offuscare la correlazione temporale tra congiuntura dei prezzi e produzione manifatturiera. Analizzando il Graf. 2 si nota che perlomeno sino ai primi anni Trenta è possibile individuare la classica relazione inversa tra prezzi e produzione tessile: ad una crescita dei primi corrisponde una diminuzione della seconda. Tuttavia occorre considerare che la peste del 1630 ebbe un effetto drammatico su tutto il tessuto economico veneziano, e che pertanto la brusca caduta della produzione fu dovuta soprattutto alle difficoltà di trovare maestranze e di far salpare le navi. Tra la metà degli anni Trenta e il 1646 le curve mostrano un certo parallelismo, con una tendenziale stagnazione dei pannilana. Il declino produttivo è evidenziato anche nel Graf. 3 che, a fronte di marcate oscillazioni dei prezzi cerealicoli, mostra una contrazione dell'attività legata ai pannilana alti. Il confronto tra le due curve, insomma, porterebbe ad escludere una significativa influenza della domanda interna sulle dinamiche del comparto laniero veneziano. Vediamo, per trovare un'ulteriore verifica, di focalizzare una congiuntura particolarmente difficile, quella dei primi anni Novanta, caratterizzata un po' ovunque da crisi annonarie e difficoltà produttive. Nella Tab. 8 vengono prese in esame le medie annuali dei prezzi del grano e della produzione di pannilana.
I dati della Tab. 8 confermano che la congiuntura di breve periodo dei prezzi alimentari non influenzò le vicende della manifattura laniera veneziana e veneta in generale. Anzi, nel caso veneziano ad una impennata del prezzo del grano nei primi anni Novanta corrispose una ripresa produttiva ed un dinamismo che risultarono superiori anche alla produzione padovana e veronese. Sembra proprio, dunque, che ancora nella fase declinante e depressiva della produzione laniera il mercato interno non abbia svolto un ruolo degno di rilievo. Ciò solleva vari problemi. Anzitutto occorre chiedersi le ragioni di questa sorta di assenza dei consumatori veneziani: eccessivi costi del prodotto per le tasche dei Veneziani? Stoffe che non soddisfacevano i loro gusti? Limiti del mercato locale? Certo è che la destinazione dei pannilana veneziani verso i mercati esteri fu una costante secolare, nonostante l'avvicendarsi delle congiunture. Questa vocazione permise da un lato di evitare la crisi degli anni Novanta, per esempio, ma dall'altro ancorò le scelte produttive ad un mercato che lungo il Seicento si stava sempre più restringendo per i tessuti veneziani.
Ma non si trattava solamente degli sbocchi per i panni alti veneziani, altrimenti non si spiegherebbero casi che, nel medesimo periodo, registrarono una crescita della produzione laniera. La curva produttiva di Padova, ad esempio, mostra una marcata ascesa dalla metà del secolo sino ai primi anni del Settecento; analogamente, i livelli produttivi nel Bergamasco raddoppiarono nei decenni a cavallo tra Sei e Settecento (46). Sebbene le difficoltà delle manifatture laniere venete sin oltre metà Seicento siano innegabili, è nondimeno importante sottolineare che, in definitiva, il sistema produttivo veneto conobbe una profonda fase di riassetto, che vide diminuire fortemente il peso assoluto e relativo del lanificio veneziano e crescere, di converso, la produzione dislocata nella Terraferma, specie nei distretti rurali. Basti considerare che nel 1687 - vale a dire in un momento in cui il processo di trasformazione era già stato avviato - la quota della produzione veneziana di panni alti tradizionali si aggirava attorno al 18 per cento del totale dello Stato, e che nel 1710 la percentuale era scesa ulteriormente al 10 per cento (47).
Assieme alla lavorazione della lana vennero coinvolti nel declino altri settori produttivi, sebbene le modalità, i tempi e le circostanze fossero in qualche maniera differenti rispetto alla produzione principale della città. Il saponificio, in base ai dati a disposizione, presenterebbe un'analoga parabola, benché il punto di declino sembri ritardato rispetto al lanificio.
Nelle redecime (documenti che raccoglievano le dichiarazioni fiscali dei contribuenti veneziani) del 1537 e 1582 figuravano rispettivamente 11 e 16 saponerie (48); agli inizi del Seicento ce n'erano 17, nel 1625 il loro numero era cresciuto a 30, ma tra Sei e Settecento rimanevano appena 6-8 botteghe per la fabbrica del sapone (49). La produzione, inoltre, si ridusse lungo il secolo, passando dai 13 milioni di libbre degli inizi ad appena 3 milioni verso la fine del secolo (50). Nel 1627 si affermava che le caldaie adibite al saponificio erano diminuite dalle 39 del passato ad appena 20 (51). L'andamento del numero di caldaie nel Seicento fu il seguente:
Se la produzione subì una diminuzione rispetto ai livelli raggiunti nel Cinquecento, è altresì vero che lungo il Seicento l'attività - almeno in base al numero di caldaie presenti a Venezia - non accusò gravi segni di cedimento, manifestando una certa tenuta nonostante la drastica diminuzione registrata nel 1677.
Un settore che invece conobbe una significativa crescita fu quello relativo alla produzione di tessuti auroserici, broccati e damaschi (Tab. 7), nel quale l'Italia settentrionale raggiunse una posizione di primo piano, a ridosso di Lione, sui mercati europei seicenteschi. A differenza dei comuni drappi di seta, le cui vicende commerciali furono alterne, ma che comunque in genere tesero al declino o alla stagnazione, le sete impreziosite d'oro conobbero un clamoroso successo tra i ceti agiati d'Europa (52). Contrariamente a quanto fece Firenze, che puntò su prodotti poco costosi per soddisfare la domanda inglese (53), a Venezia si scelse di privilegiare la domanda di mercati - Germania e Levante - che richiedevano sete sempre più lussuose. Ciò si riflesse sui livelli produttivi, che diminuirono quanto alle comuni sete e invece aumentarono per quanto riguardava i drappi auroserici. "La manufacture des estoffes de soye d'or et d'argent", riferiva il console francese Le Blond nel 1681, "se maintient toujours" (54). A confermare la discreta situazione della seteria veneziana ci sono alcune informazioni tratte da un'inchiesta promossa dal governo nel 1685. In base alle notizie raccolte da Michiel Foscarini, a Venezia si trovavano 1.086 maestri tessitori, 2.626 telai e 463 lavoranti. Sebbene questi dati non siano del tutto attendibili - sorprende il basso numero di lavoranti in rapporto ai maestri, per esempio - essi lasciano intendere che l'attività legata alla lavorazione della seta coinvolgeva un discreto numero di cittadini. Certo, l'affermazione che indicava in 40.000 persone il numero di Veneziani che nel 1672 era mantenuto dall'attività serica appare senza dubbio esagerata (55), tuttavia è senz'altro indicativa di un mutamento che era avvenuto allorché la seta aveva soppiantato la lana nelle botteghe e negli opifici della città. Lo stato attuale degli studi non consente di proporre fondate argomentazioni circa le cause di questo spostamento ma, analogamente ad altri casi (56), è presumibile che il comparto serico - e specie quello di alta qualità - abbia attratto una parte di quei capitali che non trovavano più impiego nel lanificio; capitali non solo di provenienza locale, ma giunti anche da Firenze (57). La pressione esercitata dalla concorrenza nordica nel settore laniero e la crescente domanda di tessuti serici potrebbero aver indotto gli operatori veneziani a privilegiare le attenzioni sul comparto serico ad alto valore. È presumibile, inoltre, che la crescente disponibilità di seta grezza fornita dalla Terraferma e dal Levante abbia facilitato il trasferimento ad un settore che offriva allettanti opportunità di profitto (58). Gettando uno sguardo verso la Terraferma, infatti, si rileva che lungo il Seicento le campagne videro fiorire la gelsicoltura e la produzione di seta grezza, destinata in parte ai mercati esteri. Tra gli anni Sessanta e Novanta del Seicento, per esempio, il gettito del dazio sulla seta nel Bergamasco s'incrementò di quasi tre volte, a dimostrazione dell'importanza crescente del settore (59); la produzione di seta grezza, poi, interessò lungo il Sei-Settecento l'economia della Valpolicella (60). Il commercio della seta, in effetti, costituì una delle grandi vie per l'affermazione economica e sociale nella Venezia seicentesca. Il livello di accumulazione di capitale appare impressionante. Alberto Gozzi (1579-1664), uno dei più eminenti mercanti di Venezia, costruì un ingente patrimonio partendo come semplice mercante di seta e raggiungendo al termine della sua vita l'apice della piramide economica e sociale veneziana (61). La sua ascesa fu suggellata dall'acquisto della nobiltà veneziana, offerta in seguito all'esborso di 100.000 ducati per le necessità della guerra di Candia. Gozzi non rappresentò certo l'unico caso particolarmente fortunato di mercante di seta: tra le 128 famiglie che acquisirono il titolo nobiliare negli anni 1646-1718, almeno 10 appartenevano specificatamente al mondo della mercatura serica, su un totale di 73 famiglie mercantili; 5 di esse provenivano da Bergamo, ma è assai plausibile che la loro ricchezza si fosse formata nella città lagunare (62).
Il caso della seta ci spinge a porre il quesito se nella Repubblica veneta del Seicento si possa individuare una sorta di economia regionale, dove emerga una certa divisione e specializzazione di funzioni tra le diverse aree e dove si possano individuare un relativo coordinamento ed un meccanismo di reciprocità nello scambio di beni e servizi all'interno dello Stato o, meglio, della regione o subregione. Il problema non è certo semplice, e sarebbe necessario prendere in considerazione il maggior numero di elementi possibile (trasporti, struttura daziaria, rapporti istituzionali, allocazione di risorse, struttura dei mercati, dati quantitativi...) per giungere ad un chiarimento della questione. Studi recenti hanno posto in evidenza i notevoli limiti che ha dimostrato il processo di formazione di un'economia regionale nella Repubblica (63), tuttavia le vicende seicentesche della seta mostrano che una tendenza - sebbene non sempre coscientemente guidata - verso una diversificazione e specializzazione è ravvisabile. Mentre Venezia si riservò la produzione di damaschi e broccati, merci ad alto contenuto di valore aggiunto e destinate ad un mercato d'élite, nella Terraferma le campagne fornivano la materia prima e ci si limitava alle fasi iniziali della lavorazione, e in alcune città ci si dedicava alla filatura e alla commercializzazione del prodotto verso i mercati esteri. Questo quadro, comunque, dovrebbe apparire più sfumato: spesso l'interscambio tra città e campagna è assai più complesso, in termini di flussi sia di prodotto che di capitale, e lo sviluppo di una produzione non sempre implica il completo abbandono di un'altra; inoltre, i mercanti nei distretti rurali dimostrarono una vivace capacità di esitare la seta - grezza o semilavorata - anche senza l'intervento di intermediari urbani. Ciò che interessa rilevare è che le difficoltà della manifattura serica veneziana di tessuti di media qualità furono in parte provocate dalla crescente produzione nel Dominio. L'allocazione della produzione di materia prima e delle fasi preliminari della lavorazione in campagna fecero abbassare i costi di produzione, rendendo i panni della Terraferma assai competitivi; a ciò si aggiunse una certa facilità ad accedere ai mercati dell'Europa centrale, specie per le sete del Vicentino. Questo quadro, ad ogni modo, non rimarrà statico: nel secolo successivo, infatti, a Venezia le attività connesse al setificio torneranno a svilupparsi nella lavorazione di tessuti di bassa e media qualità, coinvolgendo alcune migliaia di lavoranti e tessitori.
Accanto alle manifatture della lana e della seta, l'altro grande settore che aveva caratterizzato l'economia urbana veneziana era stato l'editoria. Fiore all'occhiello della città nel Cinquecento, centro nevralgico della stampa europea, l'industria del libro dalla fine del Cinquecento aveva conosciuto i preoccupanti segni della crisi e verso la metà del secolo successivo toccò il punto più basso del declino (64). La Tab. 10 fornisce, in sintesi, le cifre dell'andamento del comparto.
I dati evidenziano una tendenza declinante sino ai decenni centrali del Seicento, allorché si ricordavano i tempi felici in cui erano in attività oltre 120 torchi a fronte degli appena 20 del 1660 (65), mentre indicano che in seguito si verificò una certa ripresa. La crescente concorrenza estera, specie francese e fiamminga, la crisi commerciale, il peggioramento della qualità e, non ultimi, i rigori della Controriforma avevano messo in crisi librai e stampatori veneziani. La congiuntura del 1630 inferse il colpo di grazia all'attività della stampa, che comunque registrò segni in senso positivo verso l'ultimo quarto del Seicento. Approfittando delle difficoltà dei centri concorrenti di Anversa e Lione, l'editoria veneziana seppe conquistare quote di mercato in Italia e nella penisola Iberica. La via di penetrazione fu costituita dai testi di carattere religioso ed ecclesiastico, breviari e messali giudicati di eccellente qualità, che erano assai richiesti e che garantivano una buona redditività (66). La crescita di questo comparto è dimostrata dai dati della Tab. 11, che pone a confronto il numero di edizioni di breviari stampati a Venezia, Anversa e Parigi.
Che vi fosse una ripresa generale dell'editoria veneziana verso il tramonto del Seicento è altresì confermato dal numero di licenze di stampa concesse dai riformatori dello Studio di Padova: se nel periodo 1609-1622 la media annua era stata di 32 titoli, negli anni 1673-1680 il livello crebbe a 54, e ad almeno 60 (in base ad una stima su dati incompleti) tra il 1686 e il 1701 (67). La florida situazione del primo Settecento è testimoniata anche, a livello microanalitico, dalla netta progressione degli utili di Giovanni Manfré, agente libraio operante a Venezia a nome della stamperia del Seminario di Padova. Ebbene, posti pari a 100 gli utili medi annui del periodo 1700-1704, nel quinquennio successivo l'indice crebbe a 185, quindi raggiunse 318 negli anni 1710-1714, per poi arrivare a 375 nel 1715-1719. L'incremento medio annuo dei profitti a favore di Manfré fu del 22 per cento tra il 1700 e il 1722 (68). Si trattò di un caso unico di fortuna imprenditoriale o piuttosto è da ritenersi un esempio di una atmosfera generale? Sarebbe difficile, in effetti, sostenere che Manfré agisse in un contesto di depressione del settore. Tra fine Sei e inizi Settecento - ha scritto Mario Infelise - a Venezia si realizzò "lo sfruttamento più intenso di sistemi produttivi e commerciali non del tutto sconosciuti, ma scarsamente o diversamente utilizzati nel passato, i quali contribuirono al rafforzamento delle nuove aziende" (69). La risposta delle Corporazioni legate al libro durante la grave congiuntura dei decenni successivi alla peste fu una riorganizzazione del sistema produttivo (70). La classica gerarchia costituita da maestro, lavorante e garzone perse le proprie rigide connotazioni; le norme che regolavano l'assunzione e la promozione dei garzoni e dei lavoranti furono superate di fatto a favore dell'immissione di persone che recassero capitali freschi da immettere nei meccanismi produttivi. I vincoli corporativi, così, si allentarono di fronte alle esigenze del mercato e dei maestri, che poterono controllare con una certa discrezionalità l'assunzione dei praticanti e i loro salari. Il segno di questo mutamento emerse agli inizi del Settecento, allorché a Venezia operavano stampatori-librai nonostante la normativa delle Corporazioni impedisse l'esercizio di entrambe le professioni da parte di una sola persona. Il dinamismo dei maestri nella ricerca di capitali e nell'assunzione di dipendenti estranei alla Corporazione e la riduzione dei lavoranti e garzoni a forza-lavoro con scarse prospettive di promozione permisero alla stampa e all'editoria veneziane di vivere una favorevole stagione tra Sei e Settecento, pur nel quadro di un sistema corporativo formalmente rigido.
Mentre sinora abbiamo preso in considerazione attività produttive legate quasi esclusivamente alla domanda esterna, è opportuno volgere lo sguardo, pur rapido, ad uno dei settori che hanno caratterizzato il volto urbano di Venezia, l'edilizia. Nonostante questo comparto rivesta una notevole importanza per i suoi effetti moltiplicatori in un sistema economico, si deve constatare che ben pochi studi si sono soffermati sugli aspetti economici delle costruzioni, sia pubbliche che private, nella Venezia moderna. Il problema, sino a pochi anni or sono, era stato quello di porre in rapporto la congiuntura economica generale e l'andamento delle costruzioni: vi era chi affermava come vi fosse una relazione diretta tra la prima e l'attività edilizia e chi, invece, non era convinto delle prove addotte. Problema insolubile, giacché i motivi che sottendono lo sviluppo o meno dell'edilizia investono, ovviamente, tanto la disponibilità di capitali quanto il sistema di valori, sia laici che religiosi, che innerva una società. Sarebbe facile sottolineare come, in base ai dati sinora conosciuti e comunque non completi, nella Venezia seicentesca il settore edilizio conobbe una fase di depressione rispetto ai fasti rinascimentali e alla ripresa del secolo illuminista. Se nel periodo 1539-1549 furono concesse 175 licenze per nuove costruzioni private, infatti, nel 1621-1632 ne furono accordate 157 e nel 1678 non venne innalzato alcun edificio, mentre muratori e falegnami tornarono a lavorare negli anni 1754-1760 attorno a 19 nuovi cantieri (71). Nel Cinquecento si costruiva - è stato affermato - mentre nel secolo barocco ci si limitò a restaurare, per carenza di capitali (72). Certo, appare del tutto plausibile collocare nei decenni successivi alla peste del 1630 un certo rallentamento nelle nuove costruzioni dovuto alla stagnazione demografica, ma è altrettanto vero che, secondo le valutazioni di Emilio Sereni, il Sei-Settecento conobbe un forte impulso nell'erezione di ville in Terraferma. Delle ville d'interesse artistico censite nel Veneto, 257 vennero innalzate nel Cinquecento, 332 nel Seicento e 403 nel Settecento (73); le rilevazioni catastali relative ai soli contribuenti del sestiere di Cannaregio registrarono un incremento di "ville" possedute in Terraferma da 160 nel 1537 a 473 nel 1661 (74). È lecito ritenere, allora, che piuttosto che di carenza di capitali si debba parlare di una diversione dall'ambiente urbano, che - non dobbiamo dimenticare - era limitato nelle sue capacità espansive, a quello rurale, con varie implicazioni che vedremo in seguito.
Il Seicento a Venezia apparirebbe dunque un secolo di lavori edili minori: 386 furono le licenze di manutenzione, demolizione e restauro concesse tra il 1636 e il 1669, con una media di 11,3 all'anno (75). Ma anche lungo il Seicento, e specie dalla metà del secolo in poi è possibile individuare segni di espansione della superficie abitativa. In base alle rilevazioni catastali, il numero di abitazioni a Venezia passò da 24.392 nel 1661 a 26.524 nel 1712, con un incremento dell'8,7 per cento (76). Si ha l'impressione, inoltre, che si fosse diffusa, verso le aree liminari della città, un'edilizia minore, rappresentata da "casette" destinate alla residenza popolare, che sembrerebbe assumere per certi versi un carattere d'investimento speculativo (77). Ma ciò che caratterizzò le vicende edilizie della Venezia seicentesca fu lo sviluppo della celebrazione pubblica dei privati, che si manifestò concretamente nell'innalzamento o rifacimento di palazzi e nell'intervento su edifici di culto (78). Facciate di chiese, monumenti funerari, massicci e sontuosi edifici punteggiarono il volto urbano e si affiancarono alle costruzioni rinascimentali che davano lustro alla città. Ed è presumibile che un ulteriore impulso all'edilizia venne impresso da quelle famiglie che, approfittando della possibilità di acquistare il titolo di patrizio veneziano, si preoccuparono di manifestare il successo sociale con l'innalzamento di dimore consone al nuovo status e con il finanziamento di costruzioni celebrative.
Quale fu il movimento di capitali messo in atto da queste attività? Purtroppo, allo stato attuale, non siamo in grado di proporre stime soddisfacenti e comparabili con altre situazioni meglio conosciute (79); pertanto siamo costretti a fornire solo qualche dato sporadico e grossolano, che comunque riteniamo utile per tentare di valutare alcuni ordini di grandezza. Nel 1640 venne presentato un preventivo per la costruzione, dalle fondamenta sino al tetto, di alcune "case piccole" della comunità greca. L'estensore del documento, dopo aver calcolato il costo delle opere murarie, dei fabbri, tagliapietra, falegnami e finestrai, giunse al risultato di 10.968 ducati e 6 grossi (80). Una cifra non certo insignificante, che purtroppo non possiamo rapportare al volume che l'edificio avrebbe dovuto avere. Redigendo il proprio testamento nel 1643, l'avvocato Tommaso Flangini ricordò i 50.000 ducati che aveva sborsato per il palazzo - sostanzialmente ricostruito tra il 1638 e il 1640 - acquistato dai Contarini; e vent'anni dopo Girolamo Fini offrì 35.000 ducati per un palazzo sul Canal Grande a S. Maria Zobenigo costituito da due appartamenti (81). Si trattava, in questi casi, di famiglie che stavano conseguendo o erano in procinto di sancire il successo sociale entrando nella nobiltà veneziana. Era necessario pertanto investire in una degna dimora, nella spasmodica ricerca di eguagliare in sfarzo e nell'immaginario della città il livello del patriziato tradizionale. Lo sforzo celebrativo si orientò altresì verso i luoghi di culto; un fenomeno, questo, cui parteciparono numerosi e ricchi Veneziani, sia patrizi che borghesi. Nel 1648, ad esempio, il merciaio Giacomo Galli destinò l'enorme somma di 120.000 ducati da impiegarsi nella costruzione o restauro di tre chiese (82). La decorazione della facciata della chiesa di S. Moisè - stupefacente esempio di complessità barocca - protrattasi tra il 1668 e il 1689, fu finanziata da un lascito di 90.000 ducati da parte di Girolamo Fini (83). Se è lecito aspettarsi che tra i popolani arricchiti e i nuovi nobili vi fosse una tendenza alla spesa autocelebrativa, è altresì vero che anche i patrizi d'antico lignaggio non lesinarono denaro - seppur forse in minor quantità - nel commissionare busti, monumenti funebri e facciate di chiese. Vediamo alcuni casi tratti da testamenti dei dogi e dei loro familiari nel Seicento. Francesco Erizzo dispose, nel 1634, che circa 2.500 ducati fossero impiegati nell'erezione del suo monumento funebre. Andrea Contarini volle ornare la facciata della chiesa di S. Vitale con i busti del padre - che aveva portato il corno dogale - e della madre, devolvendo a tal scopo 10.000 ducati. 10 anni e 12.000 ducati furono necessari per il monumento funebre di Giovanni Pesaro, eretto a S. Maria Gloriosa dei Frari, chiesa particolarmente cara alla famiglia; mentre il bellicoso Francesco Morosini si accontentò di 7.000 ducati per il suo monumento a S. Stefano. E sempre per il proprio monumento, ai SS. Giovanni e Paolo, Silvestro Valier impegnò gli eredi per la somma di 4.000 ducati annui per 5 anni. La chiesa di S. Eustachio, invece, beneficiò di 20.000 ducati lasciati da Alvise II Mocenigo per il rifacimento del frontale (84).
Quali indicazioni trarre da questi sparsi indizi? L'impressione è che, in molti casi, la congiuntura economica negativa non abbia impedito l'impiego di grandi quantità di denaro in costruzioni di palazzi, abbellimenti, restauri, erezioni di monumenti e di sfarzose tombe. Al di là dell'indubbio significato ideologico e politico della celebrazione della casata, sul piano economico questa attività - talvolta febbrile - comportò un notevole movimento di capitali, di uomini e di materiali. Basti pensare al circuito mosso dalla costosa pietra d'Istria, il cui uso sembra essersi ancor più diffuso a Venezia dalla fine del Cinquecento per adeguarsi alla tendenza delle altre capitali, che giungeva semilavorata e che veniva rifinita nella laguna (85). Ma la funzione economica della residenza patrizia non si arresta al momento della sua costruzione: se è vero che il palazzo agisce come "moltiplicatore dei consumi nobiliari" (86), allora occorre considerare l'innalzamento di una dimora patrizia come un centro di spesa che continua nel tempo. Di fronte a numerosi settori che versavano in difficoltà, si può dedurre che quello edilizio abbia mantenuto una certa vivacità, assicurando altresì un ampio indotto costituito da trasporti, manodopera specializzata e lavorazione di materiali e prodotti per gli arredi.
Se nel corso del Seicento il comparto edile parve resistere discretamente alle difficoltà, il settore della cantieristica navale - orgoglio della Venezia rinascimentale - continuò a preoccupare le autorità. Il momento del declino si era manifestato nell'ultimo quarto del Cinquecento, allorché le navi inglesi e olandesi avevano dimostrato una evidente superiorità tecnica sulle imbarcazioni mediterranee, e veneziane in particolare. La forte concorrenza "nordica" aveva messo in crisi le costruzioni private, ed anche l'attività dell'Arsenale ne aveva risentito. La presenza di legni stranieri si fece vieppiù consistente lungo il Seicento. Nel 1606 su 27 navi di stazza superiore alle 360 tonnellate 14 risultavano di costruzione straniera; verso la fine del secolo, nel 1694, delle 55 navi a quattro alberi della flotta mercantile in attività 35 provenivano da cantieri esteri; e nel 1711 vennero conteggiate 31 unità di fabbricazione veneziana a fronte di 46 estere (87). Nel gennaio del 1646 correva voce che il governo veneziano avesse ordinato almeno 6 navi di costruzione olandese (88). La crisi si riflesse anche sul cantiere statale: la forza-lavoro effettivamente impiegata in Arsenale registrò una tendenziale diminuzione nello stesso periodo che vide l'inizio delle difficoltà provocate dai "nordici"; tuttavia dalla metà del Seicento i livelli si stabilizzarono, come risulta dalla Tab. 12.
Il totale di 856 lavoratori attivi nel tragico 1630 crebbe nei decenni successivi grazie alla ripresa demografica e alla forte domanda provocata dalla guerra di Candia (1645-1669); a fine secolo, poi, la forza-lavoro si aggirò tra le 1.200 e le 1.370 unità. In effetti lo scoppio del conflitto fece impennare in maniera drammatica la richiesta di imbarcazioni, di armi e materiali. La costruzione di galee sottili raggiunse un discreto successo, poiché i cantieri riuscirono ad armarne 149 negli anni di guerra, per non parlare dei legni più potenti (89). I significativi risultati conseguiti dall'Arsenale provano che in primo luogo la capacità produttiva dei cantieri statali non era diminuita rispetto al Cinquecento, nonostante il decremento della manodopera. Ciò implica che la produttività venne migliorata con una efficiente organizzazione delle fasi di lavoro (90). In secondo luogo, la crescita della produzione fu sostenuta anche dalla capacità di attivare diverse fonti d'approvvigionamento di materie prime, legname, metalli, canapa e pece anzitutto. Lo sforzo di convogliare materiali verso la laguna doveva essere realizzato in breve tempo e in accordo alle esigenze pressanti della macchina navale. Sforzo non da poco, sia per il sistema di rifornimento che per le aree produttive. Pur mancando di dati che s'inoltrino negli anni centrali della guerra, è tuttavia interessante analizzare l'andamento delle forniture di alcuni materiali impiegati in Arsenale sino al primo anno del conflitto (Tab. 13).
La quantità di materie prime necessarie all'Arsenale s'incrementò in misura spettacolare e stimolò la ricerca di nuove fonti di rifornimento. Non essendo sufficiente l'offerta di legname dello Stato, si fece ricorso al mercato estero; alla pece di Cattaro e Valona si affiancò quella prodotta in Friuli e Cadore (91). Ed anche per quanto riguarda la forza-lavoro, nel 1646 le porte dell'Arsenale vennero aperte a maestranze private (92). Non fu forse una coincidenza, poi, che la produzione di rame nella miniera dei Crotta in val Imperina aumentò sensibilmente all'inizio della guerra (93).
A parte la domanda di tipo militare, comunque, che svolse un importante stimolo alla produzione veneziana, la marineria commerciale oramai non era più in grado di competere con l'offerta straniera: i legni inglesi e olandesi si erano affermati per la loro maneggevolezza e potenza, e risultavano più convenienti rispetto ai legni veneziani. La crisi del settore armatoriale veniva considerata come il sintomo di un più vasto declino che aveva colpito la città lagunare; un declino legato anzitutto alla sua funzione d'intermediazione tra Oriente e Occidente, al ruolo tradizionale svolto dalle navi con il leone marciano sulle acque mediterranee. La diminuzione della flotta veneziana era il sintomo della decadenza dei commerci controllati dalla Serenissima, probabilmente il fenomeno che aveva maggiormente impressionato i contemporanei.
4. La distribuzione
Proverbiale, la funzione mercantile di Venezia: fonte secolare di ricchezza, potere e prestigio per la città intera. Una funzione che aveva indirizzato le scelte politiche dei governanti e che aveva rappresentato la principale preoccupazione dei Veneziani, fossero essi nobili o semplici cittadini. Dai traffici la città traeva il proprio sostentamento e cresceva in ricchezza: era stato un convincimento inoppugnabile e nello stesso tempo denso di significato. La mercatura ammantava quasi con un'aura di leggenda la storia veneziana; aveva segnato il carattere e forgiato gli animi e gli atteggiamenti dei Veneziani. Ora, nel Seicento, nonostante ancora alcuni di essi fossero tenacemente abbarbicati a quel mondo, il grande commercio internazionale non appariva più come la spina dorsale della città, della sua economia, della sua stessa vita. La realtà era che altre potenze, altri uomini, altri spiriti avevano sostituito i mercanti di Venezia negli scali tradizionali d'Oriente e controllavano le rotte mediterranee ed oceaniche.
La congiuntura commerciale del primo Seicento aveva colpito duramente gli interessi veneziani negli scali orientali. In base alle osservazioni di viaggiatori e dei consoli veneziani ad Aleppo, la diminuzione dei commerci veneziani, da un lato, e la parallela crescita di quelli concorrenti, dall'altro, era resa evidente (Tab. 14).
In questo scorcio di secolo furono i Francesi, e specie i Marsigliesi, a dimostrarsi concorrenti assai più aggressivi degli Inglesi e degli Olandesi. Il gettito della gabella del porto di Marsiglia, ad esempio, passò da un livello attorno alle 13.000 lire nel secondo decennio del Seicento ad oltre 21.000 nella seconda metà degli anni Sessanta (94). La progressiva scomparsa dei Veneziani dai mercati orientali sembrò sancita dalla decisione presa dal senato di eliminare i consolati ad Aleppo nel 1675 e ad Alessandria d'Egitto nel 1669 (95). Si era addirittura giunti al punto che le spezie - mercanzia tradizionale del commercio veneziano - dovevano essere importate a Venezia dai "nordici". Le proporzioni del traffico erano oramai a netto favore dei concorrenti stranieri: la quantità di spezie giunte a Rialto nel 1680, per esempio, fu di appena 2 quintali, a fronte dei 40 arrivati ad Amsterdam (96). E a Ponente le cose non parevano andar meglio. Oramai le rotte verso gli scali del Nord Europa erano controllate da mercanti e navigli inglesi e olandesi, e nel Mediterraneo occidentale solo una piccola frazione rimaneva ai Veneziani (97).
Un duro ridimensionamento della potenza commerciale della Serenissima, dunque, che, sebbene sia indiscutibile, nondimeno risulta meno drastico di quanto comunemente si ritenga. Per valutare correttamente il ruolo commerciale di Venezia nella congiuntura seicentesca crediamo sia opportuno dimenticare i fasti quattro-cinquecenteschi, i cui splendori rischiano di porre in una luce troppo negativa le vicende successive. Certo, la sostituzione dei vettori navali veneziani con legni di altre flotte comportò un evidente peggioramento della posizione veneziana, poiché ne risentì, tra l'altro, il movimento del porto e crebbe la dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime. È altresì indubbio che il volume globale delle mercanzie in transito nel porto lagunare diminuì rispetto al Cinquecento, ma in effetti il movimento generale non calò in modo drammatico.
La quantità di colli entrati nel porto è esposta nella Tab. 15.
Gli elementi presentati nella Tab. 15 possono essere assai discutibili se considerati singolarmente - vi è delineato l'andamento quantitativo piuttosto che il valore delle merci; l'imposta sull'ancoraggio subì delle sensibili variazioni in seguito ad addizionali decretate in otto occasioni tra il 1629 e il 1706 -, ma nel complesso evidenziano una tendenza abbastanza chiara. Dai primi anni del Seicento, infatti, il movimento portuale imboccò un marcato declino ed una prolungata stagnazione che s'interruppe verso gli inizi del secolo successivo con l'emergere di una certa ripresa. Ovviamente questo quadro andrebbe arricchito e opportunamente integrato con indicatori assai più incisivi, quali ad esempio la tipologia e il valore delle merci, la provenienza delle imbarcazioni, il traffico di piccolo cabotaggio, la quota di merci riesportate, e così via.
Proposto l'andamento secolare del commercio portuale veneziano, è utile porlo in relazione ad altri casi mediterranei, al fine di collocare le vicende veneziane in un contesto più ampio. Partiamo da Ragusa, l'attuale Dubrovnik (98). Anzitutto occorre dire che questo porto risentì fortemente delle congiunture politiche che interessarono i rapporti tra Venezia e l'Impero turco. Le fortune dello scalo raguseo solitamente crescevano quando i traffici tra la laguna e l'Oriente subivano difficoltà o interruzioni a seguito delle guerre. Dopo il 1630 l'attività mercantile della città dalmata entrò in un periodo di crisi, che fu interrotto dallo scoppio della guerra di Candia. Il conflitto deviò una parte dei commerci verso rotte terrestri, e Ragusa rappresentò il punto terminale di queste vie. Alcuni mercanti, inoltre, vi si trasferirono alla ricerca di un porto sicuro dove svolgere i propri commerci sotto una bandiera neutrale. Gli anni della guerra di Candia costituirono un periodo di notevole espansione per lo scalo raguseo, ma già con l'approssimarsi della pace le entrate doganali portuali manifestarono una netta flessione, che non fu contrastata dalla successiva guerra austro-turca verso la fine del secolo.
Un altro porto collegato a Venezia era Spalato. Sorto come centro terminale per i traffici terrestri dell'entroterra balcanico, in concorrenza con Ragusa, lo scalo spalatino condivise strettamente le sorti del mercato realtino. In base ai pochi dati conosciuti si può ravvisare un'analoga decadenza, che raggiunge il punto più basso nei decenni centrali del Seicento, per poi riprendersi assai lentamente in seguito (99). Un'analoga tendenza al declino si riscontra anche per il porto adriatico di Ancona. L'istituzione del porto franco le aveva permesso una forte crescita tra Cinque e Seicento, ma all'indomani del 1640 anche questo centro di traffico venne coinvolto nelle generali difficoltà: calo vistoso nei traffici e circolazione di imbarcazioni di stazza inferiore (100). Era una generale situazione negativa, insomma, quella che coinvolgeva i porti adriatici nei decenni a cavallo del Seicento. La consistente diminuzione delle merci movimentate, il restringimento dell'area commerciale, il ridimensionamento a scalo regionale, il controllo delle rotte esercitato da imbarcazioni straniere, erano elementi comuni; ciò che forse contraddistinse Venezia fu una vivacità che emerse sullo scorcio del secolo - una vivacità relativa, beninteso - che le permise di recuperare la funzione d'interscambio in una dimensione interregionale.
Se invece si prende in considerazione l'intero bacino mediterraneo, il ruolo economico giocato da Venezia si restrinse vieppiù, anche di fronte ad altri porti italiani. Se Marsiglia raggiunse il picco del suo traffico portuale a metà Seicento, in forza della potenza francese che si stava dispiegando nelle acque mediterranee, anche nella Penisola alcuni centri evitarono - almeno nel Seicento - il destino veneziano. Livorno è il caso più clamoroso. La condizione di porto franco e la posizione favorevole avevano attratto i vascelli inglesi e olandesi, che lo scelsero come scalo d'elezione verso la fine del Cinquecento. I vantaggi economici offerti dal porto toscano erano evidenti: nel 1628 venne calcolato che una balla giunta a Livorno e diretta a Vicenza avrebbe pagato 1 reale per lo scarico e il transito e 8 reali per la spedizione via terra. Nel caso la balla fosse stata sbarcata a Venezia, i costi sarebbero arrivati sino a 30-40 reali (101).
Il divario delle spese da sostenere era sconcertante. Se i calcoli dimostravano che Venezia faticava a tenere dietro allo sviluppo di Livorno, anche la vicina Genova fu spiazzata. Sebbene quest'ultimo scalo non sembri aver registrato una drammatica diminuzione dell'attività mercantile (102), Livorno assorbì una parte consistente del volume di merci che in precedenza si dirigeva verso Genova. Tuttavia il porto ligure non subì una contrazione analoga a quella veneziana: Genova continuò a costituire un punto terminale dell'economia lombarda e a convogliare buona parte della produzione destinata ai mercati di Ponente. In una statistica del 1670 redatta dal console francese a Cadice, il valore dei beni provenienti da Genova costituiva il 18,6 per cento del volume del commercio passante per Cadice; ben dietro la quota assegnata alla Francia (30 per cento), ma avanti all'Olanda (15 per cento) e all'Inghilterra (11 per cento) (103). Probabilmente il fatto che Genova costituisse, ancora addentro al Seicento, uno dei più importanti nodi nella distribuzione dell'argento americano in Europa (104) permise di sostenere anche le sorti commerciali dell'emporio ligure (105). I porti italiani del Tirreno settentrionale, dunque, attraversarono la congiuntura seicentesca in modo diverso - meno drammatico rispetto agli scali adriatici - e, nel caso di Livorno, addirittura in fase di espansione. La parte della Penisola che si collegò alle rotte nordiche usufruì di possibilità e di sbocchi che si stavano restringendo nei centri sparsi lungo le coste adriatiche.
Sarebbe sbagliato, tuttavia, ritenere che i commerci marittimi fossero diventati un monopolio controllato da Inglesi, Francesi ed Olandesi. Anche se in misura notevolmente ridotta rispetto al passato, navi, marciliane e bertoni veneziani continuarono a solcare le acque e ad attraccare nei porti del Mediterraneo.
Una stima relativa all'anno 1687 ci fornisce utili indicazioni sui traffici in Levante (Tab. 16).
La posizione veneziana, benché ben distante dalle tre grandi potenze commerciali dell'epoca, non è affatto disprezzabile; e certo ci deve costringere a ripensare in termini meno catastrofici la decadenza commerciale della Serenissima. Che i mercanti veneziani continuassero a frequentare i fondaci mediterranei, in effetti, non deve stupire; tra una guerra e l'altra, tra un attacco di pirati e un naufragio, il Mediterraneo era ancora un mare dove marinai e mercanti di Venezia si sentivano a proprio agio. Certo, i patrizi e gli agiati cittadini non s'impegnavano più come un tempo, ma altri personaggi avevano assunto il compito di fornire capitali e uomini per il commercio d'Oltremare: molti Ebrei veneziani, nel Seicento, si dedicheranno alla mercatura, e molti trafficheranno nei porti sotto il vessillo di altre nazioni, così da assicurarsi protezione dai pirati e rispetto da parte dei vascelli turchi. Nel 1646, ad esempio, il bailo di Costantinopoli Giovanni Soranzo riferì che a Smirne giungevano in continuazione "robbe d'oro" e tessuti da Venezia via Livorno a nome di mercanti inglesi ed ebrei; ma in realtà destinati a Veneziani (106). I Veneziani, poi, poterono inserirsi nelle varie fasi che videro Inglesi, Francesi e Olandesi impegnati in conflitti militari (107). Se la tregua del 1607 con la Spagna aveva permesso agli Olandesi di dedicarsi alla penetrazione nel Mediterraneo, la ripresa del conflitto nel 1621 condusse ad una fase negativa, facendo aumentare i costi di protezione del naviglio olandese. Analogamente, con l'impegno francese nella guerra dei Trent'anni, gli arrivi di argento a Marsiglia calarono drasticamente, mettendo in difficoltà i commerci con il Turco. In seguito a ciò, i mercanti veneziani conobbero una significativa ripresa tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo. Nonostante la guerra in Europa centrale, i prodotti levantini furono diretti in Germania e Olanda tramite Venezia. A questo successo contribuì in modo determinante la rete di Ebrei che aveva in Venezia uno dei principali nodi. Così, in questo periodo, i mercanti veneziani riguadagnarono posizioni alle spalle degli Inglesi ad Aleppo, e riassunsero il controllo in scali a Cipro, in Egitto e in porti minori. Lo scoppio della guerra di Candia e la fine dell'embargo spagnolo sulle Province Unite (1647) riaprirono invece una fase favorevole agli Olandesi, che riuscirono a conquistare posizioni vantaggiose a detrimento dei Veneziani. Venezia, tuttavia, mantenne un ruolo importante nel complesso della rete commerciale olandese. È interessante rilevare che, per quanto riguarda le merci provenienti dall'Olanda via terra, Venezia e Ancona rappresentarono due punti di snodo fondamentali verso il Levante. All'indomani della guerra di Candia, poi, legni veneziani riapparvero in numero rilevante nel Mediterraneo orientale. Già nel 1670 i savi alla mercanzia accennarono al "negotio [...] rinascente"; nel 1693, ad esempio, nel porto di Smirne giunsero 25 navi veneziane (108). Verso la metà del Settecento, inoltre, il porto lagunare riceveva un quinto del valore complessivo delle importazioni italiane dall'Inghilterra, Francia e Olanda (109).
Senza dubbio il mercato realtino perse una parte di quel respiro internazionale che l'aveva caratterizzato sino alla fine del Cinquecento. Tuttavia, nonostante il ridimensionamento, l'emporio veneziano mantenne una funzione rilevante nell'ambito dell'area adriatica ed italiana, e in alcuni momenti gli operatori veneziani poterono approfittare dei conflitti tra le varie potenze per inserirsi negli spazi che venivano a crearsi. La città si rafforzò come centro di servizi e si trasformò in una vera e propria capitale. Il numero dei domestici, ad esempio, crebbe da 9.983 nel 1586 a 10.235 (+ 2,5 per cento) nel 1642 e a 12.819 (+ 25,2 per cento) nel 1760. Le botteghe iscritte a catasto risultarono 4.422 nel 1661, 5.267 (+ 19,1 per cento) nel 1712 e 5.904 (+ 12,1) nel 1740 (110). La sfera dei commerci si ridusse, ma la posizione di centro politico, amministrativo ed economico dello Stato, nonché di supporto alla rete internazionale dei traffici, permise alla città di mantenere un alto tenore ed un prestigio ancora elevato. Gli stretti legami con il mercato della Germania meridionale rappresentarono inoltre un importante riferimento nel sistema economico finanziario almeno sino a metà Seicento. I crediti vantati dai mercanti - tra cui spiccavano Ebrei portoghesi - nei confronti di quell'area permisero trasferimenti di credito tramite lettere di cambio su Anversa, il principale centro del sistema imperiale spagnolo in Europa settentrionale. Venezia, così, assunse un ruolo assai rilevante nei circuiti finanziari connessi alla monarchia asburgica (111).
Una conseguenza forse sottovalutata del restringimento dell'area commerciale veneziana consistette, tuttavia, nelle accresciute difficoltà ad accedere ad informazioni economiche. La rete di agenti, corrispondenti, mercanti che aveva sostenuto l'impero commerciale veneziano sino alla fine del Cinquecento se proprio non venne smantellata si ridusse in misura consistente. Ora, l'accesso alle informazioni - elemento necessario nella strategia economica di ogni compagnia mercantile o singolo operatore - venne controllato da un'altra rete composta da "nordici" e altri operatori stranieri che sostituì quella veneziana. Le antenne di Venezia, in sostanza, ridussero il raggio di controllo sul bacino mediterraneo; e ciò potrebbe aver aumentato il senso d'incertezza e di maggior rischio che pervase l'ambiente mercantile nel Seicento. Malgrado ciò, ad ogni modo, i commerci veneziani poterono appoggiarsi, oltre che sui pochi rappresentanti della Serenissima rimasti Oltremare, anche su una ampia rete formata da Ebrei ed Armeni. Sono loro, in effetti, che sembrano aver preso il posto dei patrizi e di molti cittadini di Venezia nei fondaci e negli scali mediterranei. Il fiorente commercio di tessuti auroserici veneziani era dominato, secondo Sir Finch, da queste due "nazioni" (112); e le esportazioni delle lane che a fine Seicento ancora erano dirette in Levante attraverso i Balcani sembra fossero controllate per lo più da Ebrei (113). La novità del mondo mercantile veneziano è proprio rappresentata da una miriade di operatori - stranieri ed italiani - di origini più o meno oscure che trattano merci e denaro in città ma che non disdegnano di mantenere contatti con agenti e soci all'estero. Per centri quali Pisa, Livorno e Venezia i legami con l'area economica all'avanguardia, quella atlantica, vennero assicurati in buona parte da comunità straniere, come quella portoghese (114). Sarebbe un errore ostinarsi ad identificare il mercante seicentesco con la tradizionale figura del patrizio: si scoprirebbero pochi personaggi, che contribuirebbero a fornire un'immagine assai limitata e fuorviante della vita mercantile in città. Nella Venezia del Seicento, invece, i protagonisti dell'accumulazione e della formazione di nuovi patrimoni furono uomini
appartenenti ai ceti medi - se è consentito questo termine - che vivificarono la mercatura e che seppero occupare proficuamente gli spazi offerti dalla congiuntura economica del secolo. A differenza dell'età d'oro del commercio veneziano, la possibilità di accedere e di partecipare ai traffici si era ridotta (anche a causa del minor flusso d'informazioni in città?); la contrazione del gruppo di operatori, tuttavia, non significò la scomparsa di interessi legati al commercio e di allettanti opportunità di profitti. La questione era che i rischi erano aumentati e che, forse, occorreva maggior iniziativa per entrare nel grande giro della mercatura. La voce che il noto mercante Giacomo Galli avesse lasciato alla sua morte nel 1649 un enorme patrimonio di 1 "milione d'oro" è segno che, al di là della possibile esagerazione (115), Venezia rappresentava ancora un ambiente che offriva opportunità di costruire clamorose fortune. Le decine di famiglie mercantili che si permisero di sborsare 100.000 ducati per conseguire il titolo nobiliare sono forse l'esempio più eclatante di un successo economico che si trasforma anche in un traguardo sociale (16).
5. Alla ricerca delle cause della decadenza
Sinora ci siamo preoccupati d'individuare i segni del mutamento economico che interessò Venezia lungo il Seicento. Nell'analizzare alcuni settori abbiamo visto che all'inarrestabile declino si accompagnano timide riprese, più o meno lunghe stagnazioni, forti tenute. Un fatto è comunque indubitabile: Venezia conobbe lungo il Seicento un duro ridimensionamento nel quadro dell'economia internazionale. Questo fenomeno - sebbene possa essere considerato meno drammatico di quanto comunemente si pensi - ha condotto gli studiosi a ipotizzare le cause più diverse (117). Ora cercheremo di affrontare il problema della decadenza economica di Venezia tentando di evidenziarne i motivi, più o meno giustificati e accettati dalla storiografia, verificandoli e ponendoli in un quadro più ampio.
Sino agli inizi del Novecento vi era stata una certa identificazione tra decadenza politica veneziana - o meglio, italiana - durante il Rinascimento e declino economico. Ecco quindi che la scoperta del Nuovo Mondo e lo sfruttamento delle rotte atlantiche avevano causato, alla stessa stregua delle invasioni e delle conquiste militari straniere, la crisi della Penisola. Gli effetti dei collegamenti transoceanici sull'economia mediterranea del Cinquecento, tuttavia, vennero in seguito ridimensionati, sottolineando invece la crescita dei traffici delle spezie e il ruolo ancora centrale dell'area nell'economia mondiale (118). Il momento della decadenza economica italiana e veneziana venne dunque spostato verso il secondo-terzo decennio del Seicento, allorché divenne evidente la supremazia commerciale esercitata dai "nordici" negli scali mediterranei; una supremazia che aveva le proprie basi in un vantaggio tecnologico delle navi e in una maggior capacità propulsiva dell'apparato manifatturiero. Il forte appoggio assicurato dai governi ai mercanti e imprenditori, inoltre, rafforzava la concorrenza degli Inglesi, Olandesi e Francesi sugli Italiani. La scomparsa delle spezie dai porti terminali del Mediterraneo orientale, deviate verso i canali oceanici controllati da Inglesi e Olandesi; la forte concorrenza estera nei rifornimenti di seta e cotone; il fatto che i Ponentini pagassero le merci orientali in buone specie monetarie piuttosto che con altre merci, come invece erano usi i Veneziani; la svalutazione della moneta turca, che avvantaggiava i detentori di pregiate monete estere nonché i crescenti costi di protezione dei navigli veneziani condussero alla crisi commerciale di Venezia. A questi elementi di carattere "esterno" se ne affiancarono altri, individuati nella struttura produttiva e nella politica economica - se è lecito impiegare un tale termine - della città lagunare. Anzitutto venne sottolineato il carattere conservatore della politica del ceto dirigente marciano nell'ambito economico. La scelta di continuare a privilegiare la fabbricazione di grandi imbarcazioni, che aveva come ragione la preoccupazione di coniugare i bisogni militari con quelli commerciali, impedì di adeguare il naviglio veneziano a quello nordico, che si stava dimostrando superiore in agilità e in costi di costruzione (119). L'inadeguatezza dei trasporti veneziani e gli alti costi di protezione, sia militari che assicurativi, spinsero vieppiù verso trasporti concorrenti, con indubitabili contraccolpi sull'economia portuale veneziana.
Nel 1623, ad esempio, il mantenimento di 2 galeoni adibiti alla protezione del naviglio mercantile richiedeva 45.000 ducati in un anno. E nel 1638 si stimavano in 200.000 ducati il costo annuo dei noli versati dai mercanti veneziani e in 50.000 ducati la somma necessaria per garantire la sicurezza marittima (120). Si trattava di cifre considerevoli, tenendo conto che in quel periodo 45.000 ducati corrispondevano al costo di costruzione di 3 galee sottili, e che 200.000 ducati bastavano a fronteggiare le spese dell'Arsenale in un anno normale (121). Presumibilmente costi comparativi più vantaggiosi risultarono quelli praticati dai "nordici" rispetto ai Veneziani anche in relazione alle vicende belliche del secolo. Venezia fu infatti impegnata contro il Turco nella lunga guerra di Candia e nel conflitto che la vide impadronirsi della Morea (1684-1699) per poi perderla nuovamente (1714-1718). Guerra e incertezze nei traffici comportavano in primo luogo un sensibile aumento dei tassi. Se non è sempre agevole individuare gli elementi che caratterizzano la formazione del prezzo assicurativo lungo le varie rotte, la presenza della guerra - anche se non dichiarata - è il fattore comune che spinge verso l'innalzamento dei tassi (122). I tassi sulla rotta Venezia-Candia raggiunsero durante la guerra il 9-10 per cento, mentre si dimezzarono all'indomani del conflitto (123). Gli scontri con il Turco, dunque, che segnarono quasi tutta la seconda metà del Seicento e il secondo decennio del secolo successivo, appesantirono ulteriormente le difficoltà del commercio veneziano aggravando i costi di transazione. La guerra, tuttavia, spingeva anche verso nuove direzioni, alla ricerca di rotte e vie meno pericolose e magari sotto altre bandiere. È così che si rivitalizzarono le rotte terrestri nei Balcani e numerosi operatori veneziani continuarono i loro commerci su imbarcazioni di altri Paesi.
La dipendenza da intermediari stranieri ebbe altresì un effetto moltiplicatore ed aggravante sull'intera struttura economica veneziana. Il diradarsi dei traffici facenti capo a Venezia accrebbe i costi delle materie prime per le manifatture e le rese dipendenti dagli approvvigionamenti esteri. La crescente difficoltà a sfruttare le risorse di legname nel Mediterraneo, ad esempio, spinse verso la dipendenza dagli Olandesi, che erano in grado di usufruire del legno baltico e di trasportarlo su imbarcazioni adeguate (124). Anche per quanto riguarda la lana i problemi non mancarono. Nei primi anni Venti del Seicento, a seguito della contrazione della presenza olandese nel Mediterraneo per la guerra con la Spagna, si verificò una grave carenza di lana spagnola sulla piazza veneziana (125), vale a dire del tipo tra i più pregiati per la confezione dei tessuti. Tuttavia il quadro non è del tutto drammatico: lungo il Seicento la fiera di Foggia vide tra i principali protagonisti acquirenti di lana veneziani e, soprattutto, bergamaschi (126). E durante la guerra di Candia, sebbene il prezzo del prodotto si fosse elevato, una parte dei rifornimenti di lana venne convogliata attraverso i Balcani e il porto di Ragusa (127). Si ha l'impressione insomma che, sebbene il controllo dei collegamenti marittimi fosse passato ai "nordici", per Venezia le possibilità di alimentare le proprie industrie non fossero venute meno. Il problema, piuttosto, stava nel fatto che il declino dell'attività commerciale marittima incideva su un vasto indotto della città.
Se la decadenza del primato veneziano sui mari iniziò verso l'ultimo quarto del Cinquecento, la curva della produzione, invece, tese a scendere qualche decennio dopo. Le cause della grave situazione vennero individuate dagli studiosi nell'incapacità d'adeguamento della produzione tessile veneziana di fronte ai nuovi prodotti inglesi e francesi, nell'alto costo relativo della manodopera e nel ritardo tecnologico. In breve: nel tradizionale sistema corporativo, che impediva le innovazioni e che si ostinava a mantenere le usuali forme produttive. A tutto ciò si aggiungeva il ruolo dello Stato, con il suo pervicace protezionismo navale e la mano pesante del fisco, che contribuiva ad innalzare i costi dei prodotti (128). Questi elementi vennero indicati non solo per spiegare le vicissitudini veneziane ma furono proposti anche per il caso più ampio dell'Italia centro-settentrionale (129). Vi è stato chi, poi, ha visto nel caso veneziano il carattere di una decadenza relativa e non in termini assoluti. La prima significa la perdita di una posizione preminente a favore di altri Paesi; per quanto riguarda la decadenza assoluta, invece, secondo Rapp questa non investì la Venezia seicentesca, poiché il livello della popolazione e del reddito pro capite non diminuì rispetto al Cinquecento (130). Il problema, dunque, è complesso e affascinante: si tratta di valutare i termini di una discussione che ha coinvolto generazioni di studiosi ma che, ancora, non è stata del tutto risolta. Vediamo anzitutto di riconsiderare i classici motivi della decadenza.
Abbiamo accennato alla struttura corporativa come ad uno dei principali imputati. I vincoli imposti dalle Corporazioni avrebbero impedito l'adeguamento della produzione tessile alle mutate esigenze dei tradizionali consumatori levantini. I tessuti nordici, più leggeri e variopinti di quelli veneziani, erano stati accolti favorevolmente dai mercati orientali spiazzando i Veneziani, che non avrebbero saputo prendere adeguate contromisure. Il rifiuto dei Veneziani di confezionare stoffe "al modo d'Olanda" o d'Inghilterra avrebbe caratterizzato la politica veneziana sino al tardo Seicento, quando comparvero in città timidi tentativi di produrre tessuti presi a modello dalla concorrenza. Troppo tardi (131). La crisi del lanificio era oramai irreversibile, nonostante alcuni segni di ripresa. In realtà il sistema produttivo veneziano dimostrò di sapersi adeguare ai mutamenti del mercato già lungo il Cinquecento, modificando la produzione nel senso dei nuovi tessuti "nordici" (132). Resta inoltre da spiegare perché, tra Sei e Settecento, si verificò in alcuni distretti della Terraferma una consistente crescita della produzione laniera, sia di modesta che di alta qualità. Una localizzazione delle attività lavorative nelle campagne permise verosimilmente un abbassamento del costo del lavoro. In secondo luogo, la possibilità di sfruttare accessibili fonti d'energia (acqua) favorì questo movimento. Probabilmente lo spostamento di attività manifatturiere dalle città alle campagne costituì il più importante effetto delle difficoltà che colpirono l'economia - o almeno alcuni settori - veneta e italiana. La ricerca da parte degli imprenditori di un ambiente meno restrittivo li spinse oltre le mura cittadine; ma anche operatori non urbani, appartenenti ad una sorta di borghesia rurale, parteciparono a queste iniziative. Questo fenomeno fu reso possibile anche da un significativo mutamento verificatosi sul finire del Seicento: vale a dire la diffusione del mais nelle campagne settentrionali. I maggiori rendimenti della pianta proveniente dalle Americhe rispetto al grano e ai cereali minori permisero alla famiglia contadina di dedicare maggiori quote di tempo ad attività extra-agricole e alla coltivazione di piante legate ad attività manifatturiere (canapa, lino, gelso). Queste potenzialità del mondo rurale agirono da motore della ripresa manifatturiera attirando capitali e aumentando la produzione, destinata sia alla domanda interna che ai mercati internazionali. I tessuti prodotti in alcune aree delle campagne venete - Bergamasco, Vicentino - trovarono mercati di sbocco anche in Europa dove, apparentemente, la concorrenza nordica era assai forte. Ciò significa che i produttori veneti seppero adeguare i costi e la qualità dei tessuti ai mutati rapporti di mercato, dimostrando notevoli capacità dinamiche e considerevole flessibilità. Qualità, queste, che non si riscontrarono - almeno in termini così evidenti e diffusi - nell'ambiente lagunare. Tuttavia è opportuno chiedersi se la funzione produttiva di Venezia, ridimensionata nel contesto internazionale, non sia cambiata anche in considerazione dei processi in atto nella Terraferma. Oramai la produzione di panni alti si era spostata anche nei distretti del Dominio, con risultati incoraggianti, e profondere energie e capitali nella manifattura veneziana probabilmente appariva uno sforzo inane con prospettive poco allettanti. La divisione e specializzazione produttiva che stava emergendo nello Stato veneziano - produzioni di lusso in città e medio-basse in campagna - regolava altresì le scelte d'investimento e l'allocazione di tecnologie e capitali da parte degli imprenditori.
Per quanto riguarda la produzione serica di lusso, l'atmosfera che si respirava a Venezia era assai più stimolante e vivace. La città aveva mantenuto, e forse rafforzato, la sua posizione sia nel mercato regionale che in quello internazionale. A questo, poi, si devono aggiungere le produzioni di vetri e conterie, che costituirono altre importanti voci delle esportazioni veneziane in Europa (133). Si trattava di prodotti che mantennero elevati standards qualitativi e che dovettero affrontare la concorrenza straniera, supportata da alcuni provvedimenti adottati dai governi inglese e francese tesi a sviluppare la produzione vetraria nazionale. Il rafforzamento di questi settori fu dovuto agli stimoli del mercato, che dettero impulso agli investimenti. Nonostante la crescita di vetrerie estere in Francia e in Boemia, i vetri veneziani mantennero quote di mercato sia in Italia e Germania che nel Levante sino ai primi decenni del secolo successivo (134).
Il sistema corporativo è accusato di aver mantenuto alto il costo della manodopera e di aver sclerotizzato i rapporti di lavoro. In realtà, il ruolo delle Corporazioni in tal senso sembra assai meno pesante di quanto si creda (135). Abbiamo già visto come nel "mondo del libro" il Seicento vide delle profonde trasformazioni all'interno della categoria dei lavoratori. All'incirca dalla metà del secolo, in risposta alla congiuntura negativa, i maestri controllarono l'immissione di nuovi abilitati all'arte e assunsero sottoposti evitando i vincoli della Corporazione. Nello stesso momento riuscirono a regolare i livelli salariali di lavoranti e garzoni. Prevalse, in definitiva, un rapporto di lavoro privatistico su quello tradizionale, tutelato dalle magistrature (136). Il risultato fu che i costi di produzione si abbassarono e venne migliorata la qualità del prodotto. Il caso dei librai e stampatori, dunque, dimostra che i vincoli corporativi non agirono sempre e comunque in senso degenerativo, o perlomeno poterono essere in qualche modo aggirati. Sotto la pressione del mercato si cercarono nuove vie e si tentarono adeguamenti e innovazioni che non trovarono ostacoli insormontabili nella struttura corporativa.
Val la pena, comunque, di valutare con attenzione l'annosa questione del costo del lavoro nella Venezia seicentesca. Il problema non riguarda solo Venezia, ma è un elemento che sta al centro dei dibattiti sulla crescita e decadenza delle economie preindustriali. Purtroppo non disponiamo di molti dati sui salari, ma quelli che abbiamo (Tab. 17) possono fornirci qualche utile elemento di discussione. Confrontando le retribuzioni dei muratori inglesi e veneziani tra Cinque e Seicento, Richard T. Rapp ha evidenziato che quelle dei secondi registrarono aumenti più sensibili; in termini monetari i lavoratori veneziani erano pagati il doppio rispetto ai colleghi inglesi (137). Ciò fa ritenere che uno degli elementi chiave del successo inglese sia da individuare nel minor costo relativo della manodopera. In effetti è assai verosimile che a Venezia il costo della vita e le retribuzioni fossero piuttosto elevati; e del resto occorreva attrarre flussi migratori di forza-lavoro mantenendo paghe piuttosto alte. Occorre comunque sottolineare che i dati inglesi usati da Rapp per il suo confronto riguardano il Sud dell'Inghilterra, mentre sarebbe stato più corretto analizzare salari relativi a Londra.
Anche qui, infatti, il costo della vita e le retribuzioni erano di gran lunga superiori rispetto ad altre aree (138). Ed anche per quanto concerne l'andamento dei salari reali, quelli dell'Inghilterra meridionale decrebbero in misura meno drammatica tra Cinque e Seicento rispetto ad altri casi dell'Europa continentale (139). Quel che colpisce dal confronto dei salari espressi in chilogrammi di pane di maestri muratori di varie città (Tab. 18) è piuttosto la buona posizione del rappresentante veneziano, che migliora notevolmente nella seconda metà del Seicento. Nella fase cruciale tra fine Cinque e inizi Seicento i dati non dimostrerebbero che, per quanto riguarda i maestri muratori, a Venezia le retribuzioni avessero conosciuto consistenti incrementi; è nei decenni successivi, piuttosto, che si registra una notevole crescita, superiore a tutti gli altri salari considerati nel confronto. Sebbene non sia plausibile, in base ai dati disponibili, dichiarare che le retribuzioni veneziane non fossero superiori a quelle pagate in altre città concorrenti, conviene nondimeno riconsiderare attentamente il giudizio, che sinora era fondato per lo più sulle dichiarazioni e le lamentele di mercanti e imprenditori, sull'elevato costo del lavoro nella Venezia seicentesca.
Qual è il significato di questo alto livello retributivo? Il salario in una economia d'Ancien Régime non può essere valutato secondo i criteri di un'economia contemporanea. È stato giustamente affermato - ma forse non sempre tenuto in considerazione - che i salari edili non possono offrirci adeguati elementi per valutare il livello di vita del passato, poiché il sistema economico non era strutturato in funzione della manodopera salariata (140). La retribuzione dipendeva da numerose variabili, e la parte in moneta poteva essere integrata da una quota in natura, che spesso sfugge alla documentazione (141). Fatte queste precisazioni, non sembra tuttavia inutile prendere in considerazione con le dovute cautele i dati sulle retribuzioni. Purtroppo la mancanza d'informazioni sulle paghe in altre città venete ci impedisce - come sarebbe necessario - di porre i dati veneziani nel contesto di un più ampio mercato del lavoro regionale, e perciò saremo costretti a proporre solo qualche ipotesi.
Anzitutto salta immediatamente all'occhio come le retribuzioni nei diversi mestieri non seguano un andamento comune. In effetti la costruzione di medie annue o finanche decennali nasconde una ampia differenziazione retributiva all'interno della medesima categoria di lavoratori. Le variabili erano costituite dall'età, dall'esperienza e dalla perizia riconosciute, così come da una serie di altri elementi - non sempre chiari e codificati - che caratterizzavano il rapporto tra il prestatore d'opera e il datore di lavoro. L'andamento dei salari giornalieri, ad ogni modo, registrò una prevedibile crescita all'indomani della peste del 1630, che aveva tagliato drasticamente la forza-lavoro a Venezia. Il culmine di questa ascesa sembra essere stato raggiunto nel terzo quarto del secolo, dopodiché vi fu una tendenza alla diminuzione. Il salariato veneziano, comunque, poteva considerarsi tra i più fortunati in Europa. In termini reali, infatti, il suo salario - come abbiamo visto - era tra i più cospicui nel secondo Seicento. Le ipotesi che si possono proporre per spiegare tale fenomeno non devono limitarsi ad affermare che l'alto livello retributivo dipendeva dal costo della vita, notoriamente elevato nella città lagunare.
Appare altresì insoddisfacente indicare nel meccanismo corporativo l'elemento che permetteva ai lavoratori di difendere pervicacemente i propri salari. Il caso dell'Arte della stampa, seppure possa essere considerato atipico, ci ha mostrato una notevole elasticità del settore per quanto concerneva le assunzioni, e dunque assai verosimilmente anche per ciò che riguardava le retribuzioni. È probabile che la sensibile pressione fiscale esercitata - come vedremo - durante la lunga guerra di Candia abbia provocato un raffreddamento delle retribuzioni su alti livelli. Un ulteriore elemento da prendere in esame è la produttività del lavoro. Limitandoci al settore edile, gli investimenti in costruzioni e l'abilità degli operai potrebbero aver reso il lavoro più produttivo, con riflessi sui salari. Ed un'analoga ipotesi si potrebbe applicare ai comparti manifatturieri di lusso, primo fra tutti il settore auroserico. In un quadro settoriale di crescita, perciò, gli alti salari non costituirebbero un fattore frenante; il giudizio deve però cambiare allorché si analizzino comparti in declino, come quello della manifattura della lana in città. L'importanza degli alti salari, poi, non si limita unicamente all'area della produzione ma deve essere considerata anche in relazione alla domanda. Jan de Vries ha supposto che l'andamento declinante dei prezzi cerealicoli nell'Europa seicentesca e la tenuta dei salari abbiano permesso la liberazione di quote di reddito, in precedenza destinate al sostentamento, verso prodotti (vestiario di discreta qualità, particolari bevande, manufatti) la cui domanda è più elastica (142). Questo tipo di domanda probabilmente sostenne alcuni settori del mercato veneziano, contribuendo a rafforzare l'immagine di una città ancora opulenta e sfarzosa.
Sfarzo e opulenza, quelli di Venezia, che sembravano contrastare con la pesante pressione fiscale che i contribuenti dovettero sostenere pressoché lungo tutto il Sei e il primo Settecento. Gli annosi impegni bellici della Signoria, infatti, misero a dura prova le finanze pubbliche e le tasche dei sudditi, sia di Venezia che della Terraferma. La guerra per Candia segnò un lungo periodo di imposte, aggravi daziari, tasse straordinarie e prestiti forzosi che colpirono tutti i sudditi, e in particolare quelli veneziani, iscritti nelle liste fiscali dei cosiddetti "fuochi veneti", che si distinguevano dai contribuenti a "fuochi esteri" del Dominio. La Tab. 19 espone il numero di decime - cioè la tassa che versavano i Veneziani nella misura del 10 per cento (teorico) sui redditi dichiarati da patrimonio (beni immobili e prestiti su garanzia fondiaria) - e di campatici - imposta sia sui "fuochi veneti" che "esteri" e gravante sui fondi rurali - in alcuni periodi.
Lo scoppio della guerra comportò indubbiamente un'accentuazione della pressione tributaria, sebbene occorra rilevare che anche negli anni precedenti il carico fiscale non era stato leggero. Occorre comunque sottolineare che la determinazione del prelievo fiscale in una società d'antico regime risulta assai difficile; l'entità del carico infatti dipendeva da fattori politici e sociali. Nel caso della Repubblica di Venezia, l'insieme dei contribuenti era suddiviso, come abbiamo visto, in "fuochi veneti" ed "esteri", e fra quest'ultimi vi era un'ulteriore divisione tra cittadini e distrettuali, mentre gli ecclesiastici - come ovunque - godevano di particolari prerogative fiscali. Bisogna poi considerare il peso relativo delle imposizioni diretta e indiretta, che generalmente specificano ambiti diversi (città e distretto). Le valutazioni che seguono, dunque, rappresentano un grossolano indicatore di una situazione segnata da marcate differenze all'interno del corpo contribuente. Un suddito della Serenissima versava in media 37,44 lire nel 1607 e 51,32 nel 1625 per sé e per il suo nucleo familiare (4 componenti); ciò significa che ad un manovale edile necessitavano rispettivamente 19,7 e 26,7 giornate lavorative per soddisfare il fisco.
Nel medesimo periodo, ad un suddito francese ne sarebbero occorse da 10 a 14 (143). D'altro canto, i contribuenti olandesi non appaiono affatto avvantaggiati rispetto a quelli della Repubblica veneta: verso il 1625, infatti, il prelievo medio pro capite in Olanda rappresentava il 21,5 per cento della retribuzione di un manovale, mentre a Venezia la percentuale era appena del 3,3 (144). Il numero di campatici decretati fra gli anni Trenta e Quaranta rivela una notevole pressione sui contribuenti. Pressione che si manifestò in particolare, durante gli anni del conflitto, sui beni fondiari. La diminuzione del gettito doganale portò verso un inasprimento dei dazi sul consumo e dell'imposizione diretta sulle proprietà fondiarie. A fronte di un incremento delle tariffe daziarie del 15 per cento tra il 1645 e il 1669, si verificò invece un continuo prelievo sugli immobili, sia detenuti dai Veneziani che dai sudditi del Dominio. Tra il 1645 e il 1658 i contribuenti della Terraferma furono chiamati a sborsare un ammontare teorico di 3.730.000 ducati a titolo di campatici, sussidi straordinari e tanse (145); e i Veneziani non furono certo risparmiati. Alle decime e alle tanse si accompagnarono incrementi d'aliquota, prestiti forzosi e imposizioni sugli affitti delle case. La commissaria del veneziano Angelo degli Angeli, ad esempio, sborsò in sole decime le seguenti somme, in ducati e grossi, lungo alcuni quinquenni (146):
1636-1640 17:14
1641-1645 18:17
1646-1650 42:18
1651-1655 19:12
1656-1660 44:20
Queste cifre, in termini assoluti, sono piuttosto basse, tuttavia ciò che preme sottolineare è il netto incremento di un solo tipo d'imposta. La mano pesante del fisco poteva essere sostenuta da un sistema economico sano e per un periodo limitato: la pressione tributaria a Venezia, tuttavia, fu prolungata e soprattutto gravò su un tessuto economico che denunciava smagliature, se non proprio drammatici strappi. Gli effetti redistributivi della spesa pubblica, inoltre, vennero vanificati dall'enorme flusso di denaro che prese la via delle acque del Mediterraneo orientale, inghiottito in una guerra lontana, ma che non poteva essere evitata. Certo, l'impressione è che una quota della spesa bellica abbia ravvivato alcuni settori economici e favorito la formazione di fortune a vantaggio di operatori e intermediari legati ai meccanismi di finanziamento e approvvigionamento della macchina militare; tuttavia è assai probabile che l'effetto sull'economia della città nel suo complesso sia stato piuttosto negativo.
Come abbiamo ricordato, tra le cause del declino economico di alcune città nell'Europa del Seicento è stata proposta di recente la caduta delle rendite agrarie. Poiché le città traevano gran parte delle loro risorse dalle campagne sotto forma di canoni, imposte, rendite, la diminuzione di queste entrate avrebbe messo in serie difficoltà le basi stesse dell'economia urbana (147). Ora, l'analisi dei tassi di rendita di alcune aziende dell'Italia settentrionale conferma questo fenomeno: nel Bergamasco l'utile di alcune aziende agrarie diminuì dal 4 per cento d'inizio Seicento al 3 di fine secolo (148). Se consideriamo che a partire dal Cinquecento vi fu un sensibile spostamento d'interessi veneziani verso la terra, rafforzando così i legami economici con le vicende dell'agricoltura, è plausibile che il calo della rendita abbia colpito, almeno in una certa misura, le capacità economiche dei Veneziani.
La rendita immobiliare segnò una stagnazione, che viene evidenziata anche dall'andamento dei redditi tratti da una quindicina di fondi rurali nel Bergamasco e da alcuni affitti di case a Venezia (Tab. 20).
Come si nota agevolmente, l'andamento della rendita urbana non segnò sensibili mutamenti lungo un secolo, mentre quella fondiaria registrò una tendenza declinante (149). Se è lecito assumere questi dati come un indicatore generale della rendita, il Seicento veneziano fu caratterizzato da una certa stagnazione, che per alcuni versi favorì i percettori di salari, ma che per altri penalizzò coloro che basavano gran parte delle loro entrate sulle rendite da edifici e fondi rurali. Questi ultimi, ad ogni modo, ebbero la possibilità di attenuare il peso della congiuntura: dal 1665, infatti, entrò in vigore la decima verde; i proprietari fondiari veneziani potevano soddisfare una parte del loro onere tributario vendendo allo Stato determinati quantitativi di cereali. Da un lato, così, il governo si assicurava un adeguato flusso di grani per le esigenze della flotta, e dall'altro i contribuenti trovavano un sicuro esito ai loro cereali a prezzi di favore (150). Occorre altresì tener presente che le massicce acquisizioni di terre da parte dei Veneziani lungo il Seicento comportarono un indubbio aumento delle entrate derivanti dall'agricoltura. E quindi probabile che la tendenziale diminuzione del tasso di rendita agraria sia stata controbilanciata da un sensibile incremento del patrimonio fondiario detenuto dai Veneziani (Tab. 21).
Il problema della rendita, del profitto commerciale e delle scelte d'investimento è un altro dei nodi da sciogliere per cercare di capire la congiuntura economica veneziana del secolo. La maggior attenzione verso la rendita, rurale o finanziaria che fosse, manifestata dai Veneziani ha spinto alcuni studiosi ad indicare in questo atteggiamento una delle cause del declino. I Veneziani, insomma, nel momento in cui abbandonarono i profitti commerciali in favore della tranquilla rendita segnarono la svolta verso la crisi. La questione non è semplice da risolvere, poiché è opportuno collocare le scelte e le logiche d'investimento in un quadro il più ampio possibile, in modo da tentare di sviscerare le motivazioni che spinsero i Veneziani ad assumere atteggiamenti che, in apparenza, sembravano condurli ad un'inevitabile decadenza.
È possibile giungere ad una qualche conclusione al termine della nostra ricerca delle cause delle difficoltà veneziane? La questione non è semplice. Probabilmente una serie di concause giocò in modo che l'economia della città - o perlomeno alcuni suoi comparti - si trovasse in una fase di declino o stagnazione. Cause endogene, quali una crescente tassazione e una certa difficoltà ad aggiornare la produzione rispetto ai gusti degli acquirenti, si sommarono, e anzi vennero evidenziate, ad elementi esterni al sistema urbano, come la forte concorrenza "nordica", i problemi legati all'approvvigionamento delle materie prime e la lunga guerra che stornò risorse e capitali al di fuori dei confini dello Stato. La risposta dell'economia veneziana fu sia il mantenimento della tradizionale struttura produttiva sia, d'altra parte, un avviamento verso la ristrutturazione che avrebbe ridimensionato - com'era inevitabile del resto - il ruolo di Venezia sui mercati internazionali ma che le avrebbe consentito di svolgere una funzione ancora importante ai margini del centro dell'economia-mondo.
6. Investire a Venezia
Quali erano le opportunità d'investimento che si offrivano ai Veneziani del Seicento? In genere i settori d'impiego del denaro erano quelli che si potevano riscontrare anche nelle altre città d'Europa: acquisti di terreni, attività commerciali e manifatturiere, prestiti a privati e allo Stato. Questi settori d'impiego del denaro continuarono ad offrire opportunità ai Veneziani, ma ciò che mutò profondamente fu l'entità dei capitali profusi. Se in precedenza la mercatura e talune produzioni avevano assorbito gran parte del denaro e delle attenzioni, ora il loro flusso si stava dirigendo in modo sempre più consistente verso la terra e il prestito. Vediamo dapprima alcuni dati relativi agli acquisti di fondi rurali in Terraferma ad opera dei Veneziani (Tab. 21).
Questi dati provengono dalle dichiarazioni dei proprietari veneziani assoggettati al campatico, vale a dire un'imposta che gravava sui fondi rurali. È dunque opportuno valutare queste cifre con un sano scetticismo, in quanto ricavate da fonti di carattere fiscale. Tuttavia è chiara la progressione che la proprietà veneziana conobbe in quel periodo, aumentando la sua presenza nel Dominio di circa un terzo. In termini percentuali la quota veneziana sul totale della superficie agraria della Terraferma veneta crebbe da poco meno del 12 per cento del 1636 al 16 del 1722. Le dichiarazioni fiscali degli abitanti dei sestieri di S. Marco, S. Croce e Cannaregio mostrano che tra il 1537 e il 1661 la proprietà in Terraferma crebbe del 150 per cento, passando da 119.116 campi (un campo trevigiano è pari a 5.204 mq) a 297.313 (151). Le aree particolarmente interessate dal fenomeno erano, com'è da aspettarsi, quelle vicine alla laguna, il Padovano, il Trevigiano e il Polesine. Terre in genere fertili, che assicuravano grano e vino sulle mense dei proprietari e che potevano essere controllate con relativa facilità. Nonostante le scarse informazioni sui patrimoni familiari dei Veneziani, è possibile individuare tempi e modi di questa avanzata in Terraferma, sebbene non tutte le famiglie seguissero un modello di comportamento univoco. Infatti, se ad esempio i Pisani dal Banco registrarono, nel lungo arco di tempo tra il 1585 e il 1700, una media d'acquisto piuttosto costante - attorno a 10 campi all'anno - i Pisani Moretta, d'altro canto, non si mostrarono molto interessati all'investimento fondiario sino al 1645 (appena un campo e mezzo comprato in media negli anni 1554-1645), mentre dimostrarono un certo entusiasmo tra il 1646 e il 1706, allorché acquisirono una dozzina di campi all'anno (152). Differente il comportamento dei Querini di S. Maria Formosa, i quali, dopo aver costituito un discreto patrimonio fondiario sino a metà Seicento, manifestarono un relativo disinteresse nei cent'anni successivi (153). La crescente e sensibile propensione dei Veneziani verso la terra è comunque innegabile: certo, l'acquisizione di fondi rurali ebbe inizio ben prima del Cinque-Seicento; ma ciò che caratterizza il fenomeno è l'atteggiamento che vi si celava. Mentre in precedenza, nei secoli eroici della mercatura, la terra era considerata come una sorta di investimento di sicurezza contro i rischi imprevedibili del commercio marittimo, nei secoli dell'età moderna l'acquisto fondiario assume un diverso carattere e, soprattutto, nella gran parte dei casi svolge una funzione fondamentale nella gestione patrimoniale della famiglia veneziana.
La trasformazione del mercante in proprietario fondiario - è stato detto - fu il riflesso di un mutamento di valori che investì i Veneziani, che smisero le vesti dell'imprenditore e del mercante per indossare quelle del tranquillo rentier (154). Anche il patriziato veneziano, così, sarebbe riuscito a conseguire quella condizione del "vivere d'entrata", che sembrava la massima aspirazione dei ceti nobiliari italiani, e in parte di quelli europei, nei secoli XVI e XVII.
L'abbandono della mercatura appariva il risultato di una spinta ideologica che esaltava, di converso, valori sociali legati alla terra e alla rendita derivante dall'agricoltura (155). Se è lecito tenere in considerazione il mutamento di valori e atteggiamenti in una società, è altrettanto utile, tuttavia, allargare lo sguardo anche verso altri elementi, che potrebbero aver guidato - più o meno consciamente - le scelte economiche dei Veneziani. Anzitutto è opportuno chiedersi con quale spirito nobili e cittadini di Venezia acquisirono proprietà. Il fenomeno tra l'altro, occorre tenere presente, interessò la quasi totalità delle élites europee del Cinque e Seicento: ovunque, sulla spinta della clamorosa crescita dei prezzi cerealicoli da metà Cinque al primo Seicento, si verificarono ondate di acquisti di terra da parte di cittadini e agiati borghesi delle campagne. Questa tendenza continuò - a quanto pare - anche lungo il Seicento, nonostante la congiuntura dei prezzi non fosse così favorevole come in precedenza. Perciò, se nel Cinquecento i Veneziani e non solo loro - si interessarono alla terra tenendo d'occhio il mercato dei grani e magari profondendo capitali nell'impiantare risaie (156) (tipica coltura mercantile), nel Seicento è presumibile che si aggiunsero altre motivazioni, sebbene non si debba dimenticare l'influenza esercitata dall'andamento dei prezzi cerealicoli, come lascerebbe intravedere la Tab. 22.
Come spesso è necessario, anche in questo caso non è opportuno attribuire molta fiducia a queste cifre. Anch'esse infatti derivano dalle dichiarazioni dei contribuenti veneziani, che trasportavano i beni acquisiti in Terraferma - e pertanto registrati nei ruoli fiscali delle province del Dominio - nelle liste dei proprietari veneziani, i cosiddetti "fuochi veneti". Inoltre poteva accadere che il passaggio dei beni fosse dichiarato alle autorità fiscali dopo molto tempo dall'acquisto; ed è per limitare in una certa misura questa discrepanza che si è adottata una suddivisione in quinquenni o trienni. E interessante notare, ad ogni modo, che emerge una certa correlazione tra l'andamento relativo ai passaggi di proprietà e il livello dei prezzi nel quinquennio precedente. La quantità di campi denunciata nel 1698-1700 - il picco nella nostra serie - potrebbe essere posta in relazione agli alti prezzi cerealicoli che precedettero quel periodo. Certamente questi dati non dimostrano in modo inequivocabile che i Veneziani tendessero ad acquistare terra unicamente in base ad aspettative create dall'andamento del mercato cerealicolo - basti pensare alla disponibilità di capitale in funzione della pressione fiscale e di altre scelte d'investimento - ma è pur vero che la lettura della Tab. 22 offre spunti e ipotesi in tal senso (157). Interessi fondiari e mentalità imprenditoriale, insomma, non si esclusero, ed in parte si coniugarono nella Venezia barocca. La Tab. 22 permette qualche altra considerazione: l'andamento non sembra discostarsi di molto dai dati registrati nelle dichiarazioni del campatico (Tab. 21). Il ritmo degli investimenti in Terraferma, infatti, crebbe all'indomani della fine della guerra di Candia per poi rallentare tra Sei e Settecento, in concomitanza con le guerre di Morea. Considerando un prezzo medio di 200 ducati all'ettaro, tra il 1636 e il 1665 i Veneziani investirono nell'acquisto di terra 158.000 ducati all'anno (ovviamente questa stima è assai grossolana), 388.000 fra il 1665 e il 1682, e 113.000 dal 1682 al 1722. È assai probabile che la forte pressione fiscale esercitata in particolare sulla proprietà fondiaria abbia scoraggiato da un lato gli acquisti e, dall'altro, abbia diminuito le capacità d'investimento dei Veneziani.
Una figura emblematica di mercante veneziano che incarna anche quella di proprietario terriero è Alberto Gozzi (1579-1664), conosciuto anche sotto il nome di Alberto della Seda (158). Malgrado le generali difficoltà del commercio veneziano nella prima metà del secolo, Alberto riuscì ad accumulare una cospicua fortuna proprio nella mercatura, e in particolare nella lavorazione e smercio della seta. Tra il 16014 e il 1629 la compagnia costituita da Alberto e dallo zio Domenico Tironi assicurò un tasso medio di profitto attorno al 10 per cento annuo. Altre compagnie commerciali vennero formate, sia con piccoli soci locali che con importanti partners, quali Ascanio Samminiati e Gioacchino Guasconi (159). Al tramonto della sua vita, e dopo aver conseguito la nobiltà con l'esborso di 100.000 ducati, le sue partecipazioni in imprese commerciali e industriali si erano ridotte notevolmente, raggiungendo un valore di circa 200.000 ducati. Parallelamente, il suo patrimonio immobiliare, costituito da case e botteghe a Venezia e da oltre 1.300 campi in Terraferma, potrebbe essere valutato attorno ai 174.000 ducati. Richard T. Rapp ha opportunamente concluso che le scelte d'investimento di Gozzi dipesero anche da un'attenta valutazione dei rischi connessi alla mercatura e dei tassi di profitto relativi tra commercio e agricoltura. Un utile attorno al 3-5 per cento derivante dalla proprietà fondiaria non era certo spettacolare, tuttavia l'assenza di gravi rischi fece preferire questo investimento alla mercatura, che minacciava maggiori incertezze e tassi di profitto minori che in passato (6,4 per cento nel lungo termine). Un ulteriore elemento da non sottovalutare è che, crescendo le preoccupazioni di salvaguardia e di tutela del patrimonio familiare, i Veneziani preferirono lasciare ai loro eredi solide proprietà terriere piuttosto che merci e titoli di partecipazione in compagnie, soggetti ai rischi della "fortuna" e alla dura concorrenza dei "nordici".
Se il mercato della terra fu sostenuto da una rilevante domanda, sul versante dell'offerta il Seicento fu particolarmente interessante. Spinto dalle necessità finanziarie della guerra, infatti, il governo veneziano mise in vendita una cospicua quota di beni comunali nella Terraferma "di qua dal Mincio", vale a dire di terre che erano state concesse in uso alle comunità ma che spettavano in linea di diritto al demanio. Nel 1637 erano stati censiti circa 209.000 ettari di comunali - ad esclusione di quelli della Carnia, del Cadore e delle terre d'Oltremincio -; un patrimonio che costituiva almeno l'11 per cento della superficie agraria totale (160). Dal 1646 si susseguirono le vendite a favore di privati ed enti (161): la Tab. 23 riassume i dati per il periodo 1647-1727.
L'estensione dei terreni non era certo irrilevante, tenendo conto che si è ipotizzato che tra il 1500 e il 1800 il movimento delle bonifiche nel Veneto conquistò circa 180.000 ettari (162). Lo scorporo dei comunali accrebbe notevolmente l'offerta, e i Veneziani ebbero una parte non indifferente negli acquisti, tanto più che le terre vennero alienate a prezzi abbastanza favorevoli. Il basso prezzo della terra, che raramente superava per i campi di pianura gli 80 ducati all'ettaro (163), forniva un'ottima possibilità d'investimento. Dopo che la terra era stata preparata alla coltivazione, il valore di un buon ettaro arativo e vitato si aggirava attorno ai 200-250 ducati (164). L'altro enorme settore in cui confluirono attenzioni e capitali dei Veneziani fu il credito, sia privato che pubblico. Anche in questo caso, l'attività creditizia non era una novità in laguna; l'impressione è nondimeno che il Seicento abbia visto una partecipazione di denaro e uomini assai più ampia e significativa che in passato. Il volume di denaro impiegato nel credito per sua natura sfugge ad attendibili valutazioni: chi presta denaro non lo dichiara molto volentieri. Alcune misure fiscali prese dal senato nella prima metà del Seicento, comunque, puntarono a far emergere i capitali che i contribuenti veneziani avevano impiegato nel credito privato sotto forma di livelli. Il livello era uno strumento creditizio per mezzo del quale colui che riceveva la somma in prestito vendeva sulla carta un bene al prestatore, il quale a sua volta lo affittava al creditore dietro pagamento di un canone annuo, che di fatto rappresentava l'interesse da versare; in sostanza, si trattava di un prestito su garanzia fondiaria (165). Questa forma di credito fu piuttosto diffusa sia in ambiente urbano che rurale, nonché tra i vari strati sociali, dal comune contadino al patrizio veneziano.
A seguito delle dichiarazioni fiscali prodotte dai contribuenti veneziani nel 1625, risultò che il complesso della rendita percepita dai dichiaranti raggiungeva i 168.754 ducati. Capitalizzando questa cifra al 6 per cento - il tasso prevalente in quel torno d'anni - il denaro mobilitato risulta superare i 2.800.000 ducati (166). Indubbiamente una somma cospicua. È stato stimato che il grande fenomeno delle bonifiche cinquecentesche sia stato sostenuto da una spesa che si aggirò tra 1 milione e mezzo e 2 milioni di ducati (167). I bilanci della Repubblica registrarono entrate globali attorno ai 3.700.000 ducati negli anni Venti, e sui 3.000.000 all'indomani della peste (168). Il capitale impiegato ufficialmente in livelli, poi, corrispondeva ad un terzo del debito pubblico veneziano nel 1641 (169). Come per gli acquisti di terra, anche per il settore creditizio la traiettoria dei patrimoni familiari lascia intendere diflèrenti strategie e tempi. Così, ad esempio, i Querini si mostrarono particolarmente interessati ai livelli attorno agli anni Venti e Trenta, con somme che variarono dai 52.699 ducati nel 1625 ai 29.980 nel 1643, ma il volume del credito concesso si contrasse sensibilmente nei decenni successivi, arrivando a meno di 9.000 ducati nel 1711 (170). Ben altro caso, invece, quello dei Pisani dal Banco: dopo aver investito cospicui capitali in livelli nel primo Seicento, continuarono in questa attività in misura crescente anche nel secolo successivo (171).
Un'altra forma simulata di prestito era il cambio; sorto dapprima come mezzo di pagamento tra diverse piazze commerciali, si era in seguito trasformato anche in uno strumento creditizio slegato dal trasferimento della mercanzia. I grandi padroni del sistema del credito attraverso i cambi erano i Genovesi e i Fiorentini. Disponiamo di informazioni assai sporadiche sul coinvolgimento di Veneziani nel mondo dei cambi: certo è che direttamente o, spesso, per mezzo di agenti genovesi e soprattutto fiorentini, capitali veneziani vennero impiegati nel gioco delle fiere (172). Nel 1625 le autorità veneziane affermarono che il volume di denaro impiegato nei cambi si era ridotto da 1 milione a solo 200.000 ducati, in seguito allo spostamento di investimenti verso altri settori e in particolare nel debito statale (173). Confrontata con altre piazze, ad ogni modo, quella veneziana non sembrerebbe rivestire un ruolo particolarmente importante. Il condizionale è comunque d'obbligo: i denari impiegati nei cambi sfuggono alle rilevazioni fiscali e, nel caso dei Veneziani, l'intermediazione di operatori specializzati forestieri potrebbe offuscare un impegno finanziario forse sottostimato.
Prestiti ai privati e, soprattutto, prestiti allo Stato. I due settori si affiancano, appartengono alla categoria del credito, ma si distinguono tanto per gli strumenti che per le motivazioni che sottendono il concedere denaro a prestito. Per quanto riguarda il credito allo Stato, esso poteva assumere tanto la forma coatta (prestito forzoso) quanto quella libera. In quest'ultimo caso entravano in gioco elementi quali il mercato creditizio, mosso dal tasso d'interesse e da diverse opportunità d'investimento, nonché altri fattori, connessi allo status dei sottoscrittori, alla struttura costituzionale e, in definitiva, alla credibilità del governo.
Il sistema del debito pubblico - inteso come meccanismo di raccolta di capitali sul libero mercato dietro promessa del pagamento di un interesse garantito da un bene o un'entrata statale - si era instaurato nel Cinquecento. Mentre in precedenza il perno del finanziamento del deficit statale era stato il sistema dei prestiti obbligatori da parte dei contribuenti, dal secondo quarto del Cinquecento il rastrellamento di capitali sul mercato del credito aveva progressivamente soppiantato - ma non eliminato del tutto - il ricorso al prestito forzoso. Così, agli inizi del Seicento, Venezia poteva considerarsi tra i Paesi europei all'avanguardia per quanto riguardava il debito pubblico (174). I depositi in Zecca - che potremmo definire titoli del debito statale - erano suddivisi in due categorie: da una parte vi erano le emissioni teoricamente redimibili a medio e lungo termine, sulle quali il governo pagava un interesse (il cosiddetto pro') relativamente contenuto, dall'altra c'erano i depositi vitalizi, che assicuravano un rendimento più elevato, ma che sarebbe stato pagato sino alla morte del sottoscrittore e il cui capitale non sarebbe stato restituito. In alcuni casi, comunque, si prevedeva che il pro' sarebbe stato versato, entro certi limiti, agli eredi del defunto. Lungo il Seicento, poi, presero piede altre forme di finanziamento a lungo termine, come i depositi fuori Zecca, vale a dire fondi i cui pro' venivano versati direttamente da uffici finanziari che gestivano la riscossione di dazi. Nel 1645, ad esempio, furono venduti 27.000 ducati del gettito del dazio sull'olio, destinati alla corresponsione di un pro' del 7 per cento annuo per un periodo di 20 anni; e quindi la responsabilità del pagamento venne demandata ai cassieri della ternaria vecchia, la magistratura che aveva il controllo su quel dazio (175). Un secondo sistema, che ebbe una certa diffusione agli inizi del Settecento, fu quello dei capitali "instrumentati": le Arti e le Scuole - non solo di Venezia - si incaricavano di raccogliere capitali stipulando un contratto di prestito con i sottoscrittori, e il ricavato sarebbe stato trasferito alle casse statali. Queste istituzioni, in definitiva, si assunsero la garanzia e la tutela del credito allorché la fiducia dei prestatori nei confronti del governo si stava attenuando (176). Sul versante del debito a breve termine, invece, primeggiò il Banco Giro, l'istituto statale che fungeva da banco pubblico. Qui dal 1619 i vari fornitori della Signoria vedevano riconosciuti i propri crediti in partita di banco con facoltà di girare il titolo a terzi o a favore dello Stato stesso per il pagamento delle imposte. Verso la metà del secolo il Banco assunse anche la funzione di istituto di deposito in moneta metallica (177).
La domanda di credito statale conobbe un momento delicato durante gli anni della peste e, naturalmente, in occasione dei conflitti con il Turco. Se all'inizio del secolo Venezia era in grado di godere di un onere debitorio assai ridotto, un secolo dopo il carico sostenuto dalla finanza pubblica risulterà assai gravoso. La percentuale delle entrate destinata al servizio del debito fu inferiore al 3 per cento nel 1609; si mantenne al di sotto del 10 per cento negli anni Venti, per portarsi attorno al 17 per cento negli anni precedenti lo scoppio della guerra di Candia (178); dal 1645 in poi il senato fece un ampio ricorso al mercato creditizio e a prestiti forzosi amministrati dalla Zecca per il finanziamento del conflitto. Purtroppo non disponiamo di soddisfacenti dati sulla finanza di guerra, ma è indubbio che i costi del conflitto incisero profondamente sul bilancio della Repubblica. Nel 1668 - a ridosso della fine di una guerra che si era protratta per 25 lunghi anni - l'ambasciatore veneziano a Roma compilò un elenco di spese sostenute per la difesa dell'isola in quell'anno: soldati, polvere da sparo, miccia, piombo, ferro, legname, armi, viveri e uniformi avevano richiesto un esborso di 4.392.000 ducati (179); a questa cifra si dovrebbero inoltre aggiungere i costi per la flotta, l'Arsenale e le guarnigioni negli altri presidii in Levante e Terraferma. Insomma, la valutazione che fu fatta qualche anno dopo che il conflitto fosse costato alla Signoria 125 milioni di ducati non sembra un'esagerazione (180). Una media di 5 milioni all'anno era una spesa che la finanza veneziana non poteva sopportare senza contraccolpi. Alla vigilia della guerra le entrate statali si aggiravano attorno ai 3 milioni di ducati e, nonostante l'aumento delle imposte, la vendita di beni comunali, di uffici, di dignità (181) e del titolo di patrizio, la pressione esercitata sul bilancio dovette essere affrontata ricorrendo al credito. Come risulta dalla Tab. 24, il livello del debito statale crebbe di quasi sei volte tra il 1641 e il 1679.
Gli squilibri tra capacità finanziaria dello Stato e indebitamento emersero in maniera assai preoccupante durante la guerra, tanto che al termine del conflitto il debito del 1670 incorporava ben 11 milioni di ducati di interessi arretrati e non versati. Il rapporto tra indebitamento ed entrate passò da un discreto 2,8 nel 1641 ad almeno 8,8 nel 1670 e a 10,8 nove anni dopo. Mentre il tasso di crescita delle entrate risultò attorno ali' I per cento annuo tra 1641 e 1679, quello dell'indebitamento registrò un preoccupante I I per cento all'anno; e così sino al 1710. È opportuno tentare di dare un significato a queste cifre volgendo momentaneamente lo sguardo alle finanze di altri Stati nel medesimo periodo. Nella Francia d'inizio Seicento il quoziente tra debito pubblico complessivo ed entrate centrali fu attorno a 6, valore che deve essere considerato un indicatore positivo, visto che in quel torno d'anni Sully aveva ridato fiato alle esauste finanze reali (182). Sebbene non disponiamo di dati finanziari sul debito complessivo del re di Francia lungo il secolo, è assai verosimile che il rapporto fra debito ed entrate abbia subito un deciso aumento. Un analogo quoziente (circa 5) si riscontra nella ricca e intraprendente Olanda verso il 1640, ma una dozzina d'anni dopo il rapporto s'impennò a 12,6; tra gli anni Sessanta e Settanta si collocò tra 10 e 12, per poi giungere ad un gravoso 17,7 nel 1713(183). Le finanze statali, dunque, poste sotto pressione dagli impegni bellici mostrerebbero una tendenza a ruotare attorno ad un rapporto di 10-12 a 1 tra debito ed entrate (184); e in questo quadro la Repubblica di Venezia non sembra rappresentare un'eccezione. Il problema, tuttavia, sta nel confrontare il gravame finanziario nel quadro generale di un sistema economico: le finanze olandesi poterono sopportare una forte tensione grazie ad un'economia nazionale in vivace espansione; Venezia, viceversa, si trovò ad affrontare una enorme spesa militare proprio in un periodo in cui i maggiori settori economici stavano conoscendo un'accentuata stagnazione. I milioni incassati con le vendite di terre e uffici non potevano fronteggiare il continuo bisogno di denaro; e, analogamente, la pressione fiscale non poteva essere esercitata senza freni. La domanda di denaro sul mercato era il mezzo più efficace, ma quale sarebbe stata la risposta dei potenziali creditori?
Passando al versante dell'offerta di credito, occorre dire che gli investitori veneziani vantavano solide tradizioni. Durante le guerre precedenti denaro fresco era affluito con una certa facilità nei forzieri della Zecca e anche nella primavera del 1645 il tasso d'interesse del 5 per cento offerto dai depositi testimoniava che non vi erano particolari tensioni tra governo debitore e sottoscrittori. Ma l'atmosfèra mutò non appena comparvero le nubi della guerra. I pro' dei titoli statali vennero portati al 7 per cento e quelli sui vitalizi, precedentemente attorno al 10-12 per cento, crebbero al 14, come attesta la Tab. 25.
L'andamento dei tassi veneziani sembra seguire quello fatto segnare da altri Paesi europei: una tendenziale diminuzione, salvo nei momenti di particolari congiunture politico-finanziarie (185). Lo stato di guerra a Venezia provocò tassi relativamente più alti che in Olanda, dove i vitalizi rendevano l'11,1 per cento verso il 1640 e attorno al 9 per cento o meno nel 1667 (186). I Paesi Bassi, in effetti, furono l'area che presentò tassi inferiori rispetto al resto dell'Europa seicentesca. Ed è proprio nella possibilità di usufruire di capitali a basso costo - sia nel credito privato che in quello pubblico - che è stato individuato uno dei segreti del successo olandese in quel periodo (187). Nella città lagunare il costo del denaro nella prima metà del Seicento si era stabilizzato attorno al 5,5-6 per cento (188). La guerra di Candia ebbe pesanti conseguenze anche sul mercato del credito privato: già nel 1645 ci si lamentava che sulla piazza veneziana era impossibile trovare denaro a meno del 6 per cento, mentre a Roma si poteva sperare in un costo inferiore. L'anno successivo il tasso si aggirò attorno al 7-8 per cento; ma alla fine del conflitto il mercato registrò un calo sino al 4 per cento nei primi anni Ottanta e continuò ad oscillare attorno a questo valore sino a metà Settecento (189). Rispetto ad altri Paesi, comunque, a Venezia il governo pagava assai meno il denaro che chiedeva a prestito: sia in Francia che in Inghilterra, ad esempio, i prestatori dovettero essere attirati con tassi relativamente più elevati.
Nel pieno Seicento, ad ogni modo, i rendimenti nominali dei depositi in Zecca risultarono abbastanza allettanti: i crescenti costi e i rischi della mercatura scoraggiavano dall'investire in quel settore; e anche l'agricoltura non offriva clamorose rendite. Il tasso di rendimento effettivo, vale a dire il rendimento calcolato sul prezzo di mercato del titolo, era piuttosto favorevole. Nel 1646 gli Ottoboni vendettero delle obbligazioni sul mercato secondario a 70 su 100 (190): ciò significa che l'acquirente godette di un pro' effettivo del 7 per cento su un titolo che rendeva il 5. Qualche anno dopo, nel 1687, titoli al 3 per cento vennero venduti a 80 - una discreta quotazione - con un rendimento per il compratore del 3,75 per cento (191). I depositi in Zecca e gli altri strumenti creditizi, così, apparivano vantaggiosi e, soprattutto, piuttosto sicuri. La sicurezza dei titoli veneziani era data, in parte, dalla stessa struttura costituzionale della Repubblica. Poiché tra le file del patriziato si trovavano molti creditori dello Stato, vi era una stretta connessione tra interessi dei creditori e solvibilità del governo; una dichiarazione di bancarotta, in sostanza, avrebbe coinvolto anche le fortune di un gran numero di governanti e questo elemento probabilmente giocò in favore della credibilità della Signoria come debitore. A ciò si può aggiungere che la recente tradizione finanziaria di Venezia - tra il 1577 e i primi anni del Seicento erano stati completamente saldati i debiti - rassicurava i sottoscrittori poiché, a differenza di altri Stati, la Repubblica si era mostrata, spesso, un buon debitore. Infatti, allorché i Genovesi trasferirono i propri interessi dal credito agli Asburgo verso altri Paesi, Roma e Venezia furono le sedi dove diressero prevalentemente i loro capitali. Tra il 1617 ed il 1625, ad esempio, i Genovesi sottoscrissero il 46,3 per cento dei vitalizi emessi dalla Zecca veneziana (192); e tra il 1654 e il 1656 su 855.000 ducati presi a prestito da Venezia tramite "partiti" con privati ben 696.425 (81,5 per cento) furono sborsati da Genovesi. Al termine della guerra di Candia, il capitale genovese investito nel deposito in Zecca al 3 per cento risultò essere un terzo del totale (193). Quello genovese, sebbene di gran lunga prevalente, non fu il solo denaro straniero affluito nei forzieri veneziani; durante la guerra la Signoria si rivolse anche al mercato di Amsterdam, ottenendo crediti (194).
La domanda di credito pubblico, dunque, ebbe una notevole crescita lungo il Seicento, attirando capitali che altrimenti avrebbero trovato difficoltà ad essere impiegati con analoghi rendimenti. Tuttavia la terra e il credito non furono gli unici settori nei quali si concentrarono le attenzioni e i denari dei Veneziani: alcune attività commerciali e industriali ravvivarono l'interesse degli operatori di Rialto. Abbiamo già visto quanto la manifattura e il commercio della seta - specie i tessuti auroserici - registrassero una certa vivacità nella Venezia seicentesca: ancora nel 1714 una vendita di seta rese a Piero Pisani oltre il 10 per cento del capitale investito nel giro di tre mesi. E un analogo profitto era stato fatto segnare per una partita di caffè qualche anno prima (195). Un ottimo investimento risultò essere altresì il commercio del legname: Alvise Sagredo e i Tiepolo, ad esempio, riuscirono a trarre consistenti guadagni da quest'attività (196). Occorrevano intraprendenza - forse più che in passato - e le giuste informazioni, ma le opportunità di impiegare denaro con soddisfacenti profitti non mancavano. Certo, le difficoltà esistevano, e la sensazione che altrove venissero offerti maggiori utili - come nel caso di quei Veneziani che investirono in Olanda nella Compagnia delle Indie Occidentali (197) - era per taluni versi giustificata; ma l'attenzione all'impiego redditizio del denaro non venne mai meno. La stessa Terraferma non rappresentò l'area dove costituire unicamente interessi fondiari da meri rentiers. La scelta di coltivare grano o riso era dettata anche da valutazioni di tipo mercantile; dopo un iniziale maggior investimento il secondo avrebbe reso almeno quattro volte più del tradizionale cereale Giallo (198). Varie cartiere nel Trevigiano, poi, vennero costruite con denaro di patrizi veneziani (199). Il problema è di valutare correttamente questi episodi in un quadro generale, tentare di capire la congiuntura ed i diversi aspetti, talvolta contraddittori, che la caratterizzano. Il sistema economico veneziano si era dovuto ristrutturare a seguito della potente spinta inferta dalla concorrenza "nordica" e del mutamento strutturale che si stava verificando nell'economia europea. Gli effetti furono il duro ridimensionamento delle attività tradizionali (commercio navale e lanificio, anzitutto) e il restringimento - spaziale e quantitativo - dell'area economica controllata dagli operatori veneziani. Nello stesso tempo si accentuò l'importanza della rendita agricola e del capitale finanziario: questi flussi d'entrata assicurarono un elevato tenore di vita ai ceti agiati e permisero un diffuso consumo di lusso che vivificò talune attività, mantenendo una domanda sostenuta anche in periodi difficili. La ristrutturazione dell'economia urbana, passato il periodo di piena maturità lungo il Cinquecento, condusse nel secolo successivo ad un sistema economico basato su specifici settori trainanti, per lo più rivolti al mercato di lusso, che comunque segnarono la vocazione di Venezia. Questo mutamento fu contrassegnato da indubbie complicazioni, ma tali difficoltà non provocarono un drastico impoverimento della città: le vie della ricchezza si fecero più impervie, ma Venezia continuò ad abbagliare i visitatori in virtù del suo ruolo di capitale e di un mercato che, nonostante la contrazione, rappresentava ancora un punto di riferimento nell'area mediterranea.
* Un ringraziamento ad Andrea Zannini per le sue osservazioni, e ad Alessandra De Lorenzi per il vivace confronto.
Per un ampio quadro si v. Immanuel Wallerstein, Il sistema mondiale dell'economia moderna, II, Il mercantilismo e il consolidamento dell'economia-mondo europea, 1600-2750, Bologna 1982.
Cit. da Domenico Sella, Commerci e industrie a Venezia nel secolo XVII, Venezia - Roma 1961, p. 70.
3. Il saldo migratorio è stato calcolato in base all'equazione (I-E)=Pt-Po-(N-M) dove I è l'immigrazione, E l'emigrazione, Pt la popolazione successiva ad un determinato momento Po, N le nascite e M le morti. Pertanto il flusso d'entrata o uscita è dato dalla differenza nel numero della popolazione in due diversi momenti meno il suo saldo naturale (differenza tra nati e morti). L'andamento delineato nella Tab. 1 è sostanzialmente diverso da quello proposto da Richard T. Rapp, Industria e decadenza economica a Venezia nel XVII secolo, Roma 1986, pp. 57 ss., poiché l'autore si basa fortemente sulle cifre, erronee, di un censimento del 1655. Cf. le osservazioni critiche di John A. Marino, La crisi economica di Venezia e la New Economic Histoy, "Studi Storici", 19, 1978, pp. 79-107. Un'accurata discussione delle fonti demografiche veneziane in Giovanna Favero - Maria Moro - Pierpaolo Spinelli - Francesca Trivellato - Francesco Vianello, Le anime dei demografi. Fonti per la rilevazione dello stato della popolazione di Venezia nei secoli XVI e XVII, "Bollettino di Demografia Storica", 15, 1992, pp. 23-110. Per alcuni dati demografici di aree limitrofe, Mirto Etonti, Per una storia demografica della podesteria di Murano nei secoli XVII e XVIII, "Studi Veneziani", n. ser., 9, 1985, pp. 199-226; Sergio Perini, Il movimento demografico a Chioggia nel XVII secolo, ibid., 20, 1990, pp. 357-375.
4. Domenico Sella, The Rise and Fall of the Venetian Woollen Industry, in Crisis and Change in the Venetian Economy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, a cura di Brian Pullan, London 1968, pp. 110, 116 (pp. 106-126).
5. I dati sono esposti in Andrea Zannini, Flussi d'immigrazione e strutture sociali urbane. Il caso dei bergamaschi a Venezia, "Bollettino di Demografia Storica", 19, 1993, p. 213 (pp. 207-215).
6. Andrea Vianello, L'arte dei calegheri e zavateri di Venezia tra XVII e XVIII secolo, Venezia 1993, p. 70.
7. Giovanni Levi, Come Torino soffocò il Piemonte. Mobilità della popolazione e rete urbana nel Piemonte del Sei-Settecento, in Id., Centro e periferia di uno stato assoluto. Tre saggi su Piemonte e Liguria in età moderna, Torino 1985, pp. 11-69.
8. Jan de Vries, European Urbanization 1500-1800, Cambridge (Mass.) 1984, pp. 154-158 in particolare per i calcoli del potenziale urbano.
9. Athos Bellettini, Crisi demografiche del Seicento, ora in Id., La popolazione italiana. Un profilo storico, Torino 1987, pp. 58-59 (pp. 53-93).
10. Si v. l'aggiornato saggio di Renzo Paolo Corritore, Il processo di "ruralizzazione" in Italia nei secoli XVII-XVIII. Verso una regionalizzazione, "Rivista di Storia Economica", 10, 1993, pp. 353-386.
11. Classica l'interpretazione della crisi italiana fornita, oramai nel 1952, da Carlo M. Cipolla, Il declino economico dell'Italia, ora in Id., Saggi di storia economica e sociale, Bologna 1988, pp. 69-86.
12. Paul M. Hohenberg - Lynn H. Lees, Urban Decline and Regional Economies: Brabant, Castile, and Lombardy, 1550-1750, "Comparative Studies in Society and History", 31, 1989, pp. 450-455 (pp. 439-461); e Idd., La città europea dal Medioevo a oggi, Roma-Bari 1987, pp. 108-139.
13. Cf. il quadro tracciato da Salvatore Ciriacono, The Venetian Economy and Its Place in the World Economy of the 17th and 18th Centuries. A Comparison with the Low Countries, in The Early-Modern World-System in Geographical Perspective, a cura di Hans-Jürgen Nitz, Stuttgart 1993, pp. 120-135.
14. P.M. Hohenberg - L.H. Lees, La città europea, p. 228; Carlo M. Cipolla, Storia economica dell'Europa pre-industriale, Bologna 19752, pp. 16-17.
15. Robert C. Davis, Shipbuilders of the Venetian Arsenal. Workers and Workplace in the Preindustrial City, Baltimore 1991, pp. 102-104.
16. Per quanto riguarda la carne di manzo, è stato stimato che nel primo Seicento a Venezia se ne consumassero circa 21 kg pro capite all'anno. Cf. Salvatore Ciriacono, Acque e agricoltura. Venezia, l'Olanda e la bonifica europea in età moderna, Milano 1994, p. 88, che riporta una stima di V. Zimàny. Sul problema dei rifornimenti bovini a Venezia cf. Ugo Tucci, L'Ungheria e gli approvvigionamenti di bovini nel Cinquecento, in Rapporti veneto-ungheresi all'epoca del Rinascimento, a cura di Tibor Klaniczay, Budapest 1975, pp. 153-171; e in generale, Ian Blanchard, The Continental European Cattle Trades, 1400-1600, "Economic History Review", 39, 1986, pp. 427-460.
17. Questa valutazione è proposta da Giorgio Doria, La gestione del porto di Genova dal 1550 al 1789, in Il sistema portuale della Repubblica di Genova. Profili organizzativi e politica gestionale (secc. XII-XVIII), a cura di Id. - Paola Massa Piergiovanni, Genova 1988, p. 139 n. (pp. 137-197). Mauro Agnoletti, Aspetti tecnici ed economici del commercio del legname in Cadore (XIV-XV1 secolo), in L'uomo e la foresta, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Firenze 1996, p. 1030 (pp. 1025-1039), stima in almeno 58.000 mc il legname necessario per la costruzione nell'Arsenale veneziano di 135 galere sottili e 8 grosse nel 1602. Quanto al consumo di carbone in città, v. una memoria di fine Settecento riportata da Francesco Vecchiato, Tensioni sociali nelle corporazioni di Venezia a fine Settecento, in Venezia e l'Europa. Soldati, mercanti e riformatori, a cura di Id., Verona 1994, p. 193 (pp. 185-220).
18. Anche in questo caso sono costretto a basarmi su valutazioni relative ad altri ambiti. Il 73,5 per cento delle spese di una famiglia operaia di Anversa a fine Cinquecento era destinato all'acquisto di cibo: cf. Jan A. van Houtte - Leon van Buyten, The Low Countries, in An Introduction to the Sources of European Economic History 1500-1800, a cura di Charles Wilson - Geoffrey Parker, London 1977, pp. 111-112 (pp. 81-114). Secondo uno scrittore spagnolo del primo Seicento, il costo per l'alimentazione superava di poco più della metà il bilancio di un tipico consumatore povero (Henry Kamen, Spain in the Later Seventeenth Century, 1665-1700, London 1980, pp. 165-166). Il problema dei consumi risulta assai complesso, ma nello stesso tempo crediamo sia fondamentale affrontarlo per tentare di comprendere un sistema economico nella sua globalità. La miglior puntualizzazione metodologica - a nostro parere - è stata fornita da Jan de Vries, Between Purchasing Power and the World of Goods: Understanding the Household Economy in Early Modern Europe, in Consumption and the World of Goods, a cura di John Brewer - Roy Porter, London 1993, pp. 85-132.
19. A. Vianello, L'arte dei calegheri, p. 45.
20. Giovanni Levi, Comportements, ressources, procès: avant la "révolution" de la consommation, in Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience, a cura di Jacques Revel, Paris 1996, p. 204 (pp. 187-207), con interessanti osservazioni di carattere generale.
21. Giuseppe Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta. Storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro vicende patrimoniali tra 1705 e 1836, Roma 1984, pp. 146, 204.
22. Anche in questo caso procedo per analogia. Il notaio veronese Folognino spese negli anni 1653-1657 il 47,3 per cento del proprio budget in conto vitto (Amelio Tagliaferri, Consumi e tenore di vita di una famiglia borghese del '600, Milano 1968, p. 58). La nobile famiglia fiorentina dei Riccardi tra Sei e Settecento destinava il 23 per cento delle proprie spese al vitto (Paolo Malanima, I Riccardi di Firenze. Una famiglia e un patrimonio nella Toscana dei Medici, Firenze 1977, p. 255). Il 32,4 per cento delle spese correnti di Lorenzo Strozzi sostenute dal 1595 al 1670 riguardavano l'alimentazione (Adam Manikowski, Economic Aspects of the Cultural Patronage of a Florentine Aristocratic Family in the 17th Century, relazione tenuta alla XVII settimana di studio dell'Istituto Datini dedicata a Gli aspetti economici del mecenatismo in Europa, sec. XIV-XVIII, Prato, 22 aprile 1985, p. 17 del dattiloscritto).
23. Antonio Menniti Ippolito, Fortuna e sfortune di una famiglia veneziana del Seicento. Gli Ottoboni al tempo dell'aggregazione al patriziato, Venezia 1996, p. 151.
24. La paga dei tessitori in R.T. Rapp, Industria e decadenza economica, p. 163.
25. Tenendo presente le molte festività, il salario giornaliero di fatto era di 29 soldi a fronte dei 40 per giornata lavorativa (R.C. Davis, Shipbuilders, p. 30).
26. Ivo Mattozzi - Francesco Bolelli - Carmen Chiasera - Daniela Sabbioni, Il politico e il pane a Venezia (1570-1650). Calmieri e governo della sussistenza, "Società e Storia", 6, 1983, pp. 280-281 (pp. 271-303). Articolo sul quale mi baserò ampiamente in seguito.
27. Da uno staio di grano (ovvero circa 63 kg) si otteneva mezzo quintale di pane. Cf. Ivo Mattozzi, Il politico e il pane a Venezia (1570-1650). Le tariffe dei calmieri: semplici prontuari contabili o strumenti di politica annonaria?, "Studi Veneziani", n. ser., 7, 1983, p. 201 (pp. 197-220).
28. Luciano Pezzolo, Uomini e istituzioni tra una città soggetta e Venezia: Vicenza 1630-1797, in AA.VV., Storia di Vicenza, III, 1, L'età della Repubblica veneta (1404-1797), Vicenza 1989, pp. 139-141 (pp. 115-146).
29. Cf. il provvedimento adottato dal senato a favore di Belluno in A.S.V., Senato, Terra, reg. 98, cc. 436v-437 (24 febbraio 1628).
30. Elena Papagna, Grano e mercanti nella Puglia del Seicento, Bari 1990, pp. 52, 141. Un tomolo era pari a 40 kg. Sull'importanza della Sicilia come "isola del grano" ancora addentro al Seicento, Fernand Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, I, Torino 1976, p. 652. Quanto a Senigallia, su 14 imbarcazioni di cui si conosce la destinazione negli anni 1688-1689 nessuna raggiunse Venezia (Renzo Paci, Rese, commercio ed esportazione dei cereali nella Legazione d'Urbino nei secoli XVII e XVIII, "Quaderni Storici", 10, 1975, p. 113 [pp. 87-150]). Cf. anche Giovanni Zalin, Un singolare contratto per il rifornimento granario di Venezia agli inizi del '600, "Economia e Storia", 16, 1969, pp. 153-173.
31. Maurice Aymard, Venise, Raguse et le commerce du blé pendant la seconde moitié du XVIe siècle, Paris 1966, dimostra come a fine Cinquecento le esigenze cerealicole di Venezia venissero in gran parte soddisfatte dalla produzione locale.
32. Ugo Tucci, Commercio e consumo del vino a Venezia in età moderna, in AA.VV., Il vino nell'economia e nella società italiana medioevale e moderna, Firenze 1989 (Quaderni della Rivista di Storia dell'Agricoltura, 1), pp. 185-186 (pp. 185-202). Gian Maria Varanini, Mercato subregionale ed economie di distretto nella Terraferma veneta: il commercio del vino, in Id., Comuni cittadini e Stato regionale. Ricerche sulla Terraferma veneta nel Quattrocento, Verona 1992, p. 178 (pp. 163-181) stima in 4 ettolitri il consumo medio annuo nel tardo Medioevo.
33. David R. Ringrose, Madrid and the Spanish Economy, 1560-1850, Berkeley (Calif.) 1983, p. 119; Fernand Braudel, Capitalismo e civiltà materiale (secoli XV-XVIII), Torino 1977, p. 172; Carlo M. Cipolla, Contributo alla storia dei consumi e del costo della vita in Lombardia agli inizi dell'età moderna, ora in Id., Saggi di storia economica e sociale, Bologna 1988, p. 93 (pp. 87-112); Gabriella Sivori Porro, Costi di costruzione e salari edili a Genova nel secolo XVII, "Atti della Società Ligure di Storia Patria", n. ser., 29, 1989, p. 402 (pp. 341-423). A titolo puramente indicativo si rammenta che è stato stimato un consumo medio di 1,2 litri di birra per un contadino polacco del Cinquecento (Andrzej Wyczanski, La consommation alimentaire en Pologne aux XVIe et XVIIe siècles, Paris 1985, p. 142). Occorre tener presente, comunque, che l'apporto calorico della birra è inferiore di circa un terzo rispetto al vino (420 calorie contro 650).
34. Fernand Braudel - Frank C. Spooner, I prezzi in Europa dal 1450 al 1750, in Storia economica Cambridge, IV, L'espansione economica dell'Europa nel Cinque e Seicento, a cura di Edwin E. Rich - Charles H. Wilson, Torino 1975, p. 479 (pp. 436-562).
35. Su tutta la questione dell'olio cf. Ivo Mattozzi, Crisi, stagnazione e mutamento nello Stato veneziano sei-settecentesco: il caso del commercio e della produzione olearia, "Studi Veneziani", n. ser., 4, 1980, pp. 199-276. Ulteriori informazioni, sul versante del mercato inglese, si trovano in Gigliola Pagano De Divitiis, Mercanti inglesi nell'Italia del Seicento. Navi, traffici, egemonie, Venezia 1990, pp. 163 ss.
36. G. Pagano De Divitiis, Mercanti inglesi, pp. 47, 173. Nel 1668 a Venezia furono importate 6.256 tonnellate (10.862 miara) d'olio (I. Mattozzi, Crisi, stagnazione, p. 250): un quantitativo notevole, che porrebbe sotto una luce diversa il confronto con Londra. La difficoltà di comparare misure assai diverse, tuttavia, per ora consiglia di non abbandonarsi ad affrettate conclusioni.
37. Tuttavia vi fu ancora qualche piccolo spazio per il traffico veneziano, se è vero che la documentazione doganale londinese registra due imbarcazioni veneziane che sbarcarono merci e olio nel 1672; Calendar of Treasury Books, III, pt. 2, London 1908, p. 1306 (9 settembre 1672).
38. Ugo Tucci, Venezia nel Cinquecento: una città industriale?, in Crisi e rinnovamenti nell'autunno del Rinascimento a Venezia, a cura di Vittore Branca - Carlo Ossola, Firenze 1991, pp. 61-83.
39. R.T. Rapp, Industria e decadenza economica, pp. 128-129.
40. Walter Panciera, "L'arte matrice". I lanifici della Repubblica di Venezia nei secoli XVII e XVIII, Treviso 1996, p. 345.
41. Paolo Malanima, La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII, Bologna 1982, pp. 293, 295, 304.
42. Domenico Sella, L'economia lombarda durante la dominazione spagnola, Bologna 1982, pp. 101-102, 133 ss., 151; Giovanni Vigo, Il declino economico di una città: Como nel Seicento, "Rivista Milanese di Economia", 37, 1991, pp. 112-126.
43. I dati milanesi in Aldo De Maddalena, Prezzi e aspetti di mercato in Milano durante il secolo XVII, Milano 1949, pp. 117-123, 178. Dati sui prezzi della lana pugliese in John A. Marino, L'economia pastorale nel Regno di Napoli, Napoli 1992, pp. 476-482. Sul comportamento, non sempre univoco, del prezzo dei tessuti in Europa, F. Braudel - F.C. Spooner, I prezzi in Europa, pp. 490-494. R.T. Rapp, Industria e decadenza economica, p. 185, afferma che il prezzo medio per panno di lana nel periodo 1588-1630 fu di 79 ducati. Nel 1648 il senato acquistò una fornitura di panni alti a 14 lire il braccio, vale a dire 126 ducati: A.S.V., Senato, Zecca, filza 65 (18 gennaio 1648). Una pezza di lana corrispondeva a 56 braccia (D. Sella, Commerci e industrie, p. 119).
44. Nel 1656 appena un decimo dei panni prodotti a Venezia non fu esportato (R.T. Rapp, Industria e decadenza economica, p. 67).
45. L'esposizione classica del modello è in Ernest Labrousse, La crise de l'économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution, Paris 1944. Cf. anche Wilhelm Abel, Congiuntura agraria e crisi agrarie. Storia dell'agricoltura e della produzione alimentare nell'Europa centrale dal XIII secolo all'età industriale, Torino 1976, pp. 20-27; Pierre Vilar, Réflexions sur la "crise de l'ancien type", "inégalité des récoltes" et "sous développement", in AA.VV., Conjoncture économique, structures sociales. Hommage à Ernest Labrousse, Paris-La Haye 1974, pp. 37-48; e Peter Kriedte, Peasants, Landlords and Merchant Capitalists. Europe and the World of Economy, 1500-1800, Cambridge 1983, pp. 10-11.
46. Cf. i dati in W. Panciera, "L'arte matrice", pp. 340, 342.
47. Ibid., p. 356.
48. Ennio Concina, Venezia nell'età moderna. Strutture e funzioni, Venezia 1989, p. 68.
49. R.T. Rapp, Industria e decadenza economica, p. 158; Salvatore Ciriacono, Olio ed ebrei nella Repubblica veneta del Settecento, Venezia 1975, p. 20.
50. D. Sella, Commerci e industrie, p. 133; S. Ciriacono, Olio ed ebrei, p. 20
51. I. Mattozzi, Crisi, stagnazione, p. 231.
52. Cf. Gabriella Sivori, Il tramonto dell'industria serica genovese, "Rivista Storica Italiana", 84, 1972, pp. 893-944; D. Sella, L'economia lombarda, pp. 102-103; P. Malanima, La decadenza di un'economia, pp. 314-315; Id., L'economia italiana nel Seicento, in AA.VV., Storia della società italiana, XI, La Controriforma e il Seicento, Milano 1989, pp. 164-168 (pp. 149-188); G. Pagano De Divitiis, Mercanti inglesi, pp. 152-161; Salvatore Ciriacono, Silk Manufacturing in France and Italy in the XVIIth Century: Two Models Compared, "Journal of European Economic History", 10, 1981, pp. 167-199.
53. G. Pagano De Divitiis, Mercanti inglesi, pp. 155-156.
54. Cit. da Jean Georgelin, Venise au siècle des lumières, Paris - La Haye 1978, p. 148.
55. L'affermazione è riportata da R.T. Rapp, Industria e decadenza economica, p. 46. Nel 1631 si affermava che a Venezia vi erano circa 10.000 tessitori di panni di seta (Gigi Corazzol, Livelli stipulati a Venezia nel 1591. Studio storico, Pisa 1986, p. 129). Nel 1681 il console Le Blond stimava che nel settore auroserico veneziano fossero interessati 3.000 lavoratori (J. Georgelin, Venise au siècle des lumières, p. 148).
56. S. Ciriacono, Silk Manufacturing, p. 180, per Nîmes.
57. Sulla partecipazione di Fiorentini in commerci connessi alle seterie, José-Gentil da Silva, Banque et crédit en Italie au XVIIe siècle, I, Paris 1969, pp. 106-109.
58. La quantità di seta grezza prodotta nella Repubblica di Venezia per l'esportazione crebbe da 450.000 libbre a fine Seicento sino a oltre 1 milione verso la metà del secolo successivo (S. Ciriacono, Silk Manufacturing, p. 198). Cf. anche Carlo Poni, Archéologie de la fabrique: la diffusion des moulins à soie "alla bolognese" dans les Etats vénitiens du XVIe au XVIIIe siècle, "Annales E.S.C.", 27, 1972, nr. 6, pp. 1475-1496.
59. Luciano Pezzolo, Fiscalità e congiuntura, 1630-1715, in AA.VV., Storia economica e sociale di Bergamo, di prossima pubblicazione.
60. Peter Musgrave, Land and Economy in Baroque Italy. Valpolicella, 1630-1797, Leicester - London 1992, pp. 172-173. La sericoltura registrò una lenta diffusione nel Friuli dalla fine del Seicento (Giovanni Zalin, Dalla bottega alla fabbrica. La fenomenologia industriale nelle province venete tra '500 e '700, Verona 1987, pp. 286-293).
61. Richard T. Rapp, Real Estate and Rational Investment in Early Modern Venice, "Journal of European Economic History", 8, 1979, pp. 269-290. Per le vicende di un altro mercante auroserico, Amelio Tagliaferri, In margine alla "decadenza" italiana: profitti e investimenti di una "compagnia di negozio" veneziana (1625-1740), in Prospettive nella storia dell'industria tessile veneta, fasc. monografico di "Studi e Ricerche", 4, 1972, pp. 63-134.
62. Roberto Sabbadini, L'acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (sec. XVII-XVIII), Udine 1995, pp. 35, 43, 171-173.
63. Cf. anche per quanto segue, Salvatore Ciriacono, L'economia regionale veneta in epoca moderna. Note a margine del caso bergamasco, in AA.VV., Venezia e la Terraferma. Economia e società, Bergamo 1989, pp. 43-76; Michael Knapton, City Wealth and State Wealth in Northeast Italy,14th-17th Centuries, in La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'état moderne (XIIe-XVIIIe siècles), a cura di Neithard Bulst - Jean-Philippe Genet, Paris 1988, pp. 183-209; G.M. Varanini, Mercato subregionale ed economie di distretto, pp. 163 ss.
64. Paul F. Grendler, L'Inquisizione romana e l'editoria a Venezia 1540-1605, Roma 1983; Tiziana Pesenti, Stampatori e letterati nell'industria editoriale a Venezia e in Terraferma, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 4/I, Il Seicento, Vicenza 1983, pp. 93-129; Mario Infelise, L'editoria veneziana nel '700, Milano 1989; Ivo Mattozzi, "Mondo del libro" e decadenza a Venezia (1570-1730), "Quaderni Storici", n. ser., 24, 1989, pp. 743-786.
65. Per quanto segue, M. Infelise, L'editoria veneziana, p. 10.
66. I. Mattozzi, "Mondo del libro", p. 751.
67. Media in base alle cifre fornite da Paolo Ulvioni, Stampa e censura a Venezia nel Seicento, "Archivio Veneto", 106, 1975, pp. 57, 67, 68-69 (pp. 45-93).
68. Calcoli in base ai dati di M. Infelise, L'editoria veneziana, p. 36.
69. Ibid., p. 26.
70. I. Mattozzi, "Mondo del libro", pp. 751 ss.
71. Cf. i dati in Daniele Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Padova 1954, p. 35; e in E. Concina, Venezia nell'età moderna, p. 185. Ho corretto alcuni errori di datazione in entrambi.
72. Ruggiero Romano, La storia economica. Dal secolo XIV al Settecento, in Storia d'Italia, a cura di Id. - Corrado Vivanti, II, 2, Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII, Torino 1974, p. 1912 (pp. 1811-1931).
73. Emilio Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari 1961, p. 252. La stima di Sereni non affronta questioni delicate, quali la differenza tra erezione ex novo e ristrutturazione degli edifici e il significato di "interesse artistico".
74. Giuseppe Gullino, Quando il mercante costruì la villa: le proprietà dei Veneziani nella Terraferma, in Storia di Venezia, VI, Dal Rinascimento al Barocco, a cura di Gaetano Cozzi - Paolo Prodi, Roma 1994, pp. 894, 916 (pp. 875-924).
75. Cf. i dati in Giovanni Caniato, Arte dei mureri, in Le arti edili a Venezia, a cura di Id. - Michela Dal Borgo, Roma 1990, p. 124 (pp. 117-140).
76. D. Beltrami, Storia della popolazione, pp. 35-36. Altri dati in E. Concina, Venezia nell'età moderna, pp. 194-195.
77. Cf. E. Concina, Venezia nell'età moderna, pp. 120-121.
78. Laura Megna, Comportamenti abitativi del patriziato veneziano (1582-1740), "Studi Veneziani", n. ser., 22, 1991, pp. 312-313 (pp. 253-323).
79. V. le ottime ricerche di Richard A. Goldthwaite, La costruzione della Firenze rinascimentale. Una storia economica e sociale, Bologna 1984; e di Giorgio Doria, Investimenti della nobiltà genovese nell'edilizia di prestigio (1530-1630), "Studi Storici", 27, 1986, pp. 5-55; nonché Lawrence Stone, Family and Fortune. Studies in Aristocratic Finance in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Oxford 1973, pp. 62-91.
80. Il documento è riportato da Giorgio Gianighian, Appunti per una storia del cantiere a Venezia (secoli XVI-XVIII), in Le arti edili a Venezia, a cura di Giovanni Caniato - Michela Dal Borgo, Roma 1990, pp. 251-252 (pp. 237-256).
81. Elena Bassi, Tre palazzi veneziani della Regione Veneto, Venezia 1982, p. 198; Ead., Ca' Flangini e Ca' Morosini sul Canal Grande a San Moisè, in AA.VV., Palazzo Ferro Fini. La storia, l'architettura, il restauro, Venezia 1989, pp. 28, 41 (pp. 25-81).
82. Ugo Tucci, Carriere popolane e dinastie di mestiere a Venezia, in Gerarchie economiche e gerarchie sociali, secoli XII-XVIII, a cura di Annalisa Guarducci, Firenze 1990, p. 820 (pp. 817-851).
83. R. Sabbadini, L'acquisto della tradizione, pp. 152-153.
84. Gli esempi sono tratti da Andrea Da Mosto, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Firenze 1977, pp. 376, 387, 399, 438, 449, 458.
85. E. Bassi, Tre palazzi veneziani, p. 20.
86. Maria Antonietta Visceglia, I consumi in Italia in età moderna, in Storia dell'economia italiana, a cura di Ruggicro Romano, II, Torino 1991, p. 213 (pp. 211-241). Un'ampia trattazione in Richard A. Goldthwaite, Wealth and the Demand for Art in Italy, 1300-1600, Baltimore 1993.
87. Per questi dati, Frederic C. Lane, Il naviglio veneziano nella rivoluzione commerciale, in Id., Le navi di Venezia fra i secoli XIIIe XVI, Torino 1983, p. 20 (pp. 3-23); Ugo Tucci, La marina mercantile veneziana nel Settecento, "Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano", 2, 1960, pp. 164, 167 (pp. 155-200).
88. Calendar of State Papers, Venetian, XXVII, London 1926, p. 233 (16 gennaio 1646).
89. R.C. Davis, Shipbuilders, p. 81.
90. Ibid.
91. Raffaello Vergani, Le materie prime, in Storia di Venezia, Temi, Il Mare, a cura di Alberto Tenenti - Ugo Tucci, Roma 1991, pp. 297, 302 (pp. 285-312).
92. Marcello Forsellini, L'organizzazione economica dell'Arsenale di Venezia nella prima metà del Seicento, "Archivio Veneto", ser. V, 7, 1930, p. 73 (pp. 54-117).
93. Cf. i dati di Raffaello Vergani, Gli inizi dell'uso della polvere da sparo nell'attività mineraria: il caso veneziano, "Studi Veneziani", n. ser., 3, 1979, p. 134 (pp. 97-140).
94. Michel Morineau, Flottes de commerce et trafics français en Méditerranée au XVIIe siècle (jusqu'en 1669), "XVIIe Siècle", 86-87, 1970, pp. 156, 157 (pp. 135-171).
95. Domenico Sella, Il declino dell'emporio realtino, in AA.VV., La civiltà veneziana nell'età barocca, Firenze 1959, p. 113 (pp. 99-121).
96. La stima in Giuseppe Felloni, Profilo di storia economica dell'Europa dal medioevo all'età contemporanea, Torino 1993, p. 194.
97. Sui rapporti economici tra Italia e Province Unite, Antonella Bicci, Gli olandesi nel Mediterraneo: Amsterdam e l'Italia (sec. XVII), in AA.VV., Economies méditerranéennes: équilibres et intercommunications, XIIIe-XIXe siècles, I, Athènes 1985, pp. 39-76.
98. Francis W. Carter, The Commerce of the Dubrovnik Republic, 1500-1700, "Economic History Review", 24, 1971, pp. 387, 393-394 (pp. 370-394); Jorio Tadic, Le commerce en Dalmatie et à Raguse et la décadence économique de Venise au XVIIème siècle, in AA.VV., Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII, Venezia-Roma 1961, pp. 237-274; Renzo Paci, La "scala" di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani fra Cinque e Seicento, Venezia, 1971, pp. 71 ss.; Sergio Anselmi, Venezia, Ragusa, Ancona tra Cinque e Seicento. Un momento della storia mercantile del Medio Adriatico, Ancona 1969.
99. Dati sulle quantità di merci trasportate da Spalato a Venezia in J. Tadic, Le commerce en Dalmatie, pp. 260-262, e in R. Paci, La "scala" di Spalato, pp. 94-96.
100. S. Anselmi, Venezia, Ragusa, Ancona, pp. 50-53.
101. G. Pagano De Divitiis, Mercanti inglesi, p. 133.
102. Cf. i dati sul traffico portuale in Edoardo Grendi, Pauperismo e Albergo dei Poveri nella Genova del Seicento, e Traffico e navi nel porto di Genova tra 1500 e 1700, entrambi ripubblicati in Id., La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio fra Cinque e Seicento, Bologna 1987, pp. 228, e 309-364.
103. H. Kamen, Spain in the Later Seventeenth Century, p. 117.
104. Mancando una ricerca approfondita sull'argomento, v. alcuni dati in Artur Attman, American Bullion in the European World Trade 1600-1800, Göteborg 1986, pp. 38, 40; Michel Morineau, Incroyables gazettes et fabuleux métaux. Les retours des trésors américains d'après les gazettes hollandaises (XVIe XVIIIe siècles), Paris-Cambridge 1985, pp. 301, 302; Giorgio Doria, Conoscenza del mercato e sistema informativo: il know-how dei mercanti-finanzieri genovesi nei secoli XVI e XVII, in La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, a cura di Aldo De Maddalena - Hermann Kellenbenz, Bologna 1986, pp. 70-71 (pp. 57-121); J.-G. da Silva, Banque et crédit, p. 171; Giulio Giacchero, Il Seicento e le Compere di San Giorgio, Genova 1979, p. 472. Poco o nulla si sa delle vie che presero i metalli preziosi una volta giunti a Genova; qualche cenno su arrivi a Venezia in A.S.V., Senato, Dispacci ambasciatori, Firenze, filza 45 (5 maggio 1631); e in Fernand Braudel, Note sull'economia del Mediterraneo nel XVII secolo, "Economia e Storia", 2, 1955, p. 131 (pp. 117-142).
105. Una stima prudenziale indica in 8-10 milioni di lire genovesi il valore delle merci importate annualmente nel porto di Genova agli inizi del Seicento, mentre a metà secolo il volume del traffico con Spagna, Portogallo e "Indie" era attorno a 11 milioni e mezzo (G. Doria, La gestione del porto, p. 142).
106. Calendar of State Papers, Venetian, XXVII, p. 265 (27 giugno 1646).
107. Per quanto segue v. l'interessante articolo di Jonathan Israel, The Phase of the Dutch Straatvaart (1590-1713). A Chapter in the Economic History of the Mediterranean, "Tijdschrift voor Geschiedenis", 99, 1986, pp. 1-30. V. anche Charles Carrière, La draperie languedocienne dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Contribution à l'étude de la conjoncture levantine, in AA.VV., Conjoncture économique, structures sociales. Hommage à Ernest Labrousse, Paris-La Haye 1974, pp. 157-172.
108. Giorgio Vercellin, Mercanti turchi e sensali a Venezia, "Studi Veneziani", n. ser., 4, 1980, p. 48 (pp. 45-78); U. Tucci, La marina mercantile, p. 162.
109. Frank C. Spooner, Risks at Sea. Amsterdam Insurance and Maritime Europe, 1766-1780, Cambridge 1983, p. 178.
110. D. Beltrami, Storia della popolazione, pp. 50, 213.
111. Alcuni cenni sulla funzione di Venezia nel quadro della rete di pagamenti controllata dagli Ebrei portoghesi si trovano in Janzes C. Boyajian, Portuguese Bankers at the Court of Spain 1626-1650, New Brunswick (N.J.) 1983, pp. 74, 83-84, 89, 93.
112. The Manuscripts of Allan George Finch, II, London 1922, p. 91 (dispaccio da Pera, 12-26 novembre 1680). Sul ruolo degli Ebrei nell'economia veneziana del Seicento purtroppo manca una specifica ricerca; qualche elemento emerge dalla lettura de Gli Ebrei e Venezia, secoli XIV-XVIII, a cura di Gaetano Cozzi, Milano 1987, specie il contributo di Jonathan Israel, The Jews of Venice and Their Links with Holland and with Dutch Jewry (1600-1710), pp. 95-116. V. anche il recente libro di Benjamin Arbel, Trading Nations. Jews and Venetians in the Early Modern Eastern Mediterranean, Leiden 1995, incentrato sul Cinquecento.
113. R. Paci, La "scala" di Spalato, p. 120; e Jonathan Israel, Gli Ebrei d'Europa nell'età moderna (1550-1750), Bologna 1991, pp. 215-216, per la funzione economica.
114. Nicolás Broens, Monarquía y capital mercantil: Felipe IV y las redes comerciales portuguesas (1627-1635), Madrid 1989, p. 40.
115. Sulle dicerie che circolavano a Venezia circa la consistenza del patrimonio di Galli - tra 800.000 e 1 milione di ducati - cf. A. Menniti Ippolito, Fortuna e sfortune, p. 101.
116. Tra il 1646 e il 1718 su 128 famiglie aggregate ben 73 (57 per cento) provenivano dall'ambiente mercantile, seppure non sempre veneziano. Cf. R. Sabbadini, L'acquisto della tradizione, pp. 33 ss.
117. Per quanto riguarda i principali studi sulla questione, cf. i vari contributi in AA.VV., Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII, Venezia-Roma 1961; Crisis and Change in the Venetian Economy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, a cura di Brian Pullan, London 1968; D. Sella, Commerci e industrie; Alberto Tenenti, Venezia e i corsari, 1580-1615. Bari 1961; R.T. Rapp, Industria e decadenza economica; Id., The Unmaking of the Mediterranean Trade Hegemony: International Trade Rivalry and the Commercial Revolution, "Journal of Economic History", 34, 1975, pp. 499-525.
118. D'obbligo è il rinvio al classico F. Braudel, Civiltà e imperi, che per alcuni versi riprende alcune ipotesi di Frederic C. Lane, The Mediterranean Spice Trade: Further Evidence of Its Revival in the Sixteenth Century, pubblicato nel 1940 e riedito in Crisis and Change in the Venetian Economy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, a cura di Brian Pullan, London 1968, pp. 47-58. Non sembra, comunque, che Braudel nel redigere la sua grande opera fosse venuto a conoscenza dell'articolo di Lane (Ruggiero Romano, Braudel e noi. Riflessioni sulla cultura storica del nostro tempo, Roma 1995, p. 41). V. anche Gino Luzzatto, La decadenza di Venezia dopo le scoperte geografiche nella tradizione e nella realtà, "Archivio Veneto", ser. V, 54, 1954, pp. 162-181.
119. Alcuni dati sui costi di imbarcazioni veneziane e straniere a fine Cinquecento in A. Tenenti, Venezia e i corsari, p. 124. Sulla superiorità navale olandese, I. Wallerstein, Il sistema mondiale, pp. 69-70.
120. D. Sella, Commerci e industrie, p. 44 n.
121. Cf. le cifre in M. Forsellini, L'organizzazione economica, p. 115.
122. V. quanto emerge da Branislava Tenenti, I tassi assicurativi sulla piazza di Venezia: secc. XVI-XVII, "Studi Veneziani", n. ser., 10, 1985, pp. 43-54 (pp. 15-55); F.C. Spooner, Risks at Sea, pp. 46-47, 78, 96 ss., 190; e Jean Delumeau, Exploitation d'un dossier d'assurances maritimes du XVIIe siècle, in AA.VV., Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel, II, Toulouse 1973, p. 144 (pp. 135-163).
123. Alberto Tenenti, L'assicurazione marittima, in Storia di Venezia, Temi, Il Mare, a cura di Id. - Ugo Tucci, Roma 1991, p. 684 (pp. 663-686).
124. F.C. Lane, Il naviglio veneziano, pp. 18-21; Id., Navires et constructeurs à Venise pendant la Renaissance, Paris 1965, pp. 215-216.
125. J. Israel, The Phase of the Dutch Straatvaart, pp. 12-13; Id., Spanish Wool Exports and the European Economy, 1610-40, "Economic History Review", 33, 1980, pp. 202-203 (pp. 193-211).
126. J.A. Marino, L'economia pastorale nel Regno di Napoli, pp. 391, 393, 395-397.
127. F.W. Carter, The Commerce of the Dubrovnik Republic, pp. 382-383.
128. D. Sella, The Rise and Fall, pp. 121-125.
129. Cf. il quadro offerto da C.M. Cipolla, Il declino economico, pp. 69-86.
130. R.T. Rapp, Industria e decadenza economica, pp. 18-20, 211-215.
131. Ibid., pp. 150-152; e Salvatore Ciriacono, Mass Consumption Goods and Luxury Goods: the De-Industrialization of the Republic of Venice from the Sixteenth to the Eighteenth Century, in The Rise and Decline of Urban Industries in Italy and in the Low Countries (Late Middle Ages - Early Modem Times), a cura di Hermann van der Wee, Leuven 1988, pp. 49-50 (pp. 41-61).
132. W. Panciera, "L'arte matrice", pp. 45 ss.
133. Frederic C. Lane, Storia di Venezia, Torino 1978, pp. 186 ss.; D. Sella, Commerci e industrie, pp. 84-86.
134. Salvatore Ciriacono, Per una storia dell'industria di lusso in Francia. La concorrenza italiana nei secoli XVI e XVII, "Ricerche di Storia Sociale e Religiosa", 14, 1978, pp. 186-187 (pp. 181-202). Un cenno ai mercati del vetro veneziano in Charles-Louis de Montesquieu, Viaggio in Italia, a cura di Giovanni Macchia - Massimo Colesanti, Roma-Bari 1995, p. 13.
135. Cf. la rassegna di Tommaso Fanfani, Le corporazioni nel Centro-Nord della Penisola: problemi interpretativi, "Studi Storici Luigi Simeoni", 41, 1991, pp. 23-48; e, per il comparto laniero veneziano, W. Panciera, "L'arte matrice", p. 116.
136. I. Mattozzi, "Mondo del libro", pp. 777, 780.
137. R.T. Rapp, Industria e decadenza economica, p. 173.
138. Cf. Jan de Vries, An Inquiry into the Behavior of Wages in the Dutch Republic and the Southern Netherlands from 1580 to 1800, in Dutch Capitalism and World Capitalism/Capitalisme hollandais et capitalisme mondial, a cura di Maurice Aymard, Cambridge-Paris 1982, p. 44 (pp. 37-61).
139. Cf. i dati presentati da Henry Phelps Brown - Sheila V. Hopkins, Builders' Wage-Rates, Prices and Population: Some Further Evidence, "Economica", n. ser., 26, 1959, p. 21 (pp. 18-38). Altri confronti in Christian Vandenbroeke, The Regional Economy of Flanders and Industrial Modernization in the Eighteenth Century: a Discussion, "Journal of European Economic History", 16, 1987, pp. 164-165 (pp. 149-170).
140. Donald Woodward, Wage Rates and Living Standards in Pre-Industrial England, "Past and Present", 91, 1981, p. 45 (pp. 28-46), ma tutto il saggio è estremamente importante.
141. Cf. il quadro, valido anche per i secoli dell'età moderna, dato da Bronislaw Geremek, Salariati e artigiani nella Parigi medievale. Secoli XIII-XV, Firenze 1975, pp. 69 ss.
142. Jan de Vries, The Economy of Europe in an Age of Crisis, 1600-1750, Cambridge 1976, p. 183.
143. Ho stimato una popolazione di 1.688.000 nel 1607 e 1.714.000 nel 1625 (Amelio Tagliaferri, Ordinamento amministrativo dello Stato di Terraferma, in Venezia e la Terraferma attraverso le Relazioni dei Rettori, a cura di Id., Milano 1981, p. 41 [pp. 15-43]); le entrate sono esposte nella Tab. 24. Per il calcolo delle retribuzioni, Brian Pullan, Wage-Earners and the Venetian Economy, 1550-1630, in Crisis and Change in the Venetian Economy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, a cura di Id., London 1968, pp. 173-174 (pp. 146-174.). Per il confronto con la Francia, Michel Morineau, La conjoncture ou les cernes de la croissance, in Histoire économique et sociale de la France, a cura di Fernand Braudel - Ernest Labrousse, I, 1, Paysannerie et croissance, Paris 1977, p. 980 (pp. 869-1018); e altri dati in Philip Hoffman, Early Modern France, 1450-1700, in Fiscal Crises, Liberty, and Representative Government, 1450-1789, a cura di Id. - Kathryn Norberg, Stanford (Calif.) 1994, p. 238 (pp. 226-252).
144. I dati sull'Olanda si trovano in Jan de Vries - Adrian van der Woude, The First Moduli Economy. Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500-1815, consultato in dattiloscritto per l'edizione inglese. Sono state calcolate per il manovale veneziano 200 giornate lavorative annue.
145. L. Pezzolo, Fiscalità e congiuntura.
146. A.S.V., Ospedali e luoghi pii, b. 124, filza della Commissaria di Angelo degli Angeli.
147. P.M. Hohenberg - L.H. Lees, Urban Decline, pp. 450-455.
148. Cf. Angelo Moioli, Una grande azienda del Bergamasco durante i secoli XVII e XVIII, in Agricoltura e aziende agrarie nell'Italia centro-settentrionale (secoli XVI-XIX), a cura di Gauro Coppola, Milano 1983, pp. 599-724. Si tratta dell'unica serie storica - per quanto ci risulta - che offra dati su rendite agrarie nello Stato veneto nel lungo periodo. Alcuni dati sull'Italia settentrionale sono stati raccolti in Luciano Pezzolo, Elogio della rendita. Sul debito pubblico degli Stati italiani nel Cinque e Seicento, "Rivista di Storia Economica", 12, 1995, p. 310 (pp. 283-330).
149. Cf. l'andamento tra Sei e Settecento di alcuni canoni fondiari dei Pisani dal Banco in G. Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta, pp. 567, 569-570, 574.
150. Id., Nobili di Terraferma e patrizi veneziani di fronte al sistema fiscale della campagna, nell'ultimo secolo della Repubblica, in Venezia e la Terraferma attraverso le Relazioni dei Rettori, a cura di Amelio Tagliaferri, Milano 1981, pp. 209-210 (pp. 203-225).
151. G. Gullino, Quando il mercante, pp. 898, 922.
152. Calcoli in base ai dati forniti da Id., I Pisani dal Banco e Moretta, pp. 54, 78.
153. Renzo Derosas, I Querini Stampalia. Vicende patrimoniali dal Cinque all'Ottocento, in AA.VV., I Querini Stampalia. Un ritratto di famiglia nel settecento veneziano, Venezia 1987, pp. 48-52 (pp. 43-87).
154. Cf., ad esempio, Peter Burke, Venezia e Amsterdam. Una storia comparata delle élites del XVII secolo, Ancona 1988, pp. 150 ss.
155. Ugo Tucci, La psicologia del mercante veneziano nel Cinquecento, in Id., Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano, Bologna 1981, pp. 43-94.
156. Cf. G. Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta, pp. 45, 56.
157. Il coefficiente di correlazione tra terre acquistate e prezzo del grano è di 0,73, che può essere considerato un valore accettabile.
158. Per la vicenda di Gozzi, R.T. Rapp, Real Estate and Rational Investment, pp. 269 ss.
159. Oltre a ibid., p. 278, un cenno in J.-G. da Silva, Banque et crédit, p. 108.
160. Daniele Beltrami, La penetrazione economica dei veneziani in Terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 1956, p. 67. Sui problemi della catastazione dei beni comunali cf. Mauro Pitteri, I beni comunali nella Terraferma veneta, "Annali Veneti", 1, 1984, pp. 133-138, che stima la percentuale di comunali al 20 per cento della superficie agraria veneta.
161. Alcuni dati sui ricavi dall'inizio delle vendite sino agli anni Ottanta in Mauro Pitteri, La politica veneziana dei beni comunali (1496-1797), "Studi Veneziani", n. ser., 10, 1985, pp. 72-73 (pp. 57-80).
162. S. Ciriacono, Acque e agricoltura, p. 231.
163. Cf. i prezzi riportati in appendice a D. Beltrami, La penetrazione economica, pp. 192-195.
164. In base ai pochi dati a disposizione sembra che il prezzo della terra non abbia registrato sensibili fluttuazioni lungo il Seicento. Per qualche valutazione cf. Angelo Ventura, Considerazioni sull'agricoltura veneta e sulla accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII, "Studi Storici", 9, 1968, p. 706 (pp. 674-722); A.S.V., Notarile, Testamenti, b. 1249, c. 122v (27 settembre 1604); nonché A. Menniti Ippolito, Fortuna e sfortune, pp. 78-79. Ma sui limiti del concetto di prezzo della terra cf. le osservazioni di Giovanni Levi, Economia contadina e mercato della terra nel Piemonte di antico regime, in Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea, a cura di Piero Bevilacqua, II, Venezia 1990, pp. 535-553.
165. Attente e appassionate ricerche sono state compiute in ambito veneto da Gigi Corazzol, Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500, Milano 1979; Id., Sulla diffusione dei livelli a frumento tra il patriziato veneziano nella seconda metà del '500, "Studi Veneziani", n. ser., 6, 1982, pp. 103-128; Id., Livelli stipulati a Venezia.
166. Per questi dati cf. la tesi di laurea di Italo Ongaro, La decima straordinaria sui livelli affrancabili del 1625, Università di Venezia, a.a. 1991-1992, p. 34.
167. A. Ventura, Considerazioni sull'agricoltura veneta, pp. 697-698.
168. Luciano Pezzolo, Sistema di potere e politica finanziaria nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVII), in Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo e Età Moderna, a cura di Giorgio Chittolini-Anthony Molho-Pierangelo Schiera, Bologna 1993, p. 323 (pp. 303-327).
169. Bilanci generali della Repubblica di Venezia, I, 1, a cura di Fabio Besta, Venezia 1912, pp. 568-569.
170. R. Derosas, I Querini Stampalia, p. 54.
171. G. Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta, pp. 53, 97 ss.
172. Per il mercato veneziano dei cambi nel Seicento, Giulio Mandich, Le pacte de ricorsa et le marché italien des changes au XVIIe siècle, Paris 1953, pp. 94-99.
173. Ibid., p. 97.
174. L. Pezzolo, Elogio della rendita, pp. 285 ss.
175. A.S.V., Compilazione leggi, b. 379, cc. 258, 304 (17 novembre 1645 e 10 settembre 1652).
176. Un cenno al meccanismo in Bilanci generali, pp. CCI-CCII.
177. Per le vicende del Banco Giro cf. l'attento studio di Ugo Tucci, Convertibilità e copertura metallica della moneta del Banco Giro veneziano, "Studi Veneziani", 15, 1973, pp. 349-448.
178. I dati finanziari in L. Pezzolo, Sistema di potere, p. 323.
179. Cf. Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, VII, Venezia 1858, p. 457.
180. La stima dell'ambasciatore francese Saint-Didier è riportata da Jean Georgelin, La fiscalité dans l'Etat vénitien (17e-18e siècles): les bilanci, in Etats, fiscalités, économies, a cura di Jean Bouvier - Jean-Claude Perrot, Paris 1985, p. 31 (pp. 27-40).
181. Le sole vendite della carica di procuratore di S. Marco resero alle casse dello Stato 1.081.800 ducati fra 1645 e 1669 (A.S.V., Archivio proprio Balbi, b. 6, c.n.n.).
182. Pierre Chaunu, L'Etat, in Histoire économique et sociale de la France, a cura di Fernand Braudel - Ernest Labrousse, I, 1, Paysannerie et croissance, Paris 1977, p. 178 (pp. 11-228), per l'ammontare del debito; e Françoise Bayard, Le monde des financiers au XVIIe siècle, Paris 1988, p. 29, per le entrate.
183. Per il debito olandese, James Tracy, A Financial Revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and Renteniers in the County of Holland, 1515-1565, Berkeley (Calif.) 1985, p. 207; Marjolein C. 'T Hart, The Making of a Bourgeois State. War, Politics and Finance during the Dutch Revolt, Manchester 1993, p. 165; James C. Riley, International Government Finance and the Amsterdam Capital Market 1740-1815, Cambridge 1980, p. 77; per le entrate, J. de Vries - A. van der Woude, The First Modern Economy.
184. La finanza pontificia mostra un rapporto tra indebitamento ed entrate di 7,8 attorno al 1615, di 13,2 nel 1667 e di 16,2 nel 1678 (i dati sono tratti da un mio saggio di prossima pubblicazione). Genova, invece, denunciò uno sconcertante quoziente di 32,3 nel 1650: cf. Giuseppe Felloni, Stato genovese, finanza pubblica e ricchezza privata: un profilo storico, in Fra spazio e tempo. Studi in onore di Luigi De Rosa, a cura di Ilaria Zilli, I, Napoli 1995, pp. 393, 398 (pp. 383-406).
185. Una trattazione generale è in Sidney Homer - Richard Sylla, Storia dei tassi d'interesse, Roma-Bari 1995, pp. 168 ss.
186. J. Tracy, A Financial Revolution, pp. 211 n., 212.
187. Violet Barbour, Capitalism in Amsterdam in the 17th Century, Ann Arbor (Mich.) 1963, pp. 80-83, 85-88; Jonathan Israel, Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740, Oxford 1989, pp. 78, 200-201, 413.
188. Dati in G. Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta, p. 53.
189. Informazioni sui tassi a Venezia nelle lettere degli Ottoboni analizzate da A. Menniti Ippolito, Fortuna e sfortune, pp. 31, 59, 116, 127, 151, 152, 157; e, per il Settecento, G. Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta, pp. 212-214.
190. A. Menniti Ippolito, Fortuna e sfortune, p. 45.
191. A.S.V., Archivio Donà di Riva di Biasio, b. 61, fasc. 11, c. 44 (8 marzo 1687).
192. Bilanci generali, pp. 550-553; Giuseppe Felloni, Gli investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione, Milano 1971, p. 145.
193. G. Felloni, Gli investimenti finanziari, p. 145. Un cenno alla partecipazione dei Durazzo ai prestiti del 1653 e 1654 in L'archivio dei Durazzo Marchesi di Gabiano, Genova 1981, p. 41.
194. Un generico cenno in V. Barbour, Capitalism in Amsterdam, pp. 47, 116.
195. G. Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta, p. 113.
196. Alexander F. Cowan, Venezia e Lubecca 1580-1700, Roma 1990, p. 269.
197. V. Barbour, Capitalism in Amsterdam, p. 57.
198. Tra il 1706 e il 1738 un campo a grano rendeva in media quasi 5 ducati annui, a fronte dei 23 di quelli coltivati a riso (G. Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta, p. 173 n.).
199. Ivo Mattozzi, Un processo di accumulazione di capitale manifatturiero: le cartiere di Ceneda nel primo Seicento, "Studi Veneziani", n. ser., 16, 1988, pp. 119-120 (pp. 93-120).