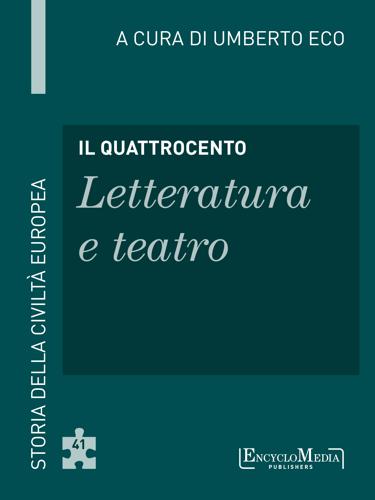La conoscenza e lo studio del greco
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
La riconquista del greco è un aspetto fondamentale nella riappropriazione del mondo classico operata dal movimento umanistico. La lingua e la letteratura greca antica vengono riscoperte gradualmente e in misura sempre maggiore dagli umanisti nel corso del secolo XV, mentre fiorisce e si impone una produzione letteraria neogreca a imitazione dei modelli originali.
La ripresa e lo sviluppo degli studi greci a Firenze
Leonardo Bruni
Vita di Dante
Opere letterarie e politiche
Tornando adunque al nostro proposito, dico che Dante virtuosamente si trovò a combattere per la patria in questa battaglia [di Campaldino]; et vorrei che ’l Boccaccio nostro di questa virtù più che dello amore di nove anni avesse fatto mentione et di simili leggerezze, che per lui si raccontano di tanto huomo. Ma che giova dire? La lingua pur va dove il dente duole, et a chi piace il bere, sempre ragiona di vini.
Doppo questa battaglia tornasi Dante a casa et agli studii più ferventemente che prima si diede; et niente di manco, niente tralasciò delle conversazioni urbane et civili. Et era mirabile cosa che, studiando continovamente, a niuna persone sarebbe paruto ch’egli studiasse per l’usanza lieta et conversatione giovanile. Nella quel cosa mi giova di riprendere l’errore di molti ignoranti, e quali credono niuno essere studiante se non quelli che si nascondono in solitudine et in otio; et io non vidi mai niuno di questi camuffati et rimossi dalla conversatione deli uomini che sapesse tre lettere. Lo ingegno grande et alto non ha bisogno di tali tormenti; anzi è verissima conclusione et certissima che quelli che non appara tosto non appara mai: sì che stranarsi et levarsi dalla conversatione è al tutto di quelli i quali niente sono atti col basso ingegno ad imprendere.
Né solamente conversò civilmente con gli uomini Dante, ma ancora tolse moglie in sua giovanezza, et la moglie sua fu gentil donna della famiglia de’ Donati, chiamata per nome monna Gemma, della quale ebbe più figliuoli, come in altra parte di questa opera diremo. Qui il Boccaccio non ha patientia, et dice le mogli essere contrarie agli studi et non si ricorda che Socrate, il più sommo philosopho che mai fusse, ebbe moglie et figliuoli et officii nella repubblica della sua città; et Aristotile, che non si può dire più là di sapientia et di doctrina, ebbe due mogli in varii tempi, et ebbe figliuoli et ricchezza assai; et Marco Tullio, et Catone, et Seneca, et Varrone, latini sommi philosophi, tutti ebbono mogli, figliuoli et officii et governi nella repubblica. Sì che, perdonimi il Boccaccio, i suoi guidicii sono molto fievoli in questa parte et molto distanti dalla vera oppinione. […]
L. Bruni, Opere letterarie e politiche, a cura di P. Viti, Torino, Utet, 1996
Nel corso dei secoli medievali la diffusa formula Graeca sunt, non leguntur (“È greco, non si legge”) riflette la communis opinio che la lingua greca sia per l’Occidente latino un oggetto sconosciuto. Ed è effettivamente vero che soltanto l’umanesimo quattrocentesco crea un vero e proprio pubblico in grado di leggere efficacemente i testi greci più impegnativi nella lingua originale. Tuttavia, la riconquista del greco nell’Europa occidentale, e più particolarmente in Italia, trova le basi nella continuità mantenutasi nei rapporti culturali tra mondo greco e mondo latino anche dopo la fine dell’Impero romano d’Occidente. Essa perdura lungo tutta l’età medievale, garantita dalle molte traduzioni di testi greci, effettuate da una cerchia ristretta ma consistente di intellettuali latini in possesso della conoscenza operativa della lingua, e dai contatti ininterrotti con il mondo bizantino intrattenuti nella nostra penisola soprattutto da Venezia e da vari centri dell’Italia meridionale.
Un primo lodevole tentativo di reintrodurre lo studio del greco a Firenze si deve al Boccaccio, che nel 1360 procura una cattedra nello Studio al monaco calabrese Leonzio Pilato. Questi però impartisce soltanto a pochi fiorentini nozioni scarse ed elementari. La vera grande svolta arriva nel 1397, ancora nel capoluogo toscano, dove per la prima volta si comincia a rendere disponibile a tutti lo studio metodico e approfondito della lingua greca. Nella città assoluta protagonista del rinnovamento umanistico il cancelliere Coluccio Salutati, anima del movimento di rinascita, è mosso da un ansioso anelito all’accesso diretto alle fonti greche, convinto com’è che “I Greci riuscirono più dotti quando fecero tesoro della cultura latina, e i Latini quando unirono alla propria la cultura greca” (Coluccio Salutati, Invito ufficiale della Signoria fiorentina al Crisolora). È dunque grazie alla risoluta iniziativa di Salutati che, con la mediazione dell’allievo fiorentino del cancelliere Iacopo Angeli da Scarperia, approda a Firenze il dotto bizantino Emanuele Crisolora per insegnare il greco “a chiunque lo voglia” a spese del Comune. L’insegnamento di Crisolora a Firenze è breve (dal febbraio 1397 al marzo 1400) ma gravido di conseguenze. Esso forma un primo fronte di letterati veramente esperti del greco e nel contempo inaugura la nuova massiccia ondata di studi che percorrerà costantemente il secolo, portando al graduale e completo recupero della lingua e della cultura del mondo greco antico e bizantino.
Leonardo Bruni e la “perfetta traduzione”
Tra gli allievi di Crisolora a Firenze è Leonardo Bruni, il discepolo e amico di Salutati che più genialmente ne eredita e mette a frutto il pionieristico spirito di riconquista della grecità, trasmettendo alla nuova generazione di umanisti fiorentini la concezione del greco come componente irrinunciabile per il progresso culturale occidentale, insieme all’idea dell’assoluta necessità di ricostruire una tradizione culturale antica bilingue e ricomposta. Bruni, letterato e uomo politico, egli stesso cancelliere di Firenze (1410/1411 e 1427/1444), apporta un contributo attivo fondamentale per l’evoluzione degli studi greci. Traduttore di molti classici (Platone, Aristotele, Senofonte, Plutarco, Demostene, Eschine, Aristofane) e scrittore originale in greco nell’opuscolo sulla Costituzione fiorentina, per primo focalizza e affronta il problema dei rapporti tra latino e greco nelle traduzioni, teorizzando la pari dignità delle due lingue. In vari scritti e soprattutto nel De interpretatione recta (“Sulla perfetta traduzione”) egli afferma la necessità, per il traduttore, di una conoscenza approfondita e raffinata della lingua di partenza come di quella di arrivo e riflette sulle vie da percorrere per giungere a una tecnica versoria che rispetti rigorosamente il significato e lo spirito dell’autore tradotto pur nell’intento di riprodurlo al meglio con i mezzi e gli usi peculiari della lingua di arrivo.
>
La posizione di Bruni si affermerà nel corso del secolo come la più seguita dagli umanisti, anche a fronte del diverso orientamento di Lorenzo Valla, profondo conoscitore di entrambe le lingue classiche e nella Collatio novi testamenti agguerrito studioso del greco evangelico, con l’ausilio del quale egli verifica e talora corregge il latino della Vulgata di san Girolamo, corrotto e imbarbarito dai guasti del tempo. Nella propria versione latina dell’orazione demostenica Pro Ctesifonte, già in precedenza tradotta da Bruni, il Valla si mostra fautore di una traduzione che si proponga piuttosto come una riscrittura in latino, mirata a esprimere il senso del testo originale ma anche tesa a gareggiare con esso per efficacia espressiva e raffinatezza linguistica. In questo genere di traduzione può e deve rendersi manifesta l’inevitabile e irriducibile competizione tra greco e latino.
Il greco in Italia attraverso il Quattrocento: umanisti, viaggiatori, mercanti
Dopo l’esperienza fiorentina, Crisolora passa a insegnare a Milano e a Pavia. La sua influenza si irraggia poi in altri centri, tra cui Ferrara e Roma, attraverso amici e allievi. Egli d’altro canto si impegna anche in un’intensa attività diplomatica, in qualità di ambasciatore dell’imperatore Manuele II, che ha come conseguenza l’ulteriore intensificarsi dei rapporti tra Bisanzio e l’ambiente umanistico italiano. Negli anni si accresce poi in Italia l’attività di traduzione dei testi e vanno istituendosi in varie città, soprattutto nel centro-nord della penisola, cattedre di greco tenute da letterati in fuga dall’Oriente bizantino sempre più vessato dalla pressione turca, ma anche da italiani ormai altamente esperti come Guarino Veronese e Francesco Filelfo, forse il migliore grecista occidentale del secolo, partito alla volta di Costantinopoli nel 1420 e rimastovi fino al 1427. Molti umanisti cominciano a viaggiare, per apprendere la lingua ma anche per visitare finalmente i mitici luoghi della graeca sapientia e portarne via libri e testimonianze antiquarie. Nel 1403, insieme a Crisolora, parte per Costantinopoli lo stesso Guarino Veronese, che in seguito insegna il greco a Venezia a Francesco Barbaro e dal cui magistero si sviluppa lo studio umanistico del greco in area veneta. Un caso rilevante quanto singolare è quello del siciliano Giovanni Aurispa. Maestro a Bologna e Firenze, bibliofilo ma soprattutto mercante di libri, egli ripetutamente si reca in Grecia per riportarne collezioni sempre più numerose di manoscritti da rivendere o barattare in patria. A lui si affianca Ciriaco d’Ancona, letterato e instancabile viaggiatore che perlustra l’intera regione ellenica alla caccia di codici come anche di reperti epigrafici e numismatici.
Teologia, filosofia e letteratura: dal concilio di Firenze all’età laurenziana
Il concilio di Firenze (1439-1443), che sancisce un’effimera riunificazione tra la Chiesa greca orientale e la latina, è un nuovo evento di capitale importanza. Esso riconferma al capoluogo toscano il ruolo di centro trainante degli studi greci e contestualmente determina un ulteriore afflusso di letterati bizantini, convenuti in Italia sia per assistere all’assise ecumenica che per trovare una sistemazione lontana dai miseri resti dell’Impero d’Oriente, in seguito definitivamente annientato con la caduta di Costantinopoli nelle mani di Maometto II nel 1453. Il travaglio per la riconquista della lingua è ormai avanzato e l’interesse dei dotti si allarga al pensiero greco sacro e profano e ai suoi rapporti con quello del mondo occidentale. Durante il concilio i dibattiti teologici su questioni trinitarie e testi patristici greci e latini danno la stura a minuziose disquisizioni interpretative, moderate e organizzate dal monaco camaldolese Ambrogio Traversari, anch’egli importante traduttore dei testi dei padri greci e delle Vitae philosophorum di Diogene Laerzio. Dalle discussioni di attinenza religiosa e dottrinale è breve il passo verso le complementari dispute filosofiche e, particolarmente, verso il confronto-scontro tra i due massimi filosofi antichi, Aristotele e Platone. O, meglio, tra aristotelismo scolastico e neoplatonismo ellenizzante: un conflitto ideologico che trasferisce in Occidente antitesi già proprie della cultura bizantina e che percorre la seconda metà del secolo fino al prevalere delle dottrine platoniche, all’interno del nuovo sistema filosofico-dottrinale improntato a un neoplatonismo perfuso di tradizione ermetica e misterica concepito da Marsilio Ficino.
In campo linguistico-letterario, la fine dell’età laurenziana vede la riconquista della grecità giunta al termine ultimo e più alto. Il “Greco dello Studio”, Angelo Poliziano, può inaugurare le sue lezioni sull’Odissea affermando che Atene si è trapiantata “tutta intera” in Firenze, divenendo “una cosa sola con lei”. E con raffinata competenza trasfusa di culto della lingua compone in greco eleganti epigrammi ed elegie, “quasi a suggellare il lavoro di un secolo” (Eugenio Garin, La letteratura degli umanisti, 2001). I tempi sono ormai maturi per le grandi edizioni a stampa, come il monumentale Aristotele di Aldo Manuzio.
I libri: raccolte e biblioteche
I molti libri greci raccolti dagli umanisti nel corso del secolo, provenienti dalla regione ellenica o confezionati in Italia, rappresentano un patrimonio librario inestimabile, distribuito all’epoca in varie biblioteche private o signorili che spesso non si sono conservate nella loro integrità. Emblematico è il caso della ricca e varia raccolta di Giovanni Aurispa, tragicamente disgregata alla sua morte, come anche dei libri dell’esule fiorentino Palla Strozzi, che a Padova lascia in dono al convento di Santa Giustina la propria collezione, poi dispersa, comprendente una significativa porzione di testi greci. A Firenze, Lorenzo de’Medici incarica i suoi collaboratori di incrementare di manoscritti bizantini e italiani la biblioteca privata medicea, mentre alla Badia Fiesolana passano i numerosi codici greci di Antonio Corbinelli e nel convento di San Marco quelli di Niccolò Niccoli. Ed è prevalentemente a scopo didattico che il grande maestro Vittorino da Feltre ne raccoglie un nutrito insieme nel convitto scolastico della Ca’ Giocosa da lui fondato a Mantova presso i Gonzaga. A Roma, Niccolò V (1397-1455, papa dal 1447) in pochi anni accresce grandemente il fondo librario papale, costituendo la sezione originaria della Biblioteca Apostolica Vaticana.
La collezione di Bessarione
Bessarione, monaco basiliano nativo di Trebisonda e in seguito cardinale (1449), equilibrato difensore del platonismo durante e dopo gli anni del concilio di Firenze, raccoglie durante la vita un’ingente collezione composta in grande maggioranza di testi greci. Affinché non vada dispersa, nel 1468 egli decide di affidarla a Venezia: la città “sicura e di agevole accesso” in cui vede un’altra Bisanzio e in cui i suoi libri possano essere letti e consultati da Greci e Latini provenienti da tutti i Paesi, continuando a testimoniare e a proiettare nei secoli futuri, dopo la drammatica rovina di Costantinopoli, la grande eredità culturale ellenica. Da essi ha origine il primo nucleo della Biblioteca Nazionale Marciana.