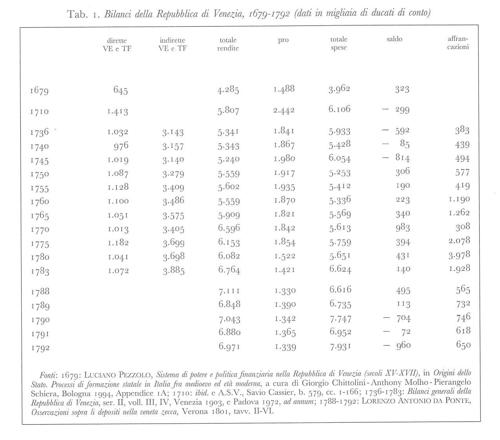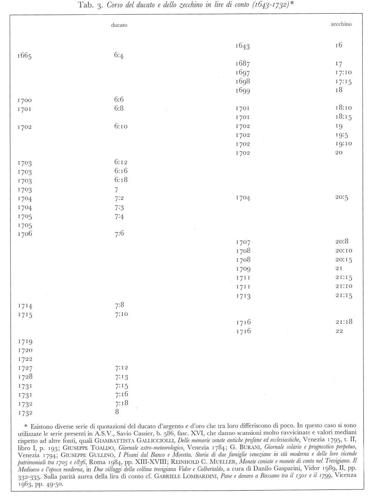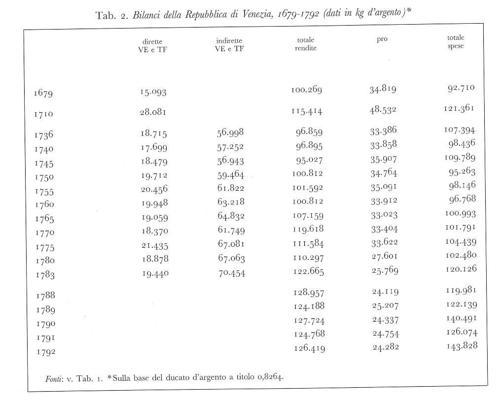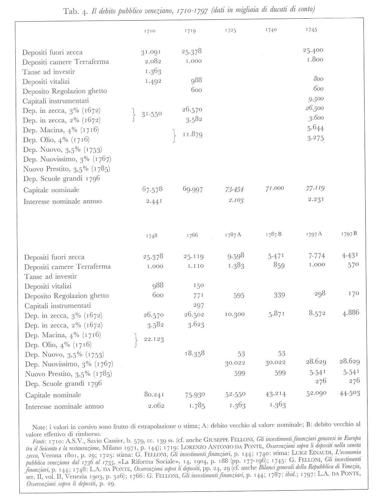La finanza pubblica: bilanci, fisco, moneta e debito pubblico
La finanza pubblica: bilanci, fisco, moneta e debito pubblico
Scrivendo vent’anni dopo la conclusione della guerra di Morea, quando la breve stagione settecentesca del dominio sul Peloponneso si era quindi già conclusa, il segretario veneziano Vendramino Bianchi, riflettendo sul significato di quella effimera vittoria, annotava come ogni piazzaforte conquistata in Morea fosse costata alla Repubblica di San Marco «un tesoro di denaro e di sangue» (1). Come lo stesso Bianchi premetteva non si trattava di un’espressione esagerata, né doveva suonare cinico l’ordine di quella ricostruzione che assegnava ai costi materiali un ruolo preminente rispetto a quelli umani: nel rievocare quel conflitto, come nel ricostruire negli atti di governo o nelle pagine della storiografia ufficiale lo scontro sei-settecentesco con la potenza ottomana tornano sovente i riferimenti all’onere quasi insopportabile che quegli otto decenni di guerra costituirono per le finanze della Repubblica.
Risulta naturale riunire l’arco di tempo tra l’inizio della guerra di Candia (1645-1669) e il termine della seconda guerra di Morea (1714-1718) in un unico periodo contrassegnato dal conflitto mediterraneo e dai suoi contraccolpi commerciali ed economici. Nel tracciare un profilo della finanza pubblica veneziana nel suo ultimo secolo repubblicano, e per meglio comprendere la situazione in cui essa versava allo schiudersi del secolo, è necessario invece cogliere al di sotto dell’indubbia unitarietà di questa fase almeno una sua suddivisione interna. Tra gli ultimi anni della guerra di Candia e i primi successivi alla definitiva perdita dell’isola venne infatti varato un insieme di provvedimenti economici e finanziari le cui implicazioni per la politica finanziaria settecentesca furono di primaria importanza.
L’onere della «neutralità armata» tra le guerre di Morea
Alcuni di questi provvedimenti, come la possibilità concessa nel 1665 ai contribuenti veneziani di pagare parte delle loro imposte in frumento (2), furono decisamente innovativi. Altri, come la soppressione tra 1662 e 1684 dei dazi portuali in uscita (3) o la manovra sul debito pubblico del 1672 (4), anticiparono linee di condotta alle quali si ricorse in seguito più volte nella speranza di affrontare gli insoluti nodi del rapporto tra incentivi al commercio e gettito daziale da una parte, e tra necessità di cassa e costo del debito pubblico dall’altra. La coniatura nel 1665 di una nuova moneta d’argento detta «ducatello» del valore di un ducato di conto (5) o la contemporanea decisione di rendere l’imposta detta campatico permanente (6) rappresentarono invece una semplice ripresa di precedenti lontani che ebbero però questa volta una continuità diversa: il ducato d’argento, ad esempio, continuò a mantenere intatti titolo e peso fino alla caduta della Repubblica costituendo così un elemento concreto di stabilità nel caotico mercato monetario del tempo.
La congiuntura economica generale che venne instaurandosi nell’ultimo quarto del XVII secolo e la ripresa del commercio marittimo sembrarono assecondare queste iniziative di riequilibrio della finanza pubblica veneziana. Mentre tale disegno iniziava a prendere corpo la decisione nel 1684 di riaprire il conflitto in Oriente inaugurò un nuovo ciclo dell’economia pubblica marciana, che doveva concludersi solo trentacinque anni dopo con la pace di Passarowitz e la fine del plurisecolare conflitto con la Sublime Porta. Dopo la fine della prima guerra di Morea passarono infatti solo un paio di anni prima che la guerra di successione spagnola non costringesse la Repubblica a reimmergersi in un’economia di guerra. «Esausto l’erario, disarmate le piazze di Terra ferma, stanchi li sudditj dagli aggravj, consumate in parte, ed in parte impegnate le pubbliche rendite, deteriorato il commerzio», scriveva sempre il Bianchi (7), il governo veneziano optò per la cosiddetta «neutralità armata», che comportava sul piano militare una sorveglianza non passiva del territorio e dei confini, e quindi un impegno considerevole di uomini e di mezzi.
Si trattava probabilmente dell’unica soluzione a disposizione del governo repubblicano, al quale non dovettero inoltre sfuggire i possibili vantaggi commerciali di una posizione neutrale. In realtà gli oneri economici e finanziari di una guerra in corso non tardarono a farsi avvertire: ne risentirono in primo luogo le popolazioni della Terraferma, soprattutto del Veronese e della Lombardia veneta, dove i passaggi e le scorrerie di Imperiali e Gallispani provocarono danni rilevanti all’agricoltura, al commercio e alle attività manifatturiere (8). La stessa navigazione commerciale non si svolse poi nella tranquillità che si auspicava: la flotta francese alla ricerca di legni imperiali risalì la costa adriatica fin addirittura al porto di Malamocco. Il piano militare imponeva infine una presenza consistente di truppe in Terraferma, circa 24.000 uomini in parte spostati dai possedimenti orientali, con costi di mantenimento considerevoli (9).
Di fronte ad una tale situazione il senato si mosse secondo linee di condotta sperimentate, agendo in primo luogo sulla leva fiscale. Nel 1705 vennero aumentate in via straordinaria le imposte dirette mediante l’imposizione di una «mezza decima suppletiva», cioè della metà dell’imposta annuale che gravava sui beni immobili dichiarati. L’anno successivo si incrementò l’addizionale ordinaria sulla stessa decima, che era già stata ritoccata nel 1695 (10) e che raggiunse così i dieci soldi per lira, la metà dell’imposta. Parallelamente si agì anche sulle tariffe daziarie, un campo di intervento che presentava più incognite che certezze per la farraginosità del sistema delle esazioni, per il timore di comprimere gli scambi e soprattutto per la consapevolezza che aumenti repentini e consistenti delle tariffe finivano semplicemente per allargare l’area della produzione e del commercio controllata dal contrabbando. Si ritoccarono due tra i dazi che fornivano i maggiori introiti: nel 1700 quello del sale (che era stato già aumentato nel 1684 e 1696) (11) e nel 1704 quello dell’olio, con una modifica che secondo i calcoli del senato avrebbe dovuto rendere 80.000 ducati in più all’anno (12).
Due documenti tornano utili per inquadrare questo passaggio (13). Si tratta dei riepiloghi completi del movimento contabile delle diverse amministrazioni della Serenissima per gli anni 1710 e 1713, compilati sulla scorta di rendiconti ufficiali (v. Tab. 1). Furono redatti in maniera accurata ma con un metodo ancora approssimativo; tuttavia, considerando la coerenza tra numerose voci e la vicinanza temporale delle due rilevazioni, può risultare utile trarne qualche indicazione, sia sul risultato dei provvedimenti fiscali a cui si è fatto sopra riferimento, sia più in generale sullo stato di salute complessivo della finanza veneziana dopo la prima neutralità armata settecentesca.
Rispetto al bilancio del 1679 le rendite appaiono in forte aumento, passando da 4.200.000 ducati di conto ad oltre 5.800.000 nel 1710; con una velocità anche superiore risultano però cresciute anche le passività, salite da 3.900.000 a 6.100.000 ducati. L’entità di tali movimenti può trarre in inganno, essendo in parte da addebitare al processo di svalutazione della moneta di conto che negli stessi anni aveva ripreso vigore. Si osservino ad esempio il ducato d’argento e lo zecchino, le monete delle contrattazioni di medio ed alto livello (v. Tab. 3); il corso del ducato, o ducatello, passò dal valore standard di 6 lire e 4 soldi del 1679 a 7:8 lire nel 1714, con una crescita quindi del 19%, mentre il ducato d’oro, o zecchino, crebbe nello stesso periodo da 16 a 21 lire e 15 soldi, il 35% in più, evidenziando una velocità di slittamento della moneta di conto paragonabile a quella dei momenti caldi della «rivoluzione di prezzi» di fine Cinquecento.
In termini reali l’aumento delle entrate fu di conseguenza assai ridotto: utilizzando come deflatore il corrispettivo metallico (in argento) dei valori sopra esposti, fatto 100 il dato del 1679, le rendite salirono a 115 nel 1710 a fronte però di un contemporaneo aumento delle uscite che toccarono l’indice 130 (v. Tab. 2). Pur tenendo conto della cautela con cui questi dati vanno interpretati, il peggioramento delle condizioni finanziarie risulta evidente, ed è confermato dal saldo di bilancio che nel 1679 presentava un avanzo di circa 300.000 ducati mentre trent’anni dopo registrava invece un passivo superiore ai 400.000 ducati.
Sebbene fossero le imposte indirette a fornire il maggior cespite all’erario erano però le imposte dirette, per la delicatezza degli equilibri che andavano a toccare inserendosi nel cuore del complesso meccanismo che regolava il rapporto tra lo stato ed i contribuenti, lo strumento fiscale utilizzato con maggiore cautela. Tra i due periodi in osservazione l’insieme delle diverse imposte dirette riscosse nella Dominante ed in Terraferma passò da 645.000 ad oltre 1.400.000 ducati, con un incremento deflazionato dell’86%.
Ad un primo esame tale aumento parrebbe imputabile all’azione delle addizionali che avrebbero dovuto apportare sulla carta incrementi considerevoli; in realtà è stato però osservato che tale strumento riuscì a malapena a coprire la svalutazione della moneta di conto (14), e quindi un aumento del carico fiscale sui beni immobili e sui redditi da lavoro e da commercio dovette effettivamente verificarsi.
È poi possibile che il dato del 1710 comprenda anche parte di anticipazioni di imposta, e non la sola imposta ordinaria riscossa. Nel 1702 risulta esser stata levata una tansa ad investir, un’imposta che colpiva i redditi derivanti da attività commerciali e le rendite finanziarie secondo una stima effettuata da un’apposita commissione, e che era stata decretata non a perder, ma con la corresponsione di un buon interesse, il 5%. Nel 1707 si ricorse poi all’anticipazione della decima (15). È certamente vero che questo tipo di prestiti a breve doveva avere una qualche sua intrinseca efficacia: dare il vantaggio di ricevere interessi per imposte che comunque si sarebbero dovute versare invogliava anche i contribuenti renitenti a sottomettersi all’imposizione fiscale. Peraltro va osservato che si trattava comunque di una forma di riscossione anticipata di entrate future, per le quali lo stato si caricava inoltre di interessi passivi.
Nel complesso le imposte dirette prima della seconda guerra di Morea apportavano il 24% del denaro che annualmente incassava la Repubblica, una percentuale superiore a quella degli ultimi anni della guerra di Candia, a testimonianza del grave impegno rappresentato dalla neutralità armata. Il governo patrizio cercò di rastrellare liquidità in ogni direzione, spingendo l’imposizione diretta fino ad un livello che può essere considerato un limite massimo strutturale oltre il quale l’elusione e l’evasione che per reazione ne sarebbero derivate avrebbero reso controproducente l’inasprimento fiscale.
Di più complessa valutazione è il giudizio sui provvedimenti daziari; sul gettito delle imposte indirette influivano infatti specularmente l’andamento della congiuntura economica generale ed elementi di contesto quali il movimento della produzione interna o del traffico portuale, che fino agli anni 1713-1714 in virtù anche della guerra in corso registrò un aumento costante (16). Le tariffe dei beni di consumo, a parte quelle dell’olio e del sale, non vennero sostanzialmente toccate, né risultano riforme dei dazi portuali o di quelli del transito interno, se non una liberalizzazione del mercato interno della lana (17).
Con le imposte dirette al loro tetto storico (18) e senza intraprendere manovre di ampio respiro nel settore daziario la possibilità di incrementare le rendite restava quindi preclusa. Due famiglie non nobili vennero aggregate al patriziato nel 1704, con un ricavo di 100.000 ducati ciascuna (di cui peraltro metà in crediti verso lo stato): somme ben lontane da quelle ottenute vent’anni prima, quando furono 26 le famiglie che versarono un simile obolo per sedere sui banchi del maggior consiglio (19). Nel 1709 venne sospesa la vendita degli uffici della burocrazia intermedia, che rendeva una decina di migliaia di ducati, e che pure poco dopo venne ripresa (20). Ben lontana dai suoi momenti migliori era pure la vendita dei beni comunali, che racimolava appena 12.000 ducati, secondo il bilancio del 1710. Esplorate o abbandonate tutte queste strade, il finanziamento del deficit non poteva che procedere secondo uno strumento conosciuto bene, così come da tutti gli stati moderni, anche dall’amministrazione marciana: l’aumento del debito pubblico.
Il ricorso massiccio e costante a questa forma di finanziamento risalta bene dal bilancio del 1710, secondo cui la somma che veniva destinata al pagamento degli interessi passivi, i cosiddetti pro, risultava essere di oltre 2.400.000 ducati, dimostrando un aumento di un quarto rispetto al 1679 e giungendo quindi ad impiegare il 42% delle entrate statali. Se si considera che a causa della neutralità armata le spese militari assorbivano una percentuale identica delle attività, il quadro con cui nel 1714 la finanza veneziana si trovò ad affrontare l’offensiva ottomana per la riconquista della Morea appare, nei suoi elementi principali, fortemente compromesso.
Il peso del debito pubblico, 1710-1719
Lo studio della finanza pubblica consente di penetrare alcuni aspetti fondamentali delle società e delle economie dell’età moderna. Osservando l’azione dello stato confrontarsi quotidianamente con le istanze di fasce sociali, istituzioni territoriali ed entità giurisdizionali diverse, viene infatti alla luce sia il processo di trasformazione delle istituzioni statali, sia il concetto che il suddito aveva di sé, del «pubblico», dell’autorità.
Agli inizi del Settecento lo stato-macchina aveva ormai raggiunto livelli di complessità e funzionalità considerevoli con amministrazioni burocratiche ramificate, reti diplomatiche stabili e apparati militari che richiedevano interventi consistenti in infrastrutture, tecnologie, uomini. Il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per sorreggere tali attività incontrava resistenze diverse. Una prima forza antagonistica era implicita nella stessa concezione corrente di stato, che accettava e difendeva al proprio interno privilegi e differenziazioni quali risultato di una diversità naturale tra i sudditi. Nel concreto dell’azione coercitiva fiscale questo si risolveva in una congerie di privilegi, esenzioni, franchigie che limitavano la capacità impositiva dello stato: si pensi alle esenzioni concesse a signorie feudali, alla presenza di vaste autonomie territoriali o al sempre problematico rapporto con enti ed istituzioni ecclesiastiche.
Un secondo fattore di resistenza era rappresentato dalla struttura dello stesso apparato amministrativo, dove accanto a realtà organizzate e produttive si trovavano uffici nei quali regnava ancora una concezione personalistica dell’ufficio pubblico e proliferavano abusi ed inefficienze. Ovviamente ogni situazione di confusione interna veniva sfruttata per sottrarsi all’imposizione statale, sicché l’inefficacia dell’amministrazione veniva a costare due volte: per lo spreco delle risorse e per l’incapacità di sottoporre tutti i contribuenti alle esazioni di legge.
Per Venezia sussistevano poi alcuni elementi di resistenza peculiari. La Serenissima estendeva il proprio dominio su un territorio ampio e disorganico, dall’entroterra lombardo all’Egeo, passando per le coste della Dalmazia e le isole Ionie. Nel governo di queste terre diverse Venezia aveva cercato di contemperare le esigenze di autogoverno locali con la necessità di mantenere salda l’autorità centrale dello stato. Il risultato presentava una sostanziale differenza tra la realtà dello stato da terra e quello da mar: nel primo l’autonomia e il ruolo di controllo assegnato ai ceti dirigenti delle città risultava più accentuato, tanto che si è potuto parlare di una forma-stato di tipo federativo; nello stato da mar i ceti dirigenti locali appaiono più in contrapposizione con le autorità veneziane (e in connivenza con i governatori patrizi) che in un rapporto funzionale con la macchina statale.
Un ulteriore elemento caratterizzante di cui tenere conto era costituito dalla particolare natura costituzionale della Serenissima, una Repubblica retta da un’oligarchia di patrizi le cui fortune, nate dalla mercatura medievale, traevano ormai sostentamento soprattutto dalla rendita fondiaria e dall’investimento finanziario (21). Rispetto alle monarchie italiane ed europee – che in questo periodo si trovarono coinvolte in problemi finanziari non meno gravi di quelli della Repubblica veneta – la vicenda della finanza pubblica marciana va considerata alla luce di tale peculiarità istituzionale, per cui i patrizi riuniti in assemblea decretavano riguardo alla materia finanziaria avendo di mira l’interesse dello stato, ma non potendo ignorare che i primi e principali contribuenti del paese erano proprio le loro famiglie, i cui patrimoni da secoli condividevano la propria sorte con i forzieri pubblici.
Una delle forme tradizionali di investimento dei capitali patrizi era costituita dai depositi pubblici che, dalla prima metà del XVI secolo, avevano sostituito i prestiti forzosi quale principale strumento di finanziamento del deficit dello stato. Essi prendevano la forma di semplici accreditamenti di capitale effettuati presso la zecca, nel qual caso si usava l’espressione depositi in zecca, oppure presso vari uffici della Dominante quali il magistrato al sal, il dazio del vino ecc., alle cui rendite era assegnato l’onere di procedere al pagamento degli interessi: si parlava allora di depositi fuori di zecca. La negoziabilità di questi titoli di credito era pienamente riconosciuta e avveniva mediante semplice giro di scrittura; per ogni tipo di deposito veniva di conseguenza a stabilirsi una quotazione di mercato che variava con il mutare della situazione economica e della politica finanziaria della Repubblica e risentiva di vari fattori, primo fra tutti la possibilità di riscuotere il credito che venne più volte inibita nei momenti di crisi bellica. Solitamente le aperture di nuovi depositi non prevedevano una scadenza del prestito: solo nel XVIII secolo, come si avrà modo di vedere, si cominciò con una certa continuità a prevedere piani di affrancazione. Caratteristiche diverse avevano i depositi vitalizi, che si diffusero dal primo Seicento e che prevedevano un interesse diverso a seconda dell’età del sottoscrittore, comprovata da un certificato di nascita (22).
Nei periodi di riassestamento post-bellici era regola di buon governo procedere a operazioni di riordino e conversione del debito. Una delle manovre che prese forma dopo la fine della guerra di Candia fu così dedicata alla riunificazione di vari depositi che esistevano dentro e fuori di zecca, tra cui alcuni fondi vitalizi che pagavano pro del 7 e 14%, in due soli depositi al 2 e 3%, nei quali furono consolidate anche le rate di pro arretrate. Il totale, di oltre 33.000.000 di ducati, costituì il cosiddetto «debito vecchio» (23).
Gli effetti di tale operazione furono vanificati dalla congiuntura apertasi con la prima guerra di Morea, quando venne nuovamente ritardato il pagamento delle rate d’interesse e ripresero a proliferare i depositi fuori di zecca. Nel 1699 vennero diminuiti i tassi dal 5 al 4% (24), ma il disavanzo di bilancio si fece cronico nei primi anni del secolo quando, come è già stato osservato, l’aumento delle rendite non riuscì a coprire le spese della neutralità armata e costrinse la Repubblica a dispiegare tutto il suo repertorio di forme di autofinanziamento.
Il bilancio del 1710 presenta a tale proposito un’interessante gamma di soluzioni. Circa 2.000.000 di ducati erano stati raccolti in Terraferma, rivolgendosi a enti e istituzioni diversi. Varie comunità locali furono sollecitate a fornire somme di denaro anche ingenti come forma di anticipo su imposte che riscuotevano sui loro territori; in bilancio non risulta dedicata alcuna somma all’ammortamento di tali debiti, che sembrano di conseguenza perpetui. Con un piano di restituzione già prefissato vennero invece registrate le somme ricevute dai Monti di pietà di Vicenza, Verona, Bergamo e Treviso negli anni 1705, 1708 e 1709, così come le prestanze delle Università degli Ebrei, di Padova, Verona e Rovigo. Considerevoli risorse vennero anche richieste ad enti ecclesiastici e assistenziali (luoghi pii, ospedali, case della pietà ecc.), mentre sembrano aver avuto ancora scarsa diffusione le anticipazioni di partiti (cioè i dazi di beni di consumo in privativa), dazi e altre entrate appaltate, metodo seguito nel solo caso del dazio della seta di Bergamo. Oltre 1.300.000 ducati erano poi contabilizzati sotto la voce tansa ad investir.
La massa più consistente del debito era formata dai diversi depositi fuori e dentro di zecca, il cui ammontare nominale superava i 64.000.000 di ducati portando il debito pubblico consolidato a 67.500.000 ducati, undici volte e mezzo le rendite annuali dello stato (v. Tab. 4). Lo zoccolo duro di tale somma era costituito dal deposito al 3% creato nel 1672, che ammontava sempre a oltre 30.000.000 di valore nominale anche se la quotazione di mercato era scesa a 71 sotto la pari (25). Di peso minore per l’erario erano i 3.500.000 ducati dei capitali al 2% (quotati attorno al 50), mentre una lunga serie di depositi fuori di zecca il cui tasso medio era del 4% (ne risultano elencati in 19 magistrature!) era evidentemente fiorita negli ultimi decenni. L’insieme degli interessi su questa montagna di debiti ammontava a 2.440.000 ducati annui e risultava considerevolmente aumentato rispetto all’inizio del secolo quando doveva aggirarsi attorno ai 2.000.000 di ducati (26), a testimonianza che il primo decennio del secolo fu epoca di indebitamento, e a tassi sostenuti.
In questa situazione di grave sbilancio strutturale la Repubblica si trovò invischiata in un conflitto al quale non si era in nessun modo preparata. Suona forse eccessivo il giudizio dell’ambasciatore francese che nel luglio 1714 sottolineava come i governanti veneziani fossero «sans argent, sans crédit, sans armes» (27), fatto sta che alla rottura delle relazioni con la Sublime Porta, nel dicembre dello stesso anno, uno dei primi fronti su cui il senato decise di intervenire fu proprio quello del debito pubblico, il cui costo corrente era inconciliabile con qualsiasi operazione di finanza straordinaria. Sono significative le conclusioni a cui giunse una delle principali magistrature economiche nel 1739, quindi dopo la perdita della Morea ed altri vent’anni di difficoltà economiche. Un «utile ammaestramento» si poteva ricavare dalle vicende finanziarie d’inizio secolo, e principalmente «quanto sia pregiudiciale il non risanare le piaghe terminate le occasioni de’ dispendi, et che non vi è sorte più infelice in un principato di quella di non poter sussistere in tempo di pace senza far nuovi debiti» (28).
Tre giorni prima del Natale 1714 il senato decretava la riunificazione dei vari depositi fuori di zecca in un solo prestito al 2% d’interesse (al 6% per i vitalizi), secondo le tradizionali modalità di conversione del debito pubblico marciano. Si trattò di una «bancarotta larvata» come ha sostenuto Luigi Einaudi (29)? Forse l’espressione è eccessiva per un’operazione non nuova per la finanza della Serenissima (e negli stessi anni praticata in altri stati italiani), in considerazione anche del fatto che la gran parte del debito consolidato riceveva il medesimo tasso del 2% in virtù della manovra del 1672. Certo la cosa spaventò, e non poco, gli investitori stranieri, tanto che, come ha riferito Giuseppe Felloni (30), la notizia del decreto suscitò a Genova una costernazione generale facendo precipitare il corso dei titoli veneziani a 37-39. Il livello degli investimenti genovesi nel debito veneziano era tale che ritenne opportuno muoversi il senato di quella città, incaricando due patrizi di recarsi a Venezia in forma privata per ottenere garanzie: la missione si risolse con grandi assicurazioni da parte veneziana e un nulla di fatto.
La politica di operare sulle uscite era ovviamente insufficiente per fare fronte alle esigenze di uno scontro che, dopo l’immediata perdita della Morea, rischiava di compromettere anche il dominio sulle isole Ionie, considerate la porta naturale dell’Adriatico. Così dopo aver risparmiato sugli interessi, ora che la guerra impediva il libero e fruttuoso traffico col Levante, era necessario rastrellare denaro liquido, a costo di ipotecare entrate future. Un ulteriore aggravio del carico fiscale venne evidentemente considerato inutile o dannoso, poiché in quest’ambito si procedette unicamente a levare una tansa persa per gli abitanti di Venezia nel 1715, e dopo due anni a rendere effettiva la redecima completata nel 1712 (31). A parte provvedimenti isolati, come la legalizzazione del gioco del lotto che fruttò 25.000 ducati d’appalto annui e 125.000 d’anticipazione (32), la manovra finanziaria si indirizzò verso due fronti: la vendita di beni e dignità pubbliche e l’aumento del debito pubblico.
Nel primo anno di guerra venne ripresa la vendita delle cariche della burocrazia intermedia non patrizia, comprese però quelle in aspettativa cioè ancora da liberarsi, la qual cosa sottraeva al controllo dello stato importanti uffici per decenni (33). Venne quindi decisa la vendita degli edifici pubblici delle Procuratie nuove, stimate in 480.000 ducati, con una lotteria di 5.000 biglietti da 100 ducati l’uno e le 8 Procuratie in palio (34). Si riprese la pratica di consentire l’entrata anticipata rispetto all’età normale dei giovani nobili nel maggior consiglio per denaro, e la vendita della prestigiosa dignità di procuratore di San Marco. Così come era stato decretato nel 1646, 1669 e 1685, vennero poi riaperte le aggregazioni alla nobiltà, con un esito però anche questa volta inferiore rispetto ai precedenti e alle aspettative: solo 8 furono le famiglie che decisero di acquistarsi l’iscrizione nel Libro d’oro patrizio (35).
Nel 1716 si abbracciò il partito di aprire un nuovo deposito, del quale i capitalisti avrebbero potuto sottoscrivere quote per una metà in contante e per l’altra metà trasportandovi debiti vecchi, quelli recentemente convertiti al 2%. L’interesse previsto era del 4% e per farvi fronte venivano destinati sia i denari di pro risparmiati grazie alla conversione del 1714, sia i proventi del dazio Macina recentemente riformato (36). Nell’aprile era stata infatti aumentata in maniera considerevole l’imposta che gravava sulla macinazione dei cereali, reintroducendo la tariffa che colpiva anche i grani minuti e coinvolgeva quindi anche le fasce sociali più disagiate. Come un po’ tutte le tasse sul macinato anche questa si trasformò in una sorta di testatico ed è emblematico che la Repubblica dovesse ricorrere a tale categoria di imposte per finanziare il debito pubblico.
La necessità di reperire in ogni possibile modo capitali disponibili spinse a volgere lo sguardo alla liquidità di cui disponevano dazieri e appaltatori, attraverso i quali si riscuoteva la maggior parte delle imposte indirette. Cominciarono così a decollare le anticipazioni e le prestanze sui dazi e sui partiti, favorevolmente accolte dagli stessi dazieri che si trattenevano il rimborso annuale più l’interesse dalla somma che dovevano dare allo stato: nel 1719 l’ammontare di questi debiti a breve superava i 3.700.000 ducati (37). Tale pratica accentuava la fragilità finanziaria dello stato, che nel momento del rinnovo dei contratti si veniva a trovare in una condizione di palese inferiorità, rinunciando spesso ad imporre aumenti delle cifre d’appalto per ottenere ulteriori anticipazioni.
Dal 1715 aumentarono considerevolmente anche i capitali instrumentati, i debiti che lo stato contraeva con Scuole devozionali, Arti di mestiere ed altri enti e istituzioni della capitale e della Terraferma. Il carattere di tale forma di debito pubblico è abbastanza singolare, nonché complesso (38). Si trattava in sostanza di somme che lo stato «otteneva in modo più o meno coattivo» (39) da tali enti, senza alcun impegno di restituzione ma ad un tasso del 4%. A loro volta gli enti reperivano il capitale in parte dalle loro consistenti immobilizzazioni, in parte dando la possibilità ai loro membri (le categorie attive del commercio, delle professioni e dell’industria) di investire denaro in un prestito fruttifero. I vantaggi di tale tipo di deposito erano diversi: la sottoscrizione avveniva mediante semplice strumento notarile tra l’affiliato e l’istituzione, per un periodo predeterminato, con garanzia di restituzione e pagamento dei pro. L’atto era poi esente dalle consuete tasse sugli strumenti notarili ed era facilmente trasfèribile mediante semplice trascrizione notarile. Così, nel concreto, sovrapponendo all’immagine vacillante del Tesoro i patrimoni conosciuti e tangibili di un’ampia gamma di istituzioni «parastatali», lo stato veneziano evitò una possibile crisi di sfiducia nei suoi confronti, che tagliando le sottoscrizioni private avrebbe avuto conseguenze catastrofiche, e rafforzò alcuni degli elementi fondamentali del prestito pubblico moderno: il suo carattere sostanzialmente anonimo, la sua trasferibilità, la predeterminazione della scadenza.
Nel 1718, persa la Morea ma salvato l’Eptaneso, la Serenissima tornava alla pace senza però che cessassero le difficoltà finanziarie tanto che, sebbene dalla riforma del 1714 l’erogazione dei pro non si fosse più interrotta, gli interessi su tutti i depositi del debito vecchio continuarono ad essere pagati solo nella misura del 2%. La scelta di non interrompere la corresponsione degli interessi segnava senza dubbio una svolta nella politica del debito, che implicava però un flusso ininterrotto di risorse e quindi la ricerca di sempre nuove entrate. Nel 1719 si aprì un nuovo deposito, fissandone il limite di raccolta a 2.000.000 di ducati e l’interesse al 3%. Tale minore vantaggio rispetto sia al deposito Macina sia ad investimenti in partita di banco (di cui si dirà tra poco) causò una fredda accoglienza da parte dei risparmiatori, tale da convincere le autorità ad adeguarne i caratteri a quelli del deposito Macina, reperendone i capitali necessari dai dazi di entrata e consumo dell’olio (40).
Un riepilogo analitico del 1719 consente di valutare il debito della Repubblica al termine della seconda guerra di Morea (v. Tab. 4). A prescindere dagli spostamenti interni dovuti anche al trasporto di crediti dai vecchi depositi ai nuovi Macina e Olio, rispetto al bilancio del 1710 il capitale nominale del debito risulta aumentato di 2.500.000 ducati, raccolti probabilmente attraverso sia i capitali instrumentati che con i nuovi depositi: una somma considerevole alla quale si era tuttavia dovuto ricorrere in un momento di gravissime difficoltà e insicurezza. Potenzialmente più preoccupante era però il sostanziale spostamento di una parte del debito ad un tasso del 4%: si pensi che un rialzo dell’interesse di un punto su una simile montagna di debiti corrispondeva ad un aumento delle spese pari alla metà di tutte le imposte dirette esatte dalla Repubblica.
Così, setacciate le rendite dei proprietari fondiari (mediante le gravezze), quelle degli investitori di capitale finanziario (con le riduzioni d’interesse sul debito), tassati i percettori di redditi da lavoro e da commercio (con le tanse e i taglioni) e rastrellato il loro risparmio (con i capitali instrumentati), aggravato il peso fiscale sulle classi lavoratrici (con l’aumento dei dazi al consumo e del dazio macina), la Repubblica si trovava di fronte al difficile compito di approfittare della riconquistata pace per riassestare il suo bilancio.
Il Banco giro e i problemi della circolazione monetaria
Una delle forme attraverso cui la Repubblica riusciva a procurarsi liquidità era la cosiddetta partita di banco, l’insieme dei crediti verso la signoria iscritti nel pubblico Banco giro.
Come ha spiegato Ugo Tucci, dopo il 1666 il Banco giro, che aveva sofferto un periodo di gravi difficoltà durante la guerra di Candia, si trasformò da semplice organo straordinario sorto per superare alcune strozzature nel servizio di tesoreria pubblica in un vero e proprio banco di deposito, raccogliendo l’eredità del cinquecentesco Banco della piazza di Rialto (41). Chiunque vi poteva depositare denaro contante, senza però ricevere alcun interesse: la somma veniva registrata nei libri contabili e poteva essere utilizzata per le normali transazioni commerciali poiché la partita di banco era legale mezzo di pagamento e di regola non poteva essere rifiutata, anche se veniva usata prevalentemente nel commercio all’ingrosso, per le lettere di cambio e nel pagamento di tributi allo stato. Una delle funzioni originarie del banco era poi quella di trasformare crediti verso lo stato, come ad esempio quelli derivanti dalla fornitura di paste metalliche alla zecca, in partita utilizzabile nel commercio.
La partita di banco fungeva quindi da succedaneo della moneta metallica e, benché la sua valutazione seguisse nella pratica quella della moneta corrente e la sua incorruttibilità fosse quindi più teorica che reale, facilitò notevolmente il commercio dando regolarità e stabilità agli scambi monetari. Le fedi di credito che venivano rilasciate al momento del deposito non assunsero mai il carattere di mezzo legale di pagamento e rimasero sempre tassativamente intrasferibili; per girare del denaro a terzi era infatti necessario presentarsi di persona in banco e solo dopo un controllo sull’effettiva consistenza del deposito l’operazione poteva avere luogo. Dal punto di vista della contabilità pubblica, infine, la circolazione allo scoperto della partita di banco può essere considerata una forma di debito pubblico fluttuante.
La valuta in cui era espressa la partita era la cosiddetta moneta di banco, la cui unità di misura era il ducato di banco. A Venezia coesistevano mezzi di pagamento diversi quali le monete metalliche, le lettere di cambio o la stessa partita di banco, che erano espressi in una moneta di conto che variava a seconda della valuta secondo cui era conteggiata. Se ad esempio un’operazione commerciale contemplava un debito di «cento ducati in moneta di banco», significava che l’obbligazione era costituita da un valore corrispondente a 100 ducati di conto (da 6 lire e 4 soldi ognuno) espressi però in moneta di banco, aumentati cioè del 20% rispetto alla valutazione in moneta corrente. La somma così risultante poteva essere saldata con un mezzo di pagamento convenuto o legale: in 100 ducati di partita di banco, ad esempio, o in tante monete da formare un valore corrispondente a 120 ducati da 6 lire e 4 soldi.
Il rapporto tra le due valute — moneta corrente e moneta di banco — si era venuto assestando attorno al 1621-1625 quando venne posto argine alla crescita di valutazione della moneta di banco, ricercata perché più affidabile, rispetto alla moneta corrente. Il loro differenziale, che era detto aggio, era stato fissato nel 1635 al 20%, ma in realtà variava con il mutare della considerazione che la piazza assegnava alla partita di banco, e soprattutto con la possibilità di convertire liberamente i crediti in contante (42).
Agli occhi di un osservatore moderno questo sistema a doppia valutazione non dimostra alcuna giustificazione logica. Se la funzione della moneta di conto appare infatti necessaria per dare un riferimento monetario stabile alla vita economica, la compresenza di diversi modi di computare tale unità di misura sembra uno stratagemma creato per complicare la circolazione monetaria, ingarbugliare la contabilità ed estorcere denaro agli sprovveduti. Molto più pratico sarebbe stato ridurre tutto ad un unico segno, ma ciò avrebbe implicato un riordinamento complessivo della contabilità pubblica, e forse non era cosa gradita né allo stato né ai soggetti forti (dazieri, finanzieri ecc.) che facevano affari con l’amministrazione.
Come in tutti i banchi di deposito anche nel Banco giro veneziano ad ogni lira incassata doveva corrispondere una lira conservata nei forzieri dell’istituto, di modo che ogni debito potesse essere prontamente restituito in buona moneta metallica. La prolungata congiuntura della prima neutralità armata e dell’ultima guerra veneto-turca spinse però l’amministrazione della Serenissima, così come era successo tra 1648 e 1666, a prelevare denaro dalle disponibilità del banco, tanto che nel 1717, quando la circolazione allo scoperto superava i 2.500.000 ducati correnti, il fondo di cassa si era ridotto a 72.000 ducati (43). Venne allora decretata la sospensione della convertibilità della partita di banco: così ai creditori che volevano monetizzare il proprio deposito non rimase che rivolgersi al mercato.
Sospesa la convertibilità, la partita precipitò fino ad essere scambiata a 93, quindi a 27 lire sotto la parità di legge. Oltre che costituire un fattore di grave disagio per il commercio tale deprezzamento rappresentava un onere considerevole per le casse dello stato, valutabile in centinaia di migliaia di ducati all’anno. Per comprendere tale fatto è necessario ritornare sulla spinosa questione delle diverse valute con cui veniva conteggiata la moneta di conto veneziana.
Tra Sei e Settecento si era infatti creata un’ulteriore complicazione, e sia la moneta corrente che quella di banco potevano assumere un valore diverso a seconda che le si intendesse al corrente della zecca o moneta curta, oppure al corrente della piazza o moneta longa (44).
Con il primo metodo di conteggio — usato in vari pagamenti allo stato ma raramente nei rapporti in cui non interveniva il pubblico — il ducato di conto veniva valutato secondo una deliberazione del 1687 a 6 lire e 4 soldi e trovava un suo corrispettivo metallico nel ducato d’argento emesso nel 1665. Con la moneta longa, valuta in cui si convenivano invece le obbligazioni tra privati oltre ad alcuni pagamenti effettuati dallo stato, si teneva invece conto della svalutazione reale della moneta corrente rispetto ai parametri fissati nel 1687. Un simile conteggio si avvicinava al valore effettivo mercantile della moneta ma non ne era ancora la quotazione di mercato: era infatti formalmente vietato scambiare pezzi monetari ad un valore che non fosse quello fissato per legge. Nel 1733 l’ultima regolazione che interessò il ducato d’argento ne fissò il valore a 8 lire, e nel 1739 vennero definitivamente regolate tutte le monete a corso legale; d’allora in poi per tutto il XVIII secolo il valore moneta longa del ducato, che venne così detto effettivo, rimase stabile (45).
Alcuni pagamenti dello stato, soprattutto in ambito militare, avevano luogo in moneta di banco alla longa. Se la partita di banco era svalutata rispetto al suo valore nominale di 120, questa differenza si trasformava in un aggravio per le casse dello stato, poiché ogni esborso in questa valuta necessitava per essere tradotto in denaro di un quantitativo superiore di pezzi metallici, così come ogni trasferimento allo stato in partita di banco apportava nel concreto una somma inferiore. Più che la preoccupazione di ridurre il debito fluttuante della partita di banco preoccupava quindi l’incidenza di tale meccanismo, per rimediare al quale si ricorse ad un espediente già utilizzato durante la sospensione della convertibilità del 1648-1666. Si accolse l’offerta di un gruppo di mercanti che proposero la stagnazione dei loro depositi, che sarebbero stati vincolati dallo stato per un determinato periodo. Si trattava in sostanza di un consolidamento di una parte del debito fluttuante, che avrebbe apportato una decurtazione della circolazione allo scoperto, con prevedibili effetti deflativi e conseguente rialzo della quotazione della partita. L’onere collaterale di tale operazione consisteva nel peso degli interessi passivi che lo stato si impegnava a corrispondere ai depositanti sulla somma stagnata; interessi del 6% per le stagnazioni che partirono nel 1718 e 1719, addirittura del 7 per quella del 1722, quindi superiori a quelli già sostenuti dai contemporanei depositi Macina e Olio, che pagavano in quegli anni il 5 1/2, 5 3/4% (46). Nel 1723 si decise di convertire 400.000 ducati di partita di banco in un prestito volontario al 6% a scadenza quinquennale, e la quotazione della partita, ormai ridotta a circa 800.000 ducati, salì a 118, ad un livello quindi che poteva consigliarne il ripristino della convertibilità. Furono gli stessi depositanti, cioè mercanti e finanzieri che traevano alti profitti dalla sospensione della convertibilità commerciando crediti in partita, a ritardare indirettamente fino al 1739 la fine del corso forzoso. Con il ritorno alla normalità si chiuse l’ultima fase di instabilità strutturale del Banco giro veneziano. Un periodo durante il quale «la politica della Repubblica, se in un momento di gravi difficoltà finanziarie aveva provocato la crisi dell’istituto, tuttavia non aveva spinto le emissioni fiduciarie fino al suo dissesto, e non appena possibile, con un’azione non priva di incertezze e di errori ma paziente e ostinata, ne aveva promosso il risanamento» (47).
Per completare il quadro delle vicende finanziarie del primo trentennio del secolo è necessario accennare ad un assieme di problemi monetari comuni in questo periodo a vari stati della penisola e che a Venezia culminarono nella sospensione della coniatura del ducato d’argento tra il 1722 e il 1733. Alla base vi fu la crescita, a partire dall’inizio del secolo, della produzione mondiale d’oro, che determinò un aumento sul mercato internazionale del prezzo dell’argento che venne amplificato dalla complessità e dalla intrinseca debolezza del sistema monetario del tempo.
Anche quello della Serenissima era un sistema apparentemente bimetallico, basato cioè su monete sia d’oro che d’argento a valore intrinseco, nel quale però era il metallo bianco a svolgere funzione di regolatore. All’alterazione del rapporto oro-argento, che squilibrava di per sé l’intero sistema, si aggiunsero gli effetti della crescita demografica di fine Seicento, della contemporanea ripresa economica e della congiuntura bellica iniziata nel 1684, che cumulandosi determinarono una maggiore richiesta di denaro e quindi stimolarono l’inflazione, il cui effetto più evidente era il deprezzamento della moneta di conto. Il corrispettivo argenteo della lira di conto, che era rimasto stabile dalla fine della guerra di Candia, cominciò dall’inizio del XVIII secolo nuovamente a diminuire, con una tendenza allo slittamento che si manifestò inarrestabile per i primi trent’anni (v. Tab. 3).
Di fronte a tale nuova instabilità monetaria le autorità veneziane non seppero che rispondere con provvedimenti temporanei, limitandosi ad avvicinare il corso legale delle monete al loro valore di piazza. L’esito limitato di interventi di tale fatta e l’incapacità di mettere mano ad energiche manovre riordinatrici, è stato scritto, dipendevano dall’atteggiamento con cui si guardava al mondo della moneta: una dimensione arcana, dove ad ogni azione di governo conseguivano reazioni inaspettate secondo un meccanismo che rimaneva perlopiù celato alla ragione (48).
Uno degli ambiti in cui più ricorrenti erano gli interventi pubblici era quello della cosiddetta moneta bassa, cioè di quella parte del numerario costituito da monete in lega di rame il cui valore intrinseco era ormai notevolmente inferiore rispetto a quello nominale. Tale classe di monete dominava gli strati inferiori della vita economica, quindi l’economia rurale, il mondo del lavoro salariato e quello del commercio al dettaglio (49). Avevano corso normale i pezzi di provenienza, lega e valore più disparati, sia veneti che esteri, che per il noto meccanismo secondo cui la moneta cattiva scaccia quella buona determinavano frequenti «inondazioni» di monete svalutate, consunte o tosate, dal contenuto intrinseco irrilevante, coniate nei territori finitimi alla Terraferma. Il fatto che la Repubblica confinasse con aree ad autorità monetaria diversa rendeva più frequenti simili evenienze, per cui se la Dominante aveva un regime monetario sufficientemente stabile e controllato, il Friuli che intratteneva stretti rapporti con l’area austriaca e soprattutto la parte più occidentale della Terraferma che verteva economicamente su Milano risentivano costantemente di tali problemi (50).
Le monete estere di bassa lega, come i trairi che nel 1722 invasero la Terraferma, tendevano a fagocitare lo spazio monetario della buona moneta argentea: se ne tollerò ad esempio l’uso in sacchetti e scartozzi, fino ad una certa quota, per il pagamento dei dazi (51). Le autorità altro non potevano fare che effettuare periodiche riconiature che però richiedevano disponibilità di metallo bianco, reperibile solo a caro prezzo. Il periodico scadimento della moneta bassa finiva così per contagiare la circolazione monetaria nei suoi strati superiori e per accentuarne i cicli inflativi.
Quando il prezzo di mercato dell’argento e la valutazione corrente delle monete di questo metallo tendevano a risalire, le autorità si trovavano di fronte alla difficile scelta se adeguarvi subito il valore ufficiale, rincorrendo così il deprezzamento della moneta con effetti moltiplicatori, oppure mantenere il corso legale sotto quello di mercato, nel qual caso si favoriva la «fuga» dei pezzi buoni verso l’estero, diventava assai difficile reperire il metallo per far lavorare la zecca, mantenere regolare la circolazione e coniare monete che riuscissero a porre argine all’infestazione di quelle pessime straniere. Quest’ordine di difficoltà fu alla base delle sospensioni della coniatura del ducato che ebbero luogo tra il 1705 e il 1713 e tra il 1722 e il 1732. Per porre termine al disagio provocato dalla insufficiente circolazione di buon numerario argenteo si adeguò progressivamente, complice anche una situazione monetaria internazionale che si avviava ormai verso l’assestamento, il valore legale dell’argento a quello di piazza, e le paste di metallo bianco ricominciarono a fluire in zecca. Il corso ufficiale fissato nel 1733 del ducato di conto moneta longa a 8 lire — un adeguamento che tecnicamente non si discostava dalla pratica tradizionale — avrebbe in realtà segnato l’ultima regolazione ufficiale della moneta veneziana nella sua storia plurisecolare.
Tre lustri prima aveva trovato una fissazione altrettanto stabile l’altra moneta-perno dell’economia veneziana, il ducato d’oro detto zecchino, la cui funzione di moneta standard per tutto il Mediterraneo orientale non venne mai meno nel corso del secolo, nonostante il crescente prestigio nella seconda metà del secolo del tallero imperiale.
Lo zecchino rappresentò per tutto il Settecento un prodotto da cui tutti trassero profitti. Per lo stato un primo introito derivava dalle quote di signoraggio e di monetaggio, un cespite che a fine Seicento con la coniatura di zecchini per la guerra raggiunse cifre anche considerevoli ma che nei periodi di pace del secolo successivo non costituì quella entrata esorbitante che si riteneva in Italia, dove circolava il mito secondo cui la zecca veneziana ricavasse enormi guadagni grazie a procedimenti segreti (52): a metà Settecento l’utile ricavato dalla coniatura degli zecchini veniva stimato in un 2% (53) e tra il 1736 e il 1783 l’insieme delle «utilità di stampo» della zecca, al netto delle spese e per tutte le monete, non rappresentò mai più dello 0,8% delle entrate statali (54).
Ben più consistenti erano invece gli introiti che derivavano dal particolare corso che avevano le monete veneziane in Dalmazia e Levante (55). Nei possedimenti orientali esse correvano infatti ad un valore nettamente superiore rispetto a quello di Venezia: 31 lire rispetto a 21:15 lo zecchino nel 1 713, 54 lire rispetto a 22 nel 1749. Poiché si fabbricavano con paste pagate al valore di piazza a Venezia, ogniqualvolta lo stato spendeva denaro in Levante ne traeva un indiretto ancorché cospicuo vantaggio, che veniva contabilizzato come un’entrata vera e propria e destinato ad usi diversi: nel 1718 ad esempio alla copertura delle spese della stagnazione della partita di banco (56). Last but not least, anche per i mercanti, data l’appetibilità del ducato d’oro sulle piazze orientali, la sua esportazione consentiva guadagni considerevoli, calcolati attorno al 20% nel secondo ’600 (57).
In conclusione, il ruolo di Venezia nel quadro del sistema monetario europeo rimase ancora per tutto il XVIII secolo di primo piano. Rispetto al 1684-1686, quando la sua zecca batteva un quinto della produzione mondiale di monete d’oro, la prima metà del secolo successivo, complice il progressivo venire meno del ruolo di «intermediario inevitabile» dei commerci internazionali della città lagunare, registrò la perdita di molte posizioni. Ma dal 1760 fino al 1800 a seguito della contrazione della produzione mondiale la sua posizione ridivenne importante in Europa. La stabilizzazione del valore delle sue monete principali, accompagnata come si è detto dall’immutabilità dei coni di ducato e zecchino, avvenne significativamente nei medesimi anni in cui in Inghilterra e in Francia si procedeva, con gli stessi esiti, nella medesima direzione. Un fatto che invita ad esprimere, come si è fatto per il Banco giro, un giudizio tutto sommato positivo sulla politica monetaria seguita dalle autorità marciane; una spia che dimostra il grado ancora elevato di partecipazione dell’economia veneziana al sistema economico europeo.
Bilanci pubblici e revisione contabile: il riordino degli anni Trenta
Dietro alle formule aride delle manovre di politica monetaria o fiscale, non è superfluo ricordarlo, ci sono gli organi dello stato che le discutono e le approvano, e questi sono composti di uomini che nei limiti del loro ceto sociale e della loro posizione burocratica, oltre che ovviamente delle loro intenzioni e capacità, le concepiscono e si adoperano per renderle effettive. Così la storia della finanza di uno stato dovrebbe considerare anche l’evoluzione del suo apparato amministrativo e burocratico, che oggi come allora funge da cinghia di trasmissione tra le decisioni politiche e l’applicazione concreta delle stesse.
La caratteristica fondamentale della costituzione marciana era la polverizzazione della funzione decisionale per cui anche in ambito economico-finanziario era assai difficile trovare un organo che detenesse un’autonomia piena anche in un solo campo di intervento quale le imposte dirette, la gestione della zecca, le tariffe dei dazi, ecc. Il criterio basilare era che il potere non dovesse essere concentrato in poche mani, sicché all’autonomia gestionale e decisionale veniva programmaticamente preferita la sovrapposizione delle competenze che avrebbe dovuto favorire i controlli reciproci ma che il più delle volte generava unicamente confusione, lentezza decisionale, mentalità dilatoria.
Tuttavia nel XVIII secolo in vari ambiti della vita dello stato si manifestò una certa tendenza all’accentramento della funzione di governo in organi ristretti, favorita anche dalla sempre maggiore complessità tecnica dell’amministrazione pubblica. Appare ad esempio in crescita il ruolo del savio cassier, forse la carica singola di maggior peso finanziario della Repubblica, l’unica che fosse potenzialmente in grado di controllare una parte consistente dei flussi di entrata ed uscita. È stato osservato che in virtù della consuetudine di aggregare questa figura alle conferenze che venivano create convocando vari organi per approfondire specifici problemi economici, il savio cassier durante il XVIII secolo dovette di fatto avere «la possibilità di orientare gran parte della legislazione economica del governo» (58).
Salvo qualche singola comparsa di nuovi organi o la nomina di provvisorie deputazioni o inquisitorati l’impianto delle istituzioni economico-finanziarie rimase quello del Cinque-Seicento, con al vertice della piramide decisionale il senato, rispetto al quale la funzione preconsultiva del collegio aumentò di importanza. L’unica eccezione è rappresentata dai deputati ed aggiunti alla provision del denaro pubblico, una magistratura creata nel 1658 che acquisì nel Settecento una crescente importanza: uniti in conferenza con il savio cassier in carica e quello appena uscito, i deputati e aggiunti costituirono di fatto nell’ultimo secolo di vita della Repubblica il vero centro programmatore della vita finanziaria (59).
Anche la struttura burocratica dello stato rimase fondamentalmente immutata, con gli uffici «di governo» riservati all’aristocrazia patrizia e le cariche intermedie — quasi ininterrottamente sottoposte a venalità — occupate da personale non nobile. L’insieme delle cariche contabili subalterne preposte all’amministrazione finanziaria e alla contabilità pubblica rientravano in questa seconda fascia di uffici, e avevano ricevuto già dal secondo Cinquecento un profilo più specifico con la creazione di un collegio dei ragionati al quale dovevano appartenere tutti gli ufficiali che avessero «maneggio di denaro» come i contadori, o «maneggio di scrittura» come gli scontri, i quadernieri, i ragionati (60).
L’ideazione di questa sorta di albo professionale per la formazione e il reclutamento del personale contabile subalterno, assieme all’istituzione nei medesimi anni di una magistratura deputata a sovrintendere e razionalizzare la contabilità pubblica, i revisori e regolatori alla scrittura, erano state tra le poche serie azioni rivolte a migliorare concretamente un sistema di contabilità pubblica caotico e dispersivo. Mancava infatti una qualsiasi forma di centralizzazione delle operazioni di cassa che erano demandate ad una congerie di uffici diversi, per cui con il ramificarsi dell’attività amministrativa il totale delle casse della sola Dominante era salito nel Settecento a oltre duecento, ognuna con una propria contabilità, e specifici criteri di gestione e registrazione contabile.
L’emergenza finanziaria della seconda guerra di Morea portò alla luce la mancanza di norme selettive nel reclutamento degli ufficiali contabili e nei criteri con cui venivano condotte le revisioni. Nel 1719 venne per la prima volta fissata un’età minima di ammissione al collegio dei ragionati, ventiquattro anni: una soglia notevolmente alta per questo corpo di un centinaio di ufficiali specializzati tra cui venivano prescelti dieci appuntadori, funzionari alle dirette dipendenze dei revisori e regolatori alla scrittura e deputati al controllo e alla revisione dei conti di tutti gli uffici, centrali e periferici, della Serenissima. Nel febbraio 1719 le norme che regolavano la procedura di revisione contabile vennero per la prima volta raccolte in un unico testo legislativo che sarebbe rimasto in vigore fino alla fine della Repubblica.
Furono proprio tre fra i migliori ragionati del corpo, quel Giovanni Maria Vianello che aveva compilato il bilancio del 1710, l’esperto Paolo Rizzi e l’allora poco più che trentenne Girolamo Costantini ad essere consultati nel 1721 per riunire i rendiconti delle casse della Repubblica. Ne doveva scaturire, di lì a qualche anno, il primo di una serie di tentativi di «riforma» dell’amministrazione finanziaria: una riforma che verrà invocata più volte senza essere mai portata concretamente avanti anche perché si scontrò ogni volta contro il muro della «molteplicità delle casse» e dell’impossibilità di eliminarle, riunificandole (61).
Fu il Rizzi ad avanzare una proposta in verità assai semplice: demandare al savio cassier la funzione di tesoreria unica, con l’effetto di semplificare la contabilità e centralizzare le funzioni di programmazione e controllo dei flussi finanziari. Su quest’ordine di problemi e sulle soluzioni che si prospettavano, ha notato Angelo Ventura, vennero a contrapporsi la visione «radicale» dei funzionari di origine non aristocratica che giunsero se non a promuovere almeno a concepire una effettiva riforma dello stato, e l’immobile conservatorismo degli organi patrizi che mascheravano dietro l’osservanza all’ordine creato dai padri l’irresolutezza del proprio comportamento politico. Così la proposta del Rizzi venne accolta solo marginalmente dalla conferenza di magistrati che l’aveva sollecitata e il senato procedette unicamente ad una modesta opera di riordino (62).
Gli anni Trenta rappresentarono per la storia della contabilità pubblica veneziana il momento più interessante del secolo XVIII. Per valutare alcuni aspetti di contesto è opportuno segnalare come negli anni centrali del decennio si susseguirono vari episodi di truffa e peculato (intacco) che videro coinvolti diversi ragionati che si appropriarono di somme anche ingenti avendo la possibilità di fuggire grazie alla lentezza delle operazioni di controllo contabile: non ultimo fu lo stesso Rizzi, nel 1735, ad essere coinvolto in malversazioni nel lotto e a lasciare l’ufficio e Venezia (63).
Nel 1736 Girolamo Costantini riunì i rendiconti di tutte le casse della Dominante e dei dominii, e riepilogandone i conti in omogenee categorie giunse a compilare un bilancio generale «di fatto» della Serenissima. Non si trattava dal punto di vista strettamente formale di una novità assoluta rispetto ad altri riepiloghi anche seicenteschi, ugualmente costruiti a partire dai bilanci delle singole casse. Ciò che contraddistingueva l’opera del Costantini, oltre ad un più solido impianto a partita doppia, era però una sistematicità tutta settecentesca nella redazione, assieme alla precisione con cui le singole voci venivano riepilogate in voci ordinate di rendita e spesa. Il quadro pur approssimativo che risultava, ritornava tuttavia un profilo sufficientemente veridico della realtà finanziaria della Serenissima.
Ebbe così inizio la serie dei Bilanci della Repubblica veneta, la cui redazione venne facilitata dall’approntarnento di appositi moduli prestampati per i rendiconti delle singole casse, che sarebbe continuata praticamente fino alla caduta e che tanto impressionò gli specialisti ottocenteschi di storia della ragioneria. Osservati sotto un’ottica più moderna e in prospettiva comparativa la loro portata innovativa è stata tuttavia ridimensionata (64). Se a Venezia tale operazione costituì uno dei punti massimi nel processo di razionalizzazione delle strutture statali, in altri paesi la riforma settecentesca dei bilanci non solo favorì un controllo più centralizzato ed efficace dei flussi ma fu funzionale ad una nuova concezione della programmazione economica e finanziaria dello stato. La possibilità che i bilanci concepiti dal Costantini potessero essere usati a tale scopo era invece inficiata sia dalla qualità dei rendiconti delle singole casse, nei quali spesso non si distingueva tra arretrati riscossi, resti, entrate straordinarie, anticipi ecc., sia soprattutto dall’intempestività con cui venivano redatti: da uno a tre anni dopo la chiusura dell’esercizio. Così la loro utilità, ha scritto Angelo Ventura, si esaurì nel fornire una base statistica utile per provvedimenti di lungo periodo quali ad esempio la riduzione del debito pubblico (65).
Negli anni che seguirono la prima redazione dei bilanci sembrò tuttavia che nell’intricato dedalo dell’amministrazione marciana le spinte verso una semplificazione delle procedure e dei ruoli potessero sortire qualche effetto rinnovatore. Il problema della «semplificazione delle casse» ritornò ad essere sollevato contestualmente allo studio dei provvedimenti per il ripristino della convertibilità del Banco giro. Fu ancora il Costantini assieme ad altri due colleghi a proporre di «obbligare il maneggio tutto della pubblica economia a passare per banco», una soluzione rivoluzionaria che avrebbe contemporaneamente riformato il Banco giro, creato un unico servizio di tesoreria, centralizzato i flussi delle entrate e delle uscite e probabilmente fatto tabula rasa delle complicazioni valutarie e monetarie. Nel più puro stile veneziano non solo la proposta non venne scartata, ma ci si apprestò addirittura ad applicarla, riducendola a mero espediente tecnico «destinato poi a sua volta ad arenarsi nella palude veneta» (66).
Sentimenti di insofferenza verso una situazione sclerotizzata provenivano anche dalle fila del patriziato. Ne rende testimonianza una nota dei revisori e regolatori alla scrittura sopra la questione del reclutamento dei ragionati e degli appuntadori, questione scottante come si è detto, dato il moltiplicarsi degli intacchi e delle fughe. La disamina dei magistrati toccava ad un certo punto espressioni e toni inusuali se non inediti per il linguaggio ufficiale della politica veneziana. «Per quanto si laudino l’età trascorse e gli uomini d’allora» giungevano a dire i patrizi «apparisc[e] che nel nostro mondo economico non vi sono stati mai lustri non che secoli d’oro, ma che si è rubato sempre». E la causa — una volta tanto — non veniva individuata in un problema di leggi insufficienti o regolamenti inosservati, ma ineriva lo specifico del rapporto personale tra i magistrati patrizi che sorvegliavano le casse e i funzionari cittadini che di fatto ne maneggiavano il contenuto e ne registravano i movimenti di denaro: «il nostro mondo [cioè quello dei patrizi] l’ha e l’ha avuta sempre con i ministri, e ragionevolmente. Tutti ne dicono male a piena voce e poi quasi tutti o per accidia o per fascino, quando sono stati alle casse gli hanno lasciati far a loro modo» (67).
Dietro alle questioni più strettamente tecniche l’amministrazione della Repubblica dimostrava una debolezza di fondo insita nel proprio modello costituzionale. Nei ruoli superiori si trovava un ceto di «ufficiali di governo» patrizi che si spostavano incessantemente tra uffici diversi e che invece, con il complicarsi delle procedure amministrative, avrebbero avuto bisogno di una sempre maggiore formazione specifica; nel concreto però l’amministrazione, soprattutto quella finanziaria, era gestita da «ufficiali di servizio» non patrizi in un ruolo teoricamente subalterno ma che di fatto ne detenevano le chiavi cioè la conoscenza dei suoi meccanismi di funzionamento. Tale realtà garantì un sufficiente livello di funzionalità del sistema, ma una seria operazione di riforma amministrativa non avrebbe potuto esimersi dall’affrontare questa contraddizione fondamentale. Anche per questo motivo tutti i tentativi settecenteschi di riforma amministrativa si esaurirono in modeste operazioni di riordino, di semplice «buon governo» settecentesco. Nel 1743 vennero ad esempio sistemate le norme che regolavano la revisione contabile delle casse della Dominante e l’ufficio degli appuntadori — che divenne una carica «a vita» — conseguì un profilo di sostanziale autonomia, con un inquisitore alle revisioni ed appuntadure patrizio in veste di coordinatore. Si trattò di un’operazione che diede subito frutti concreti, contribuendo a determinare un effettivo miglioramento nella qualità della contabilità pubblica veneziana (68). Ma non si trattò in nessun modo di quella «vera e propria riforma» che una certa storiografia vi volle vedere (69). Ne mancavano i presupposti istituzionali e sociali, prima che tecnici.
La babele dei dazi, il dedalo delle gravezze
I primi due bilanci del Costantini consentono di fare il punto sulla situazione della finanza marciana, considerandone gli aspetti strutturali (70). A metà degli anni Trenta le esigenze annuali ammontavano grosso modo a 6.000.000 di ducati, dei quali oltre un terzo era destinato alle spese di ordine militare (tra le quali erano comprese anche spese che definiremo per l’ordine pubblico oltre che costi fissi per il governo del Golfo e del dominio da mar) e una quota pressoché uguale al mantenimento del debito pubblico, di cui circa 300.000 ducati erano stanziati per il suo ammortamento. Nel complesso quindi quasi i 3/4 delle spese erano assorbiti da queste due voci e il rimanente era destinato ai costi vivi dell’amministrazione, ai lavori pubblici oltre che ad una intelaiatura di stato sociale con provvisioni ad ex dipendenti pubblici, patrizi poveri e loro famiglie, elemosine a poveri ed emarginati.
Le rendite ordinarie assommavano a 5.100.000-5.300.000 ducati, e possono essere ripartite in tre grandi voci: le imposte di consumo, quelle dirette e una congerie di cespiti secondari di varia natura. La parte del leone era svolta ancora dalle imposte indirette: i partiti e dazi della Dominante, dei domini da terra e da mar apportavano il 60% del denaro che entrava in cassa.
Sin dal suo aspetto terminologico la materia dei dazi appare difficilmente riducibile a categorie moderne che ne possano favorire la comprensione. Il termine dazio veniva infatti utilizzato per indicare i normali dazi di importazione o transito, quelli di consumo, i monopoli e le privative, ma anche le rendite derivanti da vendite in esclusiva, le imposte sulla macellazione e addirittura quelle su atti notarili, testamenti, ecc. Un’altra difficoltà è costituita dalle diverse forme di esazione. Si usavano chiamare partiti gli appalti di vari dazi riscossi assieme oppure più specificatamente quelli di generi soggetti a monopolio come il sale e il tabacco. Il sistema degli appalti fu sempre preferito dalle autorità finanziarie venete rispetto alla riscossione per Serenissima Signoria, perché per esperienza garantiva un ricavo netto superiore, nonostante il rapporto tra le autorità e i partitanti finisse spesso per essere dominato da questi ultimi in virtù della loro capacità finanziaria e grazie ai crediti che vantavano per anticipi sugli appalti. Come accadeva altrove, anche i dazieri veneti erano personaggi di un rilievo sociale non comune che spesso riuscivano a ritagliarsi una posizione di concreto significato politico e istituzionale tale da rappresentare «una vera potenza entro la compagine statale» (71): basti pensare alla possibilità che avevano di influire in maniera determinante sui prezzi di mercato oppure alla facoltà loro concessa di reprimere con squadre armate il contrabbando. Vi è una consistente casistica sull’avversione delle popolazioni venete contro il loro comportamento e i loro abusi; ne rende testimonianza un bergamasco che li descrive efficacemente come «uomini disumanati [...] carnivori, sitibondi del sangue di queste attive classi, poiché ne gl’estorquono, ne gli caricano, ne gli rovinano sino alla quarta generazione» (72).
Ma non sempre la Repubblica decideva di affidarsi a finanzieri senza scrupoli; frequentemente preferiva appaltare dazi anche importanti a enti locali, comunità o corporazioni di mestiere, magari ricavando una somma minore rispetto ad un appalto «libero», ma ottenendo di coinvolgere i ceti locali in una funzione di controllo impedendo nel contempo che si verificassero lacerazioni sociali o situazioni di carico fiscale insostenibile. Il caso del dazio della carne di Verona, la cui condotta venne affidata dal 1718 al 1758 all’amministrazione della città per contenere lotte tra fazioni e scontri corporativi, dimostra quali interessi e posizioni conflittuali fossero in gioco in questo ambito fiscale: quelli della grande massa dei consumatori tutelati (teoricamente) dal calmiere, quelli del consiglio cittadino impegnato a mantenere alto il livello del gettito, quelli del senato veneziano interessato ad incrementare il ricavo senza scompensi sociali (73). Sempre nella città scaligera il caso del dazio sulla produzione ed esportazione della seta rappresentava un esempio emblematico dell’incapacità da parte sia delle autorità veneziane sia delle istituzioni che se ne assunsero la conduzione (fra cui gli stessi mercanti di seta) di trovare un equilibrio tra modalità di esazione, peso dell’imposizione e ammontare del gettito: il tutto rinforzava un contrabbando che arrivò ad interessare 200 delle 300.000 libbre di seta grezza prodotte nella provincia (74).
I dazi più importanti erano, a metà degli anni Trenta, quelli sui principali beni di consumo, il dazio sulla seta prodotta nella Terraferma, le imposte riscosse nelle quattro dogane marittime di Venezia oltre che quelle esatte per il transito nei territori. Ognuno di questi dazi era regolato in maniera diversa. Quello del sale, che rendeva circa 600.000 ducati, era suddiviso in vari partiti pagati all’ufficio del sal della Dominante in base ad un contratto che stabiliva sia la quantità di sale che doveva essere distribuita sia il prezzo di vendita. Per quasi tutto il secolo, ad esempio, il prezzo finale imposto al partitante fu di 5 soldi la libbra a Venezia, 4 in Friuli, 6 nelle altre province. L’appaltatore rivendeva poi il sale ad impresari che lo distribuivano (75).
Quello dell’olio — 350.000 ducati di gettito medio — si reggeva sull’odiosa norma per cui tutto l’olio prodotto nello stato, province d’Oltremare incluse, doveva transitare per le dogane della capitale. Studiandone le vicende settecentesche Salvatore Ciriacono ha osservato che «oltre che apparire gravoso, si rivelava eccessivamente differenziato ed ingiusto agli occhi dei contribuenti»: il prodotto veniva infatti tassato tre volte, all’ingresso, in uscita e al consumo, in misura diversa a seconda della provenienza, della nazionalità degli importatori, dell’uso alimentare o industriale (saponifici e lanifici) che se ne sarebbe fatto, oltre che della destinazione. Il dazio d’uscita per le province più lontane era più mite perché teneva conto dei maggiori costi di trasporto e quindi delle crescenti tentazioni per il contrabbando. Il dazio entrata e uscita veniva appaltato separatamente da quello di consumo e con il metodo della serrata secondo cui l’esazione era condotta dai privati ma i bilanci erano redatti dalla magistratura dei provveditori agli olii; i conduttori avevano in più l’obbligo di riscuotere per conto pubblico le addizionali correnti sulla tariffa (76).
Per i dazi sul vino e sulle carni il discorso si complica, poiché essi erano soggetti ad un dazio al consumo nella Dominante — che rendeva rispettivamente le forti somme di 300 e 150.000 ducati circa — e a imposizioni diverse nello stato, per cui determinarne l’ammontare complessivo è allo stato attuale delle ricerche impossibile. Sebbene molti indichino nel dazio del sale la voce più consistente di quest’ordine di entrate fiscali (solo perché il partito era unico per tutto lo stato), appare tuttavia evidente che il vino, la malvasia, l’acquavite, ecc. costituissero la categoria merceologica che forniva il maggior introito all’erario, superiore anche a quello prodotto dai cereali attraverso il dazio macina e vari altri dazi e dazietti come quello del pestrin che colpiva la fabbricazione e la vendita del pane (77).
Progressivamente si dovette irrobustire nelle autorità veneziane la consapevolezza della generale utilità, se non «moralità», di una maggiore tassazione dei generi di lusso — tra i quali sarebbe però errato comprendere il vino e gli alcolici — rispetto a quelli di prima necessità. Il dazio sul tabacco venne ad esempio appaltato per la prima volta nel 1657 fruttando 46.000 ducati, nel 1736 venne iscritto a bilancio per 144.000 giungendo a renderne negli ultimi anni del secolo circa 600.000. Nel 1720 l’inquisitorato sopra i dazi con un certo gusto per il paradosso riferiva che l’aumento assai vistoso del gettito non era merito dei partitanti, bensì un dono della divina provvidenza che «avendo dato alli uomini una natura molto inclinata alla viziosità ed alla imitazione, [la natura] studia qualunque d’imitare e di viziosamente sapere il gusto di una novità ricevuta e posta in credito dall’uso delle persone più riguardevoli» (78). Nel 1745 poi i deputati si rallegravano per l’avvenuto appalto del caffè, riflettendo come «senza molti riguardi convenisse d’aggravarsi tutte quelle cose che sono di consumo voluttuoso e di lusso» (79).
Una delle voci a cui l’amministrazione marciana aveva sempre dato grande attenzione erano i dazi riscossi nelle dogane della Dominante. Questo dato appare però decisamente più significativo quale indicatore del traffico marittimo che come cespite d’entrata, rimanendo per tutto il secolo tra i 100 e i 200.000 ducati. In realtà il commercio dal quale si ricavavano maggiori introiti fiscali era quello interno sia di generi alimentari che di manufatti. Ricostruirne un profilo quantitativo sarebbe del massimo interesse per valutare le trasformazioni dell’economia veneta ma appare compito quasi impossibile data la dispersione sul territorio e la frammentarietà dell’esazione: come spiega una scrittura del 1775, una merce che uscisse da Padova diretta al consumo a Bergamo pagava il dazio d’uscita dalla città patavina, quelli di transito a Verona, Salò e Brescia e infine quelli di entrata e di consumo a Bergamo (80). Sull’importanza ai fini fiscali di tale movimento economico ha valore esemplificativo il dazio della stadella (da stadera) di Verona, un dazio di entrata, uscita e consumo riscosso alle porte della città ed in altri luoghi appositi (81), che rese nel 1736 400.000 ducati. Si trattava, grazie alla sua funzione di filtro dei commerci attraverso l’Adige per l’area tedesca, del più importante dazio di transito esatto in Terraferma, e il suo gettito paragonato a quello molto inferiore delle dogane veneziane è indicativo del peso dell’economia dello stato di terra. A questo proposito un calcolo molto parziale dei vari dazi seda delle province di Terraferma indica un cespite annuo derivante da questa importantissima attività superiore al mezzo milione di ducati, collocando quindi questa voce tra le più importanti imposte indirette.
Quelle che possono essere considerate imposte dirette venivano indicate con il termine di gravezze. La loro suddivisione tra gravezze della Dominante, della Terraferma, ecc., va riferita alla giurisdizione fiscale alla quale era sottoposto il contribuente; per quanto riguarda la tassazione fondiaria si usava ad esempio distinguere tra fuochi veneti, cioè proprietari soggetti all’autorità dell’ufficio dei dieci savi alle decime di Rialto, e fuochi esteri regolati dalle camere fiscali delle province del dominio.
Nel Settecento l’imposta diretta più pesante per i contribuenti della Dominante era la decima che apportava oltre 350.000 ducati all’erario e che avrebbe dovuto corrispondere ad un decimo dei redditi da beni immobili dichiarati. In realtà la sua incidenza reale era assai inferiore: la sua determinazione si basava infatti solo sulla dichiarazione volontaria dei possidenti a cui era inoltre concesso di versarne una parte in frumento ad un prezzo superiore rispetto a quello mercantile, con uno sconto, don, del 10% in caso di puntuale pagamento. Samuele Romanin ha stimato che in definitiva corrispondesse ad 1/30 effettivo dei redditi colpiti (82). Riscosso annualmente come la decima era il campatico, una vera e propria imposta fondiaria basata sulla destinazione agricola del fondo, che apportava altri 100.000 ducati circa, mentre a una tassazione separata erano soggetti i beni del clero, colpiti da un’apposita decima il cui importo annuale era frutto di accordi con la Santa Sede (83).
I redditi derivanti da attività commerciale, finanziaria, manifatturiera o professionale erano soggetti ad altre imposte: la tansa, una somma forfetaria decisa da una commissione apposita in base ad un’indagine fiscale, e i taglioni, imposte sui mestieri e le professioni civili riscosse dalle stesse corporazioni che furono oggetto di riforma nel 1713 (84). Infine ai dipendenti pubblici veniva trattenuta alla fonte una decima sui redditi fissi e su quelli straordinari, un’imposta che al pari delle altre poteva essere esatta anche straordinariamente in caso di stringenti necessità di bilancio.
Per i contribuenti della Terraferma lo spettro delle imposte dirette era complessivamente simile, con alcune differenze non secondarie. Non esisteva per i fuochi esteri la decima, che era sostituita da un insieme di antiche gravezze dette de mandato dominii che avevano un peso minore a seguito anche delle alienazioni di cui erano state oggetto nei secoli precedenti. Queste gravezze venivano ripartite sul territorio per contingenti: veniva cioè stabilita una quota fissa che l’erario voleva incassare e che era suddivisa tra le province; spettava quindi alle amministrazioni dei capoluoghi di provincia stimare le ricchezze dei contribuenti e ripartire la quota tra i diversi «corpi», cioè la città, il clero ed il territorio.
La differenza tra l’ammontare nel 1736 delle gravezze della Dominante e quelle esatte nei dominii — 604.000 contro 565.000 ducati — invita ad alcune riflessioni. Considerare il carico fiscale che gravava sulle due realtà in base al numero degli abitanti, come è stato fatto, appare un’operazione impropria: se si volesse ricavare un dato quantitativo affidabile si dovrebbe casomai far riferimento alla distribuzione della ricchezza o al prodotto interno lordo delle due realtà, indicatori praticamente impossibili da ricavare (85). Più utile è riflettere sul fatto che sebbene i Veneziani disponessero di 1/5 delle proprietà di Terraferma censite nel 1740 ad est del Mincio (86), di una quota considerevole dei titoli pubblici e nonostante nei loro palazzi vi fosse indubbiamente la maggior concentrazione di lusso dello stato, la maggior parte della ricchezza detenuta e del reddito prodotto apparteneva agli oltre 2.000.000 di sudditi dello stato e non ai 140.000 abitanti della Dominante. Appare quindi evidente che, proporzionalmente, le rendite immobiliari dei patrizi veneziani e i redditi professionali degli abitanti della laguna erano maggiormente tassati rispetto a quelli degli abitanti della Terraferma e del dominio, dove peraltro doveva essere più pesante la tassazione indiretta, cioè l’incidenza dei dazi.
Il quadro che ne risulta è quello di un sistema basato su una sorta di patto tra l’aristocrazia lagunare che manteneva praticamente esenti i redditi derivanti dall’investimento finanziario dei propri capitali e i ceti terrieri della Terraferma che avevano le mani libere sul bene su cui avevano fondato la propria preminenza sociale e politica, la terra (87). Da ciò scaturiva quell’impressione di una struttura tributaria «piuttosto equa ed organica» (88), che generava un carico fiscale sopportabile un po’ per tutte le categorie, la cui mitezza acquisisce rilievo se confrontata con la situazione vigente in altri stati italiani o europei. Era un sistema che si equilibrava — per così dire — verso il basso, comportando cioè una progressiva perdita di efficienza, una dispersione di risorse nonché il moltiplicarsi di abusi e sperequazioni, ma che reggendosi sulla connivenza di tutti i ceti superiori e sulla passività di una popolazione tutto sommato blandamente soggetta a tributi, non diede mai luogo ad incontrollabili fenomeni di rivolta fiscale.
La stasi delle rendite, 1730-1746
Toccando i 5.300.000 ducati di entrate effettive annue il sistema tributario veneto dimostrava a metà degli anni Trenta una capacità di prelievo nettamente diminuita rispetto ad un quarto di secolo precedente, quando erano stati raccolti 5.800.000 ducati per di più ad un valore reale della moneta di conto nettamente superiore (89). Sostanzialmente invariato, però solo in termini nominali, si dimostra il gettito delle imposte dirette che rappresentava ancora una quota percentuale delle entrate complessive elevata, il 20% circa, mentre addirittura in diminuzione risultavano le imposte di consumo, ridotte di quasi mezzo milione di ducati.
Per comprendere il significato di questa sensibile flessione bisognerebbe conoscere il movimento complessivo della produzione e dell’economia della Repubblica. Dati sufficientemente significativi si dispongono per il traffico commerciale marittimo, che conobbe dall’inizio della seconda guerra di Morea e fino al 1736 il più forte e prolungato periodo di crisi del secolo prima della caduta degli anni Novanta, con ripercussioni sull’economia della città lagunare e fallimenti di ditte commerciali. Indicazioni incerte vengono dal settore agricolo che costituiva il nerbo anche dell’economia veneta, per la mancanza di dati rappresentativi sui raccolti e per le contraddizioni insite nei prezzi cerealicoli che dimostrano solo dal 1731 una tendenza chiara al rialzo. Né vengono in aiuto informazioni demografiche, praticamente inesistenti fino ad oltre metà secolo. Danneggiamenti e scorrerie di soldatesche estere si ebbero nelle province occidentali durante la guerra di successione polacca (1733-1738) che si svolse ancora una volta perlopiù in Italia e di fronte alla quale la Repubblica scelse nuovamente la strada della neutralità armata (90).
Oltre all’ambito della contabilità pubblica, uno dei settori in cui il moltiplicarsi degli studi e delle proposte sembrò poter dare risultati concreti fu quello dei dazi marittimi, grazie alla tradizionale attenzione verso il commercio esterno che aveva portato all’attivazione sin dal 1708 di un’apposita deputazione al commercio. Nel 1736 si vararono nuove tariffe daziarie per le navi venete, considerevolmente ridotte sia per le merci in entrata che per quelle in uscita, decretando anche la sospensione dell’obbligo di navigazione in convoglio per le navi che rispondessero a precisi requisiti costruttivi e di armamento (le navi atte), contribuendo così a diminuire i costi di trasporto. Gli effetti della manovra si sommarono a quelli di una congiuntura internazionale positiva nonché ai riflessi della guerra che opponeva Russi e Austriaci contro Ottomani; il traffico delle dogane lagunari registrò un incremento di quasi il 50%, con effetti certamente positivi anche se difficilmente quantificabili sull’economia, ma ebbe come contropartita una diminuzione di 50-100.000 ducati annui nei dazi (91). Nel 1739 venne calcolato che la politica liberista aveva concesso un «dono di 115.000 ducati» al commercio e alla manifattura, per una perdita complessiva dell’erario stimata cinque anni dopo in 900.000 ducati (92). La ripresa della guerra di corsa e una flessione nel commercio internazionale abbassarono di nuovo i volumi del traffico e spinsero le autorità a ripristinare progressivamente tra il 1745 e il 1751 tariffe protezionistiche.
Indicazioni contrastanti provengono anche dal delicato settore delle imposte dirette. Tra il 1712 e il 1722 vennero effettuati la redecima e il rinnovo del campatico dei fuochi veneti, con aumenti previsti non superiori al 10%. Alla fine degli anni Trenta venne promossa la redecima sia dei beni dei contribuenti lagunari che dei fuochi esteri, un’operazione assai complicata che presupponeva la descrizione di tutti i beni fondiari secondo la loro dislocazione sul territorio, e che per i beni della Terraferma non era stata più compiuta dal 1661. Questa volta la redecima, che fu l’ultima nella storia della Repubblica marciana, venne compiuta simultaneamente per le due categorie di beni e fu gestita dal solo ufficio dei dieci savi alle decime di Rialto, compiendo quindi un significativo passo in avanti in direzione di una omogeneità del sistema (93).
Informazioni affidabili che consentano di valutare l’impatto reale di queste operazioni non sono disponibili. Daniele Beltrami nella sua preziosa opera sulla proprietà fondiaria nelle campagne venete riporta dati tratti da fonti governative sul gettito teorico di decima e campatico veneziani e sui relativi resti, cioè le somme inesatte. Questi dati sono però decisamente superiori all’ammontare delle entrate effettive registrate nei bilanci generali e provenienti dai riepiloghi di cassa dell’ufficio dei governatori alle entrate. Tirate le somme, l’unica indicazione certa è che se l’importanza di queste operazioni per il riequilibrio del carico fiscale, sperequato dai continui passaggi di terre nelle mani dell’aristocrazia lagunare, fu effettiva, la loro incidenza sulle entrate pubbliche fu invece marginale. Un modesto aumento in realtà si verificò, ma sembra piuttosto addebitabile alla diminuzione dell’evasione fiscale: i resti della decima scesero infatti dal 27,5% dell’imposta prevista del primo decennio del secolo al 12-13% dei tre decenni centrali (94). Si trattò di uno degli effetti positivi di quella tendenza al riordino e all’efficienza che tra gli anni Trenta e Quaranta apportò miglioramenti concreti anche se non determinanti al funzionamento della macchina amministrativa della Dominante.
Per quanto riguarda le imposte del dominio, sembrerebbe invece difficile trovare anche solo queste tracce di «buon governo» settecentesco. Le relazioni dei podestà in Terraferma sono un susseguirsi di lagnanze per l’inesigibilità dei resti delle imposte dirette, per l’infierire del contrabbando, per l’impossibilità di metter mano ad un riordino delle camere fiscali e della loro assurda contabilità, complicata dalla presenza di casse con contabilità diversa a seconda che i cespiti fossero riservati alle spese locali, a quelle militari o dovessero esser trasferiti a Venezia.
La curva negativa dei dazi di Terraferma può forse in parte essere spiegata con il moltiplicarsi delle esenzioni daziali, che erano dilagate con la vendita dei beni comunali tra il 1646 e il 1727 che aveva ulteriormente dilatato la presenza nobiliare e patrizia in Terraferma, sicché spesso si ritrovavano ad essere esenti dai vari dazi i prodotti delle tenute più redditizie e della produzione maggiormente orientata al mercato (95). I bilanci compilati dai revisori e regolatori alle entrate pubbliche in zecca dimostrano una sconfortante stazionarietà del gettito delle imposte indirette della Terraferma che nel 1736 appare diminuito nominalmente, quindi in forte flessione reale, rispetto al 1691 (96).
Quanto poi alla tassazione diretta e al sistema degli estimi, un anonimo progetto del 1758, quasi certamente di un ragionato appuntador, dimostrava come il decentramento dei meccanismi di accertamento avesse generato una totale difformità dei criteri di valutazione e come l’unica soluzione proficua sarebbe stata quella di ridurre tutto sul piede della decima veneziana che come era già stato inutilmente osservato nel 1738 dal magistrato sopra camere e ancora nel 1762 da un’apposita commissione garantiva un cespite superiore (97).
Per tutti i primi anni Quaranta, come testimoniano le scritture pubblicate nella serie dei Documenti finanziari della Repubblica di Venezia, deputazioni e conferenze si dilungarono nel ricercare nuove possibili fonti di reddito senza evitare che si ricadesse nella logica dei «provvedimenti straordinari», cioè anticipazioni di partiti, prestanze da enti e comunità, ecc., che erano ormai una componente strutturale del bilancio veneziano e che di straordinario avevano ormai solo l’inalterata capacità di mascherare il disavanzo dello stato. Nel 1744 la proposta di varare un’imposizione straordinaria di 450.000 ducati divisi tra Dominante e Terraferma venne accantonata soprattutto per la consapevolezza che, una volta decretata, sarebbe comunque rimasto il problema di riscuoterla (98). Il momento era grave per la finanza pubblica veneziana: gli effetti positivi sul debito pubblico della manovra del 1714 si andavano ormai esaurendo e le aggiunte ai depositi Macina e Olio diventarono praticamente annuali (99), riportando la spesa annuale per gli interessi passivi alla soglia dei 2.000.000 annui. La guerra di successione austriaca, iniziata nel 1740, costrinse la Repubblica ad un nuovo impegno per la difesa e le spese sfiorarono il preoccupante tetto dei 6.000.000 di ducati portando il disavanzo, al netto delle affrancazioni del debito, a 800.000 ducati.
Dal 1746 si cominciò comunque a intravedere un lento ma sensibile risveglio di quasi tutte le principali poste attive di bilancio. I tributi a base fondiaria aumentarono di circa un decimo tra il 1740 e il 1750 e dopo qualche anno si rimisero in moto anche le entrate dei dazi, quasi esclusivamente però quelli esatti nella Dominante. Salirono anche gli importi delle diverse tanse e taglioni, che colpivano in vario modo il commercio, le professioni ed i mestieri; nel 1738 si abolì la possibilità di pagare solo una tassa, la più alta, fra tansa e campatico, e negli anni successivi si dovette migliorare il sistema di accertamento ed esazione di questa categoria di gravezze che raddoppiarono il loro gettito tra 1736 e 1755 (100). L’estensione alla Terraferma di una tassa di successione del 5% gravante sopra le eredità ricevute al di fuori della cerchia dei parenti stretti (101) si dimostrò un’iniziativa efficace, che nel 1755 risultò apportare la rispettabile cifra di 55.000 ducati. Spia di una migliorata situazione di bilancio fu infine il diminuire dal 1747 delle anticipazioni e prestanze (102), a cui l’anno successivo andarono a sommarsi i riflessi positivi della fine della guerra di successione austriaca.
Le manovre sul debito pubblico degli anni Cinquanta e Sessanta
Una voce passiva che gravava in maniera non lieve sul cronico disavanzo era costituita dalla cifra che annualmente veniva destinata alle affrancazioni del debito pubblico, che a partire dal 1714, assieme alla corresponsione dei pro, venne inflessibilmente onorata.
Una scrittura del 1745 sottolineava l’importanza di destinare cespiti specifici al finanziamento di un fondo di ammortamento del debito, una pratica in seguito enfatizzata da molti autori che vi vollero vedere l’antecedente del Sinking Fund istituito di lì a pochi anni in Inghilterra (103). Il pagamento puntuale di interessi e quote di ammortamento, annotavano i deputati ed aggiunti, aveva determinato un fluire ininterrotto del risparmio privato nelle casse pubbliche con generale soddisfazione dei sudditi e concorso di capitali stranieri, aveva facilitato il pagamento di gravezze e dazi e soprattutto concorreva a mantenere alta l’affidabilità dello stato, la risorsa estrema, aggiungiamo noi, a cui la Repubblica contava di aggrapparsi in caso di gravi difficoltà (104). Sebbene come osservava Einaudi le autorità fossero costrette a ricorrere a nuovi debiti perché si ostinavano a rimborsare quelli vecchi (105), il «rinnovamento» del debito pubblico aveva evidenti vantaggi anche psicologici sulla platea degli investitori che assai spesso si limitavano a reinvestire i capitali affrancati nei depositi statali. Il punto debole della finanza veneziana non stava insomma nella gestione del debito ma nel sempre sbilanciato rapporto tra spese rigide e rendite inespandibili. In questo contesto si limitarono a limare qualche migliaia di ducati due mini-conversioni del debito, nel 1739 e 1746, che portarono al 4% sotto la forma di capitali instrumentati 3.000.000 di depositi a tassi superiori e che ridussero ulteriormente dal 2 all’1,3% il «debito vecchio» convertito nel 1672, e uniformemente al 2% quello oggetto di manovra nel 1714 (106).
Maggiori aperture consentì la congiuntura instauratasi dalla seconda metà degli anni Quaranta, quando le rendite cominciarono ad attestarsi sopra i 5.500.000 ducati e per la prima volta dopo molto tempo il bilancio, al netto delle somme destinate alle affrancazioni, registrò un segno positivo. Per questi anni si dispone finalmente di un riepilogo complessivo del debito della Serenissima che consente di vagliarne l’evoluzione dalla fine della guerra di Morea (v. Tab. 4). La grande massa di 55.000.000 di ducati del debito vecchio risultava inalterata e il peso degli interessi passivi comportava ancora un esborso annuo di oltre 1.000.000 di ducati. In pericoloso aumento appare il «debito nuovo», che superava i 22.000.000 di ducati dei quali solo 3.300.000 rimasti nei depositi Macina e Olio, gli altri passati tutti nei capitali instrumentati gestiti da Arti e Scuole. L’ammontare complessivo oltrepassava gli 80.000.000 di ducati, una cifra che doveva avvicinarsi al prodotto interno lordo di tutto lo stato e che, secondo la stima autorevole formulata a proposito da Andrea Tron, era pari ad oltre un quarto di tutte le ricchezze immobili dello stato (107).
Sin dal 1748 i deputati ed aggiunti alla provvision del denaro pubblico si misero in moto, spinti a procedere in direzione di una manovra di non corto respiro da una nuova, percettibile predisposizione del mercato finanziario ad accettare tassi d’interesse più bassi: accadeva infatti che le Scuole grandi offrissero subingressi, cioè reinvestimenti di depositi scaduti, al 3,5%, incamerando quindi il mezzo punto in più che lo stato pagava loro sui capitali instrumentati (108). Si trattava di un’occasione da non perdere, segnalavano al senato i deputati ed aggiunti, che si soffermavano con toni inusuali sui vantaggi generali di un abbassamento dei tassi sul debito pubblico. Ne trarrebbe giovamento il commercio, riflettevano, perché i tassi che vi si praticano vi si adeguerebbero «senza la forza d’alcun decreto», e nei paesi dove più basso è il costo del denaro «sono gl’errari de’ Prencipi ed i commerci delle nazioni più floridi e ricchi», perché aumenta il giro d’affari delle manifatture, s’impiega più manodopera che emigra dai paesi più poveri «e da tutto ciò nasce l’aumento dei consumi e per conseguenza delle pubbliche rendite» (109).
Una proposta del 1750, non giustificabile in un periodo di pace per la sua radicalità secondo Einaudi (110), venne messa da parte e si dovette attendere il 1752 e un peggioramento del saldo di bilancio perché il senato si determinasse ad una seria operazione di riordino. Nel febbraio 1753 venne offerto ai rimanenti detentori di sottoscrizioni dei depositi Macina e Olio di riscuotere subito il denaro o di trasferirlo in capitali instrumentati, trasformando quindi i loro crediti in debito perpetuo o perlomeno senza scadenza fissa di ammortamento; contestualmente venne aperto il Deposito Nuovo al 3,5%, i cui proventi sarebbero serviti a finanziare l’ammortamento del debito al 4%, quindi dei capitali instrumentati. Entrambe le fasi furono coronate da successo: l’estinzione dei depositi Macina e Olio comportò solo un esiguo numero di affrancazioni quasi esclusivamente di capitali genovesi evidenziando un differente comportamento tra investitori veneziani ancora certi dell’affidabilità del Tesoro, e capitalisti genovesi che iniziarono invece un processo di disinvestimento dai fondi pubblici della Serenissima che si sarebbe protratto a lungo. Quanto al «dissecamento» dei depositi al 4%, esso procedette fino al 1766, quando degli oltre 19.000.000 di capitali instrumentati non rimanevano in Scuole cd Arti, sotto questa forma che tanto successo ebbe nella prima metà del secolo, che poche centinaia di migliaia di ducati (111).
La manovra di estinzione dei depositi al 4% si svolse in un periodo in cui le condizioni generali della finanza pubblica veneziana inducevano ad un moderato ottimismo. La rendita effettiva dello stato salì progressivamente fin quasi a 6.000.000 di ducati grazie soprattutto ai dazi e partiti, per l’aumento dei quali fu importante il rinnovo nei metodi di appalto del sale e dell’olio (1752 e 1755) (112) e la crescita del partito del tabacco; anche i dazi di Terraferma dimostrarono finalmente un aumento apprezzabile probabilmente in virtù del progressivo recupero di alcune regalie, soprattutto diritti di macina, osterie e dazi minori alienati durante i periodi di guerra (113).
Sostanzialmente statico, nonostante il completamento del 1755 della riforma della tansa (114), rimaneva invece il contributo delle imposte dirette, la maggior parte delle quali, è opportuno ricordarlo, erano esatte per limitazion cioè sulla base di una somma prefissata che in periodi di non stringenti necessità finanziarie le autorità veneziane preferivano evidentemente non aumentare per non alterare delicati equilibri sociali ed istituzionali. Va tuttavia segnalato come attorno al 1755 venne a chiudersi la forbice tra l’ammontare delle gravezze della Terraferma e quelle della Dominante: se nel 1736 il rapporto tra le due era di 70 a 100, poco dopo la metà del secolo si registrò una sostanziale parità tra le due voci. Sebbene ciò debba essere in buona parte da attribuire all’estensione dell’imposta sulle eredità alla Terraferma, anche questo spostamento di lungo periodo evidenzia la crescita di peso demografico ed economico dei dominii italiani della Repubblica: una realtà alla quale anche la politica fiscale pur tra mille cautele e attenzioni dovette uniformarsi, se non altro per alleggerire la pressione tributaria sulla capitale il cui profilo demografico e finanziario risultava ormai ridimensionato.
Nella primavera del 1766, considerando terminata l’estinzione dei capitali al 4% e riflettendo che il mantenere aperto il Deposito Nuovo avrebbe solamente aumentato il debito pubblico, le autorità decretarono la fine delle sottoscrizioni. Nel riepilogare i risultati della lunga manovra di conversione i deputati e aggiunti «si accorsero» dell’esistenza di un’eccedenza di 800.000 ducati, con la quale pensarono di continuare l’affrancazione, programmandola in un primo momento per il solo Deposito Nuovo. In settembre il senato commetteva invece agli stessi di prendere in esame «il valor delli capitali vecchi in commercio», ritornando quindi sulla materia eterna ed insoluta del debito vecchio, i 56.000.000 di ducati oggetto delle conversioni del 1714 e prima ancora del 1672, la cui origine si perdeva quindi nelle viscere delle guerre del Seicento (115).
È difficile spiegare come mai l’ipotesi più volte presa in esame di toccare la montagna di debiti vecchi abbia trovato in questo passaggio storico la via per una sua seppur problematica risoluzione. È vero che, come si è osservato, le entrate si mantenevano ad un buon livello e il saldo di bilancio continuava da tre lustri a registrare più segni positivi che contrari; ma il debito pubblico era sceso a 75.000.000 di ducati ed il suo costo annuo di mantenimento, affrancazioni escluse, era sul livello più basso del secolo, tale quindi da non costituire un onere insopportabile. Forse furono proprio considerazioni come queste, di politica finanziaria, a spingere in favore di una manovra che affondasse il coltello nella massa del debito vecchio, e non piuttosto indicazioni economiche di carattere generale, come la severa crisi agraria che stava colpendo da qualche anno assieme a tutta l’Europa anche l’Italia settentrionale, che avrebbero invece dovuto suggerire comportamenti diversi. Né evidentemente si considerò pregiudiziale il nuovo pericolo proveniente dai dissidi con i cantoni africani, che pure da alcuni anni obbligavano alla corresponsione di gravosi tributi e spese straordinarie. Ciò che stupisce è che le autorità veneziane si siano determinate ad un’operazione di conversione, che ebbe tra l’altro caratteri abbastanza pesanti, senza esservi spinte dall’assillo di una guerra imminente — come nel 1714 — o appena terminata — come nel 1672 —, quando era giocoforza metter mano ad un bilancio compromesso. Forse nell’animo dei reggitori patrizi ritornò la memoria dell’estinzione del debito pubblico di fine Cinquecento quando però — e qui sta la differenza nonché un errore fondamentale di valutazione — il potenziale economico della Serenissima e la capacità finanziaria delle sue classi dirigenti avevano dimensioni completamente differenti.
Già in quella commissione ai deputati — studiare il valore di piazza dei capitali vecchi — era contenuta in nuce la politica che avrebbe guidato questa nuova manovra. Poiché solo una frazione del debito vecchio era nelle mani degli originari titolari mentre la maggior parte era invece passata di mano ad un prezzo considerevolmente inferiore a quello nominale, su una quota preponderante del debito vecchio si riscuotevano rate ad un tasso effettivo ben più elevato dell’1,3 o 2% di legge. Si sottolineava come tale fatto costituisse un’ingiustizia nei confronti dei detentori originari, si parlava di un problema di equità della cassa pubblica, additando il comportamento sagace dei «commercianti», massime di quelli che a prezzo infimo avevano acquistato rate vecchie mai pagate (ed in questo commercio erano specializzati soprattutto gli Ebrei). «Sono codeste» osservava Luigi Einaudi a proposito di una proposta identica di quindici anni prima, «le ordinarie premesse dei ragionamenti con i quali i governi vogliono legittimare una riduzione forzata del debito pubblico», operazione che al grande economista appariva un’aperta violazione della «pubblica fede [...] un atto che avrebbe per sempre compromesso il credito pubblico dello stato» (116), ma che, è doveroso osservare, fu comune nel medesimo volgere di tempo a vari governi europei e italiani.
La procedura di conversione ebbe come punto saliente la fissazione di un prezzo di rimborso dei debiti vecchi che venne compreso tra 38 e 57 ducati ogni 100 nominali, a seconda del tipo di debito e dell’ammontare delle rate in arretrato. Si trattava di un prezzo comunque superiore a quello della piazza, ma il meccanismo finiva per penalizzare proprio i depositanti più vecchi tra i quali in prima fila si trovavano enti ecclesiastici e casate patrizie i cui capitali erano vincolati da lasciti, fedecommessi, ecc. Si stabilì di effettuare i rimborsi per estrazione fra quanti avessero presentato domanda e per i soli detentori di capitali «liberi», non soggetti cioè a vincoli. Per raccogliere i fondi necessari all’affrancazione si aprì contestualmente un deposito detto Nuovissimo, al 3%, ma sin dai primi momenti ci si rese conto che, probabilmente per la prima volta, le previsioni dei deputati e aggiunti venivano smentite dai risparmiatori: approfittando anche di una norma che consentiva di liberare i capitali soggetti a vincoli fedecommissari, coloro che detenevano i titoli si erano recati in gran numero a riscuotere i capitali tanto che, mentre languivano le sottoscrizioni del Deposito Nuovissimo, solamente in tre mesi le restituzioni avevano superato un milione di ducati e dopo poco dovettero essere sospese (117).
Osservava Girolamo Costantini l’anno seguente che le richieste di affrancazione provenivano, oltre che dai depositanti nel Nuovo al 3,5%, soprattutto dagli investitori stranieri che detenevano quote di debito vecchio e che dopo tanto tempo forse non speravano più di rivedere il proprio denaro (118). La tendenza di questi a disinvestire è già stata notata a proposito della manovra del 1753, che tuttavia non diede loro grosse opportunità a riguardo tanto che la loro presenza sarà ancora nel 1775 di oltre 20.000.000 nominali, dei quali è lecito supporre che una quota vicina ai 3/4 fosse dei soli Genovesi (119). Ma una spinta alla riscossione dei crediti dovette provenire anche dalla particolare congiuntura dei prezzi agrari che attirava investimenti nei commerci o nella terra e che prometteva remunerazioni considerevoli a chi disponesse di liquidità. In ogni modo le disponibilità di cassa e i risparmi di pro non erano tali da consentire consistenti affrancazioni reali, per permettere le quali nel 1768 si era comunque imposto ad enti ecclesiastici e opere pie di vendere beni immobili e investirli nel Nuovissimo (120); nel 1775 si calcolò che i rimborsi effettivi avessero riguardato solo un milione e mezzo di ducati di capitali in zecca contro oltre 19.000.000 di ducati di trasporti dai vecchi depositi al Nuovissimo (121).
Questo nuovo fondo presentava una particolarità rispetto alle consuete procedure di sottoscrizione; prevedeva infatti che i capitali vi venissero iscritti classificandoli a seconda che il titolare fosse suddito o forestiero, laico o «manomorta», specificando inoltre se si trattava di un bene libero o condizionato, cioè sottoposto a vincoli che ne impedissero la dismissione.
Tale distinzione, «essenzialissima al maneggio della economia con riguardi al debito, e alla ricchezza nazionale» come si osservava nel 1775 (122), contrastava con la tendenza comune ai debiti pubblici europei ad assumere carattere anonimo, volta a favorire la negoziabilità degli stessi allontanando nel contempo la possibilità di manovre del debito pubblico che prendessero di mira singole categorie di risparmiatori, come in parte stava già facendo la Repubblica.
Fra queste categorie, principale era quella degli enti morali ed ecclesiastici il cui peso relativo aumentò considerevolmente tra il 1765, quando detenevano il 27% del debito, ed il 1787 quando la loro quota avrebbe raggiunto il 49%, soprattutto in virtù dell’impossibilità imposta loro di affrancare i depositi obbligandoli al reinvestimento (123). Per la prima di queste due date si conosce chi effettivamente componesse tale categoria di capitalisti, che vantavano quasi 21.000.000 di ducati di credito: in prima fila c’erano i conventi di suore e di frati, quindi gli ospedali e le case di pietà mentre le Scuole laiche dimostravano un forte ridimensionamento del loro impegno verso lo stato. A ben 3.000.000 ammontavano poi, sotto la voce «messe», i fondi creati con le somme destinate per testamento alla celebrazione di suffragi: un connubio funzionale tra le esigenze dello spirito e le necessità dei forzieri pubblici (124).
L’impossibilità delle riforme amministrative, 1768-1775
Il trattamento particolare riservato nella manovra iniziata nel 1767 ai beni del clero era uno dei prodromi del rinnovato interesse verso la manomorta ecclesiastica che di lì a poco avrebbe toccato anche lo stato veneziano, dove le istanze giurisdizionaliste vantavano peraltro una lunga tradizione. Dopo un paio d’anni iniziò infatti a lavorare una speciale deputazione, detta ad pias causas, che passò al setaccio l’articolatissimo mondo delle strutture ecclesiastiche venete, vagliandone diritti, rendite e patrimoni, e giungendo a stimarne l’intero capitale in 129.000.000 di ducati. Attraverso un ridimensionamento delle strutture vennero recuperati e venduti circa 11.000 ettari di terreno e il ricavato fu destinato al mantenimento del clero povero, ad aiuti per opere di assistenza e per il finanziamento della riforma scolastica (125). Severo fu l’aggravamento del peso tributario sui beni ecclesiastici: la sola decima del clero apportò 154.000 ducati nel 1775 contro i 65.000 di cinque anni prima; dal 1769 vi si aggiunse poi l’obbligo del campatico (126).
Il lavoro ed i provvedimenti portati avanti dalla deputazione ad pias causas, è stato scritto, furono uno degli interventi più decisi in questo campo che gli stati settecenteschi misero in atto e senza dubbio rappresentarono il momento di maggiore concretezza di quella breve stagione che tra 1768 e 1775 costituì la fase di massimo slancio delle tendenze riformistiche in laguna. Di questa esperienza, che toccò molteplici aspetti della vita economica della Repubblica, perlomeno in due settori si affrontarono problemi che avevano un rapporto diretto con la finanza pubblica.
Nel 1773 sotto l’impulso della conferenza tra savi cassieri e cinque savi alla mercanzia venne ripresa in esame la questione dei dazi, le cui implicazioni generali sull’economia erano della massima importanza come era risultato dai tentativi di riforma della metà degli anni Trenta. Sollecitata a diffondersi sul problema, la conferenza produsse in un paio d’anni un’analisi approfondita quanto impietosa del panorama daziario veneto, non limitandosi a cogliere la frammentarietà del sistema d’esazione o l’inutile complicazione delle tariffe, ma inoltrandosi con opportune considerazioni nella questione più generale del commercio e dei cambiamenti intervenuti nel traffico terrestre. Il progetto che scaturì da tale critica disamina, indicativa delle spinte di rinnovamento che animavano parte della classe politica veneziana, confluì in un «piano daziale» incentrato sulla necessità di ridurre la pletora di dazi a due sole imposizioni, una di consumo e una di commercio, e sull’opportunità che lo stato avocasse a sé la gestione daziaria, unificandola in un’apposita nuova magistratura. Erano però anni durante i quali la vita istituzionale della Repubblica tornava in ebollizione anche a causa delle sempre più nette differenze socio-economiche interne all’ordine patrizio; nello scontro politico il «piano daziale», contenendo un accenno di accentramento istituzionale considerato potenzialmente sovvertitore, venne accantonato (127).
Nel 1768 si era intanto riaperta la discussione anche in uno dei settori in cui nei decenni precedenti le analisi critiche e le proposte riformatrici non erano mancate, quello della struttura dell’amministrazione finanziaria e della contabilità pubblica. Vi concorse anche in questo caso la nuova situazione finanziaria che dalla metà degli anni Sessanta aveva riportato una forte instabilità nei conti dello stato. In tale congiuntura si fece più forte la necessità di un sistema di scritture riepilogative che rendessero possibile conoscere con precisione il bilancio reale dello stato in modo da intervenire con efficacia nell’esercizio in corso e programmare per tempo i flussi finanziari.
Questa rinnovata esigenza di programmazione aveva portato nel 1768, per opera degli stessi deputati ed aggiunti alla provvision del denaro pubblico e sotto la direzione del solito Girolamo Costantini, alla compilazione delle Anagrafi venete, un riepilogo articolato, da ripetersi periodicamente, dei caratteri demografici e socio-economici dello stato (128).
Si trattò di una delle più complesse operazioni amministrative portate a compimento dall’amministrazione marciana, per più versi esemplare delle spinte al rinnovamento che caratterizzarono questi anni della vita della Repubblica: se nel loro impianto le Anagrafi risultavano funzionali ad operazioni di riordino amministrativo di grande impegno riformatore la loro utilizzazione pratica fu invece, nel concreto, pressoché nulla, a sottolineare come la temperie riformistica si espresse in laguna in una serie di «riforme impossibili» (129) solamente immaginate nei loro contorni generali e mai, o solo in singoli spezzoni, trasformate in realtà.
Nel 1 769 i lavori coordinati dai deputati ed aggiunti per la riforma dei bilanci ripartirono e verso il 1774-1775, nonostante la morte del Costantini, i tempi sembravano maturi perché si traducessero in risultati. Anche in questo caso come per il piano daziale, e tanto più data l’importanza cruciale della materia, attorno al loro lavoro si concentrarono le nubi scure dello scontro politico in atto e il nuovo organo dei correttori, eletto per porre ordine nella vita istituzionale della Repubblica, promosse una propria proposta di riforma dei bilanci, elaborata dal ragionato Casoretti. L’opera di questo ministro mise in luce un particolare tecnico che doveva essere già noto, cioè come particolari partite dette aggiustamenti di scrittura consentissero di fatto di modificare i risultati economici dei rendiconti la cui veridicità, in conclusione, era aleatoria (130).
Come ha spiegato Angelo Ventura, che ha sapientemente riannodato i fili di questo significativo passaggio nella storia dell’amministrazione marciana, i tentativi di riforma del bilancio ebbero comunque due effetti pratici: vennero in primo luogo esclusi gli aggiustamenti di scrittura e quindi dal 1773 in poi i rendiconti acquistarono una maggiore affidabilità; in secondo luogo vennero redatti non più sui ristretti mensili forniti dalle singole casse ma sui riepiloghi quadrimestrali delle stesse che venivano vagliati dai ragionati appuntadori, e che quindi più difficilmente potevano riportare macroscopiche inesattezze. Da un punto di vista più generale una scrittura di compendio del lavoro di molti anni dei deputati ed aggiunti del 1775 dimostra quale valenza avrebbe avuto un effettivo e concreto rinnovamento di questo strumento contabile: un bilancio che diventasse funzionale alla programmazione economica avrebbe permesso di affrontare le questioni-cardine della revisione dei meccanismi fiscali e della perequazione dei carichi tributari. Tali modifiche di portata rivoluzionaria per l’assetto amministrativo dello stato sarebbero state possibili solo con l’accentramento della funzione di direzione e controllo della materia amministrativa e fiscale nei deputati e aggiunti alla provvision del denaro pubblico: «si presentava così [ha scritto Ventura] in veste veneziana, vale a dire stemperata, addolcita e adattata alla costituzione aristocratica, quella tendenza assolutistica [...] che determinò e improntò di sé l’esperienza riformistica degli stati settecenteschi» (131).
Spingendosi nel campo delle modifiche istituzionali ed entrando così nel cuore della lotta politica in atto la proposta dei deputati ed aggiunti conteneva in sé i motivi che ne determinarono l’affossamento e, assieme ad essa, l’accantonamento di tutti i progetti di riforma del bilancio dal 1769 in poi.
Le contraddizioni dell’ultimo ventennio
Per tutti gli anni Settanta e i primi anni Ottanta i Bilanci generali registrano un lento ma costante aumento delle rendite e un contemporaneo contenimento delle spese. Assieme al buon afflusso di capitali nel Deposito Nuovissimo che si verificò a partire dal 1771, ciò consentì di dedicare somme crescenti all’affrancazione del debito vecchio, che si trasformavano secondo le severe norme stabilite nel 1767 in risparmi effettivi: la spesa per i pro scese progressivamente fino al 21% delle entrate.
Le cifre dei bilanci, che sono disponibili purtroppo solo fino al 1783, testimoniano la crescita costante dei dazi e partiti, tra i quali soprattutto i grandi appalti riscossi nella Dominante finivano per costituire l’entrata più consistente ed elastica. Sostanzialmente statiche e quindi con valore tendenzialmente calante continuavano invece ad essere le entrate dirette, la cui inesigibilità crebbe nuovamente a partire dal 1760 e i cui resti ritornarono come agli inizi del secolo a rappresentare fino a un quarto dell’imposta dovuta (132). Gli arretrati raggiungevano ormai somme enormi, tanto che nel 1786 invece di ricorrere a nuove imposte si pensò di recuperare, rateizzandoli, quelli del campatico, ma l’iniziativa riscosse scarso successo tra gli stessi patrizi (133). Nello stesso anno venne eletta un’apposita magistratura, gli inquisitori sopra l’esazione dei pubblici crediti, che riuscì a raggiungere alcuni risultati abolendo la decima verde, vale a dire la possibilità concessa ai fuochi veneti di saldare parte delle gravezze in frumento, e unificando il pagamento di decima e campatico. I magistrati inquirenti affrontarono poi il nodo delle gravezze della Terraferma e seppure in via sperimentale e per il solo Padovano ridussero le gravezze de mandato dominii a due e abolirono il criterio dei corpi; la compilazione dell’estimo rimase però sempre affidata ad organi locali (134). Erano timidi ma concreti passi in avanti in direzione di una semplificazione fiscale.
L’insabbiamento del piano daziale aveva lasciato intatto il desolante panorama delle imposte indirette di Terraferma. Per aumentarne il gettito, a partire dal 1765 si era tentato di affittare tutti i dazi di una camera fiscale ad un solo appaltatore, una soluzione che non aveva apportato miglioramenti dal punto di vista delle entrate, irrobustendo ancor di più la posizione dei dazieri (135). Va tenuto conto che il movimento demografico della Terraferma e dello stato in generale registrò nella seconda metà del XVIII secolo solo un modesto incremento e che vari indicatori testimoniano come il potere d’acquisto delle classi inferiori sia in questo periodo palesemente diminuito (136). Di qui una prima giustificazione del mancato aumento delle imposte indirette in Terraferma, la cui staticità era tuttavia legata a fattori strutturali ben noti, quali la dispersione sul territorio dell’esazione, la molteplicità ed aleatorietà delle tariffe nonché l’incidenza del contrabbando.
Effetti inevitabilmente coincidenti finiva per avere la spinta a liberalizzare i transiti di beni agricoli e manufatti all’interno dello stato, una tendenza insita nello sviluppo economico settecentesco e che nella Repubblica veneta non si presentò con i caratteri che ebbe in altri stati regionali italiani, dove costituì uno dei capisaldi del pensiero riformatore. Già nel 1711-1712 era stata decretata una parziale liberalizzazione del commercio della lana che venne sancita più compiutamente ottant’anni dopo; negli anni Cinquanta si procedette invece ad una liberalizzazione dei commerci dei grani, mentre tra 1789 e 1791 venne semplificato, eliminando vincoli d’importazione, il commercio dei bovini (137).
Perché a proposito dei dazi si verifichi qualche effettivo passo in avanti si dovrà attendere solo il 1794 quando la magistratura dei deputati alla regolazione delle tariffe mercantili, creata una decina d’anni prima, giunge ad elaborare una normativa «che andava nella direzione della unificazione daziaria» e della soppressione delle esenzioni e dei privilegi relativi (138). La fine della Repubblica impedì tuttavia di metterne alla prova l’efficacia.
Nel 1775 in virtù dei buoni afflussi nel Deposito Nuovissimo l’affrancazione dei debiti vecchi venne rilanciata, dando precedenza alle restituzioni a sudditi della Terraferma e forestieri, ma operando una nuova riduzione forzosa sulle rate in arretrato che erano state mantenute «attaccate» al capitale (139). Ciò penalizzava ancora una volta i creditori di più antica data, tra i quali le famiglie patrizie con depositi soggetti a vincoli fedecommissari, anche se è probabile che considerate le periclitanti condizioni di buona parte del patriziato la notizia di un rimborso ad 1/4 del valore nominale di antichi interessi risultasse comunque gradita. Il ruolo effettivo dell’investimento in depositi pubblici nel processo di impoverimento della classe aristocratica veneziana è un argomento su cui rimane ancora da riflettere. Considerando la manovra del 1767 e prima ancora la svalutazione del primo Settecento, è difficile non giudicarlo sul lungo periodo un cattivo, se non pessimo affare: i rendimenti dovettero essere in molti casi più bassi di quel 2-3% annuo effettivo che fruttarono i depositi dei Pisani dal Banco e Moretta, e solo pochi dovettero riuscire, come l’intraprendente Andrea Querini già deputato ad pias causas, a convertire i crediti verso lo stato in proprietà dismesse da enti ecclesiastici (140).
Il piano di affrancazione del 1775 prevedeva l’estinzione del debito pubblico in quattro sessenni che sarebbero quindi terminati nel 1799. Nel 1784 una serie di avvenimenti interruppe il susseguirsi degli ammortamenti che tra 1776 e 1783 avevano movimentato quasi 27.000.000 di ducati. Nuove spese straordinarie tra cui quelle per la campagna navale contro i Cantoni barbareschi e inefficienze (o malversazioni?) nell’amministrazione del debito causarono una caduta nella quotazione del Nuovissimo, che scese a 82-84 sotto la pari, e una nuova corsa alla riscossione; le affrancazioni vennero sospese e solo dopo alcuni mesi se ne decretò la ripresa, ristretta però ai soli «sudditi laici e liberi» (141). In una tale congiuntura, l’apertura l’anno seguente di un nuovo fondo, il Nuovo Imprestido, nonostante il tasso di interesse del 3,5% registrò sottoscrizioni solamente per un terzo dei 2.000.000 previsti e costrinse le autorità a cercare denari all’estero (142).
Gli studiosi che si sono soffermati su questi ultimi passaggi della storia finanziaria della Repubblica hanno spiegato tali occorrenze come conseguenza inevitabile della ormai compromessa affidabilità della Repubblica, che con la manovra del 1767 e la sospensione delle affrancazioni nel 1784 aveva definitivamente pregiudicato la propria credibilità (143). Senza dubbio i fatti del 1784-1785 misero in evidenza da parte della platea di risparmiatori comportamenti nuovi, ispirati a una maggiore attenzione rispetto al passato alla salvaguardia dei propri investimenti piuttosto che a un’adesione ideologica ai destini del leone alato. Tuttavia anche in una congiuntura come quella del 1784, quando si delinearono concrete possibilità di scontro bellico, la volatilità della quotazione del Nuovissimo fu tutto sommato contenuta e i titoli di questo fondo tornarono ad avere in breve tempo una valutazione di piazza molto elevata, 97-98, che non sarebbe stata possibile se fosse venuta irreparabilmente meno la fiducia nello stato.
In realtà più che il prestigio del Tesoro in questi ultimi anni sembra fosse messo in discussione il tradizionale metodo di sottoscrizione nominativa dei depositi, che aveva permesso allo stato di procedere in maniera differenziale tra le diverse categorie di capitalisti. Così quando nel 1789 venne proposto di porre riparo all’aumentare pericoloso del deficit con la riapertura del Nuovo Imprestido, alzandone il tasso al 4%, programmandone un’affrancazione scadenzata su otto anni, e soprattutto dando la possibilità a chi volesse rimanere anonimo di ottenere un vero e proprio titolo al portatore dal taglio fisso di cento ducati, in modo da «rendere più facile la negoziazione» del credito (144), l’emissione conobbe un buon successo, tanto che l’anno seguente fu decretata un’aggiunta offrendo «biglietti di investita» anche da 500 ducati, e similmente si proseguì fino al 1794, nonostante fosse evidente che il ricorso al debito era motivato da un palese e nuovamente cronico deficit di bilancio (145). La Zecca di San Marco dimostrò quindi di essere ancora, negli anni Novanta, un luogo ritenuto sicuro per conservarvi i risparmi: le aggiunte del Nuovo Imprestido proseguirono fino a 5.800.000 ducati e, grazie al proseguimento della conversione del debito vecchio, la massa del debito si dilatò solamente di poco più di un milione. Infine — ed è un dato emblematico — le somme destinate al pagamento degli interessi giunsero a rappresentare non più del 20% delle entrate dello stato, la quota più bassa degli ultimi 150 anni (v. Tab. 4).
Che il mercato veneziano avvertisse la necessità di un salto di qualità nella gamma di strumenti finanziari disponibili è confermato dagli stessi deputati ed aggiunti che nel 1789 si soffermavano su «alcune operazioni che potrebbero essere sperimentate», tra le quali venivano nominate varie forme di prestiti vitalizi oltre che la «carta monetata» usata ormai, era osservato, da quasi tutti i sovrani d’Europa (146). È interessante rilevare come a tale proposito circolassero già progetti concreti, che a quanto è stato possibile scoprire non superarono mai lo stadio della semplice proposta: uno, anonimo, riferibile ai primi anni Ottanta prevedeva che le affrancazioni del debito avvenissero mediante l’emissione di vere e proprie banconote a pieno valore legale, che avrebbe dovuto fruttare un interesse annuo del 2% e che quindi si sarebbero semplicemente limitate a creare altro debito fluttuante (147).
I problemi di bilancio del 1784-1785 e il riaffacciarsi degli impegni militari diedero lo spunto, assieme a concrete iniziative per recuperare gli arretrati delle gravezze a cui si è fatto cenno, a nuovi progetti per la riforma dei bilanci. Un nuovo tentativo partì nel 1787 per opera dell’ufficio del savio cassier, la cui analisi critica dimostrava in maniera sconfortante come poco o nulla fosse cambiato rispetto a sessant’anni prima, quando i ragionati Vianello, Rizzi e Costantini avevano richiamato l’attenzione delle autorità patrizie sulla necessità di una trasformazione complessiva del sistema contabile. Nel 1789 fu un altro ministro contabile, Giovanni Gera, ad approfondire ancor più la questione, individuando addirittura nel mancato coordinamento tra le scritture dello scontro, che stendeva la prima nota, e quelle del quadernier, che riportava i conti in partita doppia, la causa originaria della confusione. Riforma della struttura amministrativa e riforma delle scritture contabili apparivano ancora una volta indissolubilmente legate, per cui senza procedere ad una ristrutturazione radicale, quale quella avanzata dal Gera che prevedeva l’accentramento della direzione amministrativa in due soli dipartimenti, non si sarebbe arrivati a nulla. Non può stupire che fossero gli stessi deputati ed aggiunti a lasciar cadere le soluzioni avanzate dall’illuminato ufficiale (148).
L’impossibilità di conoscere con sufficiente approssimazione la reale situazione di cassa al fine di programmare il flusso delle spese ritorna con crescente evidenza in questi ultimi anni della Repubblica. Ne rendono testimonianza le periodiche relazioni al senato del savio cassier sul fabbisogno del conservator del deposito, la cui cassa era per entità di movimenti l’unica in base alla quale si potesse provare a valutare l’andamento nelle spese in corso d’esercizio. Nel dicembre del 1790, ad esempio, è lo stesso Gera a scrivere che per l’anno in corso si poteva confidare in un consistente resto attivo. Nel marzo il savio cassier riferisce invece di un buco di mezzo milione di ducati, giustificando la differenza rispetto alle previsioni con la curiosa osservazione che «l’introito del danaro destinato in sovegno non si è combinato col momento dei bisogni» (149). Il bilancio consuntivo riporterà infine un disavanzo di 700.000 ducati.
A partire dalla fine degli anni Ottanta il movimento delle rendite e delle spese tornò a registrare saldi, al netto delle affrancazioni che si mantenevano su un livello assai inferiore rispetto al picco degli anni 1771-1783, negativi. La possibilità di avere solo i ristretti dei bilanci compilati in quegli anni assieme alla genericità delle osservazioni stese a riguardo dalle magistrature competenti consente di avanzare solo qualche ipotesi su tale nuovo peggioramento della finanza pubblica veneziana, una crisi che assieme al crollo del traffico marittimo a seguito del blocco continentale e ai contraccolpi delle guerre europee sulla produzione manifatturiera contrassegnò gli ultimi anni di vita della Repubblica (150). I deputati ed aggiunti riferiscono di crescenti spese per lavori di arginatura e scavo in fiumi, lagune e lidi, di aumento delle grazie e provvigioni, delle maggiorazioni incorse nel prezzo dei cereali per il biscotto dell’armata, e, dopo il ’91, delle somme venute a mancare per la liberalizzazione del commercio di bovini, «fatta per diretto sollievo dei sudditi» (151). In realtà erano gli stessi dati riportati dai magistrati ad evidenziare come questi fossero solo particolari di secondario rilievo in un quadro di finanza pubblica le cui rigidità e insufficienze strutturali venivano accentuate dalla nuova congiuntura politico-economica apertasi con la Rivoluzione francese.
Lo stato veneziano si avviava ad affrontare la prova esiziale della sua lunga esistenza con una finanza pubblica nelle sue grandi linee immutata rispetto a quella con cui aveva chiuso cento anni prima la guerra di Morea, l’ultima sua conquista territoriale. Nell’arco del Settecento innumerevoli erano state le occasioni per mettere mano ad una seria opera di rinnovamento della struttura amministrativa dello stato, che mirasse ad adeguarne i caratteri ai mutati connotati dell’economia e della società. In alcuni casi si procedette ad utili operazioni di riordino, in altri a efficaci manovre finanziarie, ma mai ci si staccò da una visione dello stato e della sua amministrazione che risaliva al Quattrocento: avrebbe significato cancellare un’identità storica alla quale la classe aristocratica veneziana non seppe – o forse non poté nemmeno – rinunciare.
1. Vendramino Bianchi, Istorica relazione della pace di Posaroviz, Padova 1719, p. 5.
2. Fabio Besta, Introduzione a Bilanci generali della Repubblica di Venezia, ser. I, vol. I, a cura di Id., Venezia 1912, p. CLII.
3. Massimo Costantini, La regolazione dei dazi marittimi e l’esperienza del «portofranco» a Venezia tra il 1662 e il 1684, in La finanza pubblica in età di crisi, a cura di Antonio Di Vittorio, Bari 1993, pp. 77-88.
4. A. Vietti, Il debito pubblico nelle provincie che hanno formato il primo Regno d’Italia, Milano 1884, p. 126.
5. Nicolò Papadopoli Aldobrandini, Le monete di Venezia, I-III, Venezia 1893-1919: III, pp. 368-378, 403-405.
6. Giuseppe Gullino, I patrizi veneziani di fronte alla proprietà feudale (secoli XVI-XVIII). Materiale per una ricerca, «Quaderni Storici», 43, 1980, nr. 1, p. 176 (pp. 162-193).
7. V. Bianchi, Istorica relazione, p. 5.
8. Cf. Giuseppe Gullino, Politica ed economia, a Venezia, nell’età di Benedetto Marcello (1686-1739), in Benedetto Marcello, la sua opera e il suo tempo, a cura di Franco Rossi - Claudio Madricardo, Firenze 1988, p. 8 (pp. 3-15); Ivo Mattozzi, Produzione e commercio della carta nello stato veneziano settecentesco. Lineamenti e problemi, Bologna 1975, p. 12.
9. Sulle vicende della prima neutralità armata cf. Jean Georgelin, La République de Venise et la fin du ‚dominio del mare’ (1669-1718), «Revue d’Histoire Diplomatique», 90, 1976, nrr. 3-4, pp. 193-219; Giovanni Scarabello, Il Settecento, in Gaetano Cozzi - Michael Knapton - Giovanni Scarabello, La Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, Torino 1992, pp. 554-555 (pp. 551-681).
10. G. Gullino, Politica ed economia, pp. 6-8.
11. F. Besta, Introduzione, pp. LXXII-LXXIII.
12. Salvatore Ciriacono, Olio ed ebrei nella Repubblica veneta del Settecento, Venezia 1975, p. 37.
13. Il bilancio del 1710 è in A.S.V., Savio Cassier, b. 579, cc. 1-166, ma un suo riepilogo venne pubblicato in Antonio Stella, Forma dei bilanci nella Repubblica Veneta, «Annali del R. Istituto Tecnico e Nautico di Napoli Giovan Battista della Porta», 13, 1896, pp. 8-22. Il bilancio del 1713 è in A.S.V., Collezione Svajer, b. 9, p. 97. Per i dati relativi al 1679 cf. Luciano Pezzolo, Sistema di potere e politica finanziaria nella Repubblica di Venezia (secoli XV-XVII), in Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra Medioevo ed Età Moderna, a cura di Giorgio Chittolini-Anthony Molho-Pierangelo Schiera, Bologna 1994, pp. 322-327 (pp. 303-327).
14. F. Besta, Introduzione, p. LII.
15. Per la tansa del 1702 cf. A.S.V., Savio Cassier, b. 579, passim (cc. 1-166); per la decima del 1707 G. Gullino, Politica ed economia, pp. 8-9.
16. Jean Georgelin, Venise au siècle des lumières, Paris-La Haye 1978, pp. 72-74.
17. Salvatore Ciriacono, L’economia regionale veneta in epoca moderna. Note a margine del caso bergamasco, in AA.VV., Venezia e la Terraferma. Economia e Società, Bergamo 1989, p. 63 (pp. 43-76).
18. Almeno per quanto riguarda i secc. XVI-XVIII, cf. L. Pezzolo, Sistema di potere, Appendice 1A.
19. Roberto Sabbadini, L’acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (sec. XVII-XVIII), Udine 1995, pp. 171-173.
20. Andrea Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia. I cittadini originari (sec. XVI-XVII), Venezia 1993, pp. 236-237.
21. Cf. Giuseppe Gullino, I patrizi veneziani e la mercatura negli ultimi tre secoli della Repubblica, in Mercanti e vita economica nella Repubblica Veneta (secoli XIII-XVIII), a cura di Giorgio Borelli, II, Verona 1985, pp. 403-451.
22. F. Besta, Introduzione, pp. CLXXXIII ss.; Luigi Einaudi, L’economia pubblica veneziana dal 1736 al 1755, «La Riforma Sociale», 14, 1904, pp. 186-188, 443-450, 509-534 (pp. 177-196, 429-450, 509-537); Giuseppe Felloni, Gli investimenti finanziari genovesi in Europa tra il Seicento e la Restaurazione, Milano 1971, pp. 137-159. Sui depositi vitalizi: Luciano Pezzolo, Elogio della rendita. Debito pubblico, Venezia e Stati italiani nel Cinque e Seicento, «Rivista di Storia Economica», n. ser., 12, 1995, nr. 3, pp. 283-330.
23. Lorenzo Antonio da Ponte, Osservazioni sopra li depositi nella veneta zecca, Verona 1801, pp. 30-31.
24. Scrittura dei Deputati ed aggiunti alla provvision del denaro pubblico del 28 marzo 1739, pubblicata in Bilanci generali della Repubblica di Venezia, ser. II, vol. II, Venezia 1903, p. 55.
25. G. Felloni, Gli investimenti finanziari, p. 148.
26. A. Vietti, Il debito pubblico, p. 127.
27. J. Georgelin, La Re ublique de Venise, p. 15.
28. Scrittura dei Deputati ed aggiunti alla provvision del denaro pubblico del 28 marzo 1739, pubblicata in Bilanci generali, ser. II, vol. II, p. 55.
29. L. Einaudi, L’economia pubblica, p. 188.
30. G. Felloni, Gli investimenti finanziari, pp. 146-147.
31. G. Gullino, Politica ed economia, p. 10.
32. Giovanni Dolcetti, Le bische e il giuoco d’azzardo a Venezia, 1172-1807, Venezia 1903, p. 14.
33. Andrea Zannini, Il sistema di revisione contabile della Serenissima. Istituzioni, personale, procedure (secc. XVI-XVIII), Venezia 1994, p. 36.
34. G. Dolcetti, Le bische e il giuoco, p. 234.
35. R. Sabbadini, L’acquisto della tradizione, pp. 171-173.
36. F. Besta, Introduzione, p. CXXI.
37. L.A. da Ponte, Osservazioni sopra li depositi, p. 29.
38. F. Besta, Introduzione, pp. CCI-CCII; G. Felloni, Gli investimenti finanziari, pp. 137-138; L. Einaudi, L’economia pubblica, p. 450.
39. L. Einaudi, L’economia pubblica.
40. F. Besta, Introduzione, pp. CXCVI-CXCVIII.
41. Ugo Tucci, Il Banco della Piazza di Rialto, prima banca pubblica veneziana, in Id., Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano, Bologna 1981, pp. 231-250, ma soprattutto Id., Convertibilità e copertura metallica della moneta del Banco Giro veneziano, «Studi Veneziani», 15, 1973, pp. 349-448, che si seguirà in questa parte.
42. Gino Luzzatto, Les banques publiques de Venise. Siècles XVI-XVIII, in Id., Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, p. 242 (pp. 225-258).
43. U. Tucci, Convertibilità e copertura, p. 443.
44. N. Papadopoli Aldobrandini, Le monete di Venezia, III, pp. 837-838.
45. Per il decreto del 1733 cf. Ugo Tucci, Le monete in Italia, in Storia d’Italia, V, 1, I documenti, Torino 1973, pp. 533-538 (pp. 533-579).
46. F. Besta, Introduzione, p. CXCVIII.
47. U. Tucci, Convertibilità e copertura, pp. 400-401.
48. Id., Le monete in Italia, pp. 544-545.
49. Dove avrebbe alimentato l’80% degli scambi sia in città che in Terraferma: J. Georgelin, Venise au siècle, p. 526.
50. Amelio Tagliaferri, Introduzione alle relazioni dei podestà e capitani di Brescia, in Relazioni dei rettori veneti in Terraferma, XI, Podestaria e capitanato di Brescia, Milano 1978, pp. XXVII-XXXVIII (pp. XVII-XLIX).
51. Vincenzo Padovan, Dei magistrati che ebbero ingerenza nella zecca veneta, «Archivio Veneto», 17, 1879, pp. 79-85 (pp. 74-98); N. Papadopoli Aldobrandini, Le monete di Venezia, III, pp. 539-590.
52. Carlantonio Broggia, Trattato de’ tributi, delle monete, e del governo politico della sanità, Napoli 1743, pp. 335-338.
53. Pietro Giovanni Capello, Nuovo trattato del modo di regolare la moneta, Venezia 1752, pp. 76-77.
54. Giuseppe Felloni, Finanze statali, emissioni monetarie ed alterazioni della moneta di conto in Italia nei secoli XVI-XVIII, in La moneta nell’economia europea. Secoli XIII-XVIII, a cura di Vera Barbagli Bagnoli, Firenze 1981, p. 198 (pp. 197-222).
55. Cf. su questi problemi Ugo Tucci, L’avventura orientale del tallero veneziano nel XVIII secolo, «Archivio Veneto», 113, 1979, pp. 71-130.
56. Id., Convertibilità e copertura, p. 386.
57. Id., Le emissioni monetarie di Venezia e i movimenti internazionali d’oro, in Id., Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano, Bologna 1981, p. 284 (pp. 275-316).
58. Paolo Ulvioni, Politica e riforme a Venezia nel secondo Settecento. Il «piano daziale», in Profili di storia veneta (sec. XVIII-XIX), a cura di Umberto Corsini, Venezia 1985, pp. 73-74 (pp- 65-94).
59. Sull’evoluzione delle istituzioni economico-finanziarie cf. Maria Francesca Tiepolo, Alcuni organi veneziani di controllo finanziario, in Atti del convegno nazionale finanza regionale e locale: «Autonomia e coordinamento con la finanza statale», Venezia 12-13-14 aprile 1985, Venezia 1985, pp. n.n.
60. A. Zannini, Il sistema di revisione, passim, a cui si farà implicitamente riferimento in questo paragrafo.
61. Fabio Besta, Appunti sulla compilazione dei bilanci generali di fatto, in Bilanci generali della Repubblica di Venezia, ser. II, vol. III, Bilanci dal 1736 al 1755, Venezia 1903, p. XXVI (pp. VII-XCV).
62. Angelo Ventura, Il problema storico dei bilanci generali della Repubblica veneta, in Bilanci generali della Repubblica di Venezia, ser. II, vol. IV, Bilanci dal 1756 al 1783, a cura di Id., Padova 1972, pp. LI-LX (pp. XI-CXXXIX).
63. A. Zannini, Il sistema di revisione, pp. 128-129; F. Besta, Appunti sulla compilazione, p. XXVIII.
64. A. Ventura, Il problema storico, pp. XX-L.
65. Ibid., p. XLVIII.
66. F. Besta, Appunti sulla compilazione, p. LXXXIII; A. Ventura, Il problema storico, pp. LX-LXII, da dove è tratta la citazione.
67. La scrittura è riportata in Antonio Stella, Il servizio di cassa nell’antica ‚Repubblica’ veneta, Venezia 1889, pp. 28-62 (le citazioni alle pp. 54-55).
68. A. Zannini, Il sistema di revisione, pp. 134-135.
69. Ennio Barsanti, L’inquisitorato alle revisioni e appuntature nell’antica Repubblica di Venezia, Livorno 1898, p. 13.
70. I dati che seguono sono elaborazioni tratte dai ristretti dei bilanci, Bilanci generali, ser. II, vol. III, pp. 283-307, e da L. Einaudi, L’economia pubblica, passim.
71. Marino Berengo, La società veneta alla fine del Settecento, Firenze 1956, p. 37.
72. Ibid., n. 4.
73. Francesco Vecchiato, In tema di dazio sulle carni, in Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti. XV-XVIII secolo, a cura di Giorgio Borelli - Paola Lanaro - Francesco Vecchiato, Verona 1982, pp. 317-362.
74. Anna Maria Girelli, Il Setificio veronese nel ’700, Milano 1969, passim.
75. Bartolomeo Cecchetti, Del sistema tributario nello stato veneto sulla fine del secolo XVII, «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 32, 1873-1874, pp. 779-820; Tommaso Fanfani, Note sul «partito del sale» a Venezia tra XVI e XVIII secolo: aspetti di evasione fiscale attraverso il territorio della Patria del Friuli, in Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti. XV-XVIII secolo, a cura di Giorgio Borelli - Paola Lanaro - Francesco Vecchiato, Verona 1982, pp. 127-145.
76. S. Ciriacono, Olio ed ebrei, pp. 35-49.
77. Sul dazio del vino cf. Antonio Stella, Il dazio sul vino e sull’uva nella Dominante, Torino 1891.
78. Id., Il monopolio dei tabacchi nella Repubblica Veneta, «Annali del R. Istituto Tecnico e Nautico di Napoli Giovan Battista della Porta», 10, 1893, p. 26 (pp. 1-39).
79. Bilanci generali, ser. II, vol. II, p. 437, scrittura dei Deputati ed aggiunti alla provvision del denaro pubblico del 1 8 ottobre 1745.
80. Scrittura data dalla conferenza dei cinque savi alla mercanzia e del savio cassier del 2 maggio 1775 pubblicata in Antonio Stella, Notizie generali intorno ai dazi ed alle gravezze della Terraferma sotto la Repubblica di Venezia, «Annali del R. Istituto Tecnico e Nautico di Napoli Giovan Battista della Porta», 14, 1897, pp. 1-28.
81. Paolo Preto, Il regime fiscale e le dogane in epoca veneta in rapporto all’Adige, in Una città e il suo fiume. Verona e l’Adige, a cura di Giorgio Borelli, Verona 1977, pp. 646-652 (pp. 632-681).
82. Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, VIII, Venezia 1859, p. 364.
83. Cf. Giuseppe Del Torre, La politica ecclesiastica della Repubblica di Venezia nell’età moderna: la fiscalità, in Fisco religione Stato nell’età confessionale, a cura di Herman Kellenbenz - Paolo Prodi, Bologna 1989, pp. 387-426.
84. F. Besta, Introduzione, p. CLXII.
85. J. Georgelin, Venise au siècle, pp. 542 ss.
86. Daniele Beltrami, La penetrazione economica dei veneziani in Terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei secoli XVII e XVIII, Venezia-Roma 1961, p. 123.
87. Giuseppe Gullino, I Pisani dal Banco e Moretta. Storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro vicende patrimoniali tra 1705 e 1836, Roma 1984, p. 138; Id., Nobili di Terraferma e patrizi veneziani di fonte al sistema fiscale della campagna nell’ultimo secolo della Repubblica, in Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori, Atti del convegno, Trieste, 23-24 ottobre 1980, Milano 1981, p. 213 (pp. 203-225).
88. M. Berengo, La società veneta, p. 36.
89. Cf. a proposito Jean Georgelin, La fiscalité dans l’état venitien (17e-18e s.). Les bilanci, in Etats, fiscalités, économies. Actes du cinquième congrès de l’association française des historiens économistes, 16-18 juin 1983, Paris 1985, p. 32 (pp. 28-40).
90. J. Georgelin, Venise au siècle, pp. 80-84, 282 ss., 301; G. Gullino, Politica ed economia, pp. 10-12.
91. P. Ulvioni, Politica e riforme, pp. 65-67; Daniele Beltrami, La crisi della marina mercantile veneziana e i provvedimenti del 1736 per fronteggiarla, «Rivista Internazionale di Scienze Sociali», 50, 1942, pp. 304-318; Giordano Campos, Il commercio estero veneziano nella seconda metà del ’700 secondo le statistiche ufficiali, «Archivio Veneto», ser. V, 37-38, 1936, pp. 145-183.
92. Scrittura dei Deputati e aggiunti alla provvision del denaro pubblico dell’8 marzo 1739 sul bilancio 1737, pubblicata in Bilanci generali, ser. II, vol. II, p. 75 (pp. 24-76); Scrittura degli stessi del 3 febbraio 1744, ibid., p. 349 (pp. 345-350).
93. D. Beltrami, La penetrazione economica, pp. 110-113.
94. Ibid., pp. 109-111, 160.
95. Giuseppe Gullino, Considerazioni sull’evoluzione del sistema fiscale veneto tra il XVI ed il XVIII secolo, in Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti. XV-XVIII secolo, a cura di Giorgio Borelli - Paola Lanaro - Francesco Vecchiato, Verona 1982, p. 73 (pp. 59-91); Id., I patrizi veneziani, p. 179.
96. A.S.V., Revisori e regolatori delle entrate pubbliche in zecca, b. 191.
97. Emilio Morpurgo, Marco Foscarini e Venezia nel secolo XVIII, Firenze 1880, pp. 370-377.
98. L. Einaudi, L’economia pubblica, pp. 431-432.
99. F. Besta, Introduzione, p. CXCVIII.
100. Alfredo Pino-Branca, Riforme finanziarie e inizi di tendenze unitarie nella politica veneta di terraferma nel sec. XVIII, «Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 95, 1935-1936, pp. 310 ss. (pp. 287-319). Raddoppiano il gettito i taglioni, la tansa insensibile dell’arti, comunità e traghetti e i taglioni delle arti della Dominante e la tansa della Terraferma considerati assieme, Bilanci generali, ser. II, vol. III pp. 14-15, 50-51.
101. F. Besta, Introduzione, pp. CXXXIII-CXXXIV.
102. L. Einaudi, L’economia pubblica, p. 444.
103. Cf. ad es. S. Romanin, Storia documentata, VIII, p. 242 n. 35.
104. Bilanci generali, ser. II, vol. II, p. 432, scrittura dei Deputati ed aggiunti alla provvision del denaro pubblico del 18 ottobre 1745.
105. L. Einaudi, L’economia pubblica, p. 270.
106. Ibid., pp. 511, 518, 533; G. Felloni, Gli investimenti finanziari, p. 139.
107. La stima del prodotto lordo dello stato verso il 1765 di 83-89.000.000 di ducati (da 124 soldi, cioè 65-69.000.000 di ducati effettivi, cioè da 160 soldi) è di J. Georgelin, Venise au siècle, p. 562; quella di Andrea Tron è riportata in Giovanni Tabacco, Andrea Tron e la crisi dell’aristocrazia senatoria a Venezia, Udine 19802, p. 138.
108. L. Einaudi, L’economia pubblica, p. 525.
109. Scrittura dei deputati ed aggiunti alla provvision del denaro pubblico dell’8-2-1753, pubblicata in Bilanci generali, ser. II, vol. II, p. 564 (pp. 556-565).
110. L. Einaudi, L’economia pubblica, p. 524.
111. Ibid., pp. 527-534; G. Felloni, Gli investimenti finanziari, pp. 139-140; cf. anche Enrico Castelnuovo, Intorno a due scritture finanziarie della Repubblica Veneta nel secolo XVIII, «Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», 61, 1901-1902, pt. 2, pp. 173-181.
112. A. Pino - Branca, Riforme finanziarie, pp. 297, 308.
113. A. Ventura, Il problema storico, p. LXIII e n. 19.
114. A. Pino - Branca, Riforme finanziarie, pp. 310-315.
115. A.S.V., Deputati ed aggiunti alla provvision del denaro pubblico, b. 171, pp. 5 ss.; ivi, Senato, Rettori, filza 339, scritture allegate a decreto senato 29 marzo 1775; G. Felloni, Gli investimenti finanziari, pp. 140-141. Sulla politica del debito pubblico in questa delicata fase congiunturale, v. le interessanti riflessioni di Giancarlo Mazzucato, Il disavanzo nella Repubblica di Venezia del ’700, «Nota di Lavoro», Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Venezia, 19, 1996, pp. 13-14 (pp. 1-20).
116. L. Einaudi, L’economia pubblica, pp. 522-523.
117. A. Ventura, Il problema storico, p. LXVII n. 27.
118. G. Felloni, Gli investimenti finanziari, p. 149.
119. Ibid., p. 150.
120. Ibid., p. 142.
121. A.S.V., Senato, Rettori, filza 339, scritture allegate a decreto senato 29 marzo 1775.
122. Ibid.
123. G. Felloni, Gli investimenti finanziari, p. 143.
124. J. Georgelin, Venise au siècle, p. 554.
125. M. Berengo, La società veneta, pp. 90-91; G. Scarabello, Il Settecento, p. 636.
126. Anna Maria Cadel, La politica fiscale della Repubblica veneta e il clero nel secolo XVIII. Note d’archivio, «Ateneo Veneto», 24, 1986, nrr. 1-2, pp. 205-208.
127. P. Ulvioni, Politica e riforme; G. Scarabello, Il Settecento, pp. 604-605.
128. Andrea Schiaffino, Contributo allo studio delle rilevazioni della popolazione nella Repubblica di Venezia: finalità, organi, tecniche, classificazioni, in Le fonti della demografia storica in Italia, Atti del seminario di demografia storica 1971-1972, I, 1, Roma 1971, pp. 310-324 (pp. 285-355); Aldo Contento, Il censimento della popolazione sotto la Repubblica Veneta, «Nuovo Archivio Veneto», 20, 1900, pt. I, pp. 68 ss. (pp. 5-96).
129. Cf. Enrico Basaglia, Il diritto penale, in AA.VV., Storia della cultura veneta, 5/II, Dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il Settecento, Vicenza 1986, pp. 163-178.
130. A. Ventura, Il problema storico, pp. LXIII-LXVIII, CXXVIII-CXXXVI.
131. Ibid., p. XCII.
132. D. Beltrami, La penetrazione economica, p. 160.
133. M. Berengo, La società veneta, p. 38.
134. G. Gullino, Nobili di Terraferma, p. 213; Id., Considerazioni sull’evoluzione, p. 81.
135. F. Besta, Introduzione, p. XLVI.
136. Per la popolazione cf. Karl Julius Beloch, Storia della popolazione italiana, Firenze 1994, p. 500; Andrea Schiaffino, La popolazione della Terraferma veneta nella seconda metà del ’700 secondo le «Anagrafi», in La popolazione italiana nel Settecento, Bologna 1980, pp. 173-189; per la perdita del potere d’acquisto: M. Berengo, La società veneta, pp. 105-110.
137. Per il 1711-1712 cf. S. Ciriacono, L’economia regionale veneta, p. 63; per il 1792 M. Berengo, La società veneta, p. 56; per la liberalizzazione dei grani e la defiscalizzazione dei bovini cf. Giuseppe Gullino, Dall’Arcadia all’economia: il problema agricolo nell’ultimo secolo della Repubblica veneta, in AA.VV., Venezia e la Terraferma. Economia e Società, Bergamo 1989, pp. 34, 36 (pp. 31-42).
138. Cf. Claudio Schwarzenberg, Aspetti dell’ordinamento tributario veneziano nel ’700 (con particolare riferimento alle carte conservate nell’archivio dei frari e nella biblioteca marciana), «Rivista di Diritto Finanziario», 27, 1968, p. 337 (pp. 330-343) e G. Scarabello, Il Settecento, p. 605 (da dove è tratta la citazione) che ridimensiona la portata del provvedimento letto dallo Schwarzenberg come «abolizione delle dogane interne». La farraginosità del sistema daziario alla caduta della Repubblica è resa bene da B. Cecchetti, Del sistema tributario.
139. A.S.V., Senato, Rettori, filza 339, decreto senato 22 aprile 1775 e varie scritture allegate; ibid., filza 384, scrittura della conferenza allegata a decreto senato 10 gennaio 1789.
140. G. Gullino, I Pisani, tab. VII in Appendice; Renzo Derosas, I Querini Stampalia. Vicende patrimoniali dal Cinque all’Ottocento, in I Querini Stampalia, un ritratto di famiglia nel Settecento veneziano, Venezia 1987, pp. 57-59 (pp. 43-87).
141. A.S.V., Senato, Rettori, filza 366, decreto senato 9 giugno 1784 e scritture allegate; ibid., filza 367, decreto senato 25 settembre 1784 e scritture allegate.
142. A. Ventura, Il problema storico, pp. XCVIII e CXVIII n. 105.
143. Ibid., p. XCVIII; G. Felloni, Gli investimenti finanziari, p. 142; G. Gullino, Considerazioni sull’evoluzione, p. 80.
144. A.S.V., Senato, Rettori, filza 186, scrittura allegata a decreto senato 23 maggio 1789.
145. A. Ventura, Il problema storico, p. CXVIII n. 105.
146. A.S.V., Senato, Rettori, filza 186, scrittura allegata a decreto senato 23 maggio 1789.
147. Ivi, Savio cassier, b. 586.
148. A. Ventura, Il problema storico, pp. CXVI-CXIX.
149. La previsione è in una scrittura di Giovanni Gera del 21 dicembre 1790, A.S.V., Senato, Rettori, filza
393; la citazione è tratta da ibid., scritture allegate
a decreto del senato 19 marzo 1791.
15o. I ristretti dei bilanci dal 1788 al 1792 sono pubblicati in appendice a L.A. da Ponte, Osservazioni sopra li depositi.
151. A.S.V., Senato, Rettori, filza 408, scrittura allegata a decreto del senato 12 aprile 1794.