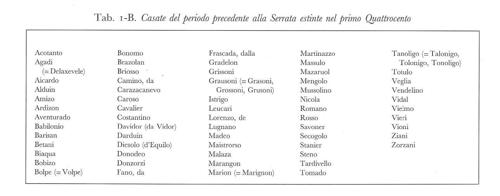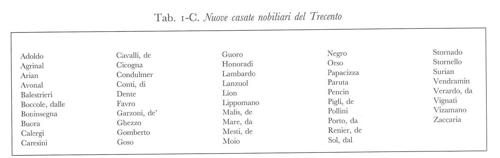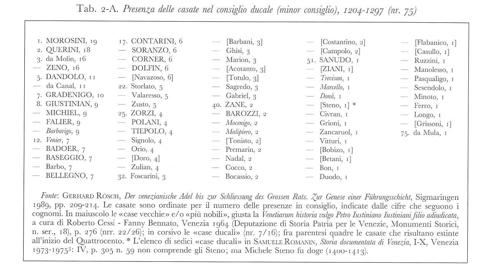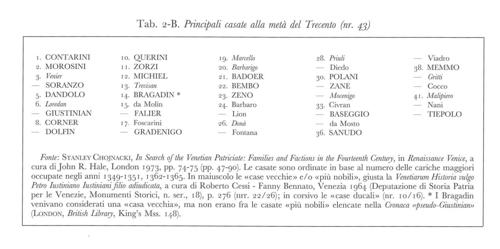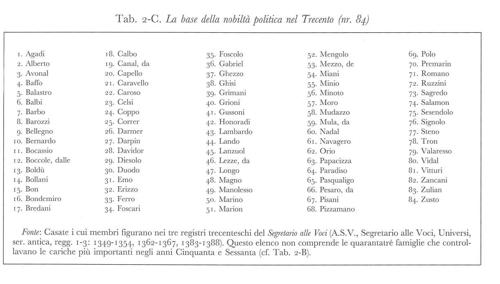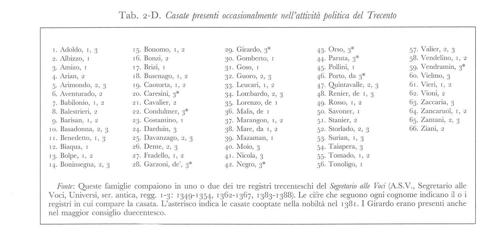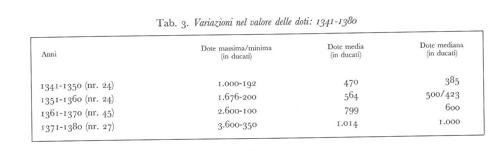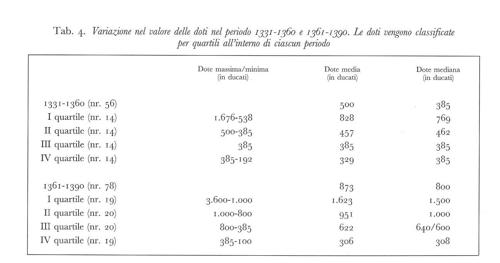La formazione della nobiltà dopo la Serrata
La formazione della nobiltà dopo la Serrata
Introduzione
Per tradizione, si ritiene che il dato di struttura essenziale della società veneziana nel Trecento venisse posto di fatto agli esordi del secolo, per rimanere poi immutato sino alla sua fine, e anzi, per parecchi secoli a venire. Si tratta dell'irrigidimento istituzionale di un'aristocrazia ereditaria precostituita, avvenuto negli anni compresi tra il 1297 e il 1323, nel corso del processo convenzionalmente, ancorché impropriamente, definito "Serrata del maggior consiglio" (1). Poiché per sei secoli gli osservatori esterni hanno costruito le proprie opinioni sulla società veneziana dopo il 1300 intorno a questo principio assoluto, quel poco di cambiamento sociale che è stato percepito riguarda le sfumature, le finezze, le questioni marginali, che non toccano la realtà di fondo della cesura istituita e imposta per legge tra una classe dominante chiaramente definita e capace di autorinnovarsi, e un "popolo" alquanto diversificato, ma comunque escluso.
Questo capitolo prende in esame il canone dominante della storia politica e sociale di Venezia alla luce di tre fattori desumibili dalla documentazione trecentesca. Il primo è di natura essenzialmente demografica: la classe dominante all'epoca della Serrata era marcatamente diversa dalla nobiltà di un secolo dopo, nel primo Quattrocento; dei cambiamenti avvenuti si parlerà più avanti, nel paragrafo 3. Il secondo è un fattore sociologico: nel corso di quel secolo la nobiltà era composta da numerosi elementi distinti, con pretese nettamente differenziate di potere e di prestigio, e di conseguenza con atteggiamenti ben diversi nei confronti delle istituzioni che ne garantivano la posizione; queste distinzioni verranno trattate nei paragrafi 2, 4, 5 e 6. Il terzo fattore è quello che rende davvero inevitabile una riconsiderazione della Serrata come momento decisivo: tra il tardo Trecento e il primo Quattrocento una seconda ondata legislativa riformula in modo più preciso e lungimirante la definizione istituzionale della nobiltà. In quanto evidenzia l'inadeguatezza dei provvedimenti del 1297-1323, la legislazione del secolo successivo rivela come nei decenni intercorsi la classe dominante veneziana, e dunque la società veneziana in genere, non fosse statica ma continuasse ad evolversi. E le esperienze di questo periodo, dal 1370 al 1430 circa, furono una fase tanto critica nell'evoluzione sociale e politica di Venezia da meritare l'appellativo di "seconda Serrata" (2).
Tre fattori che stanno tutti ad indicare la natura instabile della società veneziana nel Trecento. Parlare, come qui si fa, di famiglie e schieramenti sociali, assume un significato particolare quando si osserva che la struttura organizzativa di nobili e popolo, cioè degli schieramenti di base in cui si raggruppavano le famiglie, non era fissa bensì fluida e in evoluzione. Gli schieramenti strutturali della società si andavano plasmando e riplasmando, un dato la cui evidenza impone un riesame delle motivazioni, degli obiettivi e del comportamento dei Veneziani, che la tradizione vuole schierati da una parte o dall'altra del confine tra la nobiltà e il popolo. Il primo ed essenziale passo per una riconsiderazione della società lagunare nel Trecento consiste quindi in uno studio più attento di quel confine, che prenda in esame la composizione della nobiltà e le trasformazioni che essa subì nel secolo successivo alla Serrata. Questo capitolo è un tentativo in quella direzione.
Un tentativo inteso come "saggio". La ricerca prosopografica di base su cui deve poggiare una ricostruzione approfondita della società trecentesca rimane ancora da fare,
e questo lavoro si pone quindi un obiettivo più modesto: esaminare i tratti della nobiltà che mettono in discussione l'idea, nel dopo-Serrata, di una società dominata da una classe chiusa, ereditaria, distinta dal popolo da un'identità collettiva (cioè da un senso di appartenenza consapevole e saldamente riconosciuto), da un'ideologia collettiva (cioè da un programma comune per l'esercizio e la manifestazione del proprio ruolo di regime) e da una cultura collettiva (cioè da un sistema comune di principi e di pratiche caratterizzante la distinzione del suo comportamento sociale). L'indagine trova conforto nei documenti che attestano come l'identità, l'ideologia e la cultura comuni della nobiltà si affermassero sì, ma soltanto alla fine del secolo, con la seconda Serrata.
Quattro casate
È indispensabile, per comprendere la società veneziana del Trecento, conoscere l'evoluzione della nobiltà nel periodo successivo alla Serrata del 1297-1323. Altrettanto cruciali sono a loro volta l'importanza della vasta diversificazione interna della popolazione considerata nobile, e l'incertezza che circondò lo statuto nobiliare per buona parte del Trecento. Circostanze presentatesi sul finire del secolo limitarono la diversificazione e l'incertezza, in un processo che trasformò la classe governante, portando definitivamente a termine la Serrata, o meglio venendo a costituire la seconda Serrata: una trasformazione che rappresenta il dato sociopolitico più rilevante del Trecento, ed è dunque l'oggetto principale di questo capitolo. Per orientarci verso la sua più concreta dimensione umana, daremo qui una rapida occhiata alle diverse caratteristiche di quattro casate cui la Venezia trecentesca attribuiva, con diverse modalità, lo statuto nobiliare. Cominceremo dai Morosini.
I Morosini erano tra i supremi clans nobiliari di Venezia. Già nel secolo X avevano un peso politico tale che le loro rivalità con altre grandi casate richiesero l'intervento degli imperatori Ottoni; quanto alla loro contemporanea preminenza culturale, basterà dire che fu uno di loro a fondare il monastero di San Giorgio Maggiore (3). Ci furono Morosini fra gli elettori in sette delle nove elezioni ducali avvenute tra il 1172 e il 1275, e in diciannove degli ottantaquattro consigli ducali (il minor consiglio, costituito da sei membri) eletti tra il 1204 e il 1297 (4). Avendo già avuto un doge nel secolo XII, e un altro nel XIII, ne avrebbero visto un terzo salire al trono ducale nel 1382. La testimonianza forse più eloquente del perdurare dell'influenza e del prestigio dei Morosini sta nel fatto che nel solo secolo XIV ben sei di loro furono nominati procuratori di San Marco, la massima dignità di governo dopo il dogado (5).
La posizione centrale occupata dalla famiglia per tutto il corso della lunga storia di Venezia, e il persistere della sua influenza e del suo prestigio, la ponevano ai vertici della nobiltà. E il loro non era soltanto un peso storico: stava anche nei numeri.
Nell'estimo fiscale della proprietà immobiliare redatto durante la guerra di Chioggia, nel 1379-1380, rispetto alla dotazione di una casata media, valutata in 24.367 lire "a grossi" ripartite tra sette "stimati", il computo complessivo delle proprietà Morosini raggiungeva le 367.950 lire, ripartite tra non meno di cinquantanove intestatari; vaste proprietà che equivalevano a un 9% netto degli immobili attribuiti a nobili dall'estimo, mentre i cinquantanove Morosini "stimati" costituivano più del 5% di tutti gli intestatari di proprietà nelle centosessantasei famiglie nobiliari in estimo (6). E ancor più importante, in una classe definita dalla vita pubblica, era l'ineludibile presenza dei Morosini nel governo. Negli anni 1349-1352 e 1362-1365, per esempio, mentre la casata nobiliare media deteneva per i suoi membri ventiquattro incarichi, i Morosini ne occuparono non meno di centosettanta. A conti fatti, la loro massiccia presenza nel governo coprì più del 4% di tutte le quattromilasettantacinque cariche occupate dalle centosettantadue famiglie che parteciparono alla vita politica in quegli anni. L'attività di governo dei Morosini non era soltanto estesa, ma assai influente, poiché ebbero un numero di eletti nel solo consiglio dei pregadi (il senato) - trentatré - maggiore di quello degli incarichi occupati nell'intero apparato di governo dalla casata nobiliare media (7). Per dirla con l'antiquario settecentesco Cappellari, "per riferire le vaste glorie, e le famose attioni della Gran Casa Moresini, sarebbe d'uopo la tessitura d'un ben giusto volume" (8).
In quanto forza vitale nella politica veneziana per molti secoli, i Morosini erano tutt'uno con le fondamenta storiche sulle quali trovava giustificazione il regime nobiliare proclamato dalla Serrata (9). Numerosi com'erano, residenti in ventiquattro delle settanta parrocchie della città, sparsi su cinque dei suoi sei sestieri, era altrettanto difficile sfuggire alla loro presenza fisica (10). Di fatto, i Morosini erano i simboli onnipresenti della presa sicura esercitata sul governo e sulla società di Venezia da un'aristocrazia storicamente radicata. Come gli esponenti di altre antiche casate veneziane, un Morosini non aveva alcun bisogno di vedere convalidata la propria nobiltà: essa era fuori discussione. Certo, quanto a peso, prestigio e influenza duratura, i Morosini erano un caso estremo; ma anche altre famiglie, come vedremo in seguito, godevano del prestigio derivante dall'antica partecipazione al governo di Venezia. Un altro esempio, radicato altrettanto profondamente nella tradizione aristocratica della città, anche se ben lontano dalla massiccia presenza e dalla secolare preminenza dei Morosini, era il clan dei Caroso.
All'epoca della Serrata i Caroso erano saldamente attestati nella classe dominante. La cosiddetta Cronaca Giustinian, intorno alla metà del Trecento, riferisce che erano stati tra i tribuni di Aquileia, che secoli addietro avevano popolato Rialto; il doge Andrea Dandolo scrive nella sua Chronica che un tribuno di nome Caroso, volendo assumere lui stesso il dogado, aveva ordito una congiura per rovesciare il doge Giovanni Partecipazio nell'832 (11). Comunque sia, altre fonti risalenti al tardo secolo X comprendono i Caroso tra le maggiori famiglie veneziane (12). Marino Sanudo attribuisce loro la costruzione di San Servolo e, a conferma del venerando prestigio culturale della famiglia, già alla metà del secolo XII troviamo una certa Sicara Caroso badessa del convento di San Zaccaria (13). La famiglia fu in primo piano per tutto il secolo XIII, con presenze costanti in maggior consiglio (14); nei quattro anni che portarono alla Serrata, quattro diversi Caroso furono membri del consiglio, e provenivano da due diverse zone della città: dalla "contrada" (parrocchia) di San Vidal, nei pressi di quello che oggi è il ponte dell'Accademia, sestiere di San Marco, e da San Canciano, in Cannaregio. Uno di loro, Marco Caroso da San Vidal, era abbastanza importante da essere stato tra gli elettori del consiglio nel 1295-1296 (15), mentre un altro, Giovanni, partecipò a una delle fasi dell'elezione che portò al dogado Jacopo Contarini nel 1275; un terzo, Andrea, dimostrò la persistenza del prestigio della casata nel periodo della Serrata entrando nei pregadi nel 1301 (16).
Saldamente attestati com'erano nel governo, nella distribuzione residenziale e nel numero stesso dei loro esponenti, i Caroso - pur non godendo della preminenza dei Morosini - appartenevano a pieno titolo alla spina dorsale della classe dominante nata dalla Serrata. Famiglia "vecchia", in primo piano almeno fin dal secolo XII, e dunque con uno statuto nobiliare storicamente indiscutibile, la sua presenza attiva in maggior consiglio durante gli anni discriminanti, tra il 1293 e il 1297, le conferiva inoltre ottime credenziali anche nel dopo-Serrata. Queste credenziali, e il loro peso numerico, sarebbero state ben presto incrementate da Alberto Caroso dei Santi Filippo e Giacomo, cooptato nel maggior consiglio nel 1310 come riconoscimento per il suo contributo alla
repressione della congiura Querini-Tiepolo di quell'anno (17) - un fatto di per sé utile a indicare che nel periodo successivo alla Serrata un cognome di vecchia nobiltà non costituisce automaticamente un attestato di nobiltà personale. I Caroso erano quindi saldamente arroccati nelle posizioni che avrebbero guidato Venezia nel nuovo secolo. E nei decenni successivi non si tirarono certo indietro: ci furono Caroso nelle elezioni del doge del 1311, 1328 e 1339; tra il 1349 e il 1352, e tra il 1362 e il 1365 furono presenti in una serie di incarichi di governo che andavano da avvocato alla corte del forestier a savio agli imprestiti, e diversi di loro prestarono servizio come rettori in Istria; inoltre, in quegli anni, tre Caroso arrivarono a far parte degli organi centrali del governo, nell'alto tribunale della quarantia, in senato e nel consiglio ducale (18).
Questa forte presenza nella classe dominante dopo la Serrata non arrivò però alla fine del secolo, poiché la famiglia si estinse. Secondo Marino Sanudo, la discendenza si spense nel 1387; comunque sia, i Caroso svaniscono dai documenti ufficiali dopo il 1386, quando Andrea fu nominato giudice alla corte dell'esaminador (19). La loro scomparsa fu probabilmente dovuta a scarsa fertilità e a errori di strategia matrimoniale, poiché Andrea era uno degli unici due Caroso registrati nell'estimo del 1379-1380 (anche se un terzo, Nicoletto, compariva ancora nel 1385 nei registri delle cariche come garante per Michele Magno) (20). Rona Goffen ha segnalato una tradizione secondo la quale i Caroso erano in effetti un ramo del clan Pesaro, che invece sopravvisse ben oltre il Trecento (21), ma il fatto che le due casate vengano trattate separatamente nelle fonti contemporanee e quasi contemporanee - come la Cronaca "pseudo-Giustinian" e Le vite dei Dogi di Sanudo - ci impone di considerarle come distinte.
Come vedremo più avanti, i Caroso condivisero la sorte dell'estinzione - che finì col decimare i ranghi della nobiltà che aveva voluto la Serrata con un gran numero di vecchie casate. Sul piano della legittimazione culturale del regime, l'uscita di scena di queste antiche stirpi rappresentava un potenziale indebolimento della continuità che collegava l'ordine sociopolitico nato dalla Serrata con l'antichità veneziana, cancellando alcuni nessi convalidanti con il passato.
Ma mentre queste casate spiravano, nuove famiglie si affermavano al loro posto: i dalle Boccole, ad esempio, la cui attività nel Trecento è stata ricostruita da Dennis Romano (22). Diversamente dai Caroso, prima della Serrata la presenza politica dei dalle Boccole era inconsistente. La Cronaca trecentesca attribuita a Piero Giustinian ne fa il nome nell'elenco delle Proles nobilium venetorum, ma senza indicare la loro provenienza, né le altre caratteristiche distintive che lo stesso testo attribuisce a casate più antiche e prestigiose come i Morosini e i Caroso (23). L'appartenenza dei dalle Boccole alla nobiltà sarebbe dunque un fatto nuovo, contemporaneo alla Serrata o successivo. Alla metà del secolo, comunque, si erano già affermati come esponenti attivi della classe dominante, nelle cariche di governo come in società. Nicoletto dalle Boccole, processato nel 1351 per aver aiutato suo fratello Bastardo a sfuggire dalle mani dei capisestiere, veniva identificato negli atti come "nobilis vir"; è probabile si trattasse dello stesso Nicolò dalle Boccole che in quell'anno fu nominato avvocato alla curia del procurator. Un terzo fratello, Giovanni, anch'egli implicato nella fuga di Bastardo, fu eletto podestà di Valle nel 1350. L'apogeo fu raggiunto nel 1381, quando Francesco dalle Boccole, condannato nel 1357 per violenza carnale, coronò la propria riabilitazione e l'ascesa politica della sua famiglia divenendo uno dei sei membri del consiglio ducale (24).
Queste cariche e l'attribuzione del titolo "nobilis vir" - che come vedremo più avanti, a metà Trecento veniva attribuito in modo alquanto irregolare - dimostrano che i dalle Boccole si erano inseriti saldamente nella vita pubblica della nobiltà. Lo stesso valeva per la vita privata. Nel 1369 alla madre vedova dei fratelli di cui si è detto, Francesca dalle Boccole, veniva restituita la dote di 1.000 lire "a grossi" dall'eredità del defunto marito Marino dalle Boccole (25). È di vent'anni dopo, nel 1388, un'attestazione meno gratificante del prestigio della famiglia: Giovanni dalle Boccole, forse l'ex podestà di Valle, fu oggetto di un'aggressione disonorante da parte - nientemeno - di Alvise Venier, figlio del doge regnante. Insieme con Marco Loredan, Venier affisse corna e versi ingiuriosi sulla moglie e la suocera di Giovanni sul ponte di Ca' dalle Boccole, a Santa Ternità (26).
È possibile che quell'insulto da parte di esponenti di due casate nobiliari ben consolidate fosse provocato dal risentimento per la ricchezza e la visibilità politica di parvenus come i dalle Boccole (27): questo Giovanni dalle Boccole non compare nell'estimo del 1379-1380, ma un Francesco dalle Boccole, probabilmente suo fratello e quasi certamente il consigliere ducale del 1381, veniva stimato per 10.000 lire, una cifra che lo collocava tra i centodiciassette Veneziani più ricchi - il 5,5% più ricco dei duemilacentoventotto presenti nell'estimo (28). Per quanti risentimenti potesse scatenare nelle vecchie famiglie nobili negli anni Ottanta del Trecento, era stata quasi certamente la ricchezza il motivo originario dell'ingresso dei dalle Boccole nei ranghi della nobiltà. Già negli anni Venti gli amministratori del lascito di un altro Giovanni dalle Boccole distribuivano cospicue quantità di denaro a numerosi Veneziani con cognomi nobiliari per l'investimento nei prestiti d'affari, o "colleganze". In vita, Giovanni era stato un uomo d'affari di notevoli mezzi, tanto da potersi permettere speculazioni come la commissione a Giovanni Venier - probabilmente nobile anche lui - per un acquisto a Tunisi di seta per un valore di 6.273 lire "a grossi", e nel suo testamento del 1321 destinava 3.000 lire alla fabbrica della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (29).
Dopo la morte di dalle Boccole, gli amministratori - i procuratori di San Marco non rinunciarono alle speculazioni su vasta scala: l'investimento più consistente fu l'enorme somma di 10.000 lire prestata al figlio di Giovanni, Marino, per investimenti in colleganze marittime (30). Ma il lascito di Giovanni dalle Boccole alimentò anche altri prestiti per investimenti di notevole entità: tra il 1321 e il 1327 gli amministratori concessero una serie di prestiti a personaggi dal cognome nobiliare - 1.800 lire in tre transazioni a Marino Michiel, 4.000 lire in due transazioni a Paolo Morosini e 2.000 lire in quattro transazioni a Giovanni de Avanzo (Davanzago?) (31). Queste cifre dimostrano che il lascito dalle Boccole fu una generosa fonte di capitale per gli uomini d'affari della nobiltà; e dimostrano anche che gli eredi di Giovanni entrarono in possesso di una fortuna assai consistente.
Sebbene la nobilitazione formale dei dalle Boccole - come di tante altre famiglie nuove comparse all'interno della nobiltà trecentesca - non sia in alcun modo documentata, la loro ricchezza e la generosità con cui la mettevano a disposizione degli esponenti delle grandi famiglie bastarono a spianare la via della nobiltà ai figli di Giovanni. E la causa fu indubbiamente favorita dal fatto che le figlie di Giovanni avevano usato quella ricchezza per arrivare al matrimonio con uomini della nobiltà: Nicolò Miani, ad esempio, marito di Caterina, che in poco più di due anni ottenne dal lascito del suocero investimenti in colleganza per un totale di 5.000 lire.
Come molti matrimoni, quello tra Caterina dalle Boccole e Nicolò Miani non era soltanto un legame tra i due sposi, ma serviva a creare o rafforzare i legami, compresi quelli d'affari, tra altri membri delle due famiglie. Così il fratello di Nicolò, Piero Miani, ottenne a proprio nome 2.500 lire dal lascito di Giovanni dalle Boccole tra l'aprile 1326 e l'aprile 1327 (32). Piero Miani aveva rapporti d'affari sia con gli amministratori di Giovanni dalle Boccole che con due delle sue figlie, la moglie di suo fratello, Caterina, e la sorella di lei, Francesca, sposata con Ermolao Balbi (33). Gli investimenti intrecciavano gli interessi di due casate nobiliari, i Miani e i Balbi, con quelli dei dalle Boccole, in un tessuto reso più fitto dai legami matrimoniali. A queste relazioni si aggiungevano i matrimoni degli altri figli di Giovanni, che forgiarono legami con i Morosini, i Molin e i Venier - questi ultimi forse una conseguenza dei rapporti d'affari del patriarca Giovanni con quella famiglia (34).
Legami d'affari e di matrimonio che furono la chiave d'accesso dei dalle Boccole alla società nobiliare, un accesso consolidato dal loro impegno nell'attività di governo, con il quale si guadagnarono il riconoscimento di "nobiles viri" e l'appartenenza politica, oltre che sociale ed economica, alla nobiltà. Quando, nello stesso decennio in cui avvenne l'insulto sul ponte di Ca' dalle Boccole, un altro Giovanni dalle Boccole (probabilmente figlio di Francesco) fu nominato agli incarichi di "avvocato per ogni corte" e signore di notte a Creta, a garantire per la sua condotta onesta nell'ufficio furono esponenti dei ben consolidati clans dei Barbaro e dei Coppo. E in un rivolgimento particolarmente ironico della storia, fu uno Zanino dalle Boccole (forse la stessa persona) a far da garante quando Leonardo Loredan fu eletto podestà al Lido (35). La ricchezza, le relazioni sociali e l'attività politica dei dalle Boccole se li insediarono saldamente entro la società nobiliare, non bastarono però per innalzarli tra gli antichi clans più prestigiosi come i Morosini, e nemmeno tra le vecchie casate come i Caroso, poiché mancavano loro le essenziali qualità del numero e della storia. Il posto modesto, o inesistente, che avevano occupato nel passato di Venezia, prima della Serrata, rappresentava uno svantaggio in un regime di classe che trovava giustificazione al proprio predominio nella continuità del legame legittimante con i grandi momenti della più remota storia veneziana (36).
Fatale, nel senso più letterale, fu comunque l'esiguità del loro numero, che nel 1483 avrebbe portato la famiglia all'estinzione (37). Come vedremo poco oltre, altre famiglie la cui presenza all'interno della nobiltà trecentesca fu altrettanto modesta e transitoria condividevano le carenze storiche e biologiche dei dalle Boccole. Ma anche queste casate dalla storia effimera vanno contate tra le famiglie veneziane che costituirono la classe dominante nel Trecento. In definitiva, nell'ambito di una nobiltà costituita da categorie diverse quanto a ricchezza, antichità e grado di influenza, e che rimane difficile da delineare con precisione, i dalle Boccole riuscirono comunque a tenere saldamente il loro posto.
Altrettanto non si può dire, invece, per l'ultima delle nostre quattro casate, i Balduin, la cui posizione ambigua è un ottimo esempio della persistente indefinitezza delle distinzioni sociopolitiche nel secolo XIV. Nonostante la ricorrente comparsa del nome, non esistono attestazioni contemporanee sicure della loro appartenenza alla nobiltà, nel Trecento o in qualsiasi altro momento. Il genealogista cinquecentesco Marco Barbaro li comprendeva in un elenco di famiglie nobiliari estinte, ma ne faceva risalire l'estinzione al 1300 (38). Non compaiono però in alcun altro elenco manoscritto di nobili del Trecento, compreso quello assai dettagliato compilato da Marino Sanudo alla fine del secolo XV; né si contavano tra i membri del maggior consiglio nel secolo XIII (39). Un cenno a un'occasione in cui i Balduin si sarebbero messi in luce prima della Serrata sta nella Cronaca trecentesca attribuita a Piero Giustinian, che riconosce ad "Andreas Baldovino" e a un altro uomo il merito di aver portato il corpo di san Simeone da Costantinopoli a Venezia dopo la quarta Crociata; ma anche questo accenno identifica i due come "plebei" (40). Nondimeno, data la scarsa chiarezza intorno alla condizione nobiliare che prevalse per tutto il secolo XIV, l'intraprendenza e l'ambizione dei Balduin hanno indotto molti storici moderni a considerarli nel numero della classe dominante contemporanea (41). Ed è ironico, perché la loro ambizione assunse una forma che li allontanava dal regime nobiliare invece di introdurveli, ed è in definitiva un attestato di esclusione dalla classe dominante.
La loro prima comparsa dopo la Serrata è con un certo Giovanni, uno dei capi della congiura anti-Serrata del 1299, legata al nome di Marino Bocco, o Boccono. Nelle sue Vite dei Dogi Marino Sanudo riferisce che Marino Bocco, insieme con Giovanni Balduin e altri, infuriati perché erano "rimasti fuori del Consiglio" dopo la Serrata, cospirarono per vendicarsi uccidendo il doge e i "gentiluomini" (42). E il fallimento del tentativo non bastò certo a ridurre i Balduin a più miti consigli: è probabile che fosse ancora il risentimento verso il regime nobiliare che li aveva esclusi a indurli ad aderire alla ben più pericolosa congiura ordita dai nobili Baiamonte Tiepolo e Marco Querini nel 1310, che reclutò malcontenti anche tra i popolani. Per questo secondo atto di sedizione contro il governo nobiliare i Balduin furono condannati a subire a lungo l'umiliazione dell'obbligo di tenere sempre aperto, di giorno e di notte, il portone del loro palazzo a San Simeone Profeta (43). La terza ed ultima manifestazione dell'implacabile rancore antinobiliare dei Balduin avvenne nel 1412, quando Francesco Balduin fu impiccato per aver cospirato contro il regime, volendo "destruzer il campo della Signoria ed i zentilomeni" (44).
Questi episodi ci mostrano una famiglia Balduin assai attiva in politica, ma all'esterno del regime nobiliare, e anzi in contrapposizione ad esso; tuttavia i documenti non sono privi di ambiguità. Secondo uno studioso, un certo Leonardo Balduin fu membro del consiglio dei dieci nel 1323. La cosa è però improbabile, poiché in quegli anni il consiglio, responsabile per la sicurezza dello stato, era impegnato ad imporre le sanzioni inflitte ai Balduin per la loro partecipazione alla congiura Querini-Tiepolo; e per di più la forma in cui il nome di Leonardo Balduin compare nel documento in questione suscita sospetti circa il suo significato, perché è l'unico tra i nomi di membri del consiglio citati in questa e altre fonti che non sia preceduto dal titolo di "dominus", e perché è stato scritto fuori posizione nella pagina (45). A conti fatti, si è portati a concludere che non fosse un membro dei dieci.
Un Balduin detentore di una carica è comunque inoppugnabilmente documentato: nel 1335 Antoniello Balduin era capitano di Torre San Giuliano (46). Sebbene nel primo Trecento ancora non si fosse portato a termine il lungo processo che avrebbe riservato tutte le cariche ai membri del maggior consiglio, ed è quindi possibile che nel caso particolare l'ufficio fosse stato affidato a un ricco popolano, è altrettanto possibile che questo Antoniello fosse davvero un nobile (47). Se così fosse, è l'unico Balduin di cui sia attestata la condizione nobiliare: la famiglia è del tutto assente dagli elenchi dei detentori di cariche nei secoli XIV e XV, dall'esauriente catalogo trecentesco delle Proles nobilium venetorum nella cosiddetta Cronaca Giustinian e - a parte l'elenco delle famiglie estinte di Marco Barbaro, che comunque la vuole estinta nel 1300 - dalla tradizione cronachistica manoscritta della nobiltà veneziana. Un Nicolò Balduin ha il titolo di "ser" nell'estimo del 1379-1380, ma in quel documento l'attribuzione del rango nobiliare è informale e inattendibile (48). Indicazione inconfutabile della condizione popolare dei Balduin per tutto il Trecento parrebbe essere la loro assenza dalla prima lista ufficiale delle famiglie nobili che ci sia stata conservata, quella redatta dagli avogadori di comun nel primo Quattrocento, della quale discuteremo più avanti.
In ultima analisi, tuttavia, non possiamo stabilire con certezza se fossero nobili o meno, per lo stesso motivo per cui la posizione sociale di tanti uomini, donne e famiglie del Trecento rimane indefinita nonostante i cognomi nobiliari: la fondamentale vaghezza, cioè, del criterio di appartenenza alla classe nobiliare per tutto il corso del secolo. È questa la principale caratteristica, non solo della nobiltà, ma della struttura complessiva della società veneziana nel Trecento, che emerge da questa rapida rassegna di quattro casate: la definizione della composizione, del carattere sociale e politico e dei tratti distintivi del gruppo legittimamente dominante nel governo veneziano è incerta. Nelle pagine che seguono esploreremo ciascuno di questi elementi di incertezza.
La trasformazione della nobiltà
La chiave per comprendere la storia sociale di Venezia nel secolo XIV sta nella risposta a due interrogativi: chi apparteneva alla classe di governo? Che cosa significava appartenervi? Sono due interrogativi complementari: il significato pratico del rango nobiliare dipendeva in notevole misura dalle caratteristiche di chi lo possedeva; e nel contempo, la composizione della classe dipendeva dai requisiti necessari per appartenervi. Nel secolo XIV entrambi gli elementi assumevano rilievo vitale per la struttura dei rapporti sociali ed economici, tanto per i nobili quanto per i popolani.
In questo e nel paragrafo che segue ne esploreremo diversi aspetti, concentrando l'attenzione sui problemi emersi nel nostro rapido esame di quattro casate. Cominceremo qui ricostruendo i cambiamenti nella composizione della nobiltà nel corso del secolo.
La presenza di un ricambio significativo attenuerebbe l'immagine della Serrata come evento che fissò il governo e la società di Venezia in una struttura permanente e immutabile. Nel contesto della politica della classe dominante, riproporrebbe inoltre per il secolo XIV la questione che continua ad aleggiare irrisolta sulla storia politica della Serrata stessa, e che riemerge, sia pure in forma diversa, come momento centrale della discussione sulla politica del patriziato nel Rinascimento maturo: l'eterno problema delle clientele dei potenti, che nel Trecento ruotava intorno alla concessione stessa del rango nobiliare (49). La comparsa di nuovi venuti in sostituzione delle casate estinte porrebbe inoltre in maggiore rilievo il prestigio delle famiglie più eminenti, le cui radici affondavano nella storia dei primi secoli di Venezia; e nel contempo, metterebbe in discussione la continuità del regime successivo alla Serrata con il passato.
Sono motivi più che sufficienti per indurci a verificare le finalità della Serrata tentando una ricostruzione sistematica della costituzione della nobiltà all'indomani di quell'evento, con un occhio particolare per il fattore della stabilità nel tempo. È un compito reso difficile dalla vaghezza delle fonti ufficiali per buona parte del secolo, sia per quanto riguarda la posizione di individui, famiglie e intere casate, sia per la composizione stessa della classe nobiliare. Una documentazione tanto approssimativa, anzi, da costituire di per sé un'indicazione dell'incertezza e della fluidità dell'atteggiamento ufficiale di fronte ai fattori di distinzione della nobiltà. Le testimonianze disponibili sono comunque sufficienti per fornire una solida base alla conclusione principale di questo capitolo: che cioè la nobiltà uscita dalla Serrata non era una classe chiusa, bensì soggetta a un processo di formazione incerto e alterno. A questa conclusione si giunge studiando i cambiamenti nella composizione della nobiltà dalla Serrata all'inizio del secolo XV.
Al di là delle sue altre conseguenze, la legislazione della Serrata aveva enunciato un criterio concreto di appartenenza alla classe dominante: i precedenti incarichi di governo, specificamente definiti dall'elezione in maggior consiglio. Nel periodo immediatamente successivo alla Serrata, quindi, il nucleo irriducibile della classe di governo così definita era dato dal gruppo di uomini presenti in maggior consiglio negli anni 1293-1296, che il decreto del febbraio 1297, rinnovato l'anno successivo, indicava esplicitamente come aventi diritto a rimanere in consiglio, mentre la legge del 1323 sul criterio dell'ereditarietà trasferiva il privilegio ai loro figli e nipoti. Una definizione tecnica suscettibile di verifica che si fondeva armoniosamente con il principio culturale legittimante alla base della ridefinizione della classe dominante: la continuità con il passato, con la preminenza morale e storica conquistata dai "nostri maiores" prima della Serrata. Essenzialmente, la fusione dei due principi era riducibile al requisito dell'esperienza. In pratica, definendo la condizione nobiliare in termini di continuità storica ed esperienza di governo si perpetuava implicitamente il predominio delle case più antiche: erano loro quelle più intimamente legate con la storia passata; loro che vantavano i precedenti più illustri di servizio nei consigli di stato nell'arco dei secoli; loro le vere padrone dei meccanismi di governo.
Il principio della continuità motivava anche la seconda clausola della legge del 1297, che fissava il meccanismo in base al quale anche chi possedeva il requisito dell'esperienza pur non essendo stato in maggior consiglio tra il 1293 e il 1297 poteva essere cooptato nella classe dominante. Si voleva garantire che quella serrata di ranghi comprendesse tutti i Veneziani esperti, e dunque utili ai fini del governo - e naturalmente, tutti quelli la cui esperienza poteva costituire un potenziale rischio politico. Anche i beneficiari di questo provvedimento integrativo erano uomini con esperienza di governo, e in quanto tali loro o le loro famiglie erano stati probabilmente rappresentati in maggior consiglio nei decenni precedenti i quattro anni cruciali nel corso dei quali quel consesso si affermò come matrice di tutte le cariche del governo veneziano (50).
Il settore di popolazione che può essere ragionevolmente considerato come la base della nobiltà dopo la Serrata è dunque costituito dalle centosessantasei famiglie presenti in maggior consiglio nel 1293-1296, integrate da altre ottantuno famiglie che erano state in consiglio nel corso dei trent'anni precedenti, ma non nei quattro anni decisivi (51). La stabilità sociale e la legittimità storica del regime dipendevano dalla continuità nella composizione della nobiltà creata dalla Serrata - continuità, cioè, della legittimazione storica data dalla partecipazione ininterrotta e indiscussa di quelle duecentoquarantasette famiglie all'attività di governo.
Per nostra fortuna, la misura in cui questa continuità fu di fatto mantenuta - la misura cioè in cui la Serrata riuscì a fissare in modo definitivo la classe dominante di Venezia - può essere valutata sulla scorta di un ruolo ufficiale della nobiltà compilato all'estremo opposto del Trecento. Questo primo elenco dei nobili reperibile nei documenti ufficiali dopo la Serrata è anche il prodotto della tendenza, tipica del primo Quattrocento, a una maggiore specificità legislativa e amministrativa relativamente allo statuto giuridico nobiliare. Nel 1414 un decreto del maggior consiglio fissava le procedure da seguire nella gestione della Barbarella, o Balla d'Oro, la cerimonia annuale istituita nel 1319 in cui i giovani nobili che avessero compiuto il diciottesimo anno di età concorrevano a una lotteria che dava ai vincitori il diritto di entrare in maggior consiglio a vent'anni invece di attendere i venticinque stabiliti dalla legge (52).
Tra le nuove procedure previste dal decreto del 1414 per questa secolare istituzione si stabiliva che i magistrati responsabili della Barbarella, gli avogadori di comun, tenessero una registrazione ufficiale degli attestati con cui i giovani qualificavano il proprio diritto a prender parte alla lotteria - di fatto, i requisiti della loro appartenenza alla classe dominante. I documenti e le testimonianze addotti a sostegno delle credenziali di ciascun candidato dovevano essere "ordinate descriptis in uno quaterno ad officium Advogarie". Il provvedimento ebbe efficacia immediata: i segretari degli avogadori prepararono subito i registri in cui sarebbero state annotate le credenziali presentate da tutti i giovani che si fossero iscritti alla lotteria. In quanto ruolo delle famiglie considerate ufficialmente come nobili dagli avogadori di comun, i magistrati cui spettava la maggiore responsabilità nella verifica dei requisiti di nobilità, questi registri consentono un confronto tra la classe dominante alla fine del Trecento e quella che aveva voluto la Serrata, e ne aveva tratto i benefici, all'inizio del secolo.
Il primo registro, con le iscrizioni alla Barbarella dal 1408 al 1435, riporta duecentotrentasei famiglie riservando a ciascuna una pagina(53), e può dunque essere considerato come il ruolo ufficiale della nobiltà nel primo Quattrocento, il corrispettivo un secolo dopo delle duecentoquarantasette famiglie presenti in maggior consiglio nella seconda metà del Duecento. Questo ruolo, però, non corrisponde con esattezza all'effettiva composizione della nobiltà nel primo Quattrocento: delle duecentotrentasei famiglie cui il registro assegna una pagina, solo centoquarantadue iscrissero i propri giovani alla Barbarella negli anni presi in considerazione. Di ventuno delle novantaquattro casate rimanenti - e tra queste troviamo cognomi nobiliari ben noti come i Balastro, i dalla Fontana, i Ruzzini, gli Zancaruol - i figli avrebbero occupato incarichi di governo, o sarebbero comparsi nei registri successivi della Barbarella, più avanti nel secolo, attestando così la continuità della presenza delle loro famiglie nella classe dominante (54). Queste ventuno famiglie vanno dunque aggiunte alle centoquarantadue i cui giovani parteciparono alla Barbarella tra il 1408 e il 1435; si giunge così a un totale di centosessantatré casate ufficialmente designate come nobili, di cui le fonti di governo attestano una presenza attiva nella classe dominante del Quattrocento. A questo gruppo va aggiunto un ultimo cognome, quello dei Lombardo, assente nel registro 162, ma che compare con buona evidenza in altri documenti relativi alla nobiltà quattrocentesca (55). Rimaniamo quindi con un totale di centosessantaquattro casate attive nella nobiltà del primo Quattrocento.
Il registro 162 presenta dunque due diverse configurazioni della classe dominante, espressione di un'ambiguità di fondo nella composizione della nobiltà più di un secolo dopo la Serrata. La prima, costituita dalle centosessantaquattro famiglie attive nella vita pubblica, schiera quanto ancora rimaneva del corpo ufficiale degli effettivi della classe. Una documentazione inoppugnabile dimostra che queste famiglie asserivano la propria identità nobiliare, esercitavano le responsabilità e i privilegi politici della loro classe, e prendevano parte alla sua vita sociale, soprattutto a un'attività matrimoniale sempre più introversa (56). La seconda configurazione, costituita dall'intero spettro delle duecentotrentasei famiglie cui il registro 162 riservava un apposito spazio, rappresenta il ruolo ufficiale della composizione del regime nobiliare nella sua dimensione più ampia (57). La discrepanza tra le due cifre conduce a due osservazioni in merito agli effetti della Serrata.
In primo luogo, richiama l'attenzione sulle carenze della documentazione ufficiale, costantemente presenti fino al secolo XV inoltrato anche quando si trattava di una materia importante per un'aristocrazia ereditaria quant'era quella della sua stessa composizione, ormai sottoposta a un controllo ufficiale sempre più attento. Sebbene il decreto del maggior consiglio del 1414 avesse prodotto un importante passo avanti verso una maggiore precisione dei documenti, il fatto che esso richiamasse con energia all'esigenza di una tenuta accurata delle attestazioni scritte dimostra che anche la nobiltà meno influente era ben consapevole del fatto che, più di un secolo dopo la Serrata, la conoscenza ufficiale della sua composizione era tutt'altro che soddisfacente, per non parlare della sua sistematicità. La nuova tendenza al rafforzamento dei meccanismi documentali del governo indica un importante cambiamento nella concezione che la nobiltà aveva di sé, legato all'alterazione dei criteri che determinavano lo statuto nobiliare: dal nesso più o meno vagamente riconosciuto con la storia antica di Venezia si passava alla capacità di corrispondere a procedure di verifica legali e amministrative sempre più precise. Nonostante la nuova tendenza, però, il gran numero di casate estinte cui il registro 162 riserva uno spazio dimostra che ancora nel 1414 i tutori ufficiali della nobiltà non erano in grado di fornire ai loro segretari un rendiconto aggiornato della sua composizione.
La seconda osservazione è una conseguenza della prima. Iscrivendo duecentotrentasei famiglie laddove quelle realmente esistenti erano solo centosessantaquattro, gli avogadori rivelavano gravi incertezze non solo in merito alla composizione della classe di governo, ma sulle sue stesse dimensioni, e quindi sulla sua presenza e la sua funzione nell'insieme della società. È senz'altro vero che un certo numero delle settantadue famiglie cui il registro assegna uno spazio non utilizzato, e che non ricompaiono in epoca successiva, erano uscite di scena soltanto di recente. Esponenti di ventidue di queste famiglie avevano avuto incarichi di governo fino agli anni Ottanta del Trecento, e altre otto comparivano nell'estimo del 1379 (o quantomeno nella copia manoscritta non ufficiale che ci è stata conservata) (58).
Rimane però il fatto che la maggioranza delle famiglie estinte iscritte nel registro 162 erano scomparse dalla vita pubblica della nobiltà da diversi decenni, e per alcune non è attestata alcuna partecipazione agli incarichi di governo - unico segnale inconfutabile dello statuto nobiliare - dopo la Serrata: gli Aicardo si sarebbero estinti a metà Trecento(59); i Briosso forse ancor prima della Serrata (60); i Dondolo nel 1307 (61); i Grausoni (o Grasoni) nel 1303(62); i Pantaleo già negli anni Settanta del Duecento (63); i Pollini nel 1348 (64); i Rampani nella seconda decade del Trecento (65); i Savoner, forse, nel 1321 (66). Queste famiglie, e altre come loro, risultano praticamente invisibili nei decenni successivi alla Serrata, e si dissolsero in quell'arco di tempo senza quasi lasciar traccia di sé - un fatto confermato dall'incertezza delle fonti anche per quanto riguarda le date precise della loro estinzione (67).
Perché mai dunque, quasi un secolo dopo, gli avogadori ritennero di dover lasciare spazio alle casate estinte nel registro della Barbarella? Una componente importante della motivazione sta nella continuità con il passato. Molte delle duecentotrentasei famiglie presenti nel registro 162 vantavano un prestigio nobiliare che risaliva quantomeno a una presenza attestata in maggior consiglio nel periodo precedente la Serrata: così, per rimanere alle casate appena citate, i Briosso, i Grausoni e i Savoner - gli ultimi due con una consolidata partecipazione al governo di Venezia ancor prima dell'anno 1100 (68). Di tutte le duecentotrentasei casate iscritte nel registro della Barbarella (anzi duecentotrentasette, includendovi i Lombardo), centottantasei - il 78,5% - potevano far risalire la loro esperienza di governo al maggior consiglio duecentesco (69), e molte avevano radici ben più profonde: tra le famiglie estinte cui il registro 162 riserva uno spazio, alcune avevano fatto parte del governo fin dal momento della fondazione del comune veneziano. Oltre ai Caroso, che appartengono appunto a quest'ultima categoria, c'erano altre casate di veneranda preminenza quali i Grausoni, gli Istrigo, i Marion (Marignon), i Rosso, i Savoner, i Tonoligo (Tanoligo, Tolonigo), i Vidal e gli Ziani: tutte famiglie attive nel governo prima del 1100. E con la metà del secolo XII anche gli Acotanto, i Diesolo (d'Equilo) e gli Stanier erano entrati a far parte del gruppo dominante (70).
A ognuno di questi cognomi tanto familiari corrispondeva una rappresentazione in carne ed ossa delle fondamenta storiche della cultura politica veneziana. Non sorprende quindi che una magistratura incaricata di verificare la validità degli attestati di appartenenza alla classe dominante considerasse inevitabile, e forse indispensabile, la continuità della loro presenza - al punto di conservarne la finzione anche dopo la scomparsa della realtà effettiva.
L'interesse a mantenere il legame più stretto possibile con il passato basta però solo in parte a spiegare la persistenza di tante famiglie estinte nel ruolo avogaresco della nobiltà nel primo Quattrocento. Per cinquantuno famiglie infatti, quasi un quinto del totale, non è documentata alcuna presenza negli incarichi di governo prima della Serrata: il fatto che il registro 162 assegnasse comunque uno spazio a questi cognomi sintetizza l'enigma di fondo posto dalla lista avogaresca. Da un lato comprende i nomi di molte famiglie ormai scomparse, alcune estinte da decenni, come se fossero ancora attive nel regime nobiliare. Dall'altro però affianca a cognomi nobiliari profondamente radicati nel passato di Venezia quelli di famiglie dalle origini ad un tempo recenti e oscure - i dalle Boccole accanto ai Morosini, per rimanere a un esempio che già conosciamo. Il primo dato rivela che il governo non era informato circa la composizione della sua classe dominante; il secondo indica una certa ambivalenza nei criteri di appartenenza ad essa. Riassumendo, il quadro complessivo delineato dal registro 162 rivela, per il primo Quattrocento, una nobiltà in posizione ambigua quanto alla propria coscienza di sé, all'identità delle famiglie che era venuta cooptando dopo la Serrata, e ai principi che ne regolavano l'accesso.
Un confronto tra gli elenchi dei membri del maggior consiglio a un estremo del Trecento e il registro 162 dell'avogaria all'estremo opposto dimostra inconfutabilmente che la composizione della nobiltà fu in costante evoluzione per tutto il corso del secolo, un'evoluzione che possiamo misurare esaminando più da vicino i cambiamenti avvenuti nell'arco del periodo. La nobiltà che si arroccò sulla legislazione della Serrata era un organismo numeroso, che portò le presenze alle assemblee del maggior consiglio da meno di quattrocento negli anni Novanta del Duecento a millecento nel 1320(71). Come abbiamo già detto, la legge del febbraio 1297 conferiva il titolo assoluto di accesso in consiglio agli esponenti delle centosessantasei famiglie presenti tra il 1293 e il 1297, attribuendo la potenziale eleggibilità a quelli di altre ottantuno famiglie i cui progenitori erano stati membri del consiglio nei trent'anni precedenti. Senza dubbio la mortalità aveva assottigliato le fila di questo gruppo di duecentoquarantasette famiglie anche prima della fine del periodo della Serrata; da più d'una delle cronache manoscritte della nobiltà risulta che diciassette di esse si estinsero tra il 1250 e il 1320: tra queste, famiglie come i Barbamazolo, presumibilmente estinti con la morte di un elettore ducale nel 1268; i Betani, il cui ultimo esponente documentato fu podestà a Chioggia nel 1286; i Campolo, estinti con la morte di Giovanni, consigliere a Corone nel 1272; i Donzorzi, scomparsi con Filippo, visdomino al fondaco dei Tedeschi nel 1312; i Doro (Dauro), estinti con Andrea, consigliere ducale nel 1311; i Tonisto, scomparsi con la morte di Nicolò, podestà a Chioggia nel 1315 (72). Molte altre si dissolsero senza lasciare traccia nemmeno in queste fonti incerte.
Gli effetti delle estinzioni non vanno esagerati. Una parte imponente della classe di governo duecentesca sopravvisse ben oltre il primo Quattrocento, testimoniando con la sua stessa presenza la continuità dell'ordine sociale e politico di Venezia dal Medioevo al Rinascimento maturo: centotrentacinque casate, la spina dorsale della nobiltà dopo la Serrata, che prosperarono senza interruzione dal secolo XIII fino al Quattrocento inoltrato (si veda Tab. 1-A). Esponenti di queste famiglie sedevano in maggior consiglio prima della Serrata, e sessantanove di esse sono rappresentate anche negli incarichi esecutivi e giudiziari e nei rettorati nel corso del secolo XIII (73). Con sole tre eccezioni, tutte fornirono funzionari al governo nel corso del Trecento (74); e tutte iscrissero i figli alla Barbarella nel Quattrocento, continuando - con due sole eccezioni - ad occupare incarichi anche in quel secolo (75). Furono queste casate a creare e plasmare il carattere del regime dopo la Serrata, amalgamando il fattore legittimante della storia e dell'esperienza con le riforme politiche e amministrative che lo aggiornarono alla fine del Duecento, e temprando nella pratica concreta il frutto di questo amalgama per tutto il Trecento, e poi il Quattrocento.
Pur garantendo alla classe di governo una continuità demografica per tutto il secolo XIV, queste centotrentacinque casate non ne furono però le uniche esponenti: al loro fianco stavano altre famiglie, con caratteristiche storiche e destini biologici affatto diversi. Si tratta di un dato essenziale della nobiltà trecentesca, la cui valutazione impone di tener conto di tre elementi costitutivi: le centotrentacinque casate appena menzionate, costantemente presenti dal secolo XIII al XV; altre famiglie eminenti prima della Serrata, che non sopravvissero al Trecento; e infine una terza categoria la cui presenza nella nobiltà non è documentata prima del 1300.
Osserviamo più da vicino il secondo gruppo, costituito da sessantaquattro casate (si veda Tab. 1-B), diciotto delle quali non compaiono nei disordinati documenti ufficiali del Trecento. Anzi, secondo Marino Sanudo quattro delle famiglie presenti in maggior consiglio negli anni Novanta del Duecento si estinsero anche prima del 1300; non le abbiamo escluse, comunque, volendo presentare un quadro il più possibile completo, ma anche perché l'attendibilità cronologica di Sanudo non è affatto sicura (76). Di nove delle rimanenti quattordici, Sanudo o un altro dei cronisti della nobiltà ci dicono che sopravvissero fino a dopo la Serrata, e sei di esse ebbero incarichi di governo. Ne sono esempi i Donzorzi, che si sarebbero estinti con Filippo, visdomino al fondaco dei Tedeschi, nel 1312; i Secogolo, il cui ultimo esponente, anch'egli di nome Filippo, fu giudice del piovego nel 1352; i Lugnano, estinti con Lupino, ufficiale all'armamento, nel 1371; i Totulo, scomparsi con Giovanni, giudice del gran salario, nel 1383 (77).
Non possiamo essere del tutto certi circa le informazioni fornite da queste fonti non ufficiali, ma in assenza di documenti ufficiali che le contraddicano, e tenuto conto della verisimiglianza di molte delle loro attribuzioni di cariche, non dobbiamo nemmeno trascurarle con eccessiva leggerezza. Comunque sia, quanto ci dicono sulle famiglie estinte costituisce la tradizione, radicata nella coscienza culturale di Venezia già sul finire del Quattrocento, di una nobiltà le cui componenti attive e costituite furono falcidiate dalla mortalità nel corso del secolo successivo alla Serrata. Una tradizione, peraltro, saldamente fondata sul fatto storico, come attestano le altre quarantasei casate del secondo gruppo, tutte registrate come nobili dalle fonti ufficiali del Trecento: quarantacinque compaiono tra le case estinte iscritte dagli avogadori nel registro 162; trentadue sono presenti negli elenchi delle cariche trecenteschi.
Per quanto breve il loro tempo di permanenza nel regime successivo alla Serrata, queste quarantasei casate sicuramente documentate costituivano un elemento di tutto rilievo del suo passato, e della sua attività nel Trecento. Già abbiamo visto che molte di esse, come gli Acotanto, i Caroso, i Grausoni, i Marion, i Rosso, i Tonoligo e i Vidal, avevano fatto parte della nobiltà fondatrice del comune. La loro presenza, così profondamente radicata nella più venerabile tradizione politica, contribuiva a dare validità storica alla costituzione della Serrata, in quanto mantennero un'attiva preminenza anche successivamente, fornendo non soltanto funzionari di medio rango, ma anche personaggi capaci di occupare le massime cariche di governo anche nei decenni dopo il 1300.
L'esempio più significativo è quello degli Steno, che vantarono tra i loro esponenti politicamente attivi un Giovanni, ambasciatore nel 1349 e 1350 presso il papa e i re di Ungheria e d'Aragona, membro del consiglio ducale nel 1350 e del senato nel 1351-1352; e un Nicolò, consigliere ducale nel 1362 e nel 1365, e senatore nel 1363-1364 (78). Il più noto di loro fu il doge Michele Steno, alla cui morte nel 1413 la casata si estinse con tutti gli onori. A parte il dogado, la preminenza politica degli Steno non fu certo un'eccezione tra le famiglie che si sarebbero estinte nel primo Quattrocento: a fianco di Nicolò Steno nel senato del 1363-1364 sedevano, ad esempio, Marco Vioni, Donato Stanier, Marco e Nicolò Romano e Donato Mengolo (79); tra i senatori colleghi di Giovanni Steno nel 1351-1352 c'erano esponenti di quattro altre casate destinate presto all'estinzione: Giovanni Babilonio, Marco Caroso, Giovan Nicolò Rosso e Marco Barison (80). Alcuni di questi personaggi occupavano posizioni di eccezionale rilievo: Nicolò Romano, ad esempio, lasciò il posto in senato quando fu eletto a far parte dell'organismo responsabile della sicurezza interna, il consiglio dei dieci, nel 1363-1364; Nicolò Bolpe (Volpe) e Stefano Marion, membri del potente consiglio dei venticinque savi incaricato di coordinare la guerra con Genova nel 1351, erano stati entrambi tra i sei membri del consiglio ducale nel 1350, e Marion era stato consigliere ducale anche nel 1349 (81).
Detentori delle massime cariche di governo, questi personaggi incarnavano entrambi gli elementi dello statuto nobiliare fissati dalla Serrata: un profondo radicamento nel passato di Venezia e la capacità, fondata sull'esperienza, di prendere parte al governo della Repubblica. La loro scomparsa dalla scena, ignorata dagli avogadori nel registro 162 della Barbarella, creò dunque dei vuoti nella cultura storica, oltre che nelle risorse umane della classe di governo. Il modo in cui si pose rimedio a questo dato di fatto fornisce preziose indicazioni sulla flessibilità del regime successivo alla Serrata, in quanto i posti di governo lasciati vacanti dalle famiglie estinte potevano essere occupati da nuove reclute: e così fu. Pur trattandosi di deroghe al principio fissato nell'esperienza precedente la Serrata, i rimpiazzi si verificarono comunque, come abbiamo già visto nel caso della famiglia dalle Boccole: un gruppo di nuovi arrivati, non presenti nella nobiltà prima della Serrata, si andò affermando tanto da prendere posto nella classe dominante.
È questa la terza categoria di esponenti documentati della nobiltà trecentesca (si veda Tab. 1-C). Il gruppo è costituito da quarantotto famiglie, sette delle quali vengono però identificate come nobili soltanto in fonti non ufficiali (82); i documenti ufficiali attestano che esponenti di non meno di trentuno di esse occuparono incarichi di governo nel corso del secolo XIV, e sebbene alcuni, come i dalle Boccole, si contentassero di cariche di secondo piano (stando quantomeno alle fonti esistenti), altri furono elevati a posizioni di cospicua responsabilità.
La casata che si pose in evidenza di gran lunga maggiore fu quella dei Lion, una delle famiglie fuggite dalla Siria dopo la caduta di Acri, che si vide riconosciuto il rango nobiliare nel 1303 (83). A metà Trecento i Lion erano penetrati in forze ai massimi livelli del governo, e ben tre di loro furono eletti in senato nella medesima tornata: Nicolò, Luca e Domenico Lion furono senatori nel 1349-1350; Luca e Domenico furono rieletti nel 1350-1351, insieme con Marino Lion, mentre Nicolò passava a far parte dei venticinque savi del consiglio di guerra provvisorio; poi, nel 1351-1352, fu rieletto in senato, insieme con Domenico e Marino. Nicolò, che risulta dunque tra gli uomini politici più influenti di quegli anni, avrebbe ben presto svolto un ruolo di primo piano nella reazione del governo alla congiura del doge Marino Falier nel 1355, ruolo che gli avrebbe guadagnato l'elezione a procuratore di San Marco (84).
Tutti i Lion di cui abbiamo fatto i nomi furono comunque personaggi di rilievo, che in quegli anni fecero parte anche del consiglio ducale e di quello dei dieci; dalle loro carriere risulta evidente che nonostante la nobilitazione recente la loro casata aveva conquistato una grande influenza politica (85). In questo i Lion furono un'eccezione, ma anche esponenti di altre famiglie nuove della nobiltà compaiono in posizioni politicamente importanti alla metà del secolo. Nel senato degli anni Cinquanta, ad esempio, accanto ai tre Lion sedevano Pantalon Ghezzo, Francesco Surian (un'altra famiglia acritana) e Giovanni e Nicolò Pollini; negli anni Sessanta furono senatori Nicolò Boninsegna, Marco da Mare e Lorenzo Lanzuol (86). Partecipi di deliberazioni di importanza vitale per la vita della Repubblica nell'ambito di un consesso dotato di grande prestigio, oltre che di potere, questi uomini erano la prova della rapida ascesa delle rispettive famiglie all'appartenenza a pieno titolo alla classe dominante.
L'affermazione delle nuove casate sta ad indicare un'apertura del regime che contraddice la concezione della Serrata come battuta d'arresto della mobilità sociopolitica a Venezia. Molti dei nuovi arrivati non ottennero mai i riconoscimenti e la potenza dei senatori di cui si è appena detto, ma anche chi occupava una carica minore deve essere considerato nobile in quanto partecipe dell'attività di governo. E questo vale anche nel caso di una famiglia come gli Arian, che a quanto risulta appartenne alla nobiltà per un periodo brevissimo. È una famiglia che compare spesso, nella letteratura sull'argomento, come esempio del risentimento del ceto popolano per l'esclusione dalla nobiltà al tempo della Serrata; e anzi, un certo Antonio Arian ne fu tanto risentito che nel suo testamento del 1361 proibì alle figlie di sposare uomini appartenenti alle famiglie nobiliari (87). Eppure, soltanto due anni dopo, nel 1363, un altro Arian, Nicolò, fu eletto all'ufficio di supervisore dei dazi sul vino (88).
Il fatto che, due anni dopo il rabbioso divieto fulminato da un Arian a ogni rapporto matrimoniale coi nobili, un altro Arian occupasse una carica riservata ai nobili a fianco degli esponenti delle più antiche famiglie del ceto governante veneziano, ci mette in guardia circa un aspetto importante della nobilitazione nel Trecento: a entrare a far parte della classe dominante erano i singoli individui, non intere famiglie o lignaggi, ed è probabile che proprio nell'incertezza biologica che accompagnava queste nobilitazioni individuali risiedesse la spiegazione dell'effimera presenza degli Arian. Altrettanto brevi furono le carriere nobiliari dei Balestrieri, dei Goso, dei de Malis: ciascuna di queste famiglie ebbe incarichi di governo alla metà del Trecento, nessuna di esse compare nei documenti ufficiali prima della Serrata, nessuna sopravvisse a quel secolo, e soltanto per i Balestrieri l'ingresso nella nobiltà risulta attestato (89).
Queste fugaci apparizioni si aggiungono, da un lato, alle frequenti estinzioni nel corso del Trecento di famiglie risalenti ai primi secoli della Repubblica, dall'altro all'affermazione di nuove casate capaci di imporsi saldamente nel novero delle famiglie nobili, per delineare il quadro di una classe dominante in costante evoluzione per tutto il secolo successivo alla Serrata. La documentazione è confusa e disomogenea, con gravi lacune persino per quanto riguarda i detentori degli uffici supremi dello stato, e dunque qualsiasi tentativo di ricostruzione di quella classe non può che essere approssimativo; è comunque possibile, utilizzando le fonti esistenti, sommare le tre categorie di cui si è detto per arrivare a un totale di duecentoquarantasette casate, grandi o piccole, antiche o recenti, potenti o modeste, presenti in modo stabile o soltanto effimero nella cerchia della nobiltà, che in un modo o nell'altro appartennero alla classe di governo nel secolo XIV. Una nobiltà in costante evoluzione che ebbe un centro ampio e stabile nelle centotrentacinque casate che protrassero la propria esperienza di governo dal periodo precedente la Serrata fino a tutto il Trecento, e a buona parte del Quattrocento: sono i nomi dal suono più familiare nella storia politica ed economica di Venezia nel tardo Medioevo, per la loro preminenza, per le dimensioni delle famiglie, ma anche per la presenza costante nello scorrere dei decenni e dei secoli.
Come abbiamo già visto, però, è sbagliato far coincidere questi centotrentacinque cognomi - mera spina dorsale, per quanto estesa, della nobiltà - con la classe nel suo insieme. Accanto ad essi sedevano, negli uffici più modesti come nei consigli supremi del governo, gli esponenti di altre centododici casate, provenienti da origini e precedenti assai diversificati. Sessantaquattro di queste, presenti nell'apparato di governo prima della Serrata - in qualche caso anche per parecchi secoli - erano destinate a sparire con il primo Quattrocento, lasciando un vuoto rilevante nelle file della classe dominante, vuoto che fu colmato da quarantotto altre famiglie nuove, che in molti casi riuscirono ad inserirsi rapidamente nelle più delicate cariche di governo. Alcune di queste casate più recenti, che contavano pochi maschi adulti essendo state cooptate per i meriti individuali di alcuni loro esponenti, non sarebbero sopravvissute per più di una generazione; nel tardo Quattrocento si sarebbero estinti anche i dalle Boccole.
Anche i brevi momenti di gloria di queste famiglie più sfortunate fanno però parte dell'esperienza delle duecentoquarantasette casate che costituirono la nobiltà nel secolo XIV. Riducendo il tutto a percentuali approssimative, dello statuto nobiliare godettero per l'intero periodo che va dagli anni precedenti la Serrata al Quattrocento avanzato poco più della metà (55%) di tutte le casate ricostruibili, cioè le centotrentacinque famiglie che costituivano il nucleo forte e stabile della nobiltà. Un altro quarto abbondante (26%) della nobiltà trecentesca, radicato nel passato precedente la Serrata, si sarebbe estinto con il primo Quattrocento. Il quinto rimanente era costituito dalle famiglie che ebbero accesso per la prima volta all'attività di governo negli anni dopo la Serrata. Questo processo in cui le nuove affermazioni compensavano in pratica le estinzioni consentì alla nobiltà, novella araba fenice, di conservare tutta, o quasi, la sua forza numerica nel corso del Trecento: la permeabilità delle barriere consentiva agli uomini nuovi di colmare i posti rimasti vuoti.
Le dimensioni della classe rimasero dunque molto costanti, sia per quanto riguarda il nucleo più permanente che per quella parte della nobiltà la cui presenza risulta meno nettamente definita: le due configurazioni della classe di governo che abbiamo riscontrato nel registro 162 della Barbarella, in avogaria di comun, sono infatti individuabili per tutto il corso del Trecento. In un qualsiasi momento dato nel lungo periodo che va dal tardo secolo XIII agli inizi del XV circa centosessanta-centosettanta casate fecero parte del governo, e dunque possono essere considerate operativamente, ufficialmente, nobili. Abbiamo detto che nei quattro anni che portarono alla Serrata centosessantasei famiglie furono presenti in maggior consiglio; alcune di esse si estinsero in quegli stessi anni, ma furono sostituite da altre, altrettanto qualificate da un'esperienza di governo nei decenni precedenti. Il numero rimase costante fino agli anni centrali del Trecento: nei primi anni Cinquanta le casate presenti nelle cariche di governo erano centocinquantacinque, centosessantadue negli anni Sessanta (90); negli anni Ottanta gli incarichi erano distribuiti tra gli esponenti di centocinquantasette famiglie (91), mentre dal registro 162 degli avogadori risulta che le famiglie visibilmente attive nella vita politica della nobiltà del Quattrocento erano centosessantaquattro.
A tanta costanza nelle dimensioni numeriche della nobiltà politicamente attiva non corrispose però un'analoga continuità di composizione. Delle centosessantadue casate che parteciparono al governo negli anni Sessanta del Trecento, sedici non comparivano tra le centocinquantanove famiglie che occupavano cariche negli anni Cinquanta. Ma vale anche il criterio opposto: quattordici delle famiglie presenti negli anni Cinquanta non compaiono negli elenchi delle cariche negli anni Sessanta. Un processo di rinnovamento analogo si verificò anche vent'anni dopo: tra i funzionari in attività negli anni Ottanta compaiono personaggi di quattordici casate assenti in entrambi gli elenchi precedenti; a mo' di compensazione però, verrebbe da dire, trentadue famiglie che avevano partecipato al governo negli anni Cinquanta o Sessanta (comprese le quattordici presenti in entrambi i decenni precedenti) non figurano tra i detentori di incarichi negli anni Ottanta. In una prospettiva più ampia, che comprende l'intero periodo tra il tardo secolo XIII e gli inizi del XV, ventinove casate politicamente attive nel Quattrocento, poco meno di un quinto delle centosessantaquattro sicuramente documentate in quegli anni (cioè le centosessantatré famiglie presenti nel registro 162 dell'avogaria, più i Lombardo) erano entrate a far parte della nobiltà dopo la Serrata. Nella prospettiva inversa, quarantatré delle centosessantasei famiglie presenti in maggior consiglio nell'ultimo decennio del Duecento risultano scomparse con il primo Quattrocento (lo scarto tra i risultati delle due prospettive è dovuto alla presenza nella nobiltà quattrocentesca di famiglie assenti dal maggior consiglio negli anni Novanta del Duecento, ma che ne avevano fatto parte nei tre decenni precedenti). Dal confronto di questi dati risulta l'immagine di una nobiltà i cui quadri di governo subivano costanti modificazioni, ma che in ogni momento fu in grado di schierare un fronte attivo costituito suppergiù da centosessanta casate.
È però importante sottolineare che quest'ultimo dato si riferisce soltanto al settore della nobiltà presente nell'attività politica in un qualsiasi momento dato. Poiché il governo non si curò di documentare l'intera compagine della nobiltà, attiva o inattiva che fosse, fino alla stesura del registro 162 dell'avogaria, l'unico modo sicuro per accertare se una famiglia veniva considerata nobile nel Trecento consiste nell'identificare, attraverso gli elenchi ufficiali degli incarichi, i suoi esponenti che occupavano posizioni di governo (e nemmeno questo criterio, come vedremo più avanti, è privo di incertezze). Guardare esclusivamente alla costituzione del governo significa però ignorare la più vasta configurazione della nobiltà: dato il costante movimento di tante famiglie che entrarono e uscirono dai ranghi delle magistrature di governo tra gli anni Cinquanta e Ottanta del Trecento, è evidente che in un qualsiasi momento dato il nucleo centrale dei nobili in carica fu circondato da una riserva periferica di famiglie i cui esponenti potevano ora far parte del governo, ora esserne escluse - e alcune ne rimasero forse escluse per tutto il secolo.
Può darsi naturalmente il caso che l'assenza di molte delle casate di questa riserva periferica dagli incarichi di governo in un periodo o nell'altro fosse dovuta al fatto che esse non facessero in quel momento parte della nobiltà, che fossero cioè queste famiglie le protagoniste dirette del processo di cambiamento di composizione della classe che attraversò l'intero secolo. Per fare un esempio, nove delle quattordici casate nuove degli anni Ottanta appartenevano al gruppo di trenta casate nobilitate nel 1381 per il contributo dato alla difesa di Venezia nella recente guerra di Chioggia (92): il cambiamento, cioè, come rinnovamento. Vi furono però anche famiglie che parteciparono all'attività politica per buona parte del Trecento, ma si estinsero prima della fine del secolo: i Babilonio, ad esempio, che ebbero incarichi negli anni Cinquanta e Sessanta, e si estinsero negli anni Settanta; i Marangon, anch'essi attivi alla metà del secolo, estinti nel 1376; i Tomado, presenti nel governo negli anni Cinquanta e Sessanta, e scomparsi nel 1383; o i Vendelino, estinti negli anni Sessanta dopo aver fatto attività politica in quello stesso decennio (93). In questi casi, il cambiamento si manifestò come scomparsa.
Come qualsiasi altro gruppo sociale in un arco lungo di tempo, la classe dominante veneziana attraversò nel Trecento un cambiamento demografico, non tanto profondo da trasformarne i lineamenti generali, ma abbastanza da mettere in discussione l'idea che la Serrata avesse fissato in modo permanente l'identità collettiva della nobiltà. In quale modo questi cambiamenti furono assimilati, o provocati, è questione che tocca il cuore stesso della cultura del regime, poiché chiama in causa la coscienza che la nobiltà aveva di sé, e il suo rapporto con il resto della popolazione. La chiave di comprensione di questi cambiamenti, e della cultura aristocratica che li determinò, sta in un altro genere di distinzioni e rapporti interni alla nobiltà trecentesca. In assenza infatti di procedure regolamentate per definire e documentare i requisiti della nobiltà, la sua identità e le distinzioni che la determinavano venivano articolate con mezzi diversi da quelli ufficiali. Primi fra questi, l'influenza politica e la preminenza socioculturale. Ci occuperemo dunque, a questo punto, del modo in cui, in un contesto di indeterminatezza amministrativa, le distinzioni interne alla nobiltà ne condizionarono la collocazione nell'ambito della società veneziana.
La cerchia ristretta della nobiltà
I cambiamenti nella composizione della nobiltà nel corso del secolo XIV, e il contrasto tra un nutrito gruppo di famiglie costantemente presenti nell'attività di governo e una periferia fluttuante nella sua partecipazione alle cariche, rivelano un regime dalla doppia faccia: un corpo principale, le casate meglio note, che lasciò una traccia permanente negli autori di epoca successiva, e una componente meno appariscente, che spesso sfuggì alla loro attenzione. Il rapporto tra i due elementi è una fondamentale costante nella storia sociale di Venezia nel secolo XIV: le differenze all'interno della nobiltà sono la dinamica che dipana il racconto di quella storia. Differenze, peraltro, che non si limitano a quelle tra le casate presenti dal secolo XIII fino al XV e quelle che invece comparvero per la prima volta, o si estinsero, nel corso di quel periodo, e nemmeno a quelle tra chi partecipava d'abitudine al governo e chi vi entrava solo occasionalmente: un'ulteriore suddivisione, in cui interagivano fattori storico-culturali e politici, ebbe importanza critica nell'evoluzione della nobiltà nel Trecento.
La Cronaca trecentesca anonima della Biblioteca Marciana, un tempo attribuita a Piero Giustinian, rivela la natura di quella divisione (94). La Cronaca "pseudo-Giustinian", redatta negli anni Cinquanta, comprende una lista descrittiva dei Proles nobilium venetorum, che può essere letta come un'istantanea bene informata della storia e della composizione della nobiltà alla metà del secolo. Proponendosi, a quanto risulta, come una rassegna completa del passato e del presente della nobiltà, la lista fa il nome di casate da tempo estinte, oltre che di quelle più nuove; e il modo ben diverso in cui vengono presentate le diverse categorie pone perfettamente in luce il peso schiacciante della distinzione data dall'antichità.
Il corpo principale dei Proles nobilium è dato dai resoconti delle origini e delle gesta delle casate più antiche e prestigiose, con cenni assai più brevi sulle origini della maggioranza delle altre. Si conclude con un elenco dei "duodecim nobiliorum proles Venetiarum", che in realtà comprende tredici cognomi: Badoer, Sanudo, Michiel, Polani, Giustinian, Baseggio (o Basilio), Falier, Morosini, Contarini, Corner, Dandolo, Gradenigo e Dolfin (secondo il cronista, le ultime due avrebbero costituito in origine una famiglia unica). A questi seguono immediatamente altri dodici cognomi "que in nobilitate secuntur stirpes XII superius memoratas": Ziani, Zorzi, Zane, Bembo, Zeno, Querini, Barozzi, Memmo, Bellegno, Gauli, Tiepolo e Soranzo (95). Eccettuando i Gauli, assenti nei documenti ufficiali sia nel secolo XIII che nel XIV, tutte queste casate occuparono incarichi di governo nel Trecento; e, con l'ulteriore eccezione degli Ziani, tutte sopravvissero fino al secolo XV (96).
Con due sostituzioni (i Bragadin in luogo dei Bellegno e i Salamon in luogo degli Ziani) queste ventiquattro casate coincidono con le cosiddette "case vecchie" (i "longhi", come sarebbero poi state soprannominate) che nel Quattrocento avrebbero ingaggiato una lunga contesa con sedici casate più recenti, le "case ducali", o "curti", per il controllo del trono dogale (97). L'immenso prestigio di cui godevano le "case vecchie" dopo la Serrata risalta vividamente nei Proles nobilium. I lettori contemporanei della Cronaca non venivano soltanto invitati a ricordare nei termini più espliciti che queste erano le casate principali di Venezia, ma venivano anche intrattenuti con dettagliati racconti delle loro origini e dei loro precedenti tra i tribuni nobili ("tribuni anteriores", o "tribuni nobiles") che avevano guidato l'insediamento originario a Rialto, la cui preminenza era elemento imprescindibile delle successive glorie di Venezia. Per i Morosini, ad esempio, ci si sofferma a lungo sulla loro origine nella fusione di due antichi clans nobiliari, uno di Mantova, l'altro della Slavonia, che erano stati tra i fondatori della comunità veneziana. Si continua poi elencando le chiese edificate dai Morosini a Venezia e la gloria militare di cui si erano coperti nel corso dei secoli: emblemi di tanti trionfi erano le quattro diverse divise di cui il clan si gloriava (illustrate nel manoscritto), una delle quali acquisita nel recentissimo 1346. Altrettanto encomiastico è il racconto delle origini dei Gradenigo e dei Dolfin, fatte puntigliosamente risalire a uno dei clans nobiliari di Aquileia, quello di un certo Gardocus, fondatore della città di Grado - di qui il cognome Gradenigo; a Venezia si attribuiva ai Gradenigo l'edificazione della chiesa dei Santi Apostoli. Si dice poi che nel 1040 un ramo dei Gradenigo si staccò dalla linea principale, assumendo il cognome Dolfin ("cha Delphyno"), sicché, conclude il cronista, tra Gradenigo e Dolfin non c'è differenza sostanziale (98).
Per quanto fantasiose, queste ricostruzioni servivano a sottolineare la comune antichità, nobiltà e storica preminenza delle casate più antiche nella classe dominante, a partire dal loro contributo alla fondazione della comunità veneziana. Il dettagliato resoconto delle loro origini e gesta è in netto contrasto con i laconici riferimenti della Cronaca alle case più nuove, persino a quelle che a metà Trecento si erano già affermate come presenze politiche formidabili. Dei dalle Boccole, che come abbiamo visto furono una modesta aggiunta alla nobiltà del dopo-Serrata, si fa soltanto il nome, senza alcun cenno alle loro origini. E sono molte altre le case indicate senza ulteriori informazioni: citazioni che appaiono tanto più frettolose in quanto vengono dopo gli articolati racconti delle leggende che ammantavano le casate "più nobili".
È particolarmente significativa la bruschezza riservata alle sedici cosiddette "case ducali", i "curti": se era prevedibile che nessuno dei "curti" venisse compreso tra le venticinque casate "più nobili", lo è meno la loro relegazione in posizioni marginali, e meno ancora lo è il conferimento di attributi che, a confronto con quanto si dice delle case "più nobili", possono essere definiti quasi sprezzanti. Solo tre di esse, Barbarigo, Marcello e Moro, vengono contate tra i "tribuni" fondatori di Rialto (99); altre sette - Foscari, Gritti, Malipiero, Priuli, Trevisan, Tron e Venier - vengono identificate non, come le "case vecchie" e parecchie altre, tra i "tribuni" o "cives nobiles" provenienti da specifici insediamenti paleoveneziani intorno alla laguna, ma semplicemente come "cives, qui de multis et diversis partibus secederunt et in Rivo-alto venerunt ad habitandum" (100). Quanto alle altre sei "case ducali", i Donà, i Grimani e i Lando vengono soltanto nominati, senza specificarne le origini; dei Loredan, anch'essi di origine non precisata, si dice che furono ammessi in maggior consiglio soltanto durante il dogado di Ranieri Zeno (1253-1268), i Mocenigo non compaiono nemmeno; e i Vendramin sarebbero entrati a far parte della nobiltà soltanto nel 1381 (101).
I Proles nobilium costituiscono un'eloquente testimonianza del prestigio signorile che separava alcuni dei più antichi clans nobiliari di Venezia - il 10% più esclusivo - dalla massa delle duecentoquarantasette casate che costituivano la nobiltà dopo la Serrata: li separava non soltanto dalle famiglie periferiche, la cui partecipazione al governo era sporadica e la cui nobiltà era incerta, ma anche da altre casate eminenti e politicamente forti di origine relativamente più recente. È possibile che gli attributi leggendari conferiti ai venticinque cognomi "più nobili" da questa Cronaca trecentesca fossero luoghi comuni tradizionali, riflessi di atteggiamenti duecenteschi nei confronti della nobiltà (102), ma i clans le cui gesta già allora si consideravano degne di essere narrate non erano mere entità leggendarie: avevano ancora un peso politico reale, la cui imponenza non aveva nulla da invidiare alla loro celebrità culturale. Grazie alle assidue ricerche di Gerhard Rösch siamo in grado di valutare la loro posizione nel mondo politico veneziano prima della Serrata attingendo a quanto ci è conservato dei documenti del minor consiglio, i sei consiglieri ducali, che coprono buona parte degli anni compresi tra il 1204 e il 1297 (103). Per citare Giuseppe Maranini, questo consiglio, che doveva assistere e controllare il doge, stava "al vertice dell'edificio costituzionale". Chi vi sedeva costituiva dunque una cerchia elitaria all'interno della classe di governo che, come abbiamo già osservato nel paragrafo precedente, comprendeva nell'accezione più vasta tutte le duecentoquarantasette famiglie rappresentate in maggior consiglio nel periodo 1260-1300 (104). Poiché la presenza in consiglio ducale fornisce quindi un'attendibile indicazione delle famiglie dominanti nel Duecento, essa costituisce un'ottima traccia per valutare la continuità della classe nobiliare e del governo prima e dopo la Serrata.
I registri esistenti identificano trecentosedici consiglieri ducali nel lungo periodo compreso tra il 1204 e il 1297, appartenenti a settantacinque casate diverse (105) (si veda la Tab. 2-A). Sebbene tutte queste settantacinque casate debbano essere contate ipso facto nel nucleo più importante del gruppo egemone, il loro peso relativo era tutt'altro che omogeneo, poiché al loro interno si distinguevano cerchie sempre più ristrette di potere. Ventuno casate, ben meno di un terzo, fornirono più di due terzi (duecentododici, il 67%) dei consiglieri documentati: nel loro insieme possono essere considerate come l'élite dominante di Venezia prima della Serrata. Più schiacciante ancora fu però il predominio di una cerchia ancor più stretta di undici clans (14,6%), che monopolizzò centotrentasette nomine, quasi la metà (43%) dei membri del consiglio.
Se vi fu un'oligarchia elettiva nel Duecento, essa coincise con queste undici casate, il nucleo portante di un gruppo che di per sé costituiva un'élite all'interno della classe di governo. Non sorprende dunque trovare otto di questi undici cognomi - Morosini, Querini, Zeno, Dandolo, Gradenigo, Giustinian, Michiel e Falier - tra le "case vecchie" celebrate come "più nobili" nei Proles nobilium della Cronaca "pseudo-Giustinian" (106). Né lo scoprire che dei dieci nomi successivi, che completano la cerchia esclusiva dei ventuno clans rappresentati più di frequente, sette compaiono tra i "più nobili": Badoer, Baseggio, Bellegno, Contarini, Soranzo, Corner e Dolfin (107). Tra le famiglie "più nobili" gli Zorzi, i Polani e i Tiepolo compaiono nella decina successiva di famiglie più attive (108), e altre quattro casate furono rappresentate in consiglio, sia pure soltanto una o due volte:
gli Zane, i Barozzi, i Sanudo e gli Ziani. Riassumendo, ventidue delle venticinque casate identificate nei Proles nobilium come le più nobili e antiche nella Venezia del Trecento (e diciannove dei clans che sarebbero stati definiti "case vecchie" nel Quattrocento) comparivano tra le settantacinque famiglie presenti in consiglio ducale nel Duecento(109).
Sono però soprattutto le ventuno casate che ottennero due terzi dei posti in consiglio ducale a costituire l'elemento strutturalmente dominante del governo prima della Serrata. Sono i cognomi che echeggiano più familiari nella storia di Venezia nel tardo Medioevo, onnipresenti protagonisti delle sue vicende principali, personaggi emblematici evocati dagli storici nella ricostruzione degli eventi e delle tendenze che la contraddistinsero - così prima come dopo la Serrata. La loro preminenza nel governo non terminò infatti con il Duecento: la conservavano sostanzialmente intatta al tempo della redazione dei Proles nobilium a metà Trecento. Quanto fosse salda la loro presa sul potere risulta evidente da un confronto tra i consiglieri ducali prima della Serrata e le casate che dominarono i maggiori consigli di governo negli anni Cinquanta e Sessanta del Trecento: di nuovo il consiglio ducale, ma anche il senato, il consiglio dei dieci e la quarantia - per gli anni 1349-1352 e 1362-1365 oltre al consiglio d'emergenza dei savi eletti nel 1351-1352 per coordinare la terza guerra con i Genovesi (110). Il numero delle casate presenti in questi organismi è doppio rispetto a quelle nel consiglio ducale prima della Serrata, centocinquantatré contro settantacinque, ma la tendenza alla concentrazione si manifesta nello stesso modo alla metà del Trecento come nel Duecento: su un totale di millesettecentodue posti assegnati in questi potenti consigli negli anni presi in considerazione, quasi due terzi, millecentoventinove (66,3%) andarono a quarantatré soltanto (28%) dei centocinquantatré clans. E proprio come nel secolo precedente, il peso politico maggiore era concentrato in un nucleo più piccolo di quattordici casate, un mero 9,2%, che tenne non meno di un terzo degli incarichi: cinquecentosettantadue.
A metà Trecento l'élite era costituita in larga misura dalle stesse famiglie che avevano dominato il consiglio ducale prima della Serrata (si veda la Tab. 2-B). Dei quattordici clans che costituivano la cerchia di governo più esclusiva nel Trecento, dieci erano stati tra le ventuno casate che ebbero il maggior numero di consiglieri ducali nel secolo precedente e cinque erano tra le undici case che avevano costituito il nucleo interno del consiglio ducale (111). La stessa continuità si manifesta nella prospettiva opposta: diciassette dei ventuno clans più presenti in consiglio ducale nel secolo XIII rimasero ai vertici del governo, comparendo tra le quarantatré case che controllavano i due terzi dei seggi nei consigli più importanti a metà Trecento.
Il controllo costante sugli organi più autorevoli del governo era l'espressione concreta della continuità di un predominio che risaliva ad ancor prima del secolo XIII, al passato mitico di Venezia. Così come prima della Serrata, erano ancora le antiche casate "più nobili" elencate nella Cronaca "pseudo-Giustinian" a dominare la classe di governo a metà Trecento. Dieci dei quattordici clans che ne costituivano la cerchia interna erano "case vecchie" presenti anche nella lista del cronista: Contarini, Morosini, Soranzo, Dandolo, Giustinian, Corner, Dolfin, Querini, Zorzi e Michiel; e potremmo aggiungerne un'undicesima, i Bragadin, assenti dal consiglio ducale nel Duecento, ma che nel Quattrocento sarebbero stati considerati tra le "case vecchie". Altre undici famiglie "più nobili", tutte "case vecchie", appartenevano poi alla seconda cerchia di ventinove casate che, insieme con le quattordici del nucleo centrale, costituivano il gruppo di quarantatré clans che controllavano i consigli più importanti negli anni Cinquanta e Sessanta del Trecento (112). In definitiva, dunque, ventidue degli antichi clans riconosciuti come costruttori e simboli del passato storico e leggendario di Venezia perpetuarono la propria preminenza di esponenti dell'élite di governo fino a metà Trecento (113).
Vi furono senza dubbio cambiamenti, tra il secolo XIV e la metà del XV. I Navazoso (o Navagaioso), che con sei consiglieri ducali erano stati tra le ventidue famiglie più attive in quel consiglio, a metà Trecento erano estinti, e come loro altre undici casate di quella cerchia (114); altri, pur continuando a occupare incarichi di rilievo, videro assottigliarsi le proprie fila nel passaggio da un secolo al successivo (115). Nell'insieme, comunque, la continuità da un secolo all'altro fu assai marcata, soprattutto ai massimi livelli dell'attività politica. I Morosini, tra i quali si contava il maggior numero di consiglieri ducali, diciannove, furono secondi soltanto ai Contarini quanto a presenze nelle cariche più importanti negli anni Cinquanta e Sessanta del Trecento; i Querini, secondi dopo i Morosini con diciotto consiglieri ducali, erano al decimo posto nel secolo successivo; i Dandolo, al quinto posto nel Duecento come nel Trecento; e i Giustinian, i Michiel e i Falier, tra le undici casate più rappresentate nel consiglio ducale, stavano al sesto, al dodicesimo e al quindicesimo posto rispettivamente nell'élite di governo a metà Trecento.
Al di là degli effetti della Serrata sulla struttura complessiva della nobiltà, nel suo centro politico e storico la preminenza collettiva delle case più antiche permaneva indiscussa mezzo secolo dopo. Dai ventiquattro clans "più nobili" ancora presenti a metà Trecento - con l'aggiunta dei Bragadin e dei Salamon - che saranno considerati "case vecchie" nel Quattrocento provenivano seicentonovantatré dei millesettecentodue uomini che occuparono importanti incarichi di governo negli anni Cinquanta e Sessanta del Trecento. In altre parole, per quanto quelle ventisei casate costituissero soltanto il 17% delle centocinquantatré famiglie rappresentate nei consigli, più del 40% dei consiglieri usciva dalle loro fila. Col nuovo lustro che veniva ai loro venerabili cognomi da una fervida cronachistica che raccontava il passato di Venezia con gli occhi bene aperti sugli interessi politici del Trecento, l'immancabile ubiquità delle casate più antiche ai posti di comando del governo rendeva inevitabile la loro autorità politica e culturale (116).
Non risulta che le grandi casate si presentassero come un blocco politico, e ancor meno che avessero eguali ricchezze, o interessi economici comuni: nelle questioni più importanti i loro nomi compaiono in tutti gli avversi schieramenti, come dimostrano le ricerche di Roberto Cessi sui conflitti politici alla metà del Trecento, e le rielaborazioni del lavoro di Cessi compiute da Giovanni Pillinini e Giorgio Cracco (117). La comunanza storico-culturale non impedì certo i conflitti interni per questioni private, così come sulle materie di interesse pubblico. E la cosa non può certo sorprendere: la ricchezza ammassata, e la mera esuberanza genealogica di casate come i Contarini, con cinquantasei maschi registrati nell'estimo fiscale del 1379, i Corner con ventisette, i Dolfin e i Giustinian con venticinque ciascuno, i Michiel con ventiquattro, e gli inevitabili Morosini con cinquanta, offrivano abbondanti occasioni di attrito, sia tra i clans che al loro interno (118).
Nondimeno, l'identità collettiva e l'intrico di relazioni che legava gli antichi clans, insieme con la loro imponente presenza numerica, attribuivano loro l'aura di nobiltà paradigmatica di Venezia, che la massiccia partecipazione ai consigli principali dello stato non faceva che enfatizzare. Mezzo secolo dopo la Serrata la preminenza nella cultura pubblica e il controllo del governo appartenevano ancora alle casate che da sempre tenevano in pugno le sorti della politica, dell'economia e della società di Venezia. Non sorprende dunque che i clans "più nobili", i cui nomi continuano ad affiorare negli archivi del governo - fonte principale degli storici -, influenzino tanto la nostra idea della nobiltà trecentesca nel suo insieme.
Senza dubbio essi esercitavano un'impressione altrettanto profonda sulla nobiltà minore. Possiamo bene immaginare, per esempio, cosa provò Pantalon Ghezzo, esponente di una famiglia entrata di recente nella nobiltà, quando fu eletto in senato nel 1350-1351. Di certo si sentì esaltato e insieme intimidito, e forse anche risentito, nel prender posto a fianco di colleghi quali Tomaso Zane; Giovanni Tiepolo; Piero e Marino Michiel; Lorenzo e Marco Polani; Giovanni e Nicolò Querini; Giovanni e Moretto Gradenigo; Andrea e Nicolò Zeno; Nicolò e Piero Falier; Marino e Piero Dolfin; Fantino, Marco e Simeone Dandolo; Marco, Franceschino e Lorenzo Soranzo; Giovanni, Bertuccio e Pangrazio Zorzi; Leonardo, Piero, Andrea e Giovanni Contarini; Micheletto, Francesco, Nicoletto e Albano Morosini (119).
Agli occhi di un parvenu come Ghezzo, questo battaglione di senatori appartenenti ai più antichi clans nobiliari, abituati da secoli di esperienza ancestrale a trattare i misteri dello stato, e rappresentati da due, tre o persino quattro uomini, non poteva non apparire schiacciante: per l'esperta disinvoltura con cui trattavano fra loro, per come si destreggiavano con le procedure senatoriali, e forse per la loro inconsapevole (o consapevole) arroganza. Sicuramente la trepidazione che egli poté provare all'idea di intervenire nel dibattito, o il senso di inferiorità che poteva venirgli dalla recente ascesa della sua famiglia nella nobiltà, erano compensati dalla soddisfazione di aver scalato le vette del prestigio legato all'ingresso in senato. Sul suo essere "nobilis vir" non potevano sussistere dubbi, ma egli non poteva dimenticare che la sua "nobilitas", come quella di tutti gli altri patrizi minori, era definita da criteri fissati dagli antichi clans i cui esponenti lo circondavano nella sala del senato - e al cui prestigio i Ghezzo e gli altri nuovi venuti non potevano nemmeno sperare di assurgere.
Se però il prestigio culturale era ancora monopolio delle "case vecchie", il loro predominio politico non era altrettanto assoluto. A metà Trecento i clans più antichi condividevano l'egemonia del governo con un gruppo di casate più recenti, anch'esse presenti nell'élite di quarantatré famiglie che controllavano le cariche di governo più importanti tra il 1350 e il 1370. Tredici di esse non contavano nemmeno una presenza nel consiglio ducale duecentesco, e altre nove, rappresentate nel consiglio una o due volte soltanto, non avevano fatto parte di quell'élite. È vero che cinque di queste ventidue casate (Bembo, Bragadin, Memmo, Sanudo, Zane) non erano nuove venute ma "case vecchie" con una modesta presenza politica nel Duecento, ma le diciassette che rimangono vanno sicuramente considerate come nuove sfidanti nella corsa per il potere (120). La loro ascesa fa capire che stavano verificandosi importanti cambiamenti, che distinguono gli anni centrali del Trecento dalla temperie politica prima della Serrata, e gettano il seme di tensioni che sarebbero maturate alla fine del secolo. Poiché ora condividevano il potere con gli antichi padroni della politica veneziana, la loro comparsa è anche il segno di un nuovo impulso alla cultura politica veneziana: il lustro dell'antichità non era più l'unico criterio determinante della preminenza politica.
L'esempio più spettacolare di questo cambiamento è dato dai Loredan, usciti dall'oscurità alla metà del Duecento per arrivare al sesto posto tra le famiglie più attive nei massimi consigli di governo nel 1350-1370 - al centro cioè delle quattordici famiglie che costituivano la cerchia interna di governo (121). E non era soltanto questione di numeri: in quegli anni almeno due Loredan furono procuratori di San Marco, Paolo "il grande" e Marco, un Giovanni Loredan "il grande" fu in consiglio dei dieci e in senato, e senatori furono anche diversi altri membri della famiglia. Nel 1350-1351 è possibile che Pantalon Ghezzo, vedendosi di fronte tanti esponenti delle "case vecchie", trovasse un qualche conforto riconoscendo tra i colleghi Zani e Francesco Loredan - due presenze che costituivano una rappresentanza insolitamente modesta per la casata, che nel 1349-1350 e nel 1351-1352 contò ben quattro senatori (122).
L'improvvisa ascesa dei Loredan nelle prime file della nobiltà di governo fu particolarmente spettacolare, ma anche altre casate assursero rapidamente alla preminenza politica tra gli anni della Serrata e la metà del Trecento. Nel paragrafo precedente abbiamo visto che i Lion, da poco arrivati da Acri negli anni Novanta del Duecento, divennero anch'essi personaggi di tutto rispetto nel nuovo secolo, inserendosi tra le venticinque casate più attive nei consigli di governo. La stessa impresa riuscì ai Barbaro, entrati per la prima volta nel governo soltanto negli anni Settanta del Duecento, e assenti dalle liste del consiglio ducale; ma nel 1350-1351 c'erano due Barbaro in senato, tre nel 1351-1352, e quando Giovanni Barbaro, membro dei dieci nel 1362-1363, divenne consigliere ducale nel 1363, Marco Barbaro lo sostituì nel consiglio dei dieci del biennio 1363-1364 (123). Anche i Priuli, al ventottesimo posto tra i detentori degli incarichi più importanti a metà Trecento, la cui presenza nel regime nobiliare dei secoli XV e XVI sarebbe stata massiccia, non compaiono sulla scena politica del Duecento (124). Non ci furono Priuli nel consiglio ducale prima della Serrata, ma negli anni Sessanta del Trecento Marco Priuli fu consigliere per tre volte consecutive, oltre a prendere posto in consiglio dei dieci e in senato. In quest'ultimo lo raggiunse nel 1350-1351 Jacopo Priuli, e dunque la famiglia entra a far parte a buon diritto del gruppo di "case nuove" la cui ripetuta presenza in quel consesso riusciva in parte a controbilanciare il predominio delle "case vecchie" (125).
Altri dei quarantatré clans che costituivano l'élite di governo a metà Trecento erano rimasti nell'ombra nel periodo precedente la Serrata. Come le famiglie appena menzionate, anche i dalla Fontana, i da Mosto, i Viadro, i Gritti e i Nani erano stati praticamente assenti dal consiglio ducale nel Duecento, per poi penetrare nel nucleo politicamente più attivo della nobiltà nel periodo 1350-1370. La presenza al governo di queste ed altre famiglie nuove sarebbe aumentata nei decenni a venire, proponendole come potenziale alternativa alle casate più antiche nel ruolo di forza politica determinante nel regime. L'impressione viene confermata dal fatto che otto di esse sarebbero poi state contate tra le sedici cosiddette "case ducali", che avrebbero escluso le "case vecchie" dal dogado - di fatto, lo avrebbero monopolizzato per duecentotrent'anni (126).
Le famiglie ducali non esauriscono affatto, però, l'elenco delle "case nuove" che si affermarono nel Trecento: i Barbaro, i Diedo, i dalla Fontana, i da Mosto, i Viadro e i Nani appartengono a pieno diritto alla categoria dei nuovi arrivati di maggior peso. Rimane però un certo numero di famiglie a ricordarci che queste ordinate classificazioni possono solo approssimarsi a quella che era una realtà sociale e politica estremamente complessa. I Venier, perché non sono contati tra le "case vecchie" o "più nobili", e perché nel 1382 Antonio Venier succedette a Michele Morosini, l'ultimo doge di "casa vecchia" nel secolo XIV, sono considerati una "casa ducale". Ma non sono certo dei nuovi arrivati, avendo fatto parte della classe di governo a partire quantomeno dal secolo XI; quanto alla loro presenza tra le sedici casate più attive nel consiglio ducale prima della Serrata, non è che un'indicazione del tutto inadeguata dell'articolata attività governativa dei Venier per tutto il Duecento (127).
Che i Venier fossero al terzo posto tra le famiglie più rappresentate ai massimi livelli di governo a metà Trecento è fatto che non va dunque considerato come una novità, bensì come il segno della fondamentale coerenza del regime nobiliare nel corso dei secoli. Lo stesso vale, sia pure a un livello più modesto, per i Foscarini. La Cronaca "pseudo-Giustinian" li classifica tra i "tribuni anteriores" e "cives nobili" insediatisi a Venezia nella stessa epoca dei clans nobiliari più venerandi, e negli anni del tramonto della Repubblica, nel secolo XVIII, seppero esprimere un doge, ma non venivano comunque contati né tra le "case vecchie" né tra quelle "ducali" (128). Eppure, con tre consiglieri ducali nel secolo XIII, erano tra i trentanove clans determinanti per quel consiglio, e conservarono tanta preminenza fino a metà Trecento, contendendo ai Gradenigo il diciottesimo posto tra le quarantatré casate che controllavano le cariche più importanti.
La costante presenza dei Foscarini e dei Venier al centro del governo, o nelle sue immediate vicinanze, sottolinea un radicato fattore di continuità nella classe di governo - indipendentemente da qualsiasi etichetta classificatoria - prima e dopo la Serrata. Rimane comunque indiscutibile il fatto che a metà Trecento queste e le altre casate da sempre attive nel governo lasciarono spazio, volenti o nolenti, a colleghi partiti da una posizione modesta, o addirittura dalla completa oscurità, nel periodo precedente la Serrata. Clans come quelli dei Loredan, dei Trevisan, dei Marcello, dei Barbaro e dei Lion - per fare soltanto i nomi che compaiono tra le venticinque casate presenti nel governo a metà Trecento che si erano affermate uscendo dalla relativa oscurità del periodo precedente la Serrata - rappresentavano un importante elemento di novità nel regime. La loro massiccia presenza nelle posizioni di maggiore autorità è un'evidente riprova del cambiamento sociopolitico avvenuto nel secolo XIV all'interno della struttura istituzionale delineata dalla Serrata.
Questo autorevole gruppo di nuove casate costituiva un'implicita sfida al secolare predominio degli antichi clans "più nobili", e a quell'insieme di antichità e esperienza di governo che da tanto tempo era il criterio di qualificazione per il potere politico a Venezia. L'improvvisa interruzione nel 1382 del quasi-monopolio delle "case vecchie" sul dogado può ben essere interpretata come un segnale esplicito di quella sfida che, sul piano simbolico quantomeno, si sarebbe rivelata vincente (129). Al di là delle loro rivalità politiche, le "case vecchie" e quelle da poco assurte al potere a metà Trecento condividevano comunque una preminenza politica che le distingueva entrambe dalla grande maggioranza delle famiglie nobiliari.
La cerchia allargata della nobiltà
Nell'evolversi della nobiltà trecentesca, il predominio politico fu esercitato da un nucleo costante di circa quarantatré famiglie. Al loro interno sussistevano sostanziali differenze sui piani dell'antichità e della preminenza storica, differenze che, in una società che derivava buona parte della propria sanzione morale e legale dalla sua lunga storia, comportavano un prestigio maggiore per le case più antiche e "più nobili" (130). Gli esponenti più antichi e quelli più nuovi di questo nucleo politico controllavano comunque i principali consigli, sicché per tutto il secolo furono la loro collaborazione e i loro conflitti a condizionare le vicende politiche e le istituzioni di governo: il che equivale a dire che il loro operato collettivo diede forma alla cultura politica del regime. Nel contempo, però, il prestigio che derivava alle casate più antiche dalla loro simbiosi con la "sacra" storia della città poneva il problema della preminenza "sociale" all'interno della classe dominante. Per quanto potenti, le "case nuove", come ad esempio i Loredan e i Mocenigo, non potevano certo gareggiare con le "case vecchie" sul piano dell'antichità. Di conseguenza non avrebbero mai potuto godere di un prestigio pari al loro potere politico - fino a quando la preminenza nobiliare fosse rimasta radicata nella storia e nel mito di Venezia. Per le "case nuove" più potenti, la parità di prestigio, e quindi di posizione sociale, con le "case vecchie" passava attraverso una rielaborazione della cultura nobiliare impostata su valori diversi da quelli che facevano pendere la bilancia dalla parte delle casate più antiche.
Nella misura in cui possiamo parlare di una cultura aristocratica a Venezia prima della Serrata - con tutte le implicazioni politiche e sociali del termine -, questa fu il frutto dell'interazione tra le casate dominanti. È importante tenerlo a mente, poiché in questi termini si pone nella giusta prospettiva l'idea della nobiltà che da allora prese il sopravvento. I nomi di quelle quarantatré famiglie, le più numerose e vistose, erano immancabilmente in primo piano nelle vicende politiche, economiche e sociali sulle quali si è concentrata da sempre la storiografia del Trecento veneziano; di conseguenza, esse occupano nel dibattito erudito lo stesso posto privilegiato che avevano occupato nel governo e nella società del loro tempo. E anzi, è spesso avvenuto che la loro identità e il loro modo di agire venissero fatti coincidere con l'identità e il modo di agire della classe dominante nel suo insieme.
Ma non erano soltanto loro, la nobiltà; la maggioranza delle famiglie nobili non disponeva infatti né della prestigiosa storia, né della costante influenza politica di quell'élite. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, il nucleo predominante di quarantatré casate era circondato da ottantaquattro case satelliti. Presenti in misura meno frequente nei massimi consigli dello stato, la loro costante partecipazione all'attività di governo le poneva saldamente nella posizione di corrente principale, di zoccolo duro della classe dominante (131) (si veda Tab. 2-C). Quando sarà possibile scrivere una storia sociopolitica adeguatamente documentata di Venezia nel Trecento, è probabile che la loro presenza costante e impegnata nel governo risulterà un elemento critico nella formulazione della politica e, in senso più profondo, nella formazione della cultura politica del regime dopo la Serrata. Dalle loro fila provenivano i sostenitori, gli alleati e
i clienti delle casate più potenti, "vecchie" o "nuove" che fossero. Assai diverse tra loro, si potevano considerare un corpo unitario ancor meno di quanto non lo fosse il nucleo dominante, e i loro raggruppamenti contribuivano, a volte in modo decisivo, al peso delle diverse istanze politiche, sostenendo gli interessi dell'una o dell'altra parte all'interno dell'élite di governo (132). Come gruppo avevano una lunga esperienza nel governo di Venezia: ben settantasei di queste famiglie erano rappresentate in maggior consiglio nel Duecento, e una settantasettesima, gli Honoradi, sebbene assente dal consiglio nel decennio precedente la Serrata aveva però partecipato al governo già nel secolo XII (133); ventotto di esse ebbero consiglieri ducali nel Duecento, alcune con una frequenza notevole (134). Fu proprio affermandosi come assidui protagonisti dell'attività di governo al fianco di questo nutrito corpo di casate più esperte che nuove reclute come gli Avonal, i dalle Boccole, i Ghezzo, i Lambardo, i Lanzuol e i Papacizza consolidarono la propria posizione all'interno del regime.
Ogni esame della nobiltà e della società veneziana deve tenere questa nutrita schiera di nobiltà minore nello stesso conto che riserva ai loro colleghi più prestigiosi: erano un gruppo destinato a durare, con solide radici nel passato. Quasi tutte le famiglie saranno ancora presenti nel secolo XV, quando la loro nobiltà - anche di quelle recentemente estinte - verrà attestata dagli avogadori di comun nel primo registro della Barbarella (135). Fu però la presenza costante negli incarichi di governo per tutto il Trecento a fornire una base concreta, documentatamente politica, alla loro rivendicazione di nobiltà. Insieme con il nucleo centrale costituivano la massa critica di circa centoventisette casate che conferì al regime della Serrata una consistenza fisica nei consigli e nelle cariche di governo, oltre che una più profonda sanzione culturale, ricollegando il passato remoto della leggenda e della storia con la struttura istituzionale e il potere politico del presente.
Ma nemmeno queste centoventisette casate esauriscono la classe di governo del Trecento. Intorno a loro aleggiavano altre categorie, la cerchia esterna della nobiltà, un margine vasto e irregolare che rende problematica qualsiasi generalizzazione sulla struttura e il comportamento della nobiltà trecentesca nel suo insieme. La più numerosa, e la più sicuramente nobile, di queste categorie è costituita da sessantasei casate che, seppure meno costantemente attive delle centoventisette di cui si è appena detto, occuparono nondimeno una posizione documentata nelle funzioni di governo del regime. Personaggi di queste case compaiono in uno o due dei registri trecenteschi del Segretario alle Voci (gli elenchi dei detentori di cariche), ma non, come invece le centoventisette casate maggiori, in tutti e tre (si veda Tab. 2-D).
In generale anche queste famiglie meno attive avevano affermato la propria identità politica prima della Serrata: quarantatré su sessantasei avevano fatto parte del governo nel secolo XIII. Al loro livello, più modesto, di partecipazione alle cariche erano dunque anch'esse testimonianze viventi della continuità del regime con il passato di Venezia. Diciannove casate presenti prima della Serrata avrebbero contribuito a prolungare quella continuità comparendo nei documenti ufficiali del Quattrocento e oltre: ad esempio gli Arimondo, i Basadonna, i Benedetto, i Caotorta, i Lombardo, gli Storlado, i Valier, gli Zancaruol. Altre ventiquattro casate con esperienza politica, tra le quali gli Amizo, i Babilonio, i Bonomo, i Leucari, i Marangon, i Savoner e i Vendelino fecero parte del governo sia prima che dopo la Serrata, ma nella fase finale della loro esistenza: con il primo Quattrocento si sarebbero estinte (136). Quasi a compensazione, però, le altre ventitré casate nobiliari politicamente meno attive nel Trecento erano appena comparse sulla scena. Con famiglie come gli Adoldo, i Dente, i Guoro, i Moio, i Pollini, i Renier e gli Zaccaria, questa categoria si affermò dopo la Serrata prendendo posto nella classe di governo, ma non ancora in modo abbastanza costante da poter rientrare nel novero delle centoventisette case più attive (137). I due ultimi sottogruppi rientrano nel margine demografico fluttuante della nobiltà di cui si parlava nel paragrafo 3: alcune famiglie andavano ad estinguersi, altre entravano in scena, ma insieme bastarono a mantenere grosso modo costante l'entità numerica della classe, che si evolveva, invece, quanto all'identità delle casate che la costituivano.
Una terza componente periferica della nobiltà era di tipo ancora diverso: impersonate nella nostra analisi - a titolo di esempio - da famiglie come i Balduin, ma anche gli Arian, gli Agrinal, i Balestrieri, i Goso e i de Malis, queste casate fecero soltanto sortite effimere e mal definite nell'orbita di governo della classe nobiliare. Tra le famiglie che ebbero parte nel governo di Venezia nel Trecento, la loro posizione è quella in più netto contrasto con la solida autorevolezza delle case antiche. Presenti come sono una volta soltanto negli elenchi ufficiali degli incarichi, abbiamo qualche esitazione nel considerare gli esponenti di questo gruppo come membri a pieno titolo dell'élite di governo veneziana. Manca quell'inconfondibile marchio di nobiltà che il seggio in senato conferiva, ad esempio, a Pantalon Ghezzo, e dunque la loro esistenza si svolgeva ai margini più sfumati e remoti della classe dominante. Eppure, per quanto fluide ed elusive, queste casate, insieme con quelle che si estinsero o che ascesero a far parte della classe dominante, vanno contate - sia pure con riserva - tra le componenti della nobiltà trecentesca.
Ma nemmeno questi nomi esauriscono la lista di nobili potenziali. Oltre alle casate rappresentate assai di rado nel governo, per tutto il secolo altre ancora ne esistevano ai margini estremi della nobiltà la cui partecipazione non è in alcun modo documentata. Una presenza del tutto anomala e poco chiara in una classe dominante dal carattere essenzialmente politico: erano davvero nobili, se non prendevano parte alcuna al governo? Era davvero certo il loro statuto, se non lo sottoposero mai a verifica per l'eleggibilità alle cariche o per l'accesso in maggior consiglio? Un certo numero di queste famiglie sarebbe comparso nel registro della Barbarella dell'avogaria di comun del primo Quattrocento. Alcuni, come i Griego e i Semitecolo, colsero l'occasione per arruolare i propri figli nella Barbarella, affermando nel Quattrocento uno statuto nobiliare che non risulta attestato nei documenti del secolo precedente che ci sono stati conservati. Altri, e in particolare gli Avenario, i Campanile, gli Esulo, i Franco, i Miolo, i Pantaleo e i Rampani, pur essendo inclusi nel registro 162, non uscirono nel secolo XV dall'oscurità che li aveva avvolti nel XIV, poiché non iscrissero figli alla Barbarella, né occuparono incarichi di governo: ma poiché gli avogadori di comun li avevano considerati nobili nel 1414, non possono essere esclusi dall'elenco completo della nobiltà trecentesca.
Esistono poi altre famiglie ancora la cui appartenenza silenziosa e inattiva alla nobiltà, pur non comparendo nelle fonti ufficiali, rimaneva però registrata nella memoria collettiva della classe alla fine del Quattrocento: ve ne sono molte, menzionate di sfuggita e spesso in modo confuso, nel corpus delle cronache nobiliari. Un esempio è quello dei Bedeloto, di cui Sanudo negli anni Novanta del Quattrocento e un cronista antiquario nel 1617 ci dicono che si estinsero già nel 1280, anche se - tanto per confondere gli storici - l'autore della seicentesca Cronaca di famiglie patrizie venete dichiara che vennero nobilitati con la Serrata (138). Non è affiorata alcuna documentazione ufficiale della loro nobiltà nel Trecento, ma i Bedeloto - come hanno dimostrato le ricerche di Dennis Romano - avevano rapporti matrimoniali, sociali ed economici con altre famiglie nobili (139). Un altro caso è quello dei Disenove, che Romano colloca all'interno del ricco "popolo grande" del Trecento, ma che la tradizione cronachistica registra come famiglia nobiliare estinta nel 1361; è probabile discendessero dall'antica famiglia Decem et Nove, attestata tra le maggiori casate di Venezia già nel secolo XI (140).
Molte altre famiglie come queste compaiono nelle cronache nobiliari redatte tra il secolo XVI e il XVIII, ed è possibile che la loro inclusione tra i nobili del Trecento stia ad indicare la persistenza, anche oltre il 1500, di alcune tracce di quel principio storico-culturale della nobiltà che per tutto il secolo XIV convisse faticosamente con il principio legalistico-funzionale fissato dalla Serrata. Come dimostra l'elenco dei Proles nobilium venetorum nella Cronaca "pseudo-Giustinian", al principio storico tenevano soprattutto le "case vecchie" più potenti, che ne derivavano il prestigio della supremazia culturale, ma è possibile che anche le famiglie antiche in posizione meno preminente trovassero conferma della propria nobiltà nella presenza dei loro antenati al governo nei secoli addietro. Se ricercatori diligenti come Marino Sanudo nel tardo Quattrocento e Marco Barbaro a metà Cinquecento - entrambi uomini della nobiltà - contavano, ad esempio, i Disenove, i Galina e i Renoldo tra le casate sopravvissute fino al tardo Trecento, è ben possibile che gli esponenti di quelle case, e come loro i Veneziani contemporanei, non ritenessero necessario cercare conferme al proprio statuto nelle registrazioni ufficiali o in quell'attività di governo che ad esso veniva associata dopo la Serrata (141). Se così fu, l'asistematicità con cui il regime trecentesco applicò i criteri fissati dalla Serrata li incoraggiò in quella direzione; e anzi, è possibile che proprio l'imposizione approssimativa della legge spiegasse la disinvoltura con cui queste famiglie affrontarono il problema della propria posizione - se ne sarebbero amaramente pentite nel clima di ben più rigorosa verifica delle credenziali nobiliari che si sarebbe instaurato, come vedremo più avanti, sul finire del secolo (142).
Data la tenuta poco sistematica dei documenti ufficiali per tutto il Trecento, la posizione incerta di queste famiglie estranee alla cerchia di governo rende impossibile una ricostruzione certa e precisa della classe dominante dopo la Serrata. Ma è proprio questa qualità indefinita uno degli aspetti essenziali della composizione della nobiltà, e anzi della condizione nobiliare nel secolo XIV. In netto contrasto con l'attenzione ai documenti e le accurate procedure di controllo delle credenziali che avrebbero contraddistinto l'atteggiamento del governo verso lo statuto nobiliare nel Quattrocento, nel Trecento esso appare caratterizzato dalla flessibilità. Il carattere ondivago, evolutivo, sporadico della nobiltà marginale e l'elusività della sua costituzione che ne consegue assumono importanza critica nel rapporto tra la classe di governo e il resto della società dopo la Serrata - critica, si vuole dire, per la natura del regime nobiliare nel Trecento. La nube di indefinitezza che nasconde tanto la condizione della nobiltà periferica, quanto il processo che consentì a "case nuove" come gli Adoldo, i dalle Boccole, i Ghezzo, i Gomberto, i Lanzuol, e i Renier di affermarsi, emanava dall'incertezza nella classe dominante circa le ragioni della propria composizione.
Un'incertezza che trova espressione nelle carenze istituzionali della Serrata, nell'assenza di meccanismi efficaci per imporre nella pratica i requisiti ereditari previsti dalla legislazione del 1323 come criterio essenziale per l'appartenenza alla classe dominante, e nella mancata registrazione ufficiale dei suoi esponenti. Nelle parti conclusive di questo lavoro esamineremo il rovescio di tanta incuria. Qui, e nelle pagine che immediatamente seguono, osserveremo due aspetti della concezione trecentesca dell'appartenenza alla nobiltà che rivelano, per certe famiglie ma non per altre, l'esilità dei titoli che ad essa potevano vantare. Si tratta di due aspetti centrali della nobiltà a Venezia nel Trecento: l'attività di governo e i criteri di appartenenza alla classe nobiliare.
Sebbene personaggi e famiglie marginali come i Balduin e gli Arian, ad esempio, parrebbero da considerarsi indiscutibilmente nobili sulla scorta della loro partecipazione al governo - che dopo la Serrata si vorrebbe essere stato riserva esclusiva della nobiltà - anche questa verifica comporta un'ombra di incertezza. Nel gennaio 1367 il maggior consiglio approvò la proposta di proclamare il principio, istituito dai "progenitorum nostrorum", in base al quale chiunque occupasse i "regimina" di governo doveva essere eletto nel consiglio stesso. Il decreto specificava che da quel momento nessuno di quegli incarichi sarebbe più stato assegnato con procedura di grazia, che esonerava i richiedenti dalle procedure e dalle sanzioni ordinarie - in questo caso, le procedure elettorali (143). Le nomine "per gratiam" venivano in genere concesse a persone in difficoltà economiche: "viro nobili" Maffeo Venier, ad esempio, "qui multas adversitates et tribulationes passus est", cui fu assegnata la castellania di Castel Bonifacio per due anni (144); o "viri nobilis" Nicolò da Canal, il quale, "considerata paupertate sua et bona dispositione eius", divenne podestà del Lido per un anno, "cum salario" (145); o Marino Longo (non titolato), che "gravatus est multa familia", e dunque fu nominato capitano di un vascello di pattuglia lungo le coste istriane (146).
Le cariche come fonte di reddito sarebbero divenute un elemento importante del regime nobiliare, specie a partire dagli ultimi decenni del Trecento. In questo momento, comunque, il contesto in cui ci interessa considerare queste nomine è quello delle grazie come strumento clientelare. Come ha osservato Dennis Romano, le grazie venivano regolarmente usate dai nobili più influenti per procurare vantaggi ai loro clienti nella nobiltà minore e nel popolo, per ingigantire la propria statura individuale di "patronus" e per favorire la pace sociale offrendo una valvola di sfogo ai risentimenti provocati dai privilegi dei potenti (147). In questa prospettiva, il provvedimento del 1367 risulterebbe rivolto contro due bersagli: i potenti che sfruttavano la propria influenza per accaparrare i posti più ambiti per se stessi e per i loro riconoscenti clienti; e i cacciatori di incarichi che aggiravano le procedure elettorali ordinarie, o perché ritenevano di avere poche possibilità di raccogliere i suffragi necessari, o perché non appartenevano al maggior consiglio. È evidente che i due gruppi avevano tutto l'interesse ad opporsi alla legislazione. La sosteneva, invece, una massa di nobili minori che, privi di influenza e relazioni, potevano godere dei benefici dello statuto nobiliare solo se venivano rispettate le procedure regolari che loro stessi, con voto di maggioranza, avevano escogitato ed erano decisi a difendere.
Nel confronto, comunque, i due schieramenti lottarono testa a testa: per quattro ballottaggi agli oppositori si aggiunsero tante astensioni (i voti "non sinceri") da rendere impossibile la maggioranza; anzi, i contrari erano quasi altrettanti che i favorevoli. Ballottaggio dopo ballottaggio, i voti in favore del nuovo rigore furono duecentotredici, duecentoventi, duecentoventitré, duecentoventisei; i contrari duecento, duecentoquattro, duecentosei, centonovantasette; le astensioni novantasette, trentasette, trentaquattro, trentaquattro. Solo al quinto ballottaggio il numero dei contrari diminuì (misteriosamente) abbastanza da permettere l'approvazione della proposta: duecentoventisei a favore, ma solo centoquarantanove contrari, e trentotto astensioni (148). L'entità stessa dell'opposizione è indicazione sufficiente per identificarla con i patroni che dispensavano le cariche attraverso le eccezioni per grazia; e senza dubbio i patroni più attivi erano i nobili delle principali casate, quelli che egemonizzavano i più autorevoli consigli di governo (dei quali si è detto nel paragrafo precedente).
Le potenzialità clientelari dei clans consolidati, più numerosi e potenti, risultano evidenti dal dato inequivocabile che ben sette decenni dopo la Serrata si potessero ancora ottenere incarichi di governo in modo irregolare, scavalcando le ordinarie procedure elettorali - e nell'ulteriore evidenza di come metà della nobiltà desiderava che le cose rimanessero così. Fu probabilmente questo il modo in cui Antoniello Balduin ottenne il capitanato di Torre San Giuliano nel 1335. La pratica vietata dalla legge approvata così risicatamente nel 1367 potrebbe anche spiegare l'occasionale comparsa in qualche ufficio di esponenti di altre famiglie che si incontrano di rado nei ruoli della nobiltà, e delle quali nessuna analisi, antica o più recente, della classe dominante nel Trecento fa mai menzione: nomi come gli Arian, i Balestrieri, i Goso, i de Malis, che ebbero tutti qualche carica a metà Trecento.
In una valutazione d'insieme, l'ampio sostegno raccolto dal decreto del 1367 e l'ampia opposizione che suscitò rivelano che le procedure destinate a regolarizzare la dispensazione dei privilegi e delle responsabilità dei nobili non avevano ancora gettato radici profonde, così nella pratica come nella cultura politica della nobiltà. Ancora negli anni Sessanta, le costituenti della classe dominante erano profondamente divise sulla questione della regolarità procedurale, anche quando si trattava dei fondamentali privilegi connessi all'eleggibilità alle cariche che nei decenni a venire sarebbero stati considerati inscindibili dal rango nobiliare.
Una resistenza al rigore procedurale in sorprendente contrasto con il massiccio consenso in suo favore cinquant'anni dopo, nel 1414, nella votazione sul provvedimento che irrigidiva le regole per l'iscrizione dei candidati alla Barbarella, e prescriveva la trascrizione formale che avrebbe prodotto il registro 162 degli avogadori di comun di cui si è detto sopra. In questa occasione, i membri del maggior consiglio approvarono a maggioranza schiacciante le procedure più rigorose, con duecentottantasei voti a favore e solo ventidue contrari, con tredici astensioni (149). L'entusiasmo quattrocentesco per le garanzie contro l'intrusione di gente non qualificata nella sfera delle prerogative della nobiltà fu tutt'altra cosa rispetto al lassismo di cui diedero prova i duecento consiglieri che si opposero tenacemente alla proposta del 1367. Il contrasto tra questi due momenti legislativi ci avverte che, entrando nell'ultimo terzo del Trecento, il comportamento politico della classe dominante - la sua psicologia politica collettiva - fu marcatamente diverso rispetto alle caratteristiche che avrebbe manifestato nel periodo maturo del Rinascimento, nel tardo Quattrocento e nel Cinquecento. Per comprendere la società veneziana nel tardo Medioevo è indispensabile prendere atto del nesso tra l'ideologia nobiliare e la composizione della nobiltà nel loro contemporaneo evolversi tra il 1300 e il 1500: entrambe attraversarono un processo di sviluppo nel secolo successivo alla Serrata.
I criteri d'identificazione della nobiltà
La forte opposizione alla legge del 1367 sul rispetto delle procedure elettorali dimostra che nell'ultimo trentennio del Trecento non esisteva consenso all'interno della classe dominante nella direzione di una tutela amministrativa più rigorosa del diritto esclusivo dei suoi membri a far parte del governo. Andando più a fondo, essa rivela anzi una mancanza di consenso circa la sostanza stessa dello statuto nobiliare a Venezia, e dunque circa l'identità collettiva di coloro che ne godevano. Anche per questo, per buona parte del Trecento il governo non applicò procedure rigorose per identificare e delimitare le componenti della classe dominante: a questo si devono i confini fluttuanti della nobiltà per quasi tutto il secolo dopo la Serrata.
L'imprecisione formale e materiale dei criteri di appartenenza alla classe dominante si riflette anche nell'uso poco sistematico dei titoli destinati a distinguere i nobili dai popolani. L'uso dei titoli è tema di importanza fondamentale nell'evoluzione della politica e della società veneziana nel Trecento, e ancora una volta è stato Dennis Romano il primo a dedicarvi la sua attenzione (150). Un esame delle diverse forme che venne assumendo è indispensabile per comprendere la complessità della significazione sociale nel secolo dopo la Serrata.
Rilevando l'assenza di una netta distinzione tra i titoli per buona parte del Trecento, Romano osserva che a volte certi popolani ricchi o professionisti, i medici ad esempio, venivano chiamati "dominus", appellativo usato anche per certi nobili - ma non tutti. A quanto pare quel titolo serviva come segno generico di rispetto, di buona educazione o di omaggio. Romano ha trovato qualche Bedeloto definito "dominus", e nel 1361 così viene chiamato Giovanni de Bugni, che nell'estimo del 1379 risulterà il popolano più ricco di Venezia (151).
È alla luce di questa flessibilità nell'uso del termine che vanno valutate le due occasioni in cui Francesco Balduin viene detto "dominus", nel 1359 e nel 1360 (152): come abbiamo visto, qualche singolo Balduin assurse ad un certo grado di preminenza - uno fu persino rettore negli anni Trenta del Trecento - ed è quindi probabile che il titolo di "dominus" riconosciuto a Francesco stesse ad indicare la costante evidenza della famiglia nell'ambito fluido della periferia della nobiltà. Ma non è ratifica del rango nobiliare; piuttosto, come l'occasionale carica di governo (e il decreto del maggior consiglio del 1367 lo mette bene in chiaro), sta ad indicare l'informale preminenza che caratterizzava alcuni individui posti agli incerti confini della classe dominante.
A dire il vero, se vi fu una politica ufficiale, o almeno una pratica consuetudinaria, nell'uso più generale dei titoli, per buona parte del Trecento essa risulta imperscrutabile. L'incoerenza nell'attribuzione dei titoli è evidente persino nell'opera dei segretari del governo. Il notaio Marino, prete a San Tomà e segretario alla curia del proprio, non segue alcuno schema ricostruibile nel conferire i titoli quando registra le procedure "diiudicatum" (o "de giudicatu"), attraverso le quali le vedove o i loro eredi reclamavano la restituzione delle doti. In una serie di casi negli anni Sessanta parla di Nicoletto Manolesso senza attribuirgli titoli, ma definisce Sandro Dolfin "nobilis vir"; identifica Piero Soranzo e Marco Polo come "nobiles viri", ma per Micheletto Dolfin, Schiavo Bollani e Marco Loredan usa soltanto il titolo "ser". Rileva che Franceschina, vedova "nobilis viri" Donato Corner, era figlia "quondam nobilis viri" Paolo Contarini; ma Nicoletto Contarini, la cui vedova Maddaluzza pretese la dote nel 1368, è soltanto "ser". Il figlio "nobilis viri" Francesco Badoer compare come "ser" Giovanni Badoer, ma Pangrazio da Molin, pur essendo emancipato ("filius divisus") dal padre, il "nobilis vir" Benedetto da Molin, non porta alcun titolo. E senza titolo rimangono uomini dai cognomi nobiliari come Marco da Riva "quondam ser" Francesco, Gasparino Soranzo, Paolo Tiepolo, Luca Zane, Bartolomeo Nani e Marco Balbi (153).
Sono esempi che dimostrano la triplice incertezza dell'identificazione dei nobili per buona parte del Trecento, per l'uso incoerente dei titoli, per la possibilità che personaggi con cognomi a prima vista nobiliari fossero in realtà popolani, e per l'analoga possibilità che un apparente popolano fosse in qualche modo nobile, per aver servito il governo in modo occasionale o saltuario, o perché tale veniva informalmente considerato agli occhi dei Veneziani, o per entrambi i motivi.
Persino i segretari che registravano i processi penali nei registri delle Raspe dell'avogaria di comun non facevano nette distinzioni tra i nobili e la gente comune; un caso del 1344 esemplifica la confusione che ne conseguiva. Il 13 febbraio due uomini, Maffeo Zane e Moretto da Pesaro, furono condannati per aver violentato due figlie di Marino da Canal (154); i tre cognomi appartengono tutti a famiglie nobiliari. Ma una delle vittime era la moglie di un marinaio (Marino Montini, "marinarii"), e l'altra di un calafato (Dardi Nadal, "calefadi", anch'egli con un cognome nobiliare). Sarebbe ragionevole pensare, di fronte a matrimoni così modesti, che nonostante il cognome Marino da Canal e le sue figlie fossero popolani, ma non possiamo dirlo con certezza. In analoga oscurità rimangono i due assalitori, anch'essi privi di titoli negli atti del processo: potrebbero appartenere alla categoria dei popolani dal cognome nobiliare nella quale abbiamo provvisoriamente collocato le loro vittime; o potrebbero essere nobili. Non lo sappiamo (155).
Questa imprecisione risulta ancor più sconcertante nei casi di personaggi indicati come "nobiles viri" incriminati per reati commessi come privati cittadini. Ne è un esempio il processo dell'ottobre 1348 contro il "nobilis vir ser Jacobellus Dolfino", condannato a tre anni di carcere per aver ferito "ser Marinum Dolfino" con la spada durante un litigio (156). Il motivo per cui un Dolfin otteneva il titolo nobiliare mentre l'altro era soltanto "ser" - a meno che Jacobello fosse nobile e Marino, nonostante il cognome, popolano - rimane inspiegato, ed è probabilmente inspiegabile. Queste misteriose distinzioni notariali riguardo alla condizione sociale degli individui gettano gravi dubbi sulla possibilità di valutare davvero l'interazione all'interno, e attraverso, i confini della nobiltà (157). Ma può ben darsi che la vaghezza che tormenta gli osservatori moderni sia soltanto un riflesso della realtà del tempo: forse anche i Veneziani di allora prendevano dei popolani per nobili, specie laddove - data l'imprecisione delle linee di demarcazione sociopolitiche - i personaggi più in evidenza ai confini tra le classi non erano così facili da distinguere da quelli il cui rango nobiliare, allora come oggi, era più immediatamente individuabile.
Un altro processo presente nelle Raspe fa capire quanto dovesse essere difficile per i contemporanei cogliere le distinzioni, specie tra i nobili e i popolani che frequentavano i migliori ambienti della società veneziana. Nel marzo 1348 un gruppo di uomini fu condannato per aver provocato disordini in numerosi conventi della laguna. Privi di titolo negli atti ufficiali del processo, gli accusati venivano identificati, con una sola eccezione, con il patronimico: Zanino Savoner di "ser" Marco, Lorenzo Manolesso "quondam ser" Marco, Lodovico Querini di "ser" Giovanni, Jacobello Baseggio di "ser" Marco, Piero Coppa "miles" e Lodovico Bedeloto di "ser" Mellelo (158). All'epoca esistevano famiglie nobili di nome Savoner (Savonario), Manolesso, Querini e Baseggio, e anche dei nobili Coppo - anche se non è certo che Piero Coppa (il cui nome compare così trascritto due volte negli atti) appartenesse a quella famiglia, nonostante la sua dignità cavalleresca. Come abbiamo visto, la condizione dei Bedeloto rientrava invece nel territorio nebuloso ai margini della nobiltà. Un tempo nobili, stando ad alcune testimonianze, non compaiono nelle liste trecentesche delle cariche, eppure avevano frequenti rapporti con i nobili in campo economico e sociale - come dimostra Dennis Romano nella sua ricostruzione delle loro attività nel Trecento. Il Lodovico di Mellelo Bedeloto che in quest'occasione violava i conventi avrebbe poi sposato una donna di nome Chiara Michiel, presumibilmente di quell'illustre "casa vecchia" (159).
Sapendo degli stretti rapporti dei Bedeloto con le famiglie della nobiltà, possiamo ben chiederci in grazia di quale criterio un veneziano contemporaneo, e persino un segretario degli avogadori di comun, doveva distinguere Lodovico dai suoi coimputati - se questi a loro volta erano davvero nobili. La loro posizione individuale è infatti tutt'altro che certa, al di là della possibile impressione creata dai cognomi. Un Lodovico di Giovanni Querini sarebbe stato in senato nel 1362, e può darsi si trattasse dello stesso Lodovico Querini che aveva razziato i conventi con Lodovico Bedeloto nel 1348 (160). Ci furono inoltre almeno due personaggi di nome Marco Baseggio con incarichi di governo tra il 1349 e il 1352, uno dei quali poteva essere il padre di Jacobello; quest'ultimo però non compare nelle liste delle cariche degli anni Cinquanta e Sessanta. Né compare un Piero tra i Coppo con incarichi di governo in quello stesso periodo, né un Lorenzo tra i Manolesso. L'unico Savoner che ebbe un incarico in quegli anni si chiamava Francesco, e fu dei cinque alla pace nel 1350; pare fosse l'ultimo della casata a far parte del governo prima dell'estinzione - che comunque i cronisti della nobiltà collocano in genere negli anni Venti (161). È quindi tutto sommato possibile che Lorenzo Manolesso, Piero Coppa, Zanino Savoner e persino Jacobello Baseggio, nonostante i cognomi risonanti, appartenessero - come lo stesso Lodovico Bedeloto - alla periferia un tempo nobile, ora nebulosa, non ufficiale né documentata, della classe dominante, che però intratteneva rapporti sociali con famiglie di nobiltà sicuramente attestata come i Michiel e i Querini.
Nel contesto di queste vaghe distinzioni sociopolitiche, nel permanere degli scambi interclassisti, l'unica indicazione apparentemente sicura dell'appartenenza alla classe dominante era il titolo "nobilis vir". L'abbiamo visto riferito a tutti i livelli della nobiltà trecentesca, si chiamassero Morosini, Caroso o dalle Boccole - ma non, parrebbe, Balduin (162) -, ma è evidente che non veniva usato in tutti i casi: come l'idea stessa di nobiltà nel Trecento, ci si accorge che "nobilis vir" possedeva due significati ben distinti, l'uno giuridico-funzionale, l'altro storico-culturale. Individuando il nesso che collegava i due significati getteremo luce sul carattere peculiare della nobiltà nel secolo XIV, e troveremo una chiave per ricostruirne l'evoluzione verso il XV.
Nel significato giuridico-funzionale il titolo denotava, soprattutto nei documenti pubblici, chi faceva parte del governo - rettori, giudici e altri magistrati. Anche nei registri delle Raspe, così impenetrabilmente vaghi quanto allo statuto dei rei, gli avogadori stessi vengono quasi sempre nominati con il titolo di "nobilis vir". Per buona parte del secolo, comunque, nemmeno questo principio relativamente semplice venne applicato in modo regolare nell'uso dei documenti di governo ufficiali. Le deliberazioni del maggior consiglio forniscono molti esempi di questa incoerenza. Il 22 giugno 1350 il consiglio esaminò una causa ereditaria in atto di fronte ai giudici del procurator, che coinvolgeva anche i procuratori di San Marco e gli auditori alle sentenze (163). Ciascuno dei giudici, procuratori e auditori in causa veniva identificato per nome, con il titolo "nobilis vir". I personaggi parte privata nella disputa invece - il defunto Angelo Marcello, e Zanino, Francesco, Piero, Marco e Tomaso Caravello - venivano tutti nominati senza il titolo. Ancora una volta, non possiamo escludere che questi specifici Marcello e Caravello fossero popolani, nonostante i cognomi nobiliari; è comunque assai più probabile che fossero nobili nominati senza il titolo proprio perché agivano a titolo privato, diversamente dai magistrati coinvolti nella causa. Dieci anni dopo un altro Caravello, Luca, veniva definito "nobilis vir" con riferimento al fatto che stava per assumere l'incarico di consigliere a Capodistria, e possiamo supporre che il titolo gli venisse attribuito a causa della sua posizione ufficiale (164). Un sospetto incoraggiato da un altro esempio contemporaneo. Il 20 aprile 1350 il consiglio discusse una causa riguardante "ser Donatus Grioni", che vi compariva a titolo privato; due anni dopo invece, eletto consigliere a Creta, lo si sarebbe chiamato "nobilis vir ser Donatus Grioni" (165).
Questi esempi indurrebbero a credere che il titolo di "nobilis vir" anteposto al nome stesse ad indicare una partecipazione agli incarichi e ai consigli di governo, e dunque l'appartenenza a pieno titolo alla classe dominante. Purtroppo, invece, anche questo accenno minimo di regolarità è circondato da dubbi. I registri del maggior consiglio per gli anni Cinquanta e Sessanta contengono molti riferimenti a funzionari definiti semplicemente "ser", o nemmeno quello. Discutendo della sua rielezione a signore di notte nel 1351, Giovanni Pollini veniva chiamato soltanto "ser", e così Piero Dolfin scelto l'anno successivo per un'indagine sulle competenze di diversi uffici, Andrea Paradiso eletto e "probatus" come ufficiale al piovego nel 1357, e Piero Michiel nominato auditore delle sentenze nel 1364 (166). Se dunque "nobilis vir" era un titolo di cortesia riservato ai funzionari, il principio veniva osservato in modo alquanto incoerente persino nei documenti del maggior consiglio, l'organo che - dopo la Serrata - avrebbe dovuto essere più attento di ogni altro alla tutela della distinzione conferita dall'appartenenza alla classe nobiliare dominante.
Sul tema del significato giuridico-funzionale di "nobilis vir", dobbiamo limitarci a dire che veniva usato spesso, ma non sistematicamente, per denotare personaggi che occupavano una posizione ufficiale: un principio sfocato che fa il paio perfetto con l'accezione storico-culturale del titolo. Mentre infatti certi magistrati portavano il titolo di "nobilis vir" e altri no, ad altri personaggi il titolo nobiliare veniva attribuito da segretari e notai - e possiamo immaginare che venissero considerati nobili anche da tutti i loro concittadini - senza alcun riferimento apparente a una carica politica. In altri termini, la nobiltà di alcuni parrebbe prescindere dal nesso ufficiale tra il rango nobiliare e l'attività di governo, nesso che la legge del 1367 rivela in ogni caso come alquanto incerto.
Abbiamo già osservato che gli atti giudiziari definiscono "nobiles viri" certi personaggi anche quando compaiono a titolo privato; la stessa pratica si verifica persino nelle deliberazioni del maggior consiglio. Nelle stesse pagine in cui i magistrati vengono detti a volte "nobilis vir" e a volte soltanto "ser", anche alcuni privati vengono fregiati del titolo nobiliare, e altri no. Nel 1356, ad esempio, la grazia che concede a Fantin Contarini di aprire una "hostaria et taberna" lo definisce "nobilis vir"; nella discussione in consiglio sulle complicazioni insorte per la restituzione della dote alla vedova Cecilia Soranzo, il defunto marito veniva identificato come "nobilis viri Nicoleti Superantio"; quando Francesco e Nicoletto Nani furono autorizzati a fare cambiamenti strutturali nel loro palazzo, si parlò di loro come di "nobilibus viris" (167).
In un'epoca in cui il titolo nobiliare veniva spesso negato a personaggi delle casate più antiche e prestigiose, persino nei documenti riferiti alle cariche che occupavano, la sua attribuzione a privati individui nei documenti del maggior consiglio risulta ancor più sconcertante che non nelle trascrizioni degli atti dei tribunali. Se queste attribuzioni non ufficiali del titolo hanno un qualche significato - se cioè la pratica delle segreterie non era dettata soltanto dal caso e dal capriccio - si tratta di una concezione della nobiltà in qualche modo diversa da quella legata alla partecipazione alle funzioni di governo del regime.
Raccogliendo le fila di tutte queste accezioni diverse, per cercare di dare un senso all'uso apparentemente indiscriminato di un titolo, "nobilis vir", che dopo la Serrata avrebbe dovuto diventare un elemento di distinzione gelosamente salvaguardato, le possibili spiegazioni si riducono a tre. La prima è che i notai erano davvero distratti, o non avevano ricevuto istruzioni specifiche sull'accertamento dello statuto delle persone le cui attività documentavano. È possibile, naturalmente, ma in una società che attribuiva grande importanza alla documentazione precisa delle transazioni, sia pubbliche che private, e in cui la pratica notarile era regolamentata dal governo, la cosa starebbe ad indicare una sorprendente indifferenza per le questioni di status, alquanto anomala in un'élite sociopolitica che di recente aveva legiferato una propria identità esclusiva, isolata dal popolo.
La seconda spiegazione possibile è che i notai, i segretari e gli altri Veneziani avessero una percezione tanto chiara di chi fossero i nobili da rendere superfluo ogni puntiglio nell'attribuzione dei titoli: bastavano il nome e certi altri aspetti del modo di presentarsi per comunicare più che adeguatamente la loro distinzione. Anche questa è una spiegazione plausibile, ma si scontra con due problemi spinosi. Se i notai e gli altri Veneziani del Trecento conoscevano davvero abbastanza bene la composizione della nobiltà da rendere superflua o facoltativa l'attestazione dei titoli, dovremmo aspettarci di incontrarla ancor meno frequentemente e regolarmente nei protocolli e nei registri del secolo XV, quando l'identità collettiva della classe dominante era assai meglio consolidata. E invece i notai del Quattrocento fanno un uso ben più sistematico di "nobilis vir" che non i loro colleghi trecenteschi; anzi, la loro precisione è tanto uniforme che è difficile sfuggire alla conclusione che l'uso venisse loro imposto da un regolamento ufficiale ignoto ai notai del secolo precedente. E per di più, può darsi che l'opinione comune fosse sufficiente per riconoscere un nobile di una casata antica come i Dandolo, i Contarini, i Morosini, i Corner e così via: erano nomi noti a tutti, sinonimi, anzi, della nobiltà veneziana, e non avevano bisogno di titoli. Ma l'opinione comune si rivelava una guida assai meno sicura per individuare lo statuto di un esponente di una casa assurta da poco alla nobiltà, o la cui nobiltà era mal definita: lo statuto, per intendersi, di un dalle Boccole, di un Ghezzo, di un Lanzuol, di un Arian, di un de Malis - o anche di un Bedeloto o di un Balduin. Il criterio della riconoscibilità dei cognomi serviva meno a distinguere i nobili dai popolani che non a sottolineare le distinzioni all'interno della nobiltà, tra chi non aveva bisogno di un riconoscimento ufficiale per godere dei privilegi e del prestigio dello statuto nobiliare e chi a quel riconoscimento non poteva rinunciare.
La terza spiegazione è la più elaborata, e la più estesa, in quanto è quella che più si avvicina a tener conto di tutte le sfaccettature della distinzione sociale nel corso del Trecento. L'uso dei titoli fu conseguenza del persistere dell'ambiguità intorno alla condizione nobiliare nel periodo successivo alla Serrata. La premessa di questa spiegazione sta nella dimostrata esistenza, per buona parte del secolo dopo la Serrata, di tipi diversi di nobili, diversi quanto ad antichità, dimensioni della casata, capacità di sopravvivere e misura di coinvolgimento nell'attività di governo del regime. In questa variegata classe dirigente il titolo nobiliare, pur non venendo sempre usato in modo chiaro o preciso, nondimeno serviva per distinguere le funzioni di una società che andava lentamente adattandosi ad una nuova struttura. Diversamente dall'ordine politico precedente la Serrata, quello trecentesco si basava sulla fusione di distinzioni storico-culturali consolidate con distinzioni giuridico-funzionali affatto nuove. Da solo, il titolo "nobilis vir" trasmetteva quindi due diverse concezioni della nobiltà coesistenti a Venezia nei decenni successivi alla Serrata: quella tradizionale, in base alla quale l'appartenenza alla classe dominante si fondava sulla ricchezza, certo, ma anche su una lunga esperienza di governo, attestata negli atti ufficiali, nelle cronache o nella leggenda come elemento integrante della storia della città; e quella più nuova, delineata dalla Serrata, che condizionava la nobiltà a credenziali previste dagli statuti e valutate da apposite magistrature.
"Nobilis" assumeva quindi significati diversi nei diversi contesti. Nell'accezione storico-culturale poteva riferirsi a una persona di indubbia identità nobiliare, come nel caso di Fantin Contarini, di cui si è detto che fu autorizzato ad aprire una taverna, o quello della "nobilem dominam" Filippa, moglie di "ser" Piero Badoer cavaliere (168). Oppure poteva richiamarsi ad un'intera casata nobiliare, come quando il maggior consiglio rilevò, nel 1375, che nella contrada di San Simeon Apostolo "non sunt nisi due domus nobilium [...] que sunt Ca' Fuscari et Ca' Nicola" (169). In quest'accezione il termine indicava il carattere nobiliare collettivo condiviso da tutti i membri della casata, maschi e femmine, derivante in ultima istanza dalle vicende della sua passata partecipazione al governo di Venezia. Questi richiami al carattere nobiliare collettivo di una casa sono espressioni della medesima concezione storico-culturale che produsse a metà Trecento le identificazioni dei Proles nobilium venetorum della Cronaca "pseudo-Giustinian". Sia che fossero riferiti a una casata oppure a uno dei suoi esponenti, attestano la perdurante vigenza del principio che informò la Serrata, che cioè a Venezia la nobiltà era radicata nel passato precedente la Serrata, e in particolare nelle vicende della partecipazione di ciascuna famiglia all'attività di governo, inestricabilmente legata alla gloriosa e mitica storia della comunità veneziana.
Distinta da questa accezione tradizionale della nobiltà, ma con essa coesistente in alterne tensioni, c'era l'accezione ufficiale, giuridico-funzionale, del termine formulata dalla Serrata. In questa accezione, "nobilis" si riferiva a chi aveva superato l'esame di eleggibilità al maggior consiglio, e poteva quindi assumere incarichi di governo. In questo senso "ser" Donato Grioni divenne "nobilis vir ser" Donato Grioni quando fu scelto per un incarico a Creta. Fu probabilmente per consolidare il possesso di questo statuto nobiliare giuridico-funzionale che gli uomini di casate nuove, successive alla Serrata, come i Lion, i da Mare, i Lanzuol e i Ghezzo si diedero tanto da fare per ottenere incarichi per tutto il Trecento. Non potevano reggere il confronto con le credenziali storiche delle casate presenti nel governo nel secolo XII o anche XIII, per non dire di quelle delle "case vecchie"; ma potevano ispessire la fresca patina di nobiltà che li adornava assuefacendo i colleghi alla loro presenza attiva nella classe di governo, espressa da una documentabile partecipazione alla dimensione giuridico-funzionale della nobiltà.
Il duplice significato della nobiltà dopo la Serrata fornisce il contesto del dissenso sulle proposte del 1367 di irrigidire le procedure elettorali. L'esito quasi paritetico delle votazioni può essere letto come una competizione tra i sostenitori della vecchia e della nuova concezione della nobiltà, tra un modo di pensare radicato nel passato e un altro che rifletteva la nuova realtà politica adombrata in linea di principio dalla Serrata.
Non sorprende che la nobiltà minore guardasse con costernazione alla possibilità che popolani amici o clienti di personaggi influenti delle casate antiche potessero acquisire de facto la nuova nobiltà "funzionale" a seguito dell'elezione a un incarico di governo. Oltre a svalutare quanto loro stessi erano riusciti ad ottenere - l'accettazione a pieno titolo nella nobiltà - le incursioni per vie traverse nella classe dominante dei clienti dei più potenti minacciavano di accrescere ulteriormente l'influenza delle grandi casate vecchie. Quando da soli gli esponenti di ventidue "case vecchie" occupavano il 42% delle cariche, l'aggiunta dei voti dei clienti prometteva di perpetuare all'infinito la preponderanza delle casate antiche nella vita politica veneziana. L'applicazione puntigliosa delle procedure elettorali esistenti era per la nobiltà minore il miglior modo di proteggere la propria posizione e di evitare un aumento spropositato del predominio dei clans più antichi e potenti.
Lo scontro del gennaio 1367 va dunque compreso all'interno della più profonda corrente che attraversa l'esperienza della classe di governo del Trecento, incidendo tanto sul significato giuridico-funzionale che su quello storico-culturale della nobiltà; una corrente mossa dagli interessi divergenti dei diversi settori della nobiltà per quanto atteneva allo statuto nobiliare. Per i clans più antichi, le casate "più nobili", le gesta dei cui membri erano incastonate nella storia di Venezia, e che continuarono per tutto il Trecento a controllare le massime cariche di governo, compreso il dogado: per questi gran signori la dimostrazione delle credenziali nobiliari era pleonastica, insomma una seccatura facilmente evitabile. Per un Dandolo, un Gradenigo, un Morosini o un Contarini l'attribuzione del titolo di "nobilis vir" era questione irrilevante: gli uomini, e persino le donne, di queste casate non avevano certo bisogno di far autenticare la propria nobiltà da un notaio. È ironico però che proprio quella ben radicata dignità potesse indurre i notai e i segretari ad attribuire loro il titolo. Il profondo radicamento della nobiltà delle case "più nobili" le dotava delle prerogative formali, oltre che informali, della loro classe di appartenenza.
Sicuramente la solidità della posizione e dell'autorevolezza dei clans più antichi suscitava le invidie delle nuove e meno salde famiglie nobiliari. Nemmeno loro, però, potevano rinnegare la cultura storica in cui era impresso il prestigio delle "case vecchie", una cultura sulla quale essi giocavano ben più che non i segretari, o qualsiasi altro cittadino di Venezia: la dignità e l'autorità politica che rivendicavano in quanto membri della classe dominante dipendevano dal medesimo criterio convalidante che dava un lustro tanto particolare alle "case vecchie". L'essenza irriducibile dello statuto nobiliare proposto dalla Serrata era di tipo storico: il requisito dell'esperienza di governo, trasmessa di padre in figlio, edificata sui tanti secoli di egemonia oligarchica a Venezia. Per le nuove case nobiliari, la qualificazione giuridico-funzionale alla nobiltà formulata dalla Serrata era indissolubile da quella storico-culturale preesistente.
Il problema, per le casate la cui nobiltà fu ratificata durante o dopo la Serrata, stava dunque nell'elevare il requisito più recente al livello di quello più antico: fintantoché non vi fossero riuscite, il loro statuto sarebbe stato ad un tempo deprezzato e minacciato. Deprezzato perché in assenza di una precisa attribuzione dei titoli il riconoscimento della loro nobiltà sarebbe rimasto problematico, incerto. Prive dell'innata nobiltà evocata dai soli cognomi delle casate "più nobili", le "case nuove" dovevano fare a meno anche del riconoscimento compensativo che poteva derivare dall'attribuzione regolare e coerente del titolo "nobilis vir"; non era quindi facile distinguerle dai ricchi popolani favoriti sul piano economico e politico - e, come vedremo tra poco, su quello delle politiche matrimoniali - dalle "case vecchie" più influenti. Minacciato, perché in assenza di attestazioni ufficiali della composizione della nobiltà, e di una coerente applicazione delle procedure di verifica delle credenziali nobiliari e di nomina dei funzionari, rischiavano che il loro statuto si diluisse nell'incertezza amministrativa - se ne sarebbero accorti, con non poca pena, alcuni dei loro discendenti nel Quattrocento.
Ancora negli anni Sessanta del Trecento, coesistevano quindi in instabile equilibrio due concezioni e due livelli di nobiltà. Negli ultimi tre decenni del secolo, però, quell'equilibrio si sarebbe spezzato: avviato con piena convinzione negli anni Settanta, l'impulso verso la definizione amministrativa - cioè verso il sopravvento della concezione giuridico-funzionale della nobiltà - nato con i primi, goffi movimenti dopo la Serrata intorno al 1300, trovò nuova energia. Questo processo, inteso come completamento della Serrata, o meglio come seconda Serrata, si sarebbe protratto per buona parte del secolo successivo; ma il tardo Trecento ne vide gli esordi, e su questi rivolgeremo ora la nostra attenzione.
Verso la seconda Serrata. I primi passi
Il 27 agosto 1387 il maggior consiglio votò l'annullamento delle decisioni approvate in quella giornata, relative all'assegnazione di numerosi incarichi giudiziari e amministrativi. Remigio Soranzo, avogadore di comun, aveva dimostrato che uno dei candidati nella lista in cui venivano scelti i funzionari, ser Nicolò Morosini quondam ser Andrea di Sant'Aponal, "non fuerat probatus" in quarantia per l'accesso in maggior consiglio. Nel giorno in cui erano state condotte le verifiche, la festa di san Michele, Nicolò Morosini - spiegò Soranzo - non aveva potuto essere presente "quia tunc erat in carceribus". La prova della mancata qualificazione di Morosini stava nel registro della quarantia, dove accanto al suo nome era stata segnata una "F", che in genere indicava l'assenza o la bocciatura del candidato. A seguito della denuncia di Soranzo, i sei consiglieri ducali si impegnarono a formulare una proposta per risolvere la questione. Non riuscirono però a raggiungere il consenso, e quindi presentarono al maggior consiglio due ipotesi alternative. Tre di essi, sostenendo che la "F" nel registro della quarantia non era perfettamente leggibile ("est spegaçatum"), e che dunque la non eleggibilità di Morosini era in dubbio, proposero la conferma delle elezioni già decise dal maggior consiglio. Gli altri tre, invece, convinti che lo imponesse la precisa osservanza dei regolamenti "sancti et justi", chiedevano l'annullamento delle elezioni. La prima proposta, di non tener conto della posizione apparentemente incerta di Morosini convalidando le elezioni, raccolse i voti di settantacinque consiglieri. La seconda, di annullarle e ripeterle, ne ottenne duecentocinque, e fu quindi approvata (170).
Apparentemente questione di poco conto, questo atto rivela invece che sessanta anni dopo il decreto conclusivo della Serrata, nel 1323, la quarantia convalidava ancora le candidature per l'accesso in maggior consiglio. E inoltre, ciò che conta ancor di più, ci mostra il nuovo clima che circondava lo statuto politico nobiliare negli anni Ottanta. È possibile che in questo caso l'avogador Soranzo fosse stato fin troppo puntiglioso: dopo tutto il suo rigore nell'applicazione delle procedure elettorali fu condiviso dalla metà soltanto dei consiglieri ducali; ma nella massa dei nobili del maggior consiglio fu sostenuto da una maggioranza di quasi tre a uno. Una vittoria schiacciante in netto contrasto non solo con la perfetta parità delle parti in consiglio ducale, ma anche con la risicata approvazione nel 1367 del divieto della nomina "per gratiam" alle cariche di governo. La netta sterzata verso una rigida applicazione delle procedure non può essere separata da un altro aspetto dell'episodio del 1387: era un Morosini l'uomo cui era stata revocata l'inclusione irregolare nella lista dei candidati. Il fatto che un esponente di questo clan maestoso, onusto di storia, venisse dichiarato non eleggibile per un cavillo tecnico, e non soltanto per la nomina a una carica ma addirittura per l'accesso in maggior consiglio, segna una nuova fase nella storia del regime nato dalla Serrata.
In questo e nel paragrafo 8 osserveremo l'evolversi di questa fase, la transizione dall'ordine politico creato con la prima Serrata a quello della seconda. Ne vedremo soltanto le origini tardotrecentesche, che bastano però ad indicare le nuove rotte che andava intraprendendo la classe dominante di Venezia. Abbiamo già considerato da vicino il primo bagliore del cambiamento: la legge del 1367 che provò a por fine alla concessione dei rettorati "per gratiam", riaffermando le procedure elettorali del maggior consiglio. Approvata con molta difficoltà, questa legge fu comunque il segnale dell'avvio di una trasformazione nella politica nobiliare, un distacco dalle pratiche di clientelismo informale che consentivano alle "case vecchie" più potenti e prestigiose di perpetuare un predominio conquistato secoli prima, nella direzione di regolamenti "sancti et justi" amministrati da funzionari del governo, che aprivano la possibilità di eguale trattamento per tutti i nobili. La nuova tattica adottata nel 1367, come poi nel voto contro Nicolò Morosini nel 1387, consisteva nell'applicazione rigorosamente corretta delle procedure formali fissate dal maggior consiglio.
La tattica fu usata di nuovo nel 1370, per un provvedimento che irrigidiva il divieto per i minorenni di accedere al maggior consiglio (171). La premessa del decreto faceva osservare che i giovani vincitori dell'annuale lotteria detta Barbarella, che potevano entrare in consiglio all'età di vent'anni invece di dover attendere i venticinque, dovevano dimostrare agli avogadori di comun ("fit bona et ordinata examinatio") di aver davvero raggiunto l'età prescritta (172). Non esistevano invece verifiche di questo tipo ("nulla examinatio fiat") nel caso di altre due categorie di "junioribus" ammesse in maggior consiglio: quelli eletti come avvocati nei tribunali civili, per i quali bastavano i vent'anni, e quelli eletti, come spesso avveniva ("multotociens"), ad altri incarichi che davano anch'essi diritto di accesso in maggior consiglio ("per que veniunt de maiori consilio"). Per far sì che questi casi venissero condotti "cum equalitate", gli avogadori di comun avrebbero d'ora in avanti verificato che tutti gli uomini eletti a incarichi che comportavano l'accesso in maggior consiglio avessero almeno vent'anni; chi risultasse non averli compiuti era soggetto a una multa di 200 lire, la stessa prevista per i concorrenti alla Barbarella che gli avogadori avessero scoperto minori di diciott'anni.
Da tutto questo è evidente che settant'anni dopo l'inizio della Serrata, non soltanto gli incarichi di governo ma anche l'ingresso in maggior consiglio venivano concessi a persone la cui nobiltà era incerta, in quanto i loro requisiti non erano stati in alcun modo verificati. Nulla sta ad indicare, peraltro, che anche a quella data più tarda le verifiche venissero regolarmente effettuate sui candidati - di qualsiasi età - all'ingresso in maggior consiglio: le norme della procedura erano ancora quelle approvate nel 1319 e nel 1323, che lasciavano alla discrezione degli avogadori di comun l'opportunità di indagare sulle credenziali dei candidati. L'incertezza strutturale della condizione di appartenenza alla classe nobiliare che perdurò nei decenni successivi era insita in quella legislazione: la legge del 1323 che enunciava formalmente il principio dell'ereditarietà, pur asserendo una preferenza per i documenti ufficiali come credenziali di nobiltà, ammetteva però anche che quei documenti potevano non sussistere (173).
Parrebbe anzi che per tutto il secolo il governo non registrasse le richieste di ammissione in maggior consiglio. Gli avogadori di comun trascrivevano nelle loro Raspe le indagini condotte sulle rivendicazioni di statuto nobiliare per le quali nutrivano qualche dubbio, ma l'esiguità di questi casi sta ad indicare che la stragrande maggioranza dei candidati entrava nell'area di governo senza alcuna verifica. Eppure, per quanto informali e discrezionali le procedure dell'avogaria, i personaggi da essa approvati senza esame e poi passati alla verifica della quarantia erano sottoposti quantomeno a una forma di controllo, per quanto approssimativa. Chi veniva nominato a un incarico "per gratiam", prima del 1367, o era eletto alle avvocature civili o a una delle altre cariche cui si riferisce la legge del 1370, entrava invece a far parte del maggior consiglio d'ufficio, senza controlli di sorta.
Nicolò quondam Andrea Morosini, proclamato non eleggibile nel 1387, una ventina di anni prima sarebbe probabilmente passato senza problemi, in virtù del suo cognome altisonante. È probabile che l'irrigidimento dei requisiti di età imposto dal decreto del 1370, e il principio di "equalitas" di cui era espressione, fossero rivolti proprio contro i clans nobiliari consolidati, i cui nomi erano storicamente associati al governo di Venezia, e il cui diritto al predominio sulla città veniva istintivamente accettato dagli esponenti di famiglie meno prestigiose, meno sicuramente nobili, legate alle "case vecchie" da rapporti clientelari. Ora però, nel 1370, quelle tradizioni profondamente radicate di autorevolezza da un lato, di deferenza dall'altro, subivano l'attacco di uomini decisi a distribuire equamente i benefici della nobiltà attraverso l'imposizione di nuove procedure ufficiali: la legislazione, ad esempio, in base alla quale nessun candidato al maggior consiglio, indipendentemente dalla distinzione del suo cognome e dalle circostanze della sua candidatura, poteva evitare la verifica preventiva.
La legge del 1370, la prima ripresa dopo il 1323 del principio dell'esame preventivo delle credenziali come condizione per l'accesso al governo, segna anche l'avvio di una lunga serie di decreti in cui i criteri di appartenenza alla nobiltà venivano articolati con riferimento alla posizione dei più giovani. Nel 1356 la quarantia aveva prescritto una multa per chiunque si fosse iscritto all'estrazione della Barbarella senza aver compiuto i diciott'anni previsti dalla legge; il rigore però si estendeva soltanto ai concorrenti alla lotteria, non a chi era entrato in maggior consiglio per altre vie (174). Il punto di svolta critico può essere individuato nella legislazione del 1367 e del 1370, ben presto seguita da una manifestazione assai più significativa dell'interesse del consiglio per la definizione dei requisiti delle giovani reclute. E questa volta non si trattava soltanto della qualificazione per gli incarichi di governo, ma anche della stessa vita privata della nobiltà: in una premonizione della pratica futura, si avviava il processo di fusione delle due dimensioni dell'esperienza sociale, la pubblica e la privata, per formare una nuova cultura nobiliare a tutto tondo.
Nel 1376 fu presentata in consiglio una proposta legislativa in cui si asseriva che la sicurezza dell'onore e dello stato di Venezia ("salute et conservatione honoris et status nostri") era vincolata alla dignità del maggior consiglio, l'accesso al quale era un solenne privilegio che non andava sminuito dalla presenza di uomini indegni. Era quindi necessario provvedere a por fine alla frequente pratica ("pluries est occursum") di certi nobili di far ottenere il seggio in consiglio ai figli illegittimi generati con donne di bassa condizione ("debilibus et vilis conditionis"), che poi avrebbero sposato. Si decideva quindi che da quel momento nessun figlio illegittimo di padre nobile potesse mai entrare in maggior consiglio, anche se i suoi genitori avevano poi finito per sposarsi (175).
Il principio non era nuovo; già cent'anni prima, nel 1277, era stata approvata una legge che escludeva i bastardi dal maggior consiglio e da tutte le cariche che ne emanavano (176). La novità stava invece nella dichiarazione che il seggio in maggior consiglio era un "solene beneficium", e che la presenza in esso di uomini indegni denigrava "honorem et famam nostri dominii". E nuova era anche l'enfasi sulle qualità personali degli uomini che governavano Venezia: la discendenza da progenitori che avessero seduto anch'essi in maggior consiglio era un requisito in linea di principio, se non nella pratica sistematica, fin dal 1323. Ma nel 1376 l'eredità patrilineare non bastava più: ora occorreva una nascita nobile "legittima", e dunque un legittimo matrimonio. Per la "nobilitas" di ciascuno, cardine della sicurezza e dell'onore dello stato, era essenziale non soltanto lo statuto del padre, ma anche la circostanza della nascita.
E nel nuovo clima non contavano soltanto i protagonisti maschili della successione transgenerazionale: la differenza cruciale tra il vecchio principio, applicato senza metodo, dell'ereditarietà e il nuovo rigore era imperniata sullo statuto delle madri. La premessa alla legge del 1376 dichiara che a provocarla era stata la disapprovazione per la frequenza delle relazioni, legittimate con il matrimonio dopo la nascita di un figlio maschio, tra nobili e donne del "popolo minuto"; donne "vilis conditionis" indegne di essere madri di chi aveva la responsabilità dell'onore e della sicurezza di Venezia. Che queste donne fossero l'oggetto centrale del decreto risulta chiaro dalla sanzione prevista, perché se era possibile che le popolane avessero figli con nobili al di fuori del matrimonio, altrettanto non poteva avvenire alle donne di buona famiglia. La legge del 1376, a prima vista rivolta contro l'illegittimità, su un piano più profondo fu la prima, incerta, proclamazione legislativa del principio che vedeva nel matrimonio tra nobili, con rispettabili lignaggi di sangue per entrambi i coniugi, un momento fondamentale nella trasmissione della nobiltà di generazione in generazione. La fusione della dimensione pubblica, ufficiale, dello statuto nobiliare con i rapporti privati, domestici, all'interno delle famiglie che lo detenevano sarebbe stata la chiave di volta della nuova struttura che la nobiltà riuscì a darsi con la seconda Serrata.
Le fonti non ci consentono di stabilire quale categoria o categorie di nobili aggirassero la norma del 1277 che escludeva i bastardi dal maggior consiglio, e che dunque erano il bersaglio specifico della proposta del 1376. È molto probabile, comunque, che si trattasse delle "case vecchie": grazie alla potenza del nome, le case più influenti e prestigiose erano meglio in grado di ottenere un seggio in consiglio per i figli nati da relazioni irregolari. È certo vero che le donne di bassa condizione erano esposte alle attenzioni di uomini ricchi o eminenti di ogni risma, vecchi o nuovi, nobili o popolani (177); nella sala del consiglio, però, gli esponenti di famiglie con scarsa risonanza storica e ancor meno influenza politica avevano meno possibilità di raccogliere tra i colleghi le adesioni necessarie per nobilitare i frutti delle loro mésalliances di quante non ne avessero i nobili dei clans più grandi e potenti, con le loro vaste reti clientelari.
Le famiglie nobiliari meno distinte avevano inoltre maggiore necessità di alleanze matrimoniali ben calcolate, per meglio garantire il proprio statuto e favorire i propri interessi. Era più probabile (come vedremo tra poco) che i clans più antichi si sposassero tra loro, offrendo quindi alla prole una distinzione bilaterale, ma in definitiva contava poco chi fossero le madri dei figli dei Morosini, dei Dandolo, dei Gradenigo, dei Falier e delle altre grandi "case vecchie"; il prestigio di quei nomi rendeva sufficiente, quale credenziale per un saldo collocamento all'interno della nobiltà, la sola discendenza patrilineare. Erano invece le famiglie minori, assurte da poco alla nobiltà e dai precedenti politici più modesti, a dover rafforzare la propria posizione con attente strategie matrimoniali, che le legassero ai clans di più saldo prestigio; di preferenza, perché massimo era il loro prestigio, alle "case vecchie".
Indicazioni circa il valore attribuito ai partiti maschi dei clans più antichi ci vengono dai registri "diiudicatum" del notaio Marino, prete a San Tomà, che fu segretario presso la curia del proprio dagli anni Cinquanta ai Novanta del Trecento (178). I registri di Marino contengono molte attestazioni dell'importanza crescente assunta dal matrimonio, e soprattutto dall'alleanza matrimoniale con personaggi dotati di prestigio e di influenza, così come essa si riflette nei livelli delle doti. E queste informazioni gettano luce sul contesto sociopolitico della legislazione contro i bastardi. Anche se, come abbiamo osservato nel paragrafo precedente, l'incoerenza di Marino nell'uso dei titoli rende spesso incerto lo statuto dei diversi individui, possiamo avanzare supposizioni ragionevolmente fondate sulla nobiltà dei personaggi appartenenti alle "case vecchie". Tra il 1366 e il 1391 Marino verbalizzò un numero consistente di sentenze "diiudicatum", che autorizzavano le vedove o i loro eredi a rivendicare la restituzione della dote; in centosettanta di questi casi, in cui viene specificato l'ammontare della dote da restituire alla vedova, i mariti defunti hanno un cognome nobiliare. Sulla base di queste transazioni possiamo ricostruire un quadro complessivo delle doti pagate ai mariti nobili tra la metà e la fine del Trecento.
I livelli medi non furono costanti per tutto il periodo, caratterizzato da agitazioni economiche e sociali; possiamo farci un'idea del loro andamento studiando più da vicino centotrentaquattro di queste sentenze riferite a mariti con nomi nobiliari in cui viene indicato l'anno in cui la famiglia della moglie pagò la dote al marito, cioè l'anno del matrimonio (179). Ne risulta un sorprendente aumento nel livello delle doti dagli anni Trenta agli anni Ottanta. I dati vengono esposti nelle due tabelle che seguono: la prima ricostruisce l'aumento dell'ammontare delle doti esaminando centoventi casi in quattro decenni successivi, in ognuno dei quali sono in numero sufficiente da consentire un confronto decennio per decennio (si noti che le date si riferiscono all'anno in cui la dote fu versata al marito al momento del matrimonio, non a quello in cui fu restituita alla vedova; le cifre sono in ducati) (180):
La tabella 3 dimostra chiaramente che nell'arco di quarant'anni di aumento costante la dote media versata ai mariti nobili fu più che raddoppiata, la mediana quasi triplicata, mentre per le punte più elevate fu in pratica un'esplosione, che le portò a più di tre volte l'ammontare iniziale. Per scelta o per forza, in questo periodo i padri impegnarono somme sempre più consistenti per ottenere partiti desiderabili alle figlie. Ma la tendenza generale non toccò tutti i nobili, poiché non tutti i mariti potevano pretendere doti tanto ricche. All'estremo superiore della seriazione l'aumento fu assai più precipitoso che a quello inferiore, e la divaricazione tra le doti più cospicue e quelle più esigue andò allargandosi col passare degli anni. La tendenza risulta più chiara nella tabella 4 che confronta cinquantasei doti versate a mariti nobili nel periodo 1331-1360 con altre settantotto risalenti al periodo 1361-1390.
Tralasciando il secco incremento generale tra il primo e il secondo periodo, il dato più spettacolare è la divaricazione sempre più ampia tra le doti più ricche e quelle più esigue, cioè tra il primo e il quarto quartile di ciascun periodo. Nei matrimoni contratti tra il 1331 e il 1360 le doti più cospicue (le prime quattordici) erano in media due volte e mezza maggiori rispetto a quelle del quarto quartile, mentre nel 1361-1390 le superavano di 5,3 volte. In altre parole, tra la prima e la seconda metà del Trecento il divario che separava le doti nobiliari più ricche dalle più povere fu più che raddoppiato.
Da queste cifre risulta evidente che se la maggioranza delle famiglie nobili poteva e voleva impegnare ricchezze sempre maggiori nella ricerca di mariti nobili per le figlie, una minoranza non poté o non volle seguirle a ruota. Col finire del secolo la minoranza più povera rimaneva ferma ai livelli di dote degli anni Cinquanta, mentre il resto della nobiltà li aveva portati a somme da capogiro. All'interno della nobiltà trecentesca si svelano quindi due mercati matrimoniali affatto diversi, che in termini sociali equivalevano a due diversi tipi di nobiltà, separati da una distanza sempre più ampia.
I motivi della divaricazione economica rimangono oscuri, perché la storia economica della nobiltà non è stata ancora sottoposta a uno studio sistematico, fondato sull'approfondita ricostruzione di una gamma di esperienze familiari concrete, e attento ai diversi elementi nella composizione della classe segnalati precedentemente. Possiamo però prendere in considerazione la rilevanza all'interno della nobiltà delle diverse pulsioni e potenzialità sociali evidenziate dalle tabelle 3 e 4. E considereremo soprattutto le implicazioni della particolare appetibilità dei partiti delle "case vecchie" sul mercato matrimoniale, indice dei nuovi indirizzi assunti dalla nobiltà sul finire del Trecento.
Com'era prevedibile, data la potenza e il prestigio dei clans "più nobili" per tutto il corso del secolo, la loro rappresentanza ai massimi livelli delle doti è numerosa. Dei cinquantasei mariti che ottennero la dote tra il 1331 e il 1360, un terzo circa, diciotto, appartenevano ai clans più antichi. Non sorprende che facessero la parte del leone con le doti più cospicue: nove delle quattordici doti consistenti (cioè, il primo gruppo relativo agli anni 1331-1360 nella Tab. 4) andarono a mariti di "casa vecchia". Rimanendo ai gruppi della Tab. 4 relativi agli anni succitati, la metà di tutti i mariti di "casa vecchia" rientrava nella fascia superiore delle doti più generose. È chiaro, e tutt'altro che sorprendente, che i clans antichi, i "più nobili", erano presenti in misura sproporzionata nel più ricco dei due mercati matrimoniali di cui si diceva più sopra.
Rimane comunque vero che l'altra metà dei mariti di "casa vecchia" si sposò contentandosi di doti meno ricche; anzi, le somme portate a questi nove uomini
dalle loro spose erano tutte inferiori alla media del periodo, 500 ducati. Proprio uno dei mariti di "casa vecchia", il "nobilis vir" Federico Corner che nel 1346 sposò Agnesina, incassò la dote più esigua tra tutti i nobili in quel periodo, 500 lire "a grossi", pari a 192 ducati (181). Sebbene quindi la preminenza delle "case vecchie" comportasse spesso doti assai consistenti per i loro uomini al momento del matrimonio, non sempre il rango era garanzia immancabile di tanta generosità.
Nel secondo periodo, 1361-1390, la situazione cambiò. La prima differenza è data dalla presenza stessa delle "case vecchie" nei verbali del notaio Marino. Mentre tra il 1331 e il 1360 gli esponenti delle "case vecchie" costituivano poco meno di un terzo dei mariti (diciotto su cinquantasei), nel trentennio successivo corrispondevano a ben più di due quinti, il 43,6% (trentaquattro su settantotto). L'incremento può certo essere una particolare peculiarità del protocollo di Marino, ma potrebbe anche essere dovuto ad un maggiore interesse, nelle famiglie minori sia della nobiltà che del popolo, per l'alleanza matrimoniale con i clans più antichi.
Quest'ultima ipotesi appare ancor più probabile tenendo conto del brusco aumento nell'ammontare delle doti già rilevato per il tardo Trecento: mentre da un lato la maggioranza dei nobili operava sul piano legislativo per eliminare i privilegi di governo delle "case vecchie" nel nome dell'uguaglianza di tutta la classe, gli esponenti minori del ceto dominante lottavano per accaparrarsi il prestigio sociale che distingueva i clans più antichi pagando doti sempre più cospicue per acquistare i vantaggi derivanti dal matrimonio "più nobile". Questa posizione dissociata dei clans più antichi - un prestigio sociale che coesisteva intatto con la diminuzione del potere politico - sarebbe stato uno degli aspetti più rilevanti del panorama nobiliare nel Quattrocento (182).
I registri del notaio Marino confermano questa ipotesi. I maschi delle "case vecchie" vi compaiono come principali beneficiari dell'impennata delle doti nel tardo Trecento: i mariti che ricevettero le otto doti più consistenti nel periodo 1361-1390 erano tutti di "casa vecchia", e così tredici dei diciannove beneficiari delle doti più ricche. Si trattava di somme molto elevate, sia a confronto con le cifre del periodo precedente (1331-1360), sia con la dote media di 873 ducati in quello successivo. Soltanto quattro delle cinquantasei doti portate dalle spose nel 1331-1360 arrivavano a 1.000 ducati, mentre nel trentennio successivo ben più di un terzo delle doti, ventinove su settantotto, ammontavano almeno a quella cifra; e diciotto di esse andarono a uomini di "casa vecchia". Il che equivale a dire che sebbene gli uomini dei clans più antichi costituissero all'incirca il 44% dei settantotto mariti presenti nel periodo 1361-1390, ad essi andò uno sproporzionato 62 % delle doti da 1.000 ducati e oltre. Vi furono infatti contratti che andarono ben oltre quel limite. Nel 1376 (anno della legge contro i figli bastardi) Lorenzo Morosini ebbe una dote di 3.600 ducati dalla moglie Lucia - una somma pari a più del doppio della dote più ricca del periodo precedente (1.676 ducati) (183). La dote di Lucia superava di gran lunga tutte le altre di quel periodo, alcune delle quali però non furono certo trascurabili. Bertuccio Contarini, figlio del doge Andrea, ebbe 2.600 ducati dalla sposa Lucia nel 1370, e un altro Contarini, Marco, ne ebbe 2.700 dal matrimonio con Elena Soranzo (184).
Elena Soranzo era di "casa vecchia", e la sua comparsa in scena allarga la nostra prospettiva sulle pratiche matrimoniali dei clans più antichi, con le quali finivano per scontrarsi gli esponenti delle casate più recenti con ambizioni matrimoniali. La pratica matrimoniale e la politica nobiliare erano questioni strettamente connesse, per le "case vecchie" come per le "nuove", sia pure in modo diverso. Gli effetti concreti della superiore dignità delle "case vecchie" - come veniva espressa, per esempio, nella Cronaca "pseudo-Giustinian" - venivano messi direttamente in discussione dalle leggi del 1370 e del 1376, in cui si asseriva il principio dell'"equalitas" di tutti i nobili.
I clans "più nobili" potevano reagire a questa sfida al loro predominio politico ritirandosi nell'esclusivismo sociale, in una politica di sdegnosa endogamia, abbastanza elastica però da poter raccogliere i vantaggi matrimoniali pratici del loro prestigio. Per le "case nuove", invece, si trattava di far corrispondere all'eguaglianza politica per la quale stavano combattendo nella sala del consiglio una proporzionale crescita della condizione sociale - quella appunto che poteva derivare dal matrimonio con una "casa vecchia". L'incrociarsi di questi due obiettivi, ad un tempo potenzialmente opposti e potenzialmente complementari, ci viene illustrato dalle esperienze matrimoniali di Gasparino quondam Bellello Morosini di Santa Trinità, bisnipote di un procuratore di San Marco, mercante nell'area tradizionalmente veneziana del Levante ed esponente di una delle casate più prestigiose (185). Gasparino si sposò tre volte. La dote che ebbe nel 1367 dalla prima moglie, Lucia, figlia del ricco popolano Bandin de' Garzoni, fu di 4.000 lire "a grossi", equivalenti a 1.538 ducati: al settimo posto tra le doti più ricche registrate dal notaio Marino nel periodo 1361-1390 (186). In precedenza Bandin de' Garzoni aveva dato in sposa un'altra figlia, Caterina, al "nobilis vir" Silvestro Morosini (di un ramo diverso da quello di Gasparino), con una dote di 1.000 ducati (187).
Le nozze di due figlie di un popolano ricco e ambizioso con esponenti del clan Morosini venivano a costituire proprio quel tipo di legami tra "case vecchie" e popolo che contrastava l'aspirazione della nobiltà minore a imparentarsi con i clans più antichi. Ancor peggio, per le "case nuove", era il fatto che quei matrimoni interclassisti, oltre a trasfondere nuova ricchezza nelle "case vecchie", minacciavano anche di deprezzare i privilegi che la maggioranza dei nobili derivava dal proprio statuto, consentendo a dei nuovi arrivati di entrare nella classe dominante in modo informale, scavalcando le procedure, grazie all'appoggio di potenti protettori. È questa la spiegazione più probabile di quelle misteriose e ambigue cooptazioni nella nobiltà di cui si è detto nei paragrafi precedenti, oltre che dell'assenza di qualsiasi attestazione ufficiale di quelle nobilitazioni. Proprio per por fine a queste pratiche la legge elettorale del 1367 e quella sui limiti di età del 1370 irrigidirono le procedure che regolavano lo statuto nobiliare e l'eleggibilità alle cariche.
I matrimoni tra le "case vecchie" e i popolani più ambiziosi aggravavano per le famiglie della nobiltà minore il problema di intessere con i clans più antichi legami capaci di consolidare il loro status. La storia dei matrimoni di Gasparino Morosini induce a ritenere che le "case vecchie" tendessero ad attenersi alla secolare politica endogamica, aprendosi all'esterno in casi eccezionali, quando l'unione con una famiglia popolana come quella di Bandin de' Garzoni, o con una casa di nuova nobiltà che si era posta in evidenza, presentava vantaggi particolari. Questi legami versavano nuova linfa nei patrimoni delle "case vecchie", la cui nobiltà profondamente radicata non vacillava nemmeno di fronte a un matrimonio con il popolo (e che nel 1376 era evidentemente ancora trasferibile ai figli nati da relazioni con donne "vilis conditionis"). Il caso di Gasparino dimostra inoltre come i matrimoni interclassisti potessero forgiare forti legami economici e sociali tra le "case vecchie" e i popolani, scavalcando le casate di recente nobiltà. In un testamento redatto nello stesso anno in cui sposò Lucia de' Garzoni, egli nominava il nuovo suocero popolano suo esecutore (uno di due "commissarii"); e in un testamento successivo, redatto nel 1374, lasciava 50 ducati a ciascuno dei fratelli di Lucia, "per grande amor et raxion chio o portado sempre a quella caxa" (188).
Un'affettuosa considerazione tanto più degna di nota in quanto all'epoca del secondo testamento Lucia de' Garzoni era morta e Gasparino si era risposato, questa volta con Onesta Zane, figlia non di un popolano ma di Maffeo Zane, anch'egli esponente di una "casa vecchia". Pur avendo già un figlio dal primo matrimonio, e nonostante i rapporti che continuava a intrattenere con gli ex cognati de' Garzoni, Gasparino era ancora un partito abbastanza allettante da indurre il padre di Onesta a versare una dote di 2.000 ducati, superiore persino a quella che Gasparino aveva ottenuto dieci anni prima dall'ambizioso Bandin de' Garzoni (189). Le seconde nozze di Gasparino dimostrano dunque che il suo saldo arroccamento nel familiare ambiente delle "case vecchie" non era stato minimamente scalfito dai precedenti rapporti con una famiglia del popolo. Il terzo matrimonio seguì invece la strategia del primo, riportandolo in contatto con i popolani, e questa volta la cosa coinvolse due generazioni. La terza moglie, di nome Agnesina, era la vedova del popolano Pietro da Zara; da questo matrimonio Gasparino avrebbe guadagnato non una dote soltanto - e per la principesca somma di 3.000 ducati - ma due: Gasparino e Agnesina avevano infatti concordato il matrimonio della figlia di lei, Maria da Zara, con il figlio di lui Lorenzo, e il contratto prevedeva che Agnesina versasse al figliastro altri 1.500 ducati per la dote di Maria (190). Con questo doppio contratto matrimoniale Gasparino Morosini procurò dunque alla propria famiglia un totale di 4.500 ducati di ricchezza popolana sotto forma di doti (191).
La storia dei matrimoni di Gasparino dimostra che gli uomini delle "case vecchie" avevano ottimi motivi per sposare donne del popolo, una scelta cui accedevano con minore disinvoltura le "case nuove", preoccupate di non macchiare il proprio rango nobiliare. Per queste ultime le alleanze matrimoniali tra i clans più antichi e i popolani erano indubbiamente fonte di inquietudine, perché contribuivano ad aumentare la ricchezza complessiva delle "case vecchie", e insieme riducevano il numero dei potenziali partiti di "casa vecchia" disponibili per le famiglie più recenti che ambivano a rafforzare la propria posizione per mezzo del matrimonio. Per favorire quindi le proprie politiche matrimoniali, e insieme per limitare le alternative non nobili per i partiti di "casa vecchia", la nobiltà minore aveva interesse a scoraggiare, con mezzi legislativi, i matrimoni tra nobili e popolani.
Dall'andamento successivo dei matrimoni della nobiltà si desume che questo tipo di unione non poté mai essere impedito del tutto, nonostante una sempre più marcata tendenza all'endogamia nella classe dominante del Quattrocento (192). Ma anche se fosse stato possibile, le casate antiche avevano comunque un'ampia scelta di potenziali partiti all'interno della loro cerchia. A dispetto dei benefici economici che Gasparino Morosini e suo figlio ottennero dal matrimonio con popolane, le seconde nozze di Gasparino con Onesta Zane sono assai più conformi alla consuetudine ben radicata nella sua famiglia di contrarre matrimoni nell'ambito delle "case vecchie". La madre stessa di Gasparino non era soltanto figlia di un'antica casata: era nata Morosini, e dunque Gasparino era di sangue Morosini da entrambe le parti. E sebbene il marito di sua sorella Morosina, Piero Venier, appartenesse a una famiglia esclusa dalla cerchia ristretta dei "più nobili", pure i Venier erano tra le "case nuove" più venerabili e distinte. Ad ogni buon conto, l'altra sorella di Gasparino, Beruzza, entrò in un'altra "casa vecchia" scegliendo come marito Marco Soranzo (193).
Considerata nel suo insieme, la vicenda dei Morosini fa pensare a una strategia matrimoniale, nell'ambito delle "case vecchie", con una fondamentale distinzione tra i matrimoni dei maschi e quelli delle femmine; e questo contribuisce a spiegare l'entità delle doti pretese dai mariti appartenenti a quei clans. Come si è già detto, il figlio di Gasparino, Lorenzo, seguì le orme del padre sposando una popolana, la sorellastra Maria da Zara, come previsto dagli accordi che avevano portato al matrimonio di Gasparino con Agnesina, madre di Maria. I fratelli di Lorenzo, Bellello e Nicolò, presero invece una strada diversa, sposando entrambi donne del clan Marcello, una casa di nuova nobiltà.
Nell'insieme, le vicende matrimoniali dei maschi nel lignaggio di Gasparino Morosini indicano una pronta disposizione a sposare donne non appartenenti alla loro categoria, popolane o figlie di "case nuove" che fossero. In netto contrasto con questa tendenza, l'unica donna in quattro generazioni del lignaggio che avesse contratto un matrimonio al di fuori della cerchia delle "case vecchie" fu la sorella di Gasparino, Morosina, moglie di Piero Venier. La strategia appare chiara: mentre i maschi si accaparravano le doti di altre casate, interne o esterne alla nobiltà, tutte le sorelle, le figlie e le nipoti di Gasparino, con l'unica eccezione di Morosina, sposarono partiti di "casa vecchia", e le loro doti non uscirono da quella cerchia elitaria.
La tendenza trova conferma nella storia di un'altra famiglia Morosini, di un ramo diverso della casata. Degli otto figli sposati di Giovanni Morosini, figlio del doge Michele, solo uno, Marco, sposò una donna che non apparteneva a una "casa vecchia": Costanza figlia del "dominus" Lodovico da Cucis, probabilmente uno straniero. L'elenco dei coniugi del resto della prole è una sorta di ruolo d'onore degli antichi clans "più nobili" di Venezia: Badoer, Contarini, Dolfin, Giustinian, Michiel, Morosini e Zeno (194). Una schiacciante prevalenza dell'endogamia tra "case vecchie" favorita anche dall'entità delle doti: nel testamento del 1388 Giovanni aveva destinato 2.000 ducati per la dote di ciascuna delle figlie, i cui successivi matrimoni illustrano la radicata consuetudine endogamica delle "case vecchie", finalizzata allo scambio interno, e dunque alla conservazione, della loro ricchezza collettiva (195). Una consuetudine che rappresentava un ostacolo formidabile per le "case nuove" ansiose di innalzare la propria posizione attraverso matrimoni di prestigio. Le uniche intrusioni degne di nota, come abbiamo visto, erano quelle di donne di altre categorie che rimpinguavano la ricchezza dei clans più antichi con doti sempre più cospicue, e i casi presi in esame dimostrano che nemmeno quella tattica era priva di intoppi: le ricche doti che i padri di "casa vecchia" erano disposti ad investire nei matrimoni con altre "case vecchie", e la disposizione dei maschi di quelle casate a contrarre matrimoni anche al di fuori della nobiltà, quando c'era la convenienza economica.
Questi pochi esempi bastano a far capire il prestigio di cui godevano le "case vecchie" sul mercato matrimoniale, e contribuiscono a spiegare perché i maschi di quei clans potevano pretendere doti principesche, sia dalle "case nuove" che dai popolani. E inoltre costituiscono un contesto in cui inserire la legge del 1376 contro i figli bastardi. Imponendo il matrimonio come requisito per la trasmissione della nobiltà, e collegando formalmente l'onore e la dignità del regime con la condizione sociale delle mogli dei nobili, la legge favoriva un processo di commistione sociale nell'ambito della nobiltà, piuttosto che tra questa e i popolani. La commistione sociale così avviata all'interno della stessa classe integrava l'obiettivo della fusione politica, basato su procedure che imponevano verifiche ufficiali a tutti i nobili, per quanto leggendario il loro cognome, che proprio allora veniva portato avanti dalle leggi del 1367 e del 1370. Nell'intenzione di quei provvedimenti, tutte le famiglie nobili, indipendentemente dalla loro antichità, erano rette dalle stesse leggi e procedure; quanto all'invito rivolto dalla legge del 1376 ai maschi delle "case vecchie" a cercar moglie all'interno della classe dominante, esso si proponeva - non sappiamo con quanta efficacia - una fusione delle diverse categorie di famiglie nobiliari.
Negli anni Sessanta e Settanta del Trecento gli obiettivi di eguaglianza politica e fusione sociale nell'ambito della classe dominante erano ancora difficili da conseguire. Come abbiamo visto, la proposta del 1367 sull'applicazione delle procedure elettorali passò solo al terzo scrutinio. La legislazione contro i figli bastardi del 1376 ebbe vita altrettanto difficile, approvata anch'essa solo al terzo scrutinio, e con una maggioranza di soli dieci voti tra i quattrocentosettantotto consiglieri che parteciparono al ballottaggio (196). Sebbene le leggi del 1367, 1370 e 1376 siano rivelatrici di un'aspirazione a regolarizzare l'accesso e il godimento dei privilegi connessi al rango nobiliare, l'influenza delle "case vecchie" era ancora troppo formidabile, e la determinazione delle "case nuove" ancora troppo fiacca o male organizzata, per trasformare il rigore normativo e procedurale in uno strumento livellatore dei diversi elementi della nobiltà. Sul finire degli anni Settanta, la situazione prese però un'altra piega, accelerando il movimento nella direzione di una seconda Serrata.
Verso la seconda Serrata. La svolta
Sul finire degli anni Settanta i processi sociopolitici interni alla nobiltà che avevano prodotto le iniziative legislative di quello e del decennio precedente furono accelerati dagli effetti di una profonda crisi economica e politica, culminata con la guerra di Chioggia e le sue conseguenze. Non è questa la sede per ricostruire le fasi della congiuntura economica di Venezia tra la metà e la fine del Trecento; ma l'erosione nel tempo della ricchezza privata della tradizionale nobiltà mercantile è questione che tocca il cuore stesso dell'evoluzione della classe dominante. Con la metà del secolo il dissesto provocato dalle ricorrenti recrudescenze della peste coincise con il punto critico della rivalità commerciale, coloniale e navale con Genova, che negli anni Cinquanta e Settanta scatenò guerre costosissime (197). Ne conseguì una riduzione dei profitti dalle speculazioni oltremare, contemporanea all'aumento delle esazioni dello stato sulla ricchezza privata, in quanto il governo doveva sostenere sia la spesa interna che quella militare in un momento di contrazione del reddito dai dazi sulle importazioni (198). Le imposizioni del governo, sotto forma di prestiti forzosi, si accumulavano a ritmo incalzante: nel 1363 il debito garantito dallo stato (il "monte") era di 3,7 milioni di lire "a grossi"; dieci anni dopo si era gonfiato a 6 milioni, e nel 1379 salì ancora, fino a 8,5 milioni - più del doppio rispetto a sedici anni prima (199).
Le incessanti pressioni commerciali e fiscali sul settore privato incisero pesantemente sulla ricchezza della classe di governo. A fronte di queste tensioni economiche, soprattutto nell'ultimo trentennio del secolo, per molte famiglie veneziane mutò la concezione funzionale della nobiltà. Da partecipazione a quella che Frederic C. Lane ha paragonato a una "società per azioni" che governava soprattutto per il profitto commerciale dei suoi membri e della loro città, per molti l'appartenenza alla classe dominante venne a significare accesso alle misure assistenziali specificamente predisposte dal governo a sostegno economico della nobiltà (200). Nell'ambito del medesimo processo, la porzione sempre più consistente di ricchezza privata bloccata nei titoli del monte era negoziabile nelle transazioni dotali che garantivano le alleanze matrimoniali necessarie a consolidare o aumentare lo status delle famiglie. Il vertiginoso aumento nell'entità delle doti, di cui si è detto nel paragrafo precedente, fu facilitato da questa confluenza di motivazioni e di risorse; i lasciti dotali di Gasparino Morosini e di suo figlio Nicolò, di Giovanni del quondam doge Michele Morosini, e come loro di innumerevoli altri, erano in forma di titoli del prestito.
Le circostanze economiche che contribuirono alla trasformazione arrivarono alla fase critica tra la fine degli anni Settanta e gli Ottanta, durante e subito dopo la guerra di Chioggia (1378-1381) contro i Genovesi e i loro alleati. Assediati da una flotta genovese schierata all'ingresso della laguna, i Veneziani videro troncata la linfa vitale dei contatti commerciali con il Mediterraneo orientale. In questa situazione disperata il governo, privo delle consuete entrate dei dazi sulle importazioni, fu costretto a ricavare le risorse per la difesa della città quasi esclusivamente dai prestiti forzosi imposti ai cittadini (201) Gino Luzzatto stimava che il totale dei prestiti esatti in tempo di guerra ammontasse al 107% di tutta la ricchezza privata censibile, per lo più in forma di immobili; Frederic C. Lane calcola che il debito dello stato balzò da 8,5 milioni di lire "a grossi" nel 1379 a 12,8 milioni nel 1381 (202).
Gli effetti furono devastanti per tutti i cittadini veneziani, ricchi e poveri, nobili e popolani. Persino il doge Andrea Contarini, e il Veneziano più ricco nell'estimo del 1378-1379, Federico Corner, dovettero chiedere sovvenzioni. Ma il peso gravava soprattutto sulle persone meno abbienti, che non soltanto vedevano svanire le loro fortune, ma subivano limitazioni legali e politiche nell'impossibilità di far fronte all'incessante martellamento delle imposte (203). Furono le disperate ristrettezze economiche in cui versava un gran numero di nobili, e la risposta che ad esse riuscì a dare il governo, a contrassegnare il momento di svolta nell'evoluzione della nobiltà dopo la Serrata. Negli anni Ottanta il tentativo esitante e ambiguo degli anni Sessanta e Settanta di legiferare norme più rigorose per la determinazione dello statuto nobiliare e la definizione dei doveri e dei privilegi ad esso legati si trasformò in un indirizzo politico concertato: il nuovo indirizzo che costituisce appunto la seconda Serrata.
Durante l'assedio molti nobili, privi dei mezzi per sostenere i prestiti forzosi, videro i loro immobili confiscati e messi all'asta dal governo per realizzare le somme necessarie. Un esempio di questi sequestri fu la "possession Branda" di Ca' da Pesaro a San Giacomo dall'Orio, valutata 15.000 lire "a grossi". Leonardo Venier, accatastato per 3.000 lire "a grossi", versava ora in tale povertà che "non habet unde vivere", e fu autorizzato a vendere immobili vincolati in perpetuo alla linea maschile della sua famiglia per far fronte agli impegni (204). Gino Luzzatto concludeva il suo studio sulle traversie di questi nobili affermando che si trattò di "un vero rivolgimento di fortune e di situazioni sociali", che "economicamente e socialmente deve aver portato delle conseguenze assai più profonde, creando, accanto alla vecchia nobiltà, notevolmente diminuita ed in parte stremata di forze, una categoria abbastanza numerosa ed agguerrita di nuovi ricchi, che deve aver avuto larga parte nella più rapida espansione capitalistica della società veneziana nel secolo successivo" (205).
Di questa nuova razza di audaci facevano parte i trenta personaggi nobilitati dal senato immediatamente dopo la fine della guerra. Nel dicembre 1379, nei giorni più bui dell'assedio, nel momento più disperato della situazione militare e fiscale, il consiglio speciale di savi di guerra nominato a guidare la difesa approvò un provvedimento che concedeva la nobiltà a trenta popolani che avessero contribuito in misura straordinaria allo sforzo bellico (206); i popolani accorsero numerosi, mettendo a disposizione del governo le loro persone, i figli, i servi, l'intera fortuna (207). Il 4 settembre 1381 il senato votò per scegliere i trenta fortunati (208): le famiglie prese in considerazione erano cinquantotto, sessantadue i candidati individuali, compresi quarantasette nomi il cui contributo, o quello di loro parenti, è documentato da fonti quasi contemporanee (209).
I motivi del successo dei trenta personaggi che ottennero i voti necessari per la nobilitazione, e della sconfitta degli altri trentadue, rimangono un provocante mistero. Senza dubbio molti sacrifici eccezionalmente generosi sostenuti da popolani per lo sforzo bellico, quei sacrifici che la promessa della nobilitazione intendeva stimolare, furono debitamente premiati. Nove dei trenta avevano armato galere nella flotta che salpò nel luglio 1380 per attaccare gli assedianti genovesi (210). Altri avevano contribuito generosamente in altri modi: Francesco de Mezzo, per esempio, si guadagnò la nobiltà offrendosi volontario per la flotta con tre servitori, e sostenendo in proprio tutte le spese, pagando il soldo di dieci balestrieri per due mesi (in tutto 160 ducati) e donando alla Signoria 10.000 lire "a grossi" in titoli del prestito (211). Da un esame delle quarantasette offerte documentate risulta però evidente che l'entità dei contributi non fu il fattore decisivo per la nobilitazione di certi candidati piuttosto che di altri. Molti dei respinti avevano fatto offerte almeno altrettanto cospicue: Tomaso da Buora, per esempio, come Francesco de Mezzo si era offerto volontario a proprie spese, con un compagno e un servitore, per l'attacco contro gli assedianti genovesi; aveva inoltre donato un mese di soldo per cinquanta balestrieri e cinquanta rematori, in tutto 600 ducati, e la rendita dei suoi titoli sul monte per 6.000 lire "a grossi". Ma la sua candidatura fu seccamente respinta, con trentadue voti contro sessantuno (212). Anche Piero Regia offrì il suo servizio in galera, il soldo per dieci balestrieri per due mesi (160 ducati), e quello per altri dieci per tutto il tempo in cui le galere sarebbero rimaste in azione. Inoltre aveva prestato al governo 3.000 ducati d'oro in contanti, accettando il rinvio del rimborso a due mesi dopo la fine della guerra. Pur avendo Regla ottenuto una maggioranza di cinquantaquattro voti contro quarantatré, era comunque al di sotto di quelle conquistate dai trenta vincitori (213).
Se questi e altri generosi donatori non riuscirono a ottenere lo scopo, non si può certo dire che alcuni dei neonobilitati si fossero distinti per l'entità dei loro contributi. Antonio Darduin, Marco Orso e Giovanni Negro non compaiono nelle liste delle offerte, eppure ottennero la nobiltà rispettivamente con sessantacinque voti contro ventitré, sessantaquattro contro ventitré e cinquantotto contro quaranta (214). Altri promossi diedero invece un contributo, ma assai più modesto di quelli dei rivali respinti: Donato da Porto, per esempio, che con sessantotto voti a favore risultò undicesimo tra i più votati, aveva offerto soltanto il proprio servizio volontario nella flotta e il soldo per dieci balestrieri per due mesi, per un valore di 160 ducati; Nicolò Polo fu nobilitato con sessantadue voti pur avendo offerto solo il proprio servizio con due servitori, e il soldo di due balestrieri per due mesi (32 ducati) (215) - sacrifici di ben poco conto rispetto a quelli di da Buora e Regia, e di altri candidati respinti.
È ovvio che altre considerazioni oltre alla generosità patriottica concorrevano a determinare il successo o la sconfitta di ciascun candidato. Il caso di Piero Regla ci fornisce utili indicazioni in questo senso. Inserita in quella fascia di popolo facoltoso che Dennis Romano definisce "popolo grande", da parecchie generazioni la famiglia Regla contraeva matrimoni con personaggi dal cognome nobiliare (216); solo in due casi però con coniugi appartenenti ai clan Venier e Barbaro - si trattò di cognomi corrispondenti alle famiglie politicamente più in vista del Trecento (si veda la Tab. 2-B). E nel contempo, diversamente da tanti nobili messi alle strette, che videro confiscate le loro proprietà per il mancato pagamento dei prestiti forzosi, la fortuna di Piero Regla sopravvisse intatta agli anni di guerra. Valutato nell'estimo a 14.000 lire "a grossi" - una stima che lo collocava nel 3,6% dei più ricchi patrimoni imponibili - alla fine della guerra era ancora in grado di acquistare, per 2.000 ducati in "pecuniam contantam", una proprietà rientrante nella "commissaria" del "quondam nobilis viri" Jacopo da Molin posta all'asta dal governo a copertura del prestito forzoso (217). E inoltre poteva permettersi di intestare ai figli del fratello Zanino un lascito di 10.000 ducati (218).
Nonostante la sua ricchezza, e la generosità patriottica, a Piero Regla mancavano però i legami con le "case vecchie". Una situazione ben diversa, dunque, rispetto a quella dei de' Garzoni, che come abbiamo notato nel paragrafo precedente si erano legati in matrimonio con due diversi rami dei Morosini. I due figli del ricco Bandin de' Garzoni, i due ex cognati per i quali Gasparino Morosini nutriva "grande amor e raxion", furono nobilitati con lo scarto di voti maggiore tra tutti i candidati, settantotto a favore e solo tredici contrari (219). Va detto, certo, che Bandin de' Garzoni, che con 50.000 lire "a grossi" in titoli del monte era uno dei quattro veneziani al vertice dell'estimo, di tutti i volontari popolani era stato quello che aveva offerto l'insieme più cospicuo di contributi all'impegno di guerra (220); era stato tanto generoso, anzi, che nel gennaio 1381, otto mesi prima della selezione dei trenta nuovi nobili, i suoi figli si videro costretti a vendere una proprietà per far fronte agli oneri fiscali (221).
Tutti questi fattori contribuirono senza dubbio a favorire la causa della nobilitazione dei de' Garzoni: la generosità patriottica, i problemi economici che dovettero affrontare in conseguenza di tanti sacrifici, gli ormai consolidati legami con le casate più antiche e influenti; a conti fatti, però, è probabile che per i de' Garzoni, come per gli altri nuovi nobili, l'elemento decisivo fosse stato la familiarità con le case nobiliari dominanti. In poche parole, i candidati più vicini agli autorevoli magistrati che selezionarono ed elessero i nuovi nobili godevano di un naturale vantaggio sugli altri.
Anche Piero Regla e i suoi parenti avevano legami con la nobiltà, che sicuramente li aiutarono a conquistare il favore di una maggioranza degli elettori; ma il fatto che egli fosse riuscito a superare in floride condizioni economiche i rovesci della guerra suscitò forse le invidie di un numero di senatori ridotti alla rovina sufficiente a fargli perdere i voti decisivi - anche perché i suoi protettori nella nobiltà non avevano influenza ai massimi livelli politici: dove tale influenza pesava davvero, era quando si arrivava al conto dei voti.
Oltre ai concorrenti popolani con ottime relazioni come i de' Garzoni, Regla doveva competere infatti con altri che godevano di un ulteriore vantaggio: quello dei legami di parentela con la nobiltà. Ne è un perfetto esempio Francesco de Mezzo, significativamente identificato come "nevodo [nieuo] de ser Lucha" (222); quel Luca de Mezzo che, valutato a 30.000 lire "a grossi", era una delle tredici persone più ricche nell'estimo, ed era presumibilmente un nobile (223). Nasce il sospetto che suo nipote Francesco fosse un bastardo, o il figlio di un bastardo, la cui ineleggibilità in maggior consiglio - recentemente confermata dalle legge contro gli illegittimi del 1376 - fu opportunamente scavalcata dal peso della ricchezza dello zio all'indomani della guerra di Chioggia. Lo stesso valeva probabilmente per gli altri undici candidati con cognomi nobiliari che conseguirono la maggioranza necessaria nei ballottaggi del senato: Giovanni e Antonio Darduin, Francesco Girardo, Nicolò Longo, Paolo Nani, Marco Pasqualigo, Nicolò Polo, Nicolò Renier, Nicolò Taiapiera, Paolo e Giacomo Trevisan: con l'eccezione di Renier, tutti cognomi di famiglie appartenenti alla classe di governo prima e dopo la Serrata. E anche i Renier, misteriosamente affiorati tra i detentori di cariche negli anni Cinquanta e Sessanta del Trecento, erano ormai personaggi ben conosciuti nella classe dominante (224). Diversamente dai Regla, questi candidati offrivano quindi ai senatori le garanzie della consuetudine e dell'antichità.
È probabile che i nuovi nobili con cognomi già ben noti appartenessero a rami non documentati o illegittimi delle famiglie nobiliari. In quegli stessi anni altri personaggi il cui potenziale diritto alla nobiltà non era stato adeguatamente tutelato furono bruscamente richiamati alla necessità di regolarizzare la propria posizione dall'attenzione affatto nuova con cui gli avogadori di comun esaminavano le credenziali degli aspiranti nobili. Per buona parte del secolo gli avogadori si erano curati ben poco delle richieste di accesso allo statuto nobiliare, sebbene fin dal 1319 avessero ricevuto la responsabilità di verificarne la validità; nel 1324 (l'anno dopo l'approvazione della legge che imponeva la successione patrilineare come requisito per lo statuto nobiliare) l'avogaria cominciò a registrare per iscritto le proprie deliberazioni, ma la prima discussione di un caso di nobiltà disputata compare nelle sue Raspe soltanto nel 1342 (225).
Nei vent'anni successivi gli aspiranti furono tenuti a dimostrare la validità delle proprie credenziali con procedure registrate nelle Raspe, alcuni con successo, altri senza riuscirvi, ma i casi sono tanto pochi, rispetto alle decine di persone che dovevano entrare in maggior consiglio ogni anno, da confermare un esercizio alquanto superficiale della giurisdizione dell'avogaria nel periodo dopo la Serrata (226): il primo caso documentato di credenziali accettate non compare anzi prima del 1348 (227). Che fosse passato un quarto di secolo tra la promulgazione delle leggi restrittive e la prima imposizione a un nobile qualificato dell'obbligo della prova dimostra quindi che la stragrande maggioranza dei richiedenti ottenne dagli avogadori il beneficio del dubbio, il cui esercizio veniva appunto lasciato alla loro discrezione dalla legge del 1323. E tanta indifferenza aiuta a capire come mai fino a oltre la metà del secolo compaiano tra i detentori di cariche tanti personaggi provenienti da famiglie la cui nobiltà prima della Serrata non è in alcun modo documentata.
Già a partire dagli anni Sessanta, comunque, gli avogadori diedero prova di una maggiore attenzione alla validità delle credenziali degli aspiranti. Negli atti dei processi compaiono i primi riferimenti a documenti ufficiali ("quaternos communis") utili alla valutazione così dei casi approvati come di quelli respinti (228); solo negli anni Ottanta, però, essi cominciarono ad impiegare appieno le potenzialità investigative della loro carica. Il nuovo rigore coincise con una maggiore attenzione legislativa ai requisiti della nobiltà, e con la puntigliosa solennità che accompagnò la cooptazione dei trenta nuovi nobili nel 1381; la stessa legge del 1376 contro gli illegittimi offriva un nuovo criterio specifico di valutazione.
Nel 1381, ad esempio, gli avogadori invitavano a respingere la richiesta di ammissione in maggior consiglio di Meneghino Nadal in quanto i genitori si erano sposati dopo la sua nascita. L'invito degli avogadori - accolto dal collegio ducale, sia pure soltanto al terzo ballottaggio - si rifaceva esplicitamente alla nuova legge ("quia non poterat esse [de maiori consilio] vigore cuiusdam consilii capti 1376 die 28 mensis decembris") (229). La nuova puntigliosità caratterizzava gli interventi degli avogadori anche a fronte di riscontri favorevoli: nel 1390, ad esempio, indagando sul sospetto che il "nobilis vir" Ordelaffo Falier quondam Piero fosse nato al di fuori del matrimonio, essi accertarono sulla base di alcune testimonianze che sebbene Piero avesse avuto rapporti sessuali con la madre di Ordelaffo anche prima di sposarla, il figlio era nato dopo le nozze ("post disponsationem"), e dunque la lettera - se non lo spirito - della legge del 1376 poteva dirsi rispettata; il collegio ratificò i risultati dell'inchiesta, confermando la nobiltà di Ordelaffo (230).
Gli ultimi vent'anni del Trecento videro un ricorso senza precedenti alle procedure ufficiali da parte di personaggi come Ordelaffo Falier che aspiravano al riconoscimento formale del proprio statuto nobiliare. I nobili cretesi, in particolare, si affannarono per ottenere la ratifica ufficiale dopo un decreto del senato che concedeva una grazia ai discendenti di coloro che erano stati privati della nobiltà per aver aderito alla ribellione di Creta contro il dominio veneziano negli anni Sessanta (231). E si trattava di una preoccupazione tanto impellente che in almeno due occasioni, sul finire del decennio, furono richieste e ottenute grazie che concedevano a figli di nobili non ancora in età di sottoporre alla verifica ufficiale le loro credenziali di nobiltà: Antonio di Piero Gradenigo, di sette anni "vel circha", e Zanino e Pierino di Jacobello Querini, rispettivamente di dieci anni "vel circa" e di sette mesi "aut circa", tutti cretesi, furono autorizzati a documentare la propria ascendenza nobiliare nonostante la giovinezza, perché i genitori e i parenti avrebbero potuto non vivere abbastanza a lungo da produrre adeguate credenziali di nobiltà per i fanciulli una volta che questi avessero raggiunto l'età prevista di diciotto anni (232).
In entrambi i casi si ribadiva con forza che i fanciulli discendevano da membri del maggior consiglio ("maioris consilii, de quo antecessores sui fuerunt") (233): e proprio questo specifico criterio di nobiltà veniva applicato dagli avogadori con un'assiduità senza precedenti. L'insistenza del suo ricorrere incoraggia a ritenere che la cooptazione del 1381 avesse concentrato l'attenzione della classe dominante sul criterio dell'esperienza ancestrale di governo fissato in origine dalla Serrata: la comparsa di trenta uomini che ne erano privi per definizione acuiva nella nobiltà la consapevolezza del suo significato. Una consapevolezza che, in un momento in cui i nobili in quanto categoria andavano asserendo, nelle premesse ai decreti legislativi, la dignità particolare del proprio statuto, e il nesso indissolubile che lo legava all'onore e al benessere della società veneziana, ribadiva la determinazione a salvaguardarne l'integrità imponendo come mai prima di allora il rispetto delle procedure destinate a tutelarne l'esclusività.
Con gli anni Novanta, alla superficialità che aveva caratterizzato la verifica avogaresca delle credenziali di nobiltà negli anni Quaranta e Cinquanta si era ormai sostituito un controllo puntiglioso, con un'attenzione esplicita per la "genealogia" dei candidati - un termine, questo, fino ad allora del tutto assente, o usato assai di rado, nei documenti ufficiali (234). È possibile che il nuovo rigore, per cui lo statuto nobiliare veniva riferito in modo sempre più stretto alla documentata discendenza da chi già aveva fatto parte del maggior consiglio, fosse una diretta conseguenza dei risentimenti provocati dalle nobilitazioni del 1381. Già nel 1379 un decreto dei savi di guerra che autorizzava le cooptazioni aveva anticipato l'opposizione cui sarebbero andate incontro; approvato il provvedimento con quarantacinque voti a favore e soltanto quattro contrari e quattro astensioni, i savi avevano ritenuto necessario prevedere dure sanzioni contro i possibili oppositori delle cooptazioni: "[...] pro quolibet ponente vel consentiente partis revocationem vel declarationem in contrarium [...]" si sarebbe visto privare del suo rango nobiliare e spogliare dei suoi averi (235). Solo la prospettiva di una forte opposizione in maggior consiglio può spiegare la minaccia di misure tanto draconiane contro chiunque avesse anche soltanto criticato il provvedimento.
Nel 1379 le potenti famiglie i cui esponenti sedevano nel consiglio dei savi e in senato avevano peraltro già avuto modo di verificare più volte la consistenza dell'opposizione in quelle tendenze restrittive che si andavano diffondendo nell'ambito della nobiltà minore, che avevano prodotto le leggi del 1367, 1370 e 1376, e che ora si facevano ancor più insistenti a seguito dei rovesci economici della guerra di Chioggia. La maggioranza delle "case nuove" era già impegnata in un'aggressiva politica di tutela della propria posizione, infiorandola con un nuovo linguaggio legislativo tutto giocato sulla "solenne dignità", sull'"onore", e sul disprezzo per la prole delle donne di "vile condizione" la cui presenza l'avrebbe denigrata (236). Agli occhi di queste famiglie la cooptazione di trenta facoltosi nuovi arrivati poteva apparire come l'ennesima manovra delle casate tradizionalmente dominanti per consolidare il proprio potere inserendo loro clienti nella classe di governo - un sospetto che, ad esempio, non poteva che risultare confermato dai precedenti legami matrimoniali dei de' Garzoni con i Morosini. Tanto più che negli anni Ottanta i de' Garzoni, i Lippomano, i Vendramin, i Paruta e gli altri nuovi nobili non si presentavano soltanto come pericolosi rivali nella corsa al potere e alla conquista dei partiti più prestigiosi sul mercato dei matrimoni: i nuovi arrivati erano una minaccia anche sul terreno stesso dei mezzi della sopravvivenza economica.
I rivolgimenti degli anni di guerra avevano infatti portato ulteriori vantaggi allo statuto sociale e politico legato all'appartenenza alla nobiltà. A partire dagli anni Ottanta i nobili potevano beneficiare dei programmi istituzionali impostati dal governo per sostenerli in quelle difficili circostanze economiche; e di quel sostegno avevano disperato bisogno. Nel luglio 1383, con le finanze pubbliche ancora schiacciate dal peso della recente guerra, il maggior consiglio votò l'espulsione di tutti i nobili che non avessero ottemperato agli obblighi fiscali (237): un provvedimento chiaramente troppo drastico, che minacciava un numero eccessivo di famiglie. Tre mesi dopo, quindi, esso fu emendato per consentire ai nobili davvero privi dei mezzi per pagare ("impotentes ad solvendum") di ricorrere in quarantia; se fossero riusciti a convincere i due terzi di quella magistratura delle disperate ristrettezze in cui versavano, avrebbero conservato la nobiltà (238): una concessione di importanza cruciale, in quanto restituiva loro la possibilità di accedere alle cariche. E negli anni Ottanta l'intervento sempre più diretto del governo a sostegno dei privati in difficoltà aveva trasformato le cariche in una risorsa economica di primaria importanza.
All'inizio del 1386 il maggior consiglio approvò un decreto che proibiva a chi fosse stato nominato "patron" di una galera da mercato di accettare contemporaneamente l'elezione a rettore di uno dei possedimenti veneziani. La premessa del decreto dichiarava che "non est conveniens multiplici ratione [...] quod unus noster nobilis tali modo habeat duo sic notabilia beneficia [...]. Et utile sit providere super hoc, ut omnes participent de honoribus et beneficiis terre" (239).
Seppure regolarmente applicato anche in passato, negli anni Ottanta il principio che l'accesso alle cariche fosse un privilegio anche materiale dello statuto nobiliare divenne un tema ricorrente, specificamente ricondotto agli effetti della guerra di Chioggia (240). Nel 1387, per esempio, Bernardo Falier ottenne un'esenzione dal limite di un anno imposto alle cariche concesse per grazia per consentirgli di riprendersi dai "magna damna" sostenuti "in guerra preterita faciendo et supportando onera terre". All'inizio del 1389 Paolo quondam Romeo Querini ottenne per grazia la riduzione dei termini di una sentenza che gli impediva di assumere il comando di una galera da mercato, in quanto aveva prestato onorevole servizio come "patronus" di una galera per tutto il corso della recente guerra, venendo anche ferito. In quello stesso anno Francesco Bembo ottenne una grazia analoga perché "sicut notum est, donatio nostra semper fuit et est solita, suos bonos cives in gracia habere recommessos, et specialiter quando posuerunt vitas et corpora ad honorem et statum comunis Veneciarum". Bembo era doppiamente meritevole di gratitudine perché suo padre, "existens in servicio comunis sicut provisor in partibus Tenedi, fuit crudeliter mortuus a Turchis; et ipse ser Franciscus in guerra proxime preterita, in terra et in mare, et in galeis et in partibus Clugie, fidelissime se gessit et fuit vulneratus in persona ab inimicis in novero locis, ad honorem et statum istius benedicti dominii, et semper perseveravit usque guerram finitam, et sic est dispositus facere donec vita erit corpori, leto, et bono animo" (241).
Sono casi che rivelano in quale misura, quasi un decennio dopo la sua conclusione, l'esperienza della guerra di Chioggia rimanesse profondamente radicata nella memoria ufficiale, per il lacerante trauma collettivo che aveva inflitto alla comunità veneziana, e per i perduranti effetti delle sue devastazioni sulle fortune private dei nobili come della gente comune. L'intrecciarsi di una diffusa miseria privata con la memoria pubblica di una profonda esperienza collettiva influì a sua volta sull'atteggiamento dei nobili nei confronti della propria condizione di classe, e sulla politica nobiliare del governo. Tutti gli elementi dell'associazione, senza precedenti, dell'onore del regime con la tutela della situazione economica dei singoli nobili sono vivacemente riassunti in una petizione di grazia presentata al maggior consiglio agli inizi del 1388. Appellandosi all'"innata" consuetudine del governo di venire in aiuto "suis civibus nobilibus in eorum necessitatibus", specie quando "non suo defectu ad inopiam devenerunt", la petizione riferiva le misere circostanze in cui versava "vir nobilis" Ranieri Premarin, "civis noster, qui semper in agendis et servitiis dominii, in quibus fuit, fideliter et laudabiliter se gessit", e ora "ad debilem conditionem sit deductus, propter multam familiam qua multipliciter est gravatus, cum quatuor creaturas parvulas habeat ad alendum. Ex quo pietatis opus sit sibi misericorditer subvenire, quia aliquale onus terre huius est quod nostri nobiles mendicantes intotum deserantur" (242). Il consiglio assegnava quindi a Premarin una castellania biennale a Creta, o qualche altra carica pubblica nell'isola, "ut dictus pauper nobilis noster, in sua tanta extremitate cum suis creaturis parvulis, se valeat substentare".
Il rilievo di questo caso - uno fra tanti - non sta tanto nel fatto che Ranieri Premarin venisse sollevato dalla sua disperazione, bensì negli argomenti addotti a giustificare l'intervento: il franco riconoscimento del fatto che nel tardo Trecento esisteva già una categoria di "nostri nobiles mendicantes"; che le difficoltà domestiche dei nobili toccavano gli interessi "huius terre"; che Premarin andava aiutato perché "semper in agendis et servitiis dominii [...] fideliter et laudabiliter se gessit"; e che la sovvenzione che gli veniva dallo stato assumeva la forma della nomina a un rettorato. Sono tutti elementi, questi, della nuova ideologia nobiliare che andava prendendo forma nel tardo Trecento, e che sarebbero divenuti aspetti nodali del mito di Venezia nel Rinascimento. Ci rimane da osservare in quale modo questi fattori, conseguenze nel breve periodo del trauma della guerra di Chioggia, si inseriscano nelle tendenze di lunga durata dell'evoluzione della nobiltà nel Trecento.
La nobiltà nel 1400
Agli elementi della politica nobiliare del governo dopo la guerra di Chioggia di cui si è detto sinora ne va aggiunto un altro, anch'esso in grande evidenza nei documenti ufficiali: il collegamento tra la nuova ideologia nobiliare e le più venerande tradizioni della classe di governo che risalta a chiare lettere dalla risposta data nel 1388 dal maggior consiglio alle suppliche dell'ennesimo nobile in "pauperima conditione". Due mesi dopo aver soccorso Ranieri Premarin e le sue "creaturas parvulas", il consiglio nominò "caput advocatorum" di Creta il "nobilis vir" Piero Loredan, nipote di un procuratore di San Marco. Ancora una volta si trattava di un atto di pietà, essendo "secundum deum et honorem nostri dominii compati dicto nostro nobile", ma in questo caso i meriti di cui si teneva conto non erano quelli acquisiti personalmente da Piero Loredan, bensì "bonis operibus progenitorum suorum" (243). La virtù civica accumulata da ca' Loredan, di cui Piero era erede in quanto esponente della casata, dava sostanza al suo appello alla pubblica benevolenza, espressa nella forma quintessenzialmente nobiliare della nomina a una carica.
Associando il privilegio dell'accesso alle risorse pubbliche con il merito politico ereditato, il maggior consiglio ampliava la portata degli obiettivi della Serrata del primo Trecento. Formalmente, allora, ci si era proposti di limitare la partecipazione al governo alle famiglie che già ne avevano l'esperienza, anche se - come abbiamo più volte rilevato nelle pagine precedenti - i meccanismi procedurali o la volontà politica necessari alla realizzazione di questo obiettivo furono alquanto carenti per buona parte del secolo. Ma poiché il potere, la ricchezza e il prestigio erano saldamente in mano ai clans i cui venerabili precedenti non dipendevano in alcun modo né dalle procedure, né dagli atti di grazia, sul piano politico ai loro rappresentanti interessava ben poco se qualche nobile di dubbia provenienza riusciva a intrufolarsi nella cerchia privilegiata, o se qualche altro nobile non si curava di far ratificare i propri titoli: lo statuto e il potere delle famiglie "più nobili" e più autorevoli non ne sarebbero certo stati intaccati; anzi, il lassismo delle procedure lasciava maggiore spazio alle loro manovre clientelari.
Negli anni Ottanta, invece, la situazione era ben diversa. Dall'essere riconosciuti come nobili non dipendeva più soltanto l'appartenenza alla classe di governo, ma anche l'accesso ai programmi di assistenza economica che per molti costituivano l'unica alternativa alla disperazione. Certo, per un Falier, un Querini, un Bembo, tutti esponenti di "case vecchie" profondamente radicate nella cultura politica veneziana, il diritto a beneficiare di quei programmi doveva apparire come cosa naturale. Ma per un Premarin, e persino per un Loredan, così come per la grande maggioranza delle "case nuove", le antiche tradizioni non erano di per sé sufficienti, perché non era abbastanza salda la loro identificazione culturale con quelle tradizioni. Alle casate più recenti occorreva una certificazione esplicita della propria appartenenza alla classe privilegiata; per questo, poiché a Venezia lo statuto nobiliare significava ormai tanto poter governare, quanto poter ricavare benefici materiali dal governo, divenne sempre più importante che la distinzione discriminante che derivava dall'avere dei "progenitores" nobili non fosse scritta tanto nella leggenda e nella storia, bensì nell'esperienza recente, e in documenti ufficiali consultabili.
Le nove ferite patite da Francesco Bembo, il fedele servizio di Ranieri Premarin, la dignità procuratoria del nonno di Piero Loredan: tutto veniva ora registrato nella medesima memoria ufficiale accanto alle "genealogie" ricostruite dalle ricerche condotte dagli avogadori di comun sui documenti del governo. La discendenza patrilineare e il contributo dato al benessere dello stato si fondevano a costituire la componente essenziale della nobiltà - a condizione che avessero soddisfatto il nuovo requisito della certificazione formale da parte di determinati organismi di governo: in via eccezionale, come per le speciali grazie concesse dal maggior consiglio nell'emergenza della guerra di Chioggia, per via ordinaria quando si trattava della ratifica delle credenziali nobiliari da parte degli avogadori di comun. Queste formalità iscrivevano l'individuo e la sua famiglia nella comunità esclusiva, privilegiata e solidale dei "nobiles nostri", che comprendeva lignaggi antichi e recenti, famiglie ricche e povere, in quell'unico organismo le cui identità e dignità collettive venivano ormai ufficialmente proclamate, in modo sempre più frequente e esplicito, coincidenti con l'onore dello stato veneziano.
Se l'appartenenza a questa comunità dava accesso a nuovi privilegi, questo accesso veniva però regolamentato da nuove restrizioni. Poiché tanti nobili dipendevano dalle cariche riservate alla loro classe, la distribuzione delle cariche stesse e i loro emolumenti dovevano essere accuratamente proporzionati. Un decreto del maggior consiglio dell'agosto 1392 evidenzia in quale misura la logica del beneficio influenzasse le scelte politiche in materia di cariche pubbliche. Ribadendo ancora una volta nella premessa il principio dell'onore del regime, il provvedimento aumentava gli stipendi previsti per quattordici "officia nostra de minoribus, in quibus eliguntur continue de nostris pauperibus nobilibus, qui nullo modo possunt ex illis vivere, nec vitam suam ducere cum familiis suis" (244).
Una decisione, questa, che dimostra come le singole grazie concesse negli anni Ottanta e Novanta non erano soltanto la continuazione di una pratica consolidata, ma rientravano in un preciso programma assistenziale per la nobiltà, inaugurato dopo la guerra di Chioggia, in cui la carica pubblica veniva intesa come beneficio. E dimostra anche che l'onore del regime, già nel 1376 collegato con le qualità personali dei membri del maggior consiglio, si estendeva ora a comprendere il benessere delle famiglie dei singoli nobili.
La rilevanza della dimensione familiare risalta anche da un decreto del 1384, che dimostra come l'attenzione per il benessere economico dei nobili si collegasse con un impulso presente anche prima della guerra di Chioggia: l'esigenza di una maggiore equità nella distribuzione dei privilegi nobiliari che fu alla base della legge del 1367 per la regolamentazione delle nomine dei rettori, e di quella del 1370 sulla verifica obbligatoria dei limiti di età per i giovani che entravano in maggior consiglio. Il decreto del 1384 si apriva ribadendo quasi alla lettera i requisiti previsti dalla legge del 1370, quindi si diceva preoccupato perché nessun controllo veniva praticato "ad providendum de iuvenibus nostris qui continue eliguntur et fuerunt in aliis officiis et regiminibus nostris" (245). Stabiliva dunque che da quel momento ogni "iuvenis" eletto per la prima volta a un incarico dovesse dimostrare agli avogadori di comun di possedere i requisiti di età specifici per quell'ufficio; chiunque avesse falsificato la propria età doveva essere multato per 200 lire. Si prevedeva inoltre che quando il neoeletto a un incarico si presentava a prestare giuramento di fronte al consiglio ducale, i segretari verificassero se aveva superato l'esame degli avogadori. E infine, significativamente, si stabiliva che chiunque denunciasse un minore abusivamente in carica avrebbe ricevuto in premio un terzo della sanzione di 200 lire.
Quest'ultimo elemento indica che tra loro i nobili erano disposti a porre in evidenza le rispettive manchevolezze quanto ai requisiti per l'eleggibilità alle cariche, e che il governo era ben disposto ad approfittare di questo controllo reciproco per imporre la propria normativa. Il decreto lascia quindi intravvedere la corsa alle cariche che ormai agitava la nobiltà, e che rendeva tanto più urgente l'esigenza di procedure per una loro più equa distribuzione. La nuova legge fu gradita dalla grande maggioranza del consiglio: duecentoquarantasei voti a favore delle nuove strettezze, e soli quarantaquattro contrari, con nove astenuti ("non sinceri").
Norme come questa erano dovute alla consapevolezza, comune alle famiglie nobilitate di recente e alle "case vecchie" oggi in difficoltà, dei generali vantaggi offerti da una legislazione che limitasse l'accesso ai privilegi nobiliari, regolandone la distribuzione tra chi poteva goderne. Ma servirono anche ad accelerare due correnti più profonde nella politica del governo verso la classe dominante. Le norme che regolavano la concessione delle cariche innestavano ancor più a fondo nella cultura nobiliare il principio che la determinante essenziale della condizione di classe di tutti i nobili, al di là dell'antichità e del prestigio del loro lignaggio, era quella legale, procedurale. Così come, dopo il 1376, i figli bastardi dei potenti avevano trovato alquanto difficile (se non impossibile) sedere a fianco dei loro padri in maggior consiglio, ora anche i figli legittimi - fossero di "casa vecchia", della maggioranza delle "case nuove", o della fresca nobiltà del 1381 - dovevano prestarsi a dimostrare di essere qualificati per la carica.
Fu nel contesto di questa asserzione sempre più energica di impersonale rigore procedurale che il 27 agosto 1387 il maggior consiglio annullò le elezioni effettuate in quel giorno perché Nicolò quondam Andrea Morosini era stato compreso nelle liste pur non essendo ancora stato "probatus" per il maggior consiglio. All'indomani della guerra di Chioggia le difficoltà dei privati e gli interventi del governo accelerarono la tendenza verso una maggiore eguaglianza tra i nobili per il mezzo delle procedure amministrative.
La seconda tendenza manifesta nella legge del 1384 è data dall'enfasi sulla distinzione in base all'età: quasi ad annunciare il costante interesse legislativo del Quattrocento, la legislazione degli anni Ottanta e Novanta del Trecento delineava in modo assai più netto i ruoli specificamente assegnati alle diverse fasce di età. I rampolli della nobiltà già erano stati oggetto delle leggi del 1370 e del 1376, con le quali la classe dirigente asseriva i principi fondamentali della propria abilitazione a governare facendo riferimento al cruciale momento di transizione in cui gli esponenti della nuova generazione venivano introdotti al governo. Ora, nel 1384, quell'abilitazione politica era caratterizzata da ulteriori sottigliezze. Il nuovo provvedimento ebbe comunque anche un altro effetto, accelerando la fusione della vita pubblica e privata della nobiltà: una fusione che nel Quattrocento avrebbe generato una cultura nobiliare in cui l'identità sociale stessa delle persone, adulte o giovani che fossero, veniva plasmata dai meccanismi amministrativi che governavano la classe dominante.
L'obiettivo pratico dichiarato dei nuovi controlli sull'età era di garantire che i più importanti incarichi di governo fossero occupati da uomini maturi. Ma la maturità non era l'unico requisito: l'esclusione dei funzionari troppo giovani serviva anche a riservare gli incarichi agli uomini sposati che ne avevano bisogno - come ammetteva candidamente il provvedimento che nel 1392 aumentava le retribuzioni - per mantenere le loro famiglie. Esistevano certo, nel governo, posizioni destinate a chi aveva da poco compiuti i vent'anni, ma la grande maggioranza degli incarichi era riservata a chi aveva almeno venticinque o trent'anni, o persino di più: in altre parole, l'età in cui era più probabile che un uomo fosse già sposato (246). Le cariche di maggiore responsabilità, e le meglio remunerate, venivano riservate a uomini la cui dimostrata maturità era funzionale sia alla sfera pubblica che a quella privata (247). La legge del 1384 ratificava dunque ufficialmente un'articolata sequenza di fasi nel conseguimento della maggiore età per i maschi, di soglie familiari e cronologiche da varcare, e istituiva momenti di verifica ufficiali per garantire che quelle soglie venissero superate in modo conforme ai principi fissati dal governo. Il nesso che collegava questa sistematica stratificazione per età con la funzione di governo della nobiltà, e con la particolare importanza attribuita al ruolo paterno, era dato dall'onnipresente realtà dell'incarico di governo come impiego remunerativo, come mezzo di sostentamento per le famiglie dei nobili. La carica intesa sia come responsabilità pubblica che come beneficio privato si andava affermando come riserva non soltanto della nobiltà, ma più specificamente dei nobili maschi maturi e sposati.
Alla fine del Trecento, dunque, un tipo ideale di nobile veniva configurato dall'impulso concomitante delle ristrettezze economiche in cui versavano le famiglie nobiliari e dell'intervento assistenziale del governo: quello del patriarca, uomo di governo e capo-famiglia, e in quanto tale perno intorno al quale si realizzava la fusione della vita pubblica con quella privata, della strategia politica con quella domestica, in un'unica ideologia nobiliare ufficialmente definita e controllata.
L'espressione simbolica di questa strutturazione del ruolo paterno venne con due leggi del 1402 e del 1403 che imponevano l'uso dei patronimici per identificare i candidati durante le elezioni agli incarichi in maggior consiglio. Erano dovute alla confusione creata dalla presenza in consiglio di più uomini con lo stesso nome e cognome: i voti dati ad altri potevano quindi essere erroneamente assegnati ad un unico candidato ufficiale. Che si legiferasse in proposito è un'ulteriore riprova di quanto fossero numerosi gli uomini in corsa per un posto di governo, dell'esigenza sempre più diffusa del governo di identificare in modo più preciso i nobili, e della funzione centrale dell'identità paterna, ormai divenuta la chiave non soltanto dello statuto nobiliare, ma dell'accesso all'elemento sempre più essenziale di quello statuto, la carica politica. Nella prospettiva più lunga dell'evoluzione della nobiltà dopo la Serrata, le leggi sui patronimici - così come buona parte della contemporanea legislazione procedurale - parrebbero mirate a neutralizzare l'influenza delle "case vecchie" più numerose e potenti, i clans che con maggiore probabilità potevano avere in consiglio un gran numero di membri dallo stesso nome. È un'ipotesi incoraggiata dalle parole della premessa della legge, destinata a garantire "ut servetur omnis equalitas in electionibus nostris" (248). L'identità paterna, ufficialmente registrata, diventava dunque un ulteriore strumento di quel livellamento di clans antichi e nuovi che fu al centro della riformulazione tardotrecentesca dell'ideologia nobiliare secondo indirizzi legalistico-funzionali.
Nel corso del Quattrocento non soltanto il ruolo dei padri nella convalidazione dell'identità, ma anche la loro autorità e i loro doveri a fronte tanto del regime quanto delle rispettive famiglie, sarebbero stati enunciati sempre più esplicitamente da leggi e dichiarazioni pubbliche; e da questo derivò anche un'articolazione più precisa delle funzioni delle mogli e dei figli, nella vita privata come in quella pubblica (249). Ma già negli anni Ottanta e Novanta del Trecento il nesso sempre più stretto tra rango nobiliare e interessi di famiglia andava amplificando l'intervento normativo del governo nei rapporti e nelle strategie familiari. La concessione di incarichi ai nobili in difficoltà che avevano combattuto con valore durante la guerra di Chioggia veniva esplicitamente presentata come un intervento in favore delle loro famiglie, comprese le "creaturas parvulas" (250). Anche i privilegi speciali che consentivano ai figli molto giovani dei nobili cretesi di confermare le proprie credenziali di nobiltà prima dell'età prestabilita dimostrano la disponibilità del governo a tener conto delle esigenze particolari delle famiglie nobiliari. Il terzo ambito interessato era quello delle strategie matrimoniali, il che ci conduce all'ultima componente integrale della nuova ideologia nobiliare.
Più sopra avevamo ricondotto l'incremento vertiginoso delle doti nella seconda metà del Trecento a due circostanze principali: la richiesta di matrimoni promotori di status, soprattutto da parte delle "case nuove" disposte a investire doti consistenti per legarsi in matrimonio con i clans più antichi e prestigiosi; e la negoziabilità, ai fini delle doti, dei titoli del prestito di stato, in cui era ormai immobilizzata una quota sempre maggiore di ricchezza privata. Negli ultimi decenni del secolo a questi fattori se ne aggiunse un terzo: l'alleanza matrimoniale come risorsa nella corsa alle cariche politiche. Proprio perché faceva conto sugli incarichi di governo la maggioranza dei nobili aveva appoggiato le leggi sulla loro più equa distribuzione, e sull'irrigidimento dei controlli dei requisiti di nobilità dei potenziali concorrenti; per lo stesso motivo aspiravano a stringere legami con famiglie che potevano aiutarli ad acquisire incarichi per se stessi e i propri figli (251). Le doti erano la tradizionale espressione di questi legami, e la caccia ai voti in maggior consiglio attribuì una nuova e intensa dimensione all'uso già ben consolidato del matrimonio come mezzo per acquisire, conservare o promuovere il prestigio, e per convertire a un uso produttivo i titoli del "monte". Per tutti questi motivi i padri si dedicavano ad accalappiare i generi più desiderabili con uno zelo tanto spregiudicato da indurre la premessa di una legge del senato del 1420 sulla limitazione delle doti ad osservare che essi parevano i concorrenti in una gara, con tanto di vincitori e perdenti (252).
La legge attesta che nel Quattrocento il governo si sforzò di contenere questi eccessi; ma già al tempo della guerra di Chioggia era intervenuto in materia di doti, a tutela delle donne sposate e delle famiglie che avevano provveduto a dotarle. L'intervento va valutato nel contesto del permanere, dopo il matrimonio, dei legami tra le donne sposate e le famiglie d'origine, e i padri in particolare, i quali avevano tutto l'interesse a incoraggiare la lealtà delle figlie sposate, per assicurarsi che la ricchezza uscita con le loro doti rientrasse in famiglia sotto forma di donativo (253). Come abbiamo già visto, il denaro della dote non passava definitivamente al genero ma rimaneva proprietà della moglie e costituiva il suo apporto al patrimonio: proprio dai registri della procedura "diiudicatum", attraverso la quale le vedove o i loro eredi rientravano in possesso delle doti, sono state tratte le informazioni sulle doti di cui si è detto più sopra (254). Questo diritto delle donne, e la speranza dei padri di poterne condividere i vantaggi, contribuisce a spiegare il fatto, altrimenti straordinario, che proprio mentre il governo, oberato dalla pressione finanziaria della guerra di Chioggia, andava confiscando senza pietà per arretrati sui prestiti i palazzi nobiliari che si ergevano come simboli visibili di identità del lignaggio maschile, il senato tutelasse accuratamente dagli effetti di quelle confische il diritto delle mogli alla reintegrazione della dote, che doveva venire "primo et ante omnia" (255).
Il provvedimento sottolinea l'importanza attribuita dai reggitori dello stato veneziano, essi stessi padri di figlie riccamente dotate, alla garanzia di accesso per le vedove all'eredità dei mariti per rientrare in possesso delle doti: quando il marito riceveva la dote dalla nuova moglie, veniva infatti obbligato a impegnare un'adeguata parte della sua proprietà a garanzia del rimborso, in genere sotto forma di titoli del "monte" o immobili. Intervenendo a tutela dei diritti delle donne sulle doti proprio mentre la disperata situazione fiscale lo induceva a feroci depredazioni delle sostanze degli uomini, il governo si proponeva come tutore dell'intangibilità della più importante tra le transazioni interfamiliari nella sfera privata. Di fatto, interveniva per garantire la sicurezza degli investimenti decisi dai padri che promuovevano le fortune di famiglia utilizzando le doti per ottenere matrimoni vantaggiosi.
Salvaguardando le strategie matrimoniali private, l'autorità pubblica guardava alle donne e all'intrico di relazioni che le collegava alla struttura bifamiliare in cui entravano al momento del matrimonio. Questa attenzione del governo toccava direttamente l'autorità paterna, rafforzandola e controllandola a un tempo, generando nel corso del Quattrocento una sorta di condominio patriarcale tra i singoli padri e lo stato.
Per contrappasso, la legislazione che tutelava i diritti sulle doti delle donne e dei loro eredi contrastava i diritti e i poteri dei mariti, limitandoli nella medesima misura in cui garantiva gli investimenti dei padri nei matrimoni delle figlie. Popolate di padri e mariti, le assemblee legislative di Venezia si sforzavano di definire i diritti e i doveri di ciascuno - di fatto, di delineare i termini delle due dimensioni del patriarcato privato, avendo come riferimento prescrittivo il complesso fenomeno sociale della donna sposata. La transazione matrimoniale, che comportava quell'ambiguo e indefinito passaggio delle donne da una famiglia all'altra, divenne dunque - come le cariche - un fattore decisivo nella campagna legislativa per una maggiore equità nei rapporti tra i nobili e le loro famiglie. E come nel caso delle cariche, gli agenti principali della risultante fusione della vita pubblica con quella privata sotto l'egida dell'autorità del governo furono i "patres-familias", microcosmici simboli patriarcali della nuova cultura nobiliare.
Le caratteristiche della nobiltà che cominciavano a profilarsi negli anni Ottanta e Novanta del Trecento avrebbero assunto contorni più netti col procedere del Quattrocento. Non sarebbero stati visibili appieno fino agli anni Trenta, quando la seconda Serrata può dirsi conclusa, ma la trasformazione della classe dominante, e la conseguente generale ristrutturazione dei rapporti sociali che avrebbe caratterizzato Venezia nel Rinascimento, erano già state energicamente inaugurate nel 1400. La vaghezza, le incertezze, l'incompiutezza dell'ordine sociopolitico proposto dalla prima Serrata del 1300 erano ormai avviate a cancellarsi. Abbiamo insistito sul rivolgimento economico della guerra di Chioggia come scintilla che innescò la campagna legislativa e amministrativa tesa a identificare, definire, assistere e regolamentare in modo sistematico la classe di governo: una campagna che conseguì a Venezia la ratifica della versione giuridico-funzionale, accanto a quella storico-culturale, della nobiltà.
Ancor prima però dei decisivi eventi dei tardi anni Settanta, l'assenza di un'ideologia nobiliare consensuale, valida per tutti i settori della nobiltà - la cerchia interna dominante, un corpo principale ben definito, e una cerchia esterna dal profilo più ambiguo - aveva prodotto tensioni che trovarono espressione legislativa già negli anni Sessanta. Soltanto quando tutti i settori della nobiltà avessero trovato un elemento di convergenza nella richiesta di prerogative concepite appositamente come riserva esclusiva di un'élite precisamente definita, il consenso poteva prendere forma. Quel consenso si profilò all'indomani della guerra di Chioggia, trovando espressione in un'autorità di governo interventista, dotata della capacità, della volontà, e progressivamente degli strumenti legali, per esercitare un controllo benevolo ma livellatore sui diversi elementi compositivi della classe e, in sostanza, per presidiare con un'attenzione senza precedenti i confini che li separavano dal resto della società veneziana. L'ufficializzazione simbolica di questo consenso venne nel 1403, quando una famosa decisione del collegio (il consiglio ducale con i capi della quarantia) respinse la proposta di nobilitare un'eminente famiglia popolana ogniqualvolta si fosse estinta una casata nobiliare (256). Da quel momento, la nobiltà veneziana divenne ufficialmente la riserva di un gruppo discreto e ben definito di casate; poco più di dieci anni dopo, nel 1414, la loro identità sarebbe stata ufficializzata dall'avogaria di comun nell'elenco delle famiglie i cui figli potevano concorrere alla Barbarella - un elenco a sua volta prodotto di un provvedimento legislativo (257). Con il nuovo secolo, dunque, si era finalmente giunti al consenso sulla definitiva chiusura della classe dominante, e a quel consenso era stata data forma istituzionale.
Il consenso, espressione di una nuova ideologia nobiliare, si basava sulla fusione della concezione giuridico-funzionale della nobiltà con quella storico-culturale. Momento centrale per la trasformazione nobiliare nel tardo Trecento fu infatti la crisi economica in cui le "case vecchie" erano precipitate insieme con gli altri nobili di lignaggio meno antico. Gli uomini di casa Contarini, Corner, Bembo, Falier, Querini e Gradenigo ricorrevano al governo nel momento del bisogno, e ottenevano l'aiuto del maggior consiglio: queste stesse grandi casate, dunque, contribuirono decisamente alla trasformazione della classe dominante veneziana, da semplice nobiltà di governo radicata nella storia a patriziato del privilegio. La trasformazione, per meglio dire, per mezzo della quale il privilegio, inteso come beneficio materiale, divenne elemento integrante della funzione di governo della classe: un elemento che i nobili delle "case vecchie" come di quelle "nuove", delle famiglie eminenti come di quelle modeste, avevano ogni interesse a tutelare gelosamente con il massimo rigore procedurale (258).
Traduzione di Enrico Basaglia
1. Cf. Frederic C. Lane, The Enlargement of the Great Council of Venice, in Florilegium Historiale: Essays Presented to Wallace K. Ferguson, a cura di John G. Rowe - W.H. Stockdale, Toronto 1971, pp. 236-274; Gerhard Rösch, Der venezianische Adel bis zur Schliessung des Grossen Rats. Zur Genese einer Führungsschicht, Sigmaringen 1989, cap. 6: Die sogenannte Serrata des Maggior Consiglio vom Jahre 1297; Giorgio Cracco, Società e stato nel Medioevo veneziano, Firenze 1967, pp. 211-350; Margarete Merores, Der grosse Rat von Venedig und die sogenannte Serrata vom Jahre 1297, "Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte", 21, 1928, pp. 33-113; Guido Ruggiero, Modernization and the Mythic State: The Serrata Revisited, "Viator", 10, 1979, pp. 245-256.
2. La legislazione relativa alla seconda Serrata viene in parte esaminata più oltre. V. anche Stanley Chojnacki, Social Identity in Renaissance Venice: the Second Serrata, "Renaissance Studies", 8, 1994, pp. 341-358.
3. Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani filio adiudicata, a cura di Roberto Cessi - Fanny Bennato, Venezia 1964 (Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Monumenti Storici, n. ser., 18), p. 60. V. anche G. Rösch, Der venezianische Adel, p. 28.
4. Per gli elettori del doge, v. G. Rösch, Der venezianische Adel, pp. 122, 128, 132, 144, 154, 163, 165, 179, 185. Per il minor consiglio, ibid., pp. 209-214.
5. Marco Barbaro, Arbori de' Patritii Veneti, in A.S.V., Miscellanea Codici, I, Storia Veneta, 21, vol. 5, c. 284. Sette Morosini trecenteschi vengono identificati come procuratori in Girolamo Alessandro Cappellari-Vivaro, Il Campidoglio Veneto, III, in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 17 (= 8306), cc. 118v-119v.
6. I prestiti della Repubblica di Venezia (secc. XIII-XII), a cura di Gino Luzzatto, Padova 1929 (Documenti finanziari della Repubblica di Venezia, ser. III, I, pt. 1), pp. 138-195.
7. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, cc. 61-76v; reg. 2, cc. 33-37. Sull'occupazione delle cariche da parte dei nobili e sulle loro valutazioni nell'estimo v. Stanley Chojnacki, In Search of the Venetian Patriciate: Families and Factions in the Fourteenth Century, in Renaissance Venice, a cura di John R. Hale, London 1973, pp. 47-90.
8. G.A. Cappellari-Vivaro, Il Campidoglio, c. 117.
9. Giorgio Cracco, La cultura giuridico-politica nella Venezia della "Serrata", in AA.VV., Storia della cultura veneta, 2, Il Trecento, Vicenza 1976, pp. 238-271.
10. I prestiti della Repubblica di Venezia, passim.
11. Andreae Danduli ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta a. 46-1280 d. C., a cura di Ester Pastorello, in R.I.S.2, XII, 1, 1938-1958, p. 149. Venetiarum historia, p. 275.
12. G. Rosch, Der venezianische Adel, pp. 22, 66; M. Merores, Der grosse Rat, pp. 65-66.
13. Su Sicara Caroso, v. G. Rösch, Der venezianische Adel, p. 201. Marin Sanudo, Le vite dei Dogi, a cura di Giovanni Monticolo, in R.I.S.2, XXII, 4, 1900-1911, p. 25.
14. G. Rösch, Der venezianische Adel, pp. 125-129.
15. Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia, a cura di Roberto Cessi, I, Bologna 1931, pp. 341-360.
16. Su Giovanni Caroso nell'elezione ducale del 1275 v. Martin da Canal, Les estoires de Venise. Cronaca veneziana in lingua francese dalle origini al 1275, a cura di Alberto Limentani, Firenze 1972, pp. 358-365. Su Andrea Caroso in senato, v. Venezia (Repubblica di Venezia). Consiglio dei Rogati. Le deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato). Serie "Mixtorum", I, Libri I-XIV, a cura di Roberto Cessi - Paolo Sambin, Venezia 1960 (Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Monumenti Storici, n. ser., 15), p. 15.
17. A.S.V., Miscellanea Codici, I, Storia Veneta, nr. 44, c. 1. Sulla congiura, v. Dennis Romano, The Aftermath of the Querini-Tiepolo Conspiracy in Venice, "Stanford Italian Review", 1987, pp. 147-159.
18. Sulle elezioni ducali v. Venetiarum historia, pp. 211, 216, 224. Per le altre cariche, v. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, cc. 1, 10v, 14v, 18, 39, 61v; reg. 2, cc. 17, 18v, 29, 34.
19. M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 17. Un altro manoscritto quattrocentesco data l'estinzione della famiglia al 1382: Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 186 (= 7654), c. 15. La nomina di Andrea Caroso è in A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 3, c. 14.
20. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 3, C. 21; I prestiti della Repubblica di Venezia, pp. 172-173.
21. Rona Goffen, Piety and Patronage in Renaissance Venice: Bellini, Titian, and the Franciscans, New Haven (Conn.) 1986, pp. 184-185 n. 3.
22. Dennis Romano, Patricians and Popolani: The Social Foundations of the Venetian Renaissance State, Baltimore 1987, pp. 46-50.
23. Venetiarum historia, p. 273. La copia più autentica della Cronaca Giustinian conservata alla British Library non comprende però i dalle Boccole nella sua lista dei Proles nobilium venetorum (London, British Library King's Mss. 148, cc. 126-141). Su questi manoscritti v. Antonio Carile, Note di cronachistica veneziana: Piero Giustinian e Nicolò Trevisan, "Studi Veneziani", 9, 1967, pp. 103-126, in particolare pp. 109 ss. Un certo "Bonus-filius Buchulo" firmò un atto del 1122 trascritto da M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 23 n. 18. Né M. Merores (Der grosse Rat), né G. Rösch (Der venezianische Adel), inseriscono tuttavia i dalle Boccole nei loro elenchi della nobiltà prima della Serrata.
24. Sul reato sessuale di dalle Boccole v. D. Romano, Patricians and Popolani, p. 48; sulla sua appartenenza al consiglio ducale, v. Raphayni de Caresinis Cancellarii Venetiarum Chronica a. 1343-1388, a cura di Ester Pastorello, in R.I.S.2, XII, 2, 1922, p. 56. Sulle altre cariche occupate dai dalle Boccole, v. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, cc. 11, 27. I processi a Nicolò e Giovanni sono ivi, Avogaria di Comun, Raspe, reg. 3642, cc. 160v, 162v.
25. A.S.V., Cancelleria Inferiore, Notai, b. 114, Marino di San Tomà, protocollo "Diiudicatum, 1366-91", cc. n.n., 2 luglio 1369.
26. Vittorio Lazzarini, Marino Faliero, Firenze 1963, p. 153.
27. Una tradizione vuole che Alvise Venier fosse indotto a questa azione dal suo amore per la moglie di Giovanni dalle Boccole: Pompeo G. Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata, I-III, Bergamo 1922-19266: I, p. 486.
28. I prestiti della Repubblica di Venezia, passim (p. 141 per la valutazione dei dalle Boccole). Sui diversi livelli di ricchezza nell'estimo, v. Gino Luzzatto, La storia economica di Venezia dall'XI al XVI secolo, Venezia 1961, pp. 129-130.
29. Per il testamento di Giovanni, v. D. Romano, Patricians and Popolani, p. 46; per l'investimento con Giovanni Venier, A.S.V., Cancelleria Inferiore, Notai, b. 68, Marino Doto, protocollo, cc. n.n., atto del 22 novembre 1322.
30. A.S.V., Cancelleria Inferiore, Notai, b. 68, Marino Doto, protocollo, cc. n.n., atto del 15 marzo 1324. Sulle colleganze marittime e locali v. G. Luzzatto, La storia economica, pp. 83-90.
31. A.S.V., Cancelleria Inferiore, Notai, b. 68, Marino Doto, protocollo, cc. n.n., atti del 24 giugno 1321, 5 marzo e 4 aprile 1323, 7 giugno e 31 luglio 1324, 30 marzo e 2 ottobre 1325, 29 gennaio 1326 m.v.
32. Ibid., atti del 7 gennaio 1323 m.v., 15 e 22 aprile 1326, 30 aprile 1327: l'ultimo atto attesta il matrimonio di Nicolò Miani con Caterina dalle Boccole.
33. Ibid., atti del 30 aprile e 2 maggio 1327.
34. Sugli altri matrimoni dei dalle Boccole, v. D. Romano, Patricians and Popolani, p. 46.
35. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 3, cc. 11v, 23v, 30.
36. Sull'importanza del passato remoto di Venezia come legittimazione del regime, v. Edward Muir, Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton (N J.) 1981 (trad. it. Il rituale civico a Venezia nel Rinascimento, Roma 1984).
37. Marin Sanudo, De origine, situ et magistratibus urbis Venetae, ovvero La città di Venetia (1493-1530), a cura di Angela Caracciolo Aricò, Milano 1980, p. 206. V. inoltre D. Romano, Patricians and Popolani, pp. 49-50.
38. Marco Barbaro, Famiglie nobili venete estinte, in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 935 (= 7428), c. 9r-v.
39. Non risultano nella lista dei membri del maggior consiglio riportata in Deliberazioni del Maggior Consiglio, né negli elenchi compositi della nobiltà duecentesca redatti da G. Rösch, Der venezianische Adel, pp. 127-133, 209-233, e da M. Merores, Der grosse Rat, pp. 65-69. Il cognome Alduin o Aldoin compare in alcune fonti più tarde, ad esempio nella seicentesca Cronaca di famiglie patrizie venete, in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VI. 185 (= 9008), c. 3. È improbabile si trattasse di una variante di "Balduin"; è piuttosto, come indicava Giovanni Monticolo, una forma di "Arduin", spesso reso come "d'Arduin" o "Darduin" (M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 19 n. 3). Sull'attiva carriera politica di Nicolò Alduin nel Duecento v. G. Rösch, Der venezianische Adel, p. 144.
40. Venetiarum historia, p. 142.
41. D. Romano, The Aftennath, p. 152; Guido Ruggiero, The Boundaries of Eros: Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice, New York 1985 (trad. it. I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento, Venezia 1988), p. 73; S. Chojnacki, In Search, p. 73.
42. Marin Sanuto, Vitae ducum Venetorum (421-1493), in R.I.S., XXII, 1733, col. 581. Giovanni Balduin non compare tra gli undici cospiratori impiccati identificati da Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, I-X, Venezia 1973-19753: III, p. 7 n. 2.
43. Vittorio Lazzarini, Aneddoti della congiura Quirini-Tiepolo, "Nuovo Archivio Veneto", 10, 1895, pp. 85-86 (pp. 81-96); v. anche D. Romano, The Aftermath, p. 152.
44. Cronaca Dolfin, in S. Romanin, Storia documentata, IV, p. 46 n. 78. L'azione intrapresa contro di lui dal consiglio dei dieci è in A.S.V., Consiglio dei Dieci, Deliberazioni Miste, reg. 9, cc. 82-83.
45. Consiglio dei Dieci, Deliberazioni Miste, registri I-II (1310-1325), a cura di Ferruccio Zago, Venezia 1962 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. I, Archivi Pubblici), pp. 149-150. L'indice, p. 205, identifica Leonardo come membro dei dieci. V. anche V. Lazzarini, Aneddoti, pp. 86, 93-94.
46. Consiglio dei Dieci, Deliberazioni Miste, registri III-IV (1325-1335), a cura di Ferruccio Zago, Venezia 1967 (Fonti per la storia di Venezia, Sez. I, Archivi Pubblici), p. 215.
47. Nel 1325 capitano della Torre di San Giuliano era il "nobilis vir Iacobus de Canali" (ibid., p. 14). Il riferimento successivo ad Antoniello Balduin non antepone però il titolo "nobilis vir".
48. Sulla presenza di Nicolò Balduin nell'estimo, v. I prestiti della Repubblica di Venezia, p. 189. Molti degli "stimati" cui viene anteposto il titolo "ser" divennero nobili solo più avanti, il che suscita dubbi circa la precisione cronologica delle attribuzioni sociali nel documento. V. Margarete Merores, Der venezianische Steuerkataster von 1379, "Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte", 16, 1922, pp. 415-416. In un mio precedente studio attribuivo lo statuto nobiliare ai Balduin sulla scorta del riferimento nell'estimo; per i motivi sin qui sostenuti, ritengo ora che l'attribuzione fosse erronea (S. Chojnacki, In Search, p. 73).
49. V. G. Cracco, Società e stato; Id., Patriziato e oligarchia a Venezia nel Tre-Quattrocento, in Florence and Venice: Comparisons and Relations, a cura di Sergio Bertelli - Nicolai Rubinstein - Craig H. Smyth, I, Quattrocento, Firenze 1979, pp. 71-98; Gaetano Cozzi, Authority and Law in Renaissance Venice, in Renaissance Venice, a cura di John R. Hale, London 1973, pp. 293-345; Robert Finlay, Politics in Renaissance Venice, New Brunswick (N.J.) 1980.
50. Sui componenti del gruppo politicamente attivo nel secolo XIII, all'interno e all'esterno del maggior consiglio, v. G. Rösch, Der venezianische Adel, pp. 127-133, 209-233.
51. I nomi sono desunti dagli elenchi riportati in Deliberazioni del Maggior Consiglio, I, pp. 269-362: Electores et electi de maiori consilio.
52. Il decreto del 1414 è in A.S.V., Maggior Consiglio, reg. 21, Leona, cc. 241v-242. Sulla Barbarella, v. Stanley Chojnacki, Political Adulthood in Fifteenth-Century Venice, "American Historical Review", 91, 1986 (trad. it. Il raggiungimento della maggiore età politica a Venezia nel XV secolo, "Ricerche Venete", 1, 1989 [Venezia tardomedievale. Istituzioni e società nella storiografia angloamericana, a cura di Michael Knapton], pp. 59-86), pp. 791-810.
53. A.S.V., Avogaria di Comun, Balla d'Oro, reg. 162.
54. Le casate sono: Albizzo, Balastro, Bocassio, Bonzi, Calergi, Cavalli, dalla Fontana, Fradello, Ghezzo, Gomberto, Mazaman, Megano, Quintavalle, Ruzzier, Ruzzini, Savorgnan, Semitecolo, Sesendolo, Vizamano, Zancaruol e Zusto. Ibid., regg. 163-164, prosegue la registrazione della Barbarella fino agli anni Novanta del Quattrocento. Gli elenchi degli incarichi sono ivi, Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, regg. 4 e 6.
55. I Lombardo sono inseriti nel secondo registro della Barbarella (ivi, Avogaria di Comun, Balla d'Oro, reg. 163), oltre che ivi, Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 4. La famiglia era antica, essendo stata presente in maggior consiglio nell'ultimo decennio del Duecento, e nelle liste delle cariche trecentesche. I documenti suscitano dubbi circa il nesso tra questa casata e i Lambardo, con i quali vengono spesso confusi. Una fonte, che le considera come due case distinte (come fanno peraltro numerosi documenti pubblici), riferisce che si fusero nel 1491 (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 186 [= 7654], c. 34v).
56. Solo sette di queste settantaquattro famiglie sono assenti dalla compilazione dei matrimoni nobiliari del Quattrocento raccolta dal genealogista cinquecentesco Marco Barbaro nel suo Libro di nozze patrizie, in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 156 (= 8492). Quattro delle assenti, peraltro, erano nobilitazioni onorarie di notabili stranieri: Malatesta, della Scala, dal Verme, Gonzaga.
57. Si ricordi che questo numero non comprende i Lombardo, che fanno parte delle centosessantaquattro famiglie attive di cui si è appena detto. Delle duecentotrentasei famiglie cui il registro 162 assegna uno spazio, quelle delle quali riusciamo a identificare esponenti nel Quattrocento sono quindi centosessantatré.
58. Le ventidue famiglie al governo negli anni Ottanta sono le seguenti: Adoldo, Agadi, Aventurado, Boninsegna, Caresini, Caroso, da Porto, Davidor, Darduin, Dente, Diesolo (o d'Equilo), Lanzuol, Marion, Mengolo, Moio, Negro, Nicola, Papacizza, Romano, Steno, Vidal e Vielmo. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 3. Le altre otto casate presenti nell'estimo sono: Babilonio, Bolpe (o Volpe), Buora, Costantino, Istrigo, Rosso, Vendelino e Vioni. I prestiti della Repubblica di Venezia, pp. 62-141, passim.
59. Si estinsero nel 1353, secondo M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 32; nel 1365, secondo la seicentesca Cronaca di famiglie patrizie venete, c. 4v.
6o. Nel 1280 secondo M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 22; nel 1293 secondo la Cronaca di famiglie patrizie venete, c. 11v.
61. M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 27; non compaiono nella Cronaca di famiglie patrizie venete.
62. M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 31; Cronaca di famiglie patrizie venete, c. 24v.
63. M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 39; Cronaca di famiglie patrizie venete, c. 38.
64. M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 39; non ne parla la Cronaca di famiglie patrizie venete. Nicolò e Giovanni Pollini furono comunque eletti in pregadi (senato) nel 1351; A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, c. 61r-v.
65. Nel 1314, stando alla Cronaca di famiglie patrizie venete, c. 40v; nel 1319 stando a M. Sanudo, Le vite dei Dogi, e a Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 186 (= 7654), c. 48v, da cui risulta che il loro ultimo esponente fu Nicolò Rampani, che fu avogadore di comun.
66. M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 42; Cronaca di famiglie patrizie venete, c. 42; Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 186 (= 7654), c. 52. Un Francesco Savoner fu comunque eletto nei cinque alla pace nel 1350; A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, c. 2.
67. È possibile che qualche esponente di queste famiglie occupasse incarichi di governo nei periodi non coperti dai documenti che ci sono conservati, e in particolare da A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, regg. 1-3, che non danno informazioni sulla prima parte del Trecento.
68. G. Rösch, Der venezianische Adel, p. 22.
69. Tra le famiglie attive nel Quattrocento presenti in A.S.V., Avogaria di Comun, Balla d'Oro, reg. 162, i Greco, i Guoro, gli Honoradi e i Semitecolo, che pure non compaiono in maggior consiglio nel 1260-1300, avevano avuto incarichi di governo prima del 1300. Tra le famiglie estinte nel registro, anche gli Alduin e i Pantaleo avevano occupato cariche prima della Serrata (G. Rösch, Der venezianische Adel, pp. 67, 68, 144, 229).
70. G. Rösch, Der venezianische Adel, pp. 65-69.
71. F.C. Lane, The Enlargement, p. 145.
72. M. Sanudo, Le vite dei Dogi, pp. 22, 23, 26, 27, 28; Cronaca di famiglie patrizie venete, cc. 7, 17, 18v, 46; Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 186 (= 7654), cc. 10V, 18r-v, 54.
73. Esponenti di sessantanove di queste famiglie compaiono nelle preziose liste dei detentori di cariche nel Duecento redatte da G. Rösch, Der venezianische Adel, pp. 209-233 e passim.
74. Solo tre famiglie di questo gruppo, i della Scala, i Megano e i Ruzzier, non sono presenti negli elenchi di detentori di incarichi del Trecento; A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, regg. 1-3.
75. Pur avendo tutte iscritto i loro figli nel reg. 162 dell'avogaria, i della Scala e i Megano non compaiono negli elenchi di detentori di incarichi del Quattrocento; ibid., regg. 4 e 6.
76. Gli Ardizon, i Betani, i Carazacanevo e i Mazaruol - questi ultimi dati per estinti da Sanudo già nel 1171! (M. Sanudo, Le vite dei Dogi, pp. 18, 22, 25, 36). Poiché i Mazaruol erano in maggior consiglio negli anni Novanta del Duecento, questa dichiarazione di Sanudo induce a utilizzare con prudenza le sue date di estinzione.
77. Ibid., pp. 28, 33, 42, 44; Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 186 (= 7654), cc. 18, 52, 55.
78. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, cc. 1, 14v, 37, 61; reg. 2, cc. 1, 33.
79. Ibid., reg. 2, c. 38. Sull'evoluzione giurisdizionale e formale dei pregadi v. Enrico Besta, Il Senato veneziano (origine, attribuzioni, costituzione e riti), Venezia 1899 (Miscellanea della Regia Deputazione di Storia Patria, ser. II, 5), in particolare le pp. 41-43 per i provvedimenti speciali del periodo 1363-1364.
80. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, c. 61v.
81. Ibid., cc. 1, 21r-v; reg. 2, c. 34v. Sull'attività del consiglio di guerra dei venticinque, v. Roberto Cessi, Introduzione storica a La regolazione delle entrate e delle spese (Sec. XIII-XIV), Padova 1925 (Documenti finanziari della Repubblica di Venezia, ser. I, I, pt. 1), pp. CXLI ss.
82. Le sette casate (Agrinal, di Conti, Favro, de Mesti, de Pigli, dal Sol e Stornello) risultano accolte nella nobiltà da una fonte di incerta autenticità: A.S.V., Miscellanea Codici, I, Storia Veneta, nr. 44, c. 1r-v. Le altre quarantuno casate vengono identificate come nobili negli elenchi di detentori di cariche del Trecento o nel reg. 162 dell'avogaria di comun.
83. F.C. Lane, The Enlargement, pp. 237-238, 261 n. 2. Le sette famiglie, che sappiamo essere state ammesse in maggior consiglio dopo la fuga da Acri, sono: Barisan, Benedetto, Bondumier, Lion, Marmora, da Molin dal molin d'oro e Surian. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 719 (= 7425), c. 75v. Tranne i Lion e i Surian, tutte avevano fatto parte del consiglio nel tardo Duecento.
84. V. Lazzarini, Marino Faliero, pp. 205 e passim.
85. Per le cariche dei Lion alla metà del secolo, v. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. i, cc. I, 16, 19v, 39v, 61. Sulla famiglia nelle vicende politiche del periodo v. Giovanni Pillinini, Marino Falier e la crisi economica e politica della metà del '300 a Venezia, "Archivio Veneto", ser. V, 84, 1968, pp. 45-7
86. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, cc. 19v, 61v; reg. 2, cc. 33r-v, 37v.
87. V. Lazzarini, Marino Faliero, p. 250. Un'altra interpretazione vuole che Antonio Arian fosse un nobile espulso dalla classe con l'intera famiglia per la sua disonestà negli affari. P.G. Molmenti, La storia di Venezia, II, p. 66.
88. Per la carica di Nicolò Arian v. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 2, c. 12. Una cronaca nobiliare seicentesca sostiene che la famiglia Arian si estinse nel 1349 con un certo Nicoletto, "massaro all'oro" (Cronaca di famiglie patrizie venete, c. 4).
89. "Rainaldus Balestarius, estimador auri" sarebbe stato iscritto alla nobiltà nel 1301. M. Barbaro, Famiglie nobili venete estinte, c. 6. Sugli incarichi di governo di queste famiglie v. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, cc. 12, 15; reg. 2, c. 25.
90. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, regg. 1 (1349-1354) e 2 (1362-1367).
91. Ibid., reg. 3.
92. Si tratta di Caresini, Condulmer, de' Garzoni, Girardo, Negro, Orso, Paruta, da Porto e Vendramin. Va comunque rilevato che i Girardo erano stati presenti in maggior consiglio prima della Serrata. Sulle cooptazioni del 1381, v. oltre.
93. Secondo Marino Sanudo i Vendelino si estinsero nel 1360 con Dardi, "advocatus per curias" (Le vite dei Dogi, p. 45), che però risulta eletto camerlengo a Treviso ancora nel 1362. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 2, c. 25. Per le date di estinzione delle altre casate, M. Sanudo, Le vite dei Dogi, pp. 21, 35, 44.
94. Venetiarum historia, pp. V-VII n. 8, XV-XXIII; A. Carile, Note, pp. 104-118.
95. Venetiarum historia, p. 276. La Cronaca contemporanea conservata nella British Library non comprende i Dolfin tra i "duodecim nobiliores proles", né elenca le altre dodici famiglie (London, British Library, King's Mss. 148, c. 141). Secondo Antonio Carile il manoscritto di Londra è una copia cinquecentesca autentica della Cronaca redatta negli anni Cinquanta del Trecento da Piero Giustinian, il cui originale è conservato nella Bibliothèque Nationale di Parigi (A. Carile, Note, pp. 110-118). La Cronaca di Parigi-Londra è diversa da quella conservata a Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. lat. cl. X. 36a (= 3326), il testo pubblicato da Roberto Cessi e Fanny Bennato, e un tempo attribuito a Piero Giustinian (v. Venetiarum historia, p. VII n. 8).
96. I Gauli risultano estinti nel 1356 secondo M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 31 e secondo Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 186 (= 7654), c. 29v. Sanudo colloca erroneamente l'estinzione degli Ziani con la morte del doge Pietro Ziani nel 1381, quando in realtà il doge morì nel 1229 (Le vite dei Dogi, p. 46 n. 13). Ibid., c. 59, risultano estinti nel 1348, poi corretto in 1248. V. anche G. Rösch, Der venezianische Adel, p. 125 n. 71. Ci fu comunque un Dinamante Ziani supervisore della lavorazione dell'oro nel 1364 e membro della quarantia nel 1365. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 2, cc. 14, 39.
97. S. Chojnacki, In Search, pp. 49-50; R. Finlay, Politics, pp. 92-96. Le sedici "case ducali" sono elencate in S. Romanin, Storia documentata, IV, p. 305 n. 59.
98. Venetiarum historia, pp. 256-258.
99. Ibid., p. 274.
100. Ibid., pp. 275-276.
101. Ibid., pp. 270-273.
102. È un'interpretazione proposta da G. Rösch, Der venezianische Adel, p. 125.
103. I componenti del consiglio ducale negli anni in questione sono pubblicati ibid., pp. 209-214.
104. Giuseppe Maranini, La costituzione di Venezia dalle origini alla Serrata del Maggior Consiglio, Firenze 1974, p. 261; le competenze e le responsabilità del consiglio ducale sono trattate alle pp. 241-262. V. ora, però, G. Rösch, Der venezianische Adel, pp. 134-135.
105. G. Rösch, Der venezianische Adel, p. 135, indica un totale di trecentoquattordici. Non mi è possibile conciliare questo totale con il mio (che pure si basa sui suoi elenchi) di trecentosedici.
106. I tre altri componenti di questo nucleo erano i da Molin, i da Canal e i Barbarigo.
107. I Bellegno non sono compresi tra le "case vecchie".
108. Cioè, queste tre casate, ciascuna con quattro esponenti in consiglio, fanno parte delle trentuno famiglie più attive in consiglio ducale.
109. Le casate "più nobili" assenti dal consiglio erano i Bembo, i Gauli e i Memmo. Le "case vecchie" assenti erano i Bembo, i Bragadin, i Memmo e i Salamon.
110. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, regg. 1 e 2, passim. V. S. Chojnacki, In Search, pp. 64, 73-75.
111. Le cinque case che avevano fatto parte delle prime undici nel Duecento sono: Morosini, Dandolo, Giustinian, Querini, Michiel. Le altre cinque, anch'esse fra le ventuno famiglie più attive in consiglio ducale, sono: Contarini, Venier, Soranzo, Corner e Dolfin. Le altre quattro componenti dell'élite di potere a metà Trecento sono gli Zorzi, con quattro rappresentanti in consiglio ducale prima della Serrata, i Trevisan, con un consigliere ducale, i Loredan e i Bragadin, mai rappresentati all'epoca in consiglio.
112. Le undici casate "più nobili" sono: Falier, Gradenigo, Badoer, Bembo, Zeno, Polani, Zane, Baseggio, Sanudo, Memmo e Tiepolo. Di queste soltanto i Bembo non erano stati rappresentati in consiglio ducale prima della Serrata.
113. L'elenco completo delle quarantatré casate è pubblicato in S. Chojnacki, In Search, pp. 74-75.
114. La tradizione cronachistica concorda sull'estinzione dei Navazoso nel 1342. M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 37; Cronaca di famiglie patrizie venete, c. 36; Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 186 (= 7654), c. 41v. Le altre famiglie del consiglio ducale estinte a metà Trecento sono: Doro (Dauro), Barbani, Acotanto, Totulo, Tonisto, Campolo, Bobizo, Betani, Flabanico, Casullo e Grissoni.
115. Per esempio gli Zeno, che dal quarto posto tra le famiglie del consiglio ducale a metà Trecento decaddero al ventitreesimo.
116. Sulla cronachistica alla metà del Trecento v. G. Cracco, Società e stato, pp. 401-418; e Girolamo Arnaldi, Andrea Dandolo doge-cronista, in La storiografia veneziana fino al secolo XVI: aspetti e problemi, a cura di Agostino Pertusi, Firenze 1970, pp. 127-268.
117. R. Cessi, Introduzione storica, pp. CXLV-CLXXXVII, passim; G. Pillinini, Marino Falier, pp. 70-71; G. Cracco, Società e stato, pp. 389-399 e passim.
118. I prestiti della Repubblica di Venezia, pp. 139-194, passim. Sulla ricchezza collettiva delle case più antiche, v. S. Chojnacki, In Search, pp. 60-70, 73-75.
119. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, cc. 19v-21. Una cronaca nobiliare seicentesca comprende i Ghezzo tra le centosei famiglie che sarebbero entrate a far parte della nobiltà a seguito della Serrata (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 719 [= 7425], c. 75v). Come i dalle Boccole, i Ghezzo vengono nominati nei Proles nobilium senza attribuzione di provenienza (Venetiarum historia, p. 272).
120. Dieci di esse non compaiono mai nel consiglio ducale prima della Serrata: Loredan, Bembo, Lion, dalla Fontana, Diedo, Priuli, da Mosto, Viadro, Gritti e Nani. Le altre ebbero uno o due rappresentanti in consiglio: Trevisan, Marcello, Donà, Mocenigo, Civran, Cocco (Cauco) e Malipiero.
121. Secondo la Cronaca "pseudo-Giustinian", furono nobilitati soltanto negli anni Cinquanta o Sessanta del Duecento (Venetiarum historia, p. 273). Gerhard Rösch non ha trovato alcuna traccia di loro nelle fonti prima del tardo Duecento (Der venezianische Adel).
122. Per i due procuratori di San Marco, v. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, c. 40v; Maggior Consiglio, reg. 20, Novella (copia del 1682), c. 203. Per le altre cariche, v. Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, cc. 16v, 21v, 61r-v; reg. 2, c. 34v.
123. Sulla loro prima comparsa in maggior consiglio negli anni Settanta del Duecento v. G. Rösch, Der venezianische Adel, p. 131. Per gli incarichi che ottennero a metà Trecento, A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, cc. 19v, 21, 61r-v; reg. 2, cc. 1, 32, 34v. La Cronaca "pseudo-Giustinian" non indica nemmeno la provenienza dei Barbaro, che considera come semplici "cives" tra i fondatori di Venezia (Venetiarum historia, pp. 268, 276).
124. Stando alla Cronaca "pseudo-Giustinian", appartenevano alla categoria degna di minor menzione, quella dei "cives de diversis partibus" insediatisi a Venezia (Venetiarum historia, pp. 270, 276). Compaiono per la prima volta negli archivi politici con la loro elezione in maggior consiglio nel 1261 (G. Rösch, Der venezianische Adel, p. 130).
125. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, cc. 17, 21; reg. 2, cc. 1, 32.
126. Le otto case ducali sono: Loredan, Trevisan, Marcello, Donà, Priuli, Mocenigo, Gritti e Malipiero.
127. V. G. Rösch, Der venezianische Adel, p. 66 e passim (in particolare l'indice, p. 277). I Proles nobilium comprendono due stemmi dei Venier (Venetiarum historia, p. 269).
128. Venetiarum historia, pp. 268, 275. Marco Foscarini fu doge dal maggio 1762 al marzo 1763.
129. Con la sola eccezione di Lorenzo Celsi (1361-1365), tutti i dogi dei secoli XIII e XIV, fino al 1382, provenivano dalle "case vecchie".
130. V. Edward Muir, Images of Power: Art and Pageantry in Renaissance Venice, "American Historical Review", 84, 1979, pp. 16-52; Id., Civic Ritual.
131. Queste casate sono presenti nei tre periodi coperti dalla documentazione trecentesca sui detentori di cariche: 1349-1354, 1362-1367 e 1383-1388 (A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, regg. 1-3).
132. Esempi in R. Cessi, Introduzione storica, pp. CLII-CLIV e passim. Per un confronto con il Cinquecento, v. R. Finlay, Politics, pp. 59 ss.
133. G. Rösch, Der venezianische Adel, p. 68.
134. Tre di esse - i da Canal, i Barbo e i Bellegno - erano state tra le ventuno casate più presenti in consiglio ducale, con almeno sei rappresentanti nel corso del secolo. Altre otto - i Valaresso, gli Zusto, i Signolo, gli Orio, i Ghisi, i Marion, i Sagredo e i Gabriel - avevano avuto almeno tre consiglieri ciascuna (ibid., pp. 209-214).
135. Le casate di questo gruppo alle quali A.S.V., Avogaria di Comun, Balla d'Oro, reg. 162, assegna uno spazio nonostante fossero estinte sono: Agadi, Caroso, Davidor, Diesolo (d'Equilo), Mengolo, Romano, Steno e Vidal - e inoltre Lanzuol e Papacizza, la cui carriera nella classe di governo fu quindi alquanto breve.
136. A ventitré di esse veniva assegnato uno spazio nel primo registro della Barbarella, ma in realtà erano estinte nel primo Quattrocento (ibid.). I Vieri, che non compaiono nel registro della Barbarella ma corrispondono alle altre caratteristiche di questo gruppo, sono la ventiquattresima.
137. Il gruppo comprende otto casate nuove cooptate nella nobiltà a seguito della guerra di Chioggia, nel 1381: Caresini, Condulmer, de' Garzoni, Negro, Orso, Paruta, da Porto e Vendramin. La cooptazione del 1381 interessò anche alcuni Girardo, una casata che era stata anche presente in maggior consiglio prima della Serrata.
138. M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 23; Cronaca di famiglie patrizie venete, c. 8v; Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 719 (= 7425), c. 76. Il nome compare per l'ultima volta come "Bendelotto".
139. D. Romano, Patricians and Popolani, pp. 51-52.
140. G. Rösch, Der venezianische Adel, p. 67; D. Romano, Patricians and Popolani, pp. 50-51; M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 27; Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 186 (= 7654), c. 19; Cronaca di famiglie patrizie venete, c. 18v. Il cronista Marco Barbaro, a metà Cinquecento, identifica l'ultimo Disenove nobile in Vico, morto nel 1361 (M. Barbaro, Famiglie nobili venete estinte, c. 20).
141. M. Sanudo, Le vite dei Dogi, pp. 27, 32, 40; M. Barbaro, Famiglie nobili venete estinte, cc. 20, 42, 77v-78.
142. Nel Quattrocento esponenti delle famiglie Arian, Bedeloto, Buora e Renoldo non sarebbero riusciti ad ottenere la ratifica del proprio statuto nobiliare.
143. A.S.V., Maggior Consiglio, reg. 20, Novella, c. 272 (27 gennaio 1366 m.v.).
144. Ivi, Cassiere della Bolla ducale, Maggior Consiglio, ser. antica, reg. 14 (1357-1360), c. 22v.
145. Ibid., c. 27v.
146. Ibid., c. 29. Longo fu nominato "capitaneus ligni Riperie Istrie".
147. Sulla procedura per grazia e le sue applicazioni v. Dennis Romano, ῾Quod sibi fiat gratia': Adjustment of Penalties and the Exercise of Influente in Early Renaissance Venice, "Journal of Medieval and Renaissance Studies", 13, 1983, pp. 251-268; Id., Patricians and Popolani, pp. 123- 127.
148. Questi i totali dei voti nei cinque ballottaggi: cinquecentonove, quattrocentosessantuno, quattrocentosessantatré, quattrocentocinquantacinque, quattrocentotredici. Il calo tra il primo e il secondo ballottaggio è dovuto all'uscita dei votanti "non sinceri"; meno chiaro risulta il motivo della scomparsa tra il quarto e il decisivo quinto ballottaggio di quarantotto voti contrari rimasti costanti nelle quattro votazioni precedenti.
149. A.S.V., Maggior Consiglio, reg. 21, Leona, cc. 241v-242.
150. D. Romano, Patricians and Popolani, pp. 37-38.
151. Per i Bedeloto v. ibid. Sul "dominus" Giovanni de Bugni v. A.S.V., Cancelleria Inferiore, Notai, b. 79, notaio Lodovico Falcon, protocollo, cc. n.n., 12 aprile 1361. De Bugni fu stimato nel 1379 per 50.000 lire "a grossi" (I prestiti della Repubblica di Venezia, p. 185).
152. Si parla di un "ser Johanni Balduino domini Francisci". A.S.V., Cancelleria Inferiore, Notai, b. 19, notaio Benedetto Blanco, protocollo, cc. n.n., atti del 24 settembre 1359 e del 2 marzo 1360.
153. Ibid., b. 114, Marino di San Tomà, protocollo "Diiudicatum, 1366-91", cc. n.n., atti dal 5 febbraio 1366 m.v. al 3 gennaio 1370 m.v., passim.
154. Ivi, Avogaria di Comun, Raspe, reg. 3642, c. 69.
155. Dagli elenchi dei detentori di cariche negli anni 1349-1352 risulta la presenza di due Maffeo Zane; non è possibile accertare quale dei due (se pure fu uno di loro) fosse l'aggressore sessuale del 1344. Nessun Moretto da Pesaro compare tra i detentori di incarichi in quegli anni. Ivi, Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, passim.
156. Ivi, Avogaria di Comun, Raspe, reg. 3642, c. 126v.
157. Esempi di queste valutazioni sono in Guido Ruggiero, Violente in Early Renaissance Venice, New Brunswick (N.J.) 1980 (trad. it. Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento, Bologna 1982), passim.
158. A.S.V., Avogaria di Comun, Raspe, reg. 3642, c. 119v.
159. D. Romano, Patricians and Popolani, pp. 51-52.
160. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 2, c. 30.
161. Ibid., reg. 1, c. 2. L'estinzione dei Savoner nel 1321, con la morte di Giovanni, è attestata in M. Sanudo, Le vite dei Dogi, p. 42; Cronaca di famiglie patrizie venete, c. 42; Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 186 (= 7654), c. 52.
162. Guido Ruggiero sostiene che in un documento del 1359 un Leonardo Balduin veniva "chiaramente etichettato come nobile" (The Boundaries of Eros, p. 182 n. 13), ma si tratta di un errore di interpretazione del documento, che non attribuisce alcun titolo a Balduin (A.S.V., Avogaria di Comun, Raspe, reg. 3642, c. 305v).
163. A.S.V., Maggior Consiglio, reg. 20, Novella, c. 10r-v.
164. Ibid., c. 180v (13 settembre 1360).
165. Ibid., cc. 6, 37v-38v (28 aprile 1352).
166. Ibid., cc. 32v, 44, 129v, 227.
167. Ibid., cc. 99, 101v, 181v.
168. Ibid., c. 228v.
169. Ibid., c. 395v. Marco Nicola fu vescovo di Castello nel 1184-1225, e diversi esponenti della casata furono in maggior consiglio nella seconda metà del Duecento (G. Rösch, Der venezianische Adel, pp. 132, 192). I Nicola compaiono nell'elenco dei Proles nobilium a metà Trecento (Venetiarum historia, p. 272). Poiché non ebbero incarichi negli anni Cinquanta e Sessanta, non sono compresi tra le casate politicamente attive nella Tab. 2-C. Occuparono comunque incarichi di governo negli anni Ottanta (A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 3).
170. Gli astenuti ("non sinceri") furono ventitré (A.S.V., Maggior Consiglio, reg. 21, Leona, c. 21).
171. Ibid., reg. 19, Novella, c. 138v.
172. Sulla Barbarella, v. Stanley Chojnacki, Kinship Ties and ϒoung Patricians in Fifteenth-Centuy Venice, "Renaissance Quarterly", 38, 1985, pp. 240-270; Id., Il raggiungimento della maggiore età.
173. A.S.V., Avogaria di Comun, reg. 2, Capitolare, cap. 220, c. 68r-v (25 novembre 1319); cap. 221, c. 68v (16 settembre 1323). V. G. Rösch, Der venezianische Adel, pp. 179-180.
174. A.S.V., Avogaria di Comun, reg. 2, Capitolare, c. 69v. La legge del 1370 di cui si è detto più sopra dichiara che il decreto del 1356 era stato approvato dal maggior consiglio oltre che dalla quarantia. Non sono però riuscito a trovarne la documentazione nelle deliberazioni del maggior consiglio di quel periodo.
175. Ivi, Maggior Consiglio, reg. 19, Novella, c. 171v.
176. Ivi, Avogaria di Comun, reg. 14, Parti in materia araldica, c. 3 (26 ottobre 1277).
177. V. G. Ruggiero, The Boundaries of Eros.
178. A.S.V., Cancelleria Inferiore, Notai, b. 114, Marino di San Tomà, protocollo "Diiudicatum, 1366-91". Il protocollo non ha foliazione; si fa riferimento alla data dell'atto in esame.
179. In genere la dote veniva pagata al momento della "transductio" della moglie nella casa del marito.
180. I valori delle doti vengono indicati in monete diverse, che abbiamo convertito in ducati per poterli confrontare. Le conversioni si basano sulle tabelle delle equivalenze in Frederic C. Lane - Reinhold C. Müller, Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice, I, Baltimore - London 1985, p. 131, tab. 5.
181. A.S.V., Cancelleria Inferiore, Notai, b. 114, Marino di San Tomà, protocollo "Diiudicatum, 1366-91", atto del 21 febbraio 1381 m.v. Il cognome di Agnesina non viene indicato.
182. Stanley Chojnacki, Marriage Legislation and Patrician Society in Fifteenth-Centuy Venice, in Law, Custom and the Social Fabric in Medieval Europe: Essays in Honor of Bryce Lyon, a cura di Bernard S. Bachrach - David Nicholas, Kalamazoo (Mich.) 1990, pp. 163-184.
183. A.S.V., Cancelleria Inferiore, Notai, b. 114, Marino di San Tomà, protocollo "Diiudicatum, 1366-91", atto del 4 gennaio 1384 m.v. Non ci è noto il nome della famiglia d'origine di Lucia. Il testamento di Lorenzo induce a pensare che Lucia fosse la sua seconda moglie (ibid., b. 128, Rizzo, 6, nr. 28).
184. Ibid., b. 114, Marino di San Tomà, protocollo "Diiudicatum, 1366-91", atti del 15 gennaio 1374 m.v. e 12 novembre 1376. Il cognome d'origine della moglie di Bertuccio Contarini non viene indicato nell'atto.
185. Le attività commerciali di Gasparino "in oriente" sono attestate nei documenti della sua successione, o "commissaria" (A.S.V., Procuratori di San Marco, Commissarie miste, b. 89). Il suo bisnonno paterno era Marco Morosini procuratore (Ivi, Cancelleria Inferiore, Notai, b. 73, Egidio, protocollo 1, cc. n.n., atto del giugno 1320).
186. Ivi, Cancelleria Inferiore, Notai, b. 114, Marino di San Tomà, protocollo "Diiudicatum, 1366-91", atto del 17 dicembre 1371. L'estimo del 1378-1379 valutava Bandin de' Garzoni per 50.000 lire "a grossi", ponendolo tra i cinque più ricchi (I prestiti della Repubblica di Venezia, p. 174). Sui diversi livelli di ricchezza, v. M. Merores, Der venezianische Steuerkataster von 1379, pp. 415-419. Sui de' Garzoni v. Telesforo Bini, I lucchesi a Venezia: alcuni studi sopra i secoli XIII e XIV, Lucca 1853, pp. 172-184.
187. A.S.V., Cancelleria Inferiore, Notai, b. 114, Marino di San Tomà, protocollo "Diiudicatum, 1366-91", atto del 17 ottobre 1371. Silvestro apparteneva a un ramo dei Morosini diverso da quello di Gasparino. Questa dote fu una delle quattro più cospicue tra le cinquantasei documentate nel periodo 1331-1360.
188. Ivi, Notarile, Testamenti, b. 1062, Lorenzo della Torre, nr. 244 (27 marzo 1367); nr. 300 (14 aprile 1374).
189. La dote di Onesta Zane compare nel testamento di Gasparino del 1374 (v. la nota precedente). Il nome di suo padre risulta dal testamento di lei, del 1374 (ibid., b. 573, Giorgio Gibellino, nr. 308, 27 gennaio 1373 m.v.).
190. I rapporti di parentela sono stati ricostruiti sulla base dei testamenti di Gasparino, 20 agosto 1389 (ibid., nr. 182), di Agnesina, 1° luglio 1389 (ibid., b. 574, Gibellino, nr. 535) e della figlia di Agnesina, Maria da Zara, 8 novembre 1399 (ibid., nr. 654).
191. Pare che il contratto di matrimonio di Gasparino prevedesse anche la restituzione di soli 1.380 ducati della dote di Agnesina alla cessazione del matrimonio; nel testamento del 1389 Gasparino rilevava di aver riconosciuto tale obbligo limitato nei confronti di Agnesina in una "carta", probabilmente una "carta securitatis dotis" registrata dal notaio.
192. V. S. Chojnacki, Marriage Legislation, p. 170.
193. Le informazioni genealogiche e matrimoniali sono in A.S.V., Notarile, Testamenti, b. 1062, della Torre, protocollo, cc. 15v-16; ibid., b. 108, Boninsegna, nr. 84. Sulla preminenza dei Venier tra le "case nuove" v. sopra, par. 4.
194. Ivi, Avogaria di Comun, Balla d'Oro, reg. 163, cc. 303, 305v, 322v; ivi, Notarile, Testamenti, b. 1157, dalle Croci, protocollo II, c. 46; ivi, Procuratori di San Marco, Commissarie Miste, b. 2, Giovanni Morosini, protocollo, verso della prima copertina; ivi, Cancelleria Inferiore, Notai, b. 24, Rolandino Bernardi, pergamena 2 giugno 1420; M. Barbaro, Libro di nozze patrizie, c. 323.
195. A.S.V., Procuratori di San Marco, Commissarie Miste, b. 2, Giovanni Morosini, Libro della Commissaria.
196. La votazione finale fu di duecentoquarantaquattro a favore, centottantacinque contrari e quarantanove astenuti ("non sinceri") (A.S.V., Maggior Consiglio, reg. 19, Novella, c. 171v).
197. Sulla peste v. Reinhold C. Müller, Peste e demografia. Medioevo e Rinascimento, e Id., Aspetti sociali ed economici della peste a Venezia nel Medioevo, entrambi in AA.VV., Venezia e la peste 1348/1797, Venezia 1979, pp. 71-96; e Maria Teresa Todesco, L'andamento demografico della nobiltà veneziana allo specchio delle votazioni nel Maggior Consiglio (1297-1797), "Ateneo Veneto", 176, 1989, pp. 119-169, e in particolare pp. 128-130.
198. V. G. Luzzatto, La storia economica di Venezia, pp. 135-145; e Frederic C. Lane, Venice, a Maritime Republic, Baltimore 1973 (trad. it. Storia di Venezia, Torino 1978), pp. 172-186.
199. Frederic C. Lane, The Funded Debt of the Venetian Republic, in Id., Venice and History, Baltimore 1966 (trad. it. Sull'ammontare del "Monte Vecchio" di Venezia, in Il debito pubblico della Repubblica di Venezia, dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV, a cura di Gino Luzzatto, Milano 1963, p. 283 [pp. 273-292]), p. 88 (pp. 87-98).
200. Donald E. Queller, The Venetian Patriciate: Reality versus Myth, Urbana (Ill.) 1986 (trad. it. Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito, Roma 1987); G. Cozzi, Authority and the Law, pp. 298-301; S. Chojnacki, Political Adulthood, pp. 797-798.
201. Sugli effetti economici dell'assedio, v. Reinhold C. Müller, Effetti della guerra di Chioggia (1378-1381) sulla vita economica e sociale di Venezia, "Ateneo Veneto", n. ser., 19, 1981, pp. 27-42; Roberto Cessi, La finanza veneziana al tempo della guerra di Chioggia, in Id., Politica ed economia di Venezia nel Trecento, Saggi, Roma 1952, pp. 172-248; G. Luzzatto, La storia economica di Venezia, pp. 144-145. L'analisi più approfondita è in R. Cessi, Introduzione storica. Questo studio fondamentale è stato ripubblicato in Il debito pubblico della Repubblica di Venezia, dagli ultimi decenni del XII secolo alla fine del XV, a cura di Gino Luzzatto, Milano 1963.
202. G. Luzzatto, La storia economica di Venezia, p. 142; F.C. Lane, The Funded Debt, p. 88.
203. Il debito pubblico, pp. 165-176.
204. I prestiti della Repubblica di Venezia, pp. 192, 203; 191, 208; 153, 218.
205. Il debito pubblico, pp. 170-171. V. anche M.T. Todesco, L'andamento demografico, p. 129.
206. A.S.V., Senato, Misti, reg. 36, c. 86.
207. Daniele di Chinazzo, Cronica de la guerra de Veniciani a Zenovesi, a cura di Vittorio Lazzarini, Venezia 1958 (Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Monumenti Storici, n. ser., 11), pp. 73-82. V. anche Vittorio Lazzarini, Le offerte per la guerra di Chioggia e un falsario del Quattrocento, "Nuovo Archivio Veneto", n. ser., 4, 1902, pp. 202-213.
208. La documentazione ufficiale di questa iniziativa è andata perduta. V. M. Sanuto, Vitae ducum, coll. 739-740. Nel secolo XVII Giannantonio Muazzo scrive di averne veduto un'attestazione, sebbene nelle Miste del senato "non li si trovano con la ballotatione" (Giannantonio Muazzo, Patritiorum, I, in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 196 [= 8578], c. 129).
209. Su alcuni nomi le fonti non concordano; ai fini del nostro studio è stata compilata una lista sulla base delle concordanze nelle identificazioni di G. Muazzo, Patritiorum, cc. 129-130; D. di Chinazzo, Cronica de la guerra, pp. 74-82, 142-143, 207; e V. Lazzarini, Le offerte per la guerra, pp. 205-211. Alcune delle identificazioni in M. Sanuto, Vitae ducum, coll. 739-740, non compaiono nelle altre fonti.
210. D. di Chinazzo, Cronica de la guerra, pp. 142-143. Chinazzo identifica come "de puovolo" quattro degli "armadori": "ser Çanin d'Arduin, ser Nicholò de Renier da San Martin, ser Jachomo Taiapiera da San Marchuola, e ser Marcho Cicogna". Lo statuto sociale degli altri cinque - "ser Jachomo Viçemano de Chandia, ser Joachomelo Trivixav, ser Çorçi Chalerguo de Chandia, ser Piero Pençin e ser Marcho Pasqualigo de Chandia" - non è indicato, ma furono tra i trenta uomini nobilitati l'anno successivo (ibid., pp. 207-208).
211. Ibid., pp. 76-77; V. Lazzarini, Le offerte per la guerra, p. 209.
212. D. di Chinazzo, Cronica de la guerra, p. 80; V. Lazzarini, Le offerte per la guerra, p. 211. I rematori costavano 4 ducati al mese. I totali dei voti per questa e altre nomine sarebbero stati trascritti da documenti ufficiali da G. Muazzo, Patritiorum, c. 130.
213. Una fonte sostiene che alla prima votazione Regla fu alla pari con Bartolomeo Paruta, che poi ebbe la meglio nel ballottaggio successivo (T. Bini, I lucchesi a Venezia, p. 239).
214. I totali dei voti sono in G. Muazzo, Patritiorum, c. 129v. Antonio Darduin fu accettato nella nobiltà insieme con un fratello, "ser Çanin d'Arduin de puovolo", che D. di Chinazzo nomina tra gli "armadori" che armarono galere per la flotta veneziana nel 1380 (Cronica de la guerra, p. 142).
215. G. Muazzo, Patritiorum, cc. 129v-130; D. di Chinazzo, Cronica de la guerra, pp. 74-77; V. Lazzarini, Le offerte per la guerra, pp. 206-207, 209.
216. D. Romano, Patricians and Popolani, pp. 52-55.
217. I prestiti della Repubblica di Venezia, pp. 202-203.
218. D. Romano, Patricians and Popolani, p. 54
219. G. Muazzo, Patritiorum, c. 129r-v; M. Sanuto, Vitae ducum, col. 739.
220. M. Merores, Der venezianische Steuerkataster von 1379, p. 416; D. di Chinazzo, Cronica de la guerra, p. 76; V. Lazzarini, Le offerte per la guerra, p. 208; I prestiti della Repubblica di Venezia, p. 174.
221. I prestiti della Repubblica di Venezia, p. 207.
222. "Nevodo" è in D. di Chinazzo, Cronica de la guerra, p. 76; "nieuo" è in V. Lazzarini, Le offerte per la guerra, p. 209.
223. I prestiti della Repubblica di Venezia, p. 145. Sulla posizione di Luca de Mezzo nella fascia dei più ricchi v. M. Merores, Der venezianische Steuerkataster von 1379, p. 416. Nell'estimo viene identificato come "ser Luca de Mezzo", ma come nei casi di "ser Tomaso Avogadro" e "ser Piero Danselmo", le cui famiglie sarebbero state nobilitate soltanto nel Quattrocento, il titolo "ser" in questo documento non è indicazione affidabile di uno statuto nobiliare nel 1378-1379. I prestiti della Repubblica di Venezia, pp. 154, 156.
224. A.S.V., Segretario alle Voci, Universi, ser. antica, reg. 1, c. 2.
225. Ivi, Avogaria di Comun, Raspe, reg. 3642, c. 29 (14 febbraio 1341 m.v.).
226. Sulle dimensioni numeriche del maggior consiglio v. M.T. Todesco, L'andamento demografico, pp. 128-129 e Appendice 1, pp. 150-151.
227. A.S.V., Avogaria di Comun, Raspe, reg. 3642, c. 120.
228. Ibid., reg. 3643, cc. 77v, 95v (27 ottobre 1365, 22 giugno 1367).
229. Ibid., reg. 3644, c. 27r-v (11 marzo 1381).
230. Ibid., c. 155v (17 dicembre 1390). Ordelaffo era figlio di "quadam domina Francischa de Padua".
231. Ibid., cc. 41, 50v-51, 58v-59, 72v, 95v, 111, 117, 131v, 138v, 139v, 161 e passim.
232. Ibid., c. 105r-v (Gradenigo, 13 luglio 1387); ivi, Maggior Consiglio, reg. 21, Leona, cc. 32v-33 (Querini, 1° luglio 1389).
233. Ibid., Leona, cc. 32v-33v (Querini, 1° luglio 1389).
234. "[...] utrum sui et eius genologia a quibus traxit ortem et originem [...]" (ivi, Avogaria di Comun, cc. 183v, 185v). Non ho incontrato il termine in alcun documento ufficiale riferito alla nobiltà precedente a questo.
235. M. Sanuto, Vitae ducum, col. 741. Secondo Sanudo il decreto è nel "Libro XXXVI Rogatorum ad Chart. 85"; non mi è stato dato di trovarlo negli archivi del senato.
236. Le citazioni sono dalla legge contro i bastardi del 1376 (A.S.V., Maggior Consiglio, reg. 20, Novella, c. 171v).
237. I prestiti della Repubblica di Venezia, pp. 227-229.
238. A.S.V., Maggior Consiglio, reg. 20, Novella, cc. 434v-435v (3 ottobre 1383).
239. Ibid., reg. 21, Leona, e. 14 (1° gennaio 1385 m.v.).
240. Nei decenni precedenti sono documentate numerose grazie che autorizzavano la concessione di incarichi a nobili (e a volte a uomini di incerto statuto) che avessero particolari meriti o necessità. V. ad esempio gli incarichi affidati al "viro nobili" Maffeo Venier quondam Maffeo, "qui multas adversitates et tribulationes passus est", e al "vir nobilis" Nicolò Agadi, che si era esposto a gravi pericoli in missione "de mandato dominii in Romandiola, Justinopoli et Tarvisio". Ma si rilevi anche la concessione del comando di una squadra navale di pattuglia sulla costa istriana al non titolato Marino Longo, che "gravatus est multa familia". Ivi, Cassiere della Bolla Ducale, Maggior Consiglio, ser. antica, reg. 14, cc. 22v (27 agosto 1357), 56 (5 febbraio 1357 m.v.), 29 (21 dicembre 1357).
241. Ivi, Maggior Consiglio, reg. 21, Leona, cc. 30v-31 (23 maggio 1389). Le grazie concesse a Bernardo Falier e Paolo Querini sono ibid., cc. 19v (18 agosto 1387), 29 (20 gennaio 1388 m.v.).
242. Ibid., c. 22v (16 febbraio 1387 m.v.).
243. Ibid., c. 23 (19 aprile 1388). Piero veniva identificato come "quondam ser Andree quondam domini Marci procuratoris". Gli fu affidato per cinque anni l'incarico di "caput advocatorum in Candia".
244. Ibid., cc. 61v-63v (10 agosto 1392).
245. Ibid., c. 210r-v (20 marzo 1384).
246. Stanley Chojnacki, Measuring Adulthood: Adolescence and Gender in Renaissance Venice, "Journal of Family History", 17, 1992, pp. 378-379 (pp. 371-395); Id., Il raggiungimento della maggiore età.
247. Robert Finlay, The Venetian Republic as a Gerontocracy: Age and Politics in the Renaissance, "Journal of Medieval and Renaissance Studies", 8, 1978, pp. 157-178.
248. A.S.V., Maggior Consiglio, reg. 21, Leona, c. 127r-v (19 febbraio 1401 m.v.). Il decreto disponeva inoltre che quando qualcuno veniva eletto senza specificare il patronimico o altra forma di identificazione, se uno o più altri portavano lo stesso nome e cognome ("unus vel plures habentes ipsum nomen et stirpem") l'elezione doveva essere invalidata. Il provvedimento fu riformulato con un altro decreto del 20 gennaio 1403 m.v. (ibid., c. 141).
249. Sul ruolo dei padri nella società nobiliare del Quattrocento, v. Stanley Chojnacki, Subaltern Patriarchs: Patrician Bachelors in Renaissance Venice, in Medieval Masculinities: Regarding Men in the Middle Ages, a cura di Clare A. Lees, Minneapolis 1994, pp. 73-90. Sul ruolo delle madri, v. Id., "The Most Serious Duty": Motherhood, Gender, and Patrician Society in Renaissance Venice, in Refiguring Woman: Perspectives on Gender and the Italian Renaissance, a cura di Marilyn Migiel - Juliana Schiesari, Ithaca (N.Y.) 1991, pp. 126-148.
250. Negli atti che concedevano loro la grazia di un incarico, sia Ranieri Premarin che Piero Loredan erano detti "gravatus" dalle responsabilità di famiglia (A.S.V., Maggior Consiglio, reg. 21, Leona, cc. 22v, 23).
251. V. S. Chojnacki, Kinship Ties and ϒoung Patricians.
252. "[...] qui conantur alios vincere in expensis quasi reputando se victores" (A.S.V., Senato, Misti, reg. 53, c. 70r-v); pubblicato in Giulio Bistort, Il Magistrato alle Pompe della Repubblica di Venezia, Venezia 1909 (rist. Bologna 1969, p. 107).
253. Nel suo testamento del 1391 Pellegrina Venier Basadonna riconosceva con leale gratitudine che "mio pare non aver respeto a la so condizion de tanti fioli et fie ch'el me de tanta de dota et coriedi plus de la mitade de zo che lo aveva al mondo". Lo nominava quindi suo erede residuale, pregando "caramente" il marito di non aversene a male (A.S.V., Notarile, Testamenti, b. 364, Darvasio, nr. 44).
254. V. sopra, par. 7. Cf. Stanley Chojnacki, Dowries and Kinsmen in Early Renaissance Vertice, "Journal of Interdisciplinary History", 5, 1975, pp. 571-600; Id., The Power of Love: Wives and Husbands in Late lldedieral Venice, in Women and Power in the Middle Ages, a cura di Mary Erler - Maryanne Kowaleski, Athens (Georgia) 1988, pp. 126-148.
255. "[...] cum [...] sit bonum taliter providere quod ipse mulieres de suis dotibus sint bene secure, vadit pars quod si dicti sapientes vendiderint possessiones que sint obligate pro dotibus mulierum, primo et ante omnia ipse mulieres assecurentur de suis dotibus super ipsis possessionibus". (A.S.V., Senato, Misti, reg. 36, c. 69v, 24 settembre 1380; pubblicato in I prestiti della Repubblica di Venezia, p. 201).
256. A.S.V., Collegio, Notatorio, reg. 3, c. 111v.
257. Ivi, Avogaria di Comun, Balla d'Oro, reg. 162. V. sopra, par. 3.
258. V. Aldo Mazzacane, Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il "secolo della Terraferma", in AA.VV., Storia della cultura veneta, 3/I, Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, Vicenza 1980, p. 577 (pp. 577-650): "Dalla crisi di fine Trecento [...] Venezia uscì con un profondo riassetto dei suoi equilibri politici interni [...]. Di fronte ai pericoli di disgregazione, derivanti da una guerra che aveva ridotto gli spazi economici e messo in forse la funzione stessa di transito dell'emporio realtino, il patriziato si strinse intorno allo stato, trovando in esso il suo cemento e la sua unità [...]".