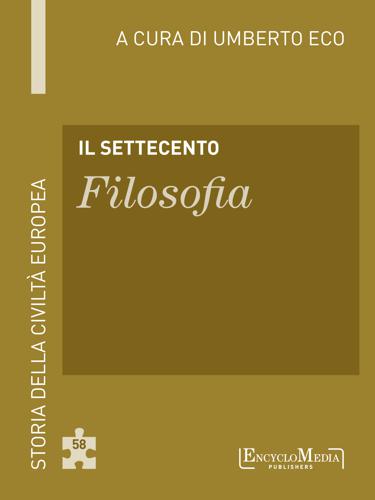La letteratura libertina
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Assimilato – dal Girard dei Synonymes françois – alla figura del bandito e a quella del vagabondo, il libertino anima i salotti e le conversazioni del bel mondo peccando contro i buoni costumi per amore del piacere. L’indocilità del carattere, che secondo l’abbé Girard forma il destino del vagabondo, diventa nel libertino propensione per l’incostanza ed elogio di un’esistenza la quale, tacendo il cursus honorum, propone il gioioso catalogo delle conquiste amorose.
Don Giovanni da Casanova a Laclos
Il lettore che apre le prime pagine della Storia della mia vita di Giacomo Casanova può gustare l’autoritratto del grande libertino, definito nel paradosso di chi dichiara di essere stato allievo di se stesso e si fa un dovere di amare il proprio precettore: “Per quel che mi riguarda, ben sapendo di essere stato la causa principale di tutte le sventure che mi sono capitate, mi sono trovato con piacere in condizione di essere lo scolaro di me stesso e in dovere di amare il mio precettore”. Casanova viaggiatore, giocatore d’azzardo, indovino e sacerdote di Paracelso, buon letterato e cavaliere di Seingalt per il solo diritto dell’alfabeto, deve gran parte della sua fama all’impressionante elenco di conquiste femminili che inorgogliscono le pagine delle sue memorie, non meno del piacere di avere beffato gli stolti.
Facendo l’apologia del proprio temperamento e dichiarando di non avergli mai resistito, Casanova sembra soffermarsi, nelle prime pagine della Storia, nella rievocazione dei piaceri e degli aromi che hanno invaso la sua esistenza. Lo spunto rievocativo si spinge a tal punto da mescolare l’odore delle donne amate con l’aroma dei cibi più graditi, sicché il ricordo olfattivo del bel sesso lascia talvolta il posto al rimpianto del pasticcio di maccheroni e del formaggio ben fermentato. I volti di attrici e gentildonne, monache e novizie, matrone e giovani ragazze, accompagnano Casanova nelle contrade d’Europa, da Mosca a Istanbul, fondendosi nella rapida successione della rievocazione.
Se molte donne hanno parti di comparse nel diario erotico casanoviano, altre appaiono scolpite per il tratto sontuoso o piccante, romanzesco o folle del loro ritratto psicologico. Più a lungo il lettore è portato a soffermarsi su Bettina, isterica lettrice di romanzi e prima conquista del dongiovanni giovinetto, finché non compare, sulla gondola che la porta all’appuntamento in piazza San Marco con Casanova, l’aristocratica figura di M.M. uscita dal convento.
Se M.M., monaca veneziana e amante del De Bernis, concede al Casanova l’empio diploma di violatore di conventi, esercitandone il talento seduttivo nella tessitura degli intrighi, la Marchesa d’Urfé, con la sua folle credulità in auspici e oroscopi, gli conferma il ruolo picaresco di raggiratore della fiducia altrui sotto le vesti cagliostresche di sacerdote dell’occulto.
Il libertino in maschera al ballo della mondanità settecentesca compie le sue riflessioni da boudoir a margine dei fortunati incontri amorosi e riveste di un manto estetico le proprie pulsioni: “Così quello che sempre ha esercitato un eccezionale fascino su di me è la bellezza animata di una donna, e propriamente quella bellezza che ogni donna porta in viso, perché è nel viso che risiede ciò che incanta; ed è un fatto che le sfingi che vediamo a Roma o a Versailles ci facciano innamorare dei loro corpi nonostante siano deformi nel pieno senso della parola. Contemplando i loro bei visi, infatti, finiamo per trovare bella anche la loro deformità”. Questo profilo del dongiovanni posto in attitudine contemplativa davanti alla sfinge femminile rende omaggio a quanto Diderot scrive nella voce “Libertinage” dell’Encyclopédie riconoscendo al libertino, quando la sua condizione non privilegi il soddisfacimento dei meri bisogni materiali, i talenti di un bel esprit. I volti e le maschere, le silhouette e i ritratti femminili inseguono la vita del dongiovanni facendo capolino dalla conversazione della scrittura memorialistica. A tal punto il libertino paga il suo tributo al demone femminile da riconoscergli con Restif de la Bretonne un dominio assoluto: “Io non vivevo, io non respiravo, io non ero felice o infelice che grazie alle donne. Io l’ho già detto, io lo ripeto; e con tutta probabilità io lo ridirò ancora”. Se al sultano è dato il possesso del serraglio, all’incostante seduttore è concesso il piacere di rievocare sul piano della memoria, una a una, le diverse conquiste, finché queste non rivivono nella gioiosa messa in scena del catalogo scritto dalla penna di Da Ponte per la musica di Mozart. In maschera o a volto scoperto, il libertino è sempre travestito perché nasconde nella brillante immagine mondana non solo il fine della conquista erotica, ma la stessa identità sociale del suo personaggio trafitto dalle lucide osservazioni che la Merteuil di Laclos dedica al bel Valmont: “Un bel volto mero effetto del caso; un’eleganza che l’uso del mondo dà quasi sempre, e in verità un’intelligenza alla quale del resto potrebbe supplire una volgare chiacchiera; un’abbastanza lodevole impudenza, dovuta forse però esclusivamente alla facilità dei primi successi: ecco, se non faccio errore, tutti i vostri mezzi”.
Giacomo Casanova
Uno dei molteplici incontri amorosi di Casanova
Storia della mia vita
Puntualmente, all’ora fissata, vidi arrivare una gondola a due remi. Ne scese una maschera che disse qualcosa al barcaiolo di prua e poi si avviò verso la statua. Vedendo però che la maschera era un uomo, mi allarmai e mi tirai da parte dolendomi di non avere con me le pistole. La maschera fece il giro della statua, mi si avvicinò e mi tese una mano con una calma che mi tolse ogni dubbio. Riconobbi il mio angelo vestito da uomo. M. M. rise della mia sorpresa poi mi prese il braccio e senza dir parola ci incamminammo verso piazza San Marco, l’attraversammo e raggiungemmo il casino che distava solo cento passi dal teatro di San Moisè.
Tutto era come avevo disposto. Salimmo e io mi tolsi subito la maschera. M. M., invece, si divertì a passeggiare lentamente in tutti gli angoli del luogo delizioso dove veniva accolta, felice che la contemplassi in tutte le pose, di profilo e di faccia, e che ammirassi il suo abbigliamento che testimoniava quanto ricco fosse il suo amante. Tra l’altro, era rimasta affascinata dal prodigio degli specchi che riflettevano la sua figura in cento modi diversi, anche se stava immobile. La sua immagine, che gli specchi le rimandavano moltiplicata, nella luce delle candele acconciamente disposte, le offriva uno spettacolo nuovo che la faceva innamorare di se stessa. Intanto, seduto su uno sgabello, esaminavo con attenzione l’eleganza del suo abbigliamento. Aveva un abito di velluto rasato rosa, ricamato a lustrini d’oro sugli orli, un panciotto elegantemente ricamato ed eccezionalmente ricco, calzoncini di raso nero, merletti fatti con l’ago, orecchini di brillanti, un solitario di gran pregio al mignolo e all’altra mano un anello di cui si scorgeva solo una superficie di taffetà bianco ricoperta da un cristallo convesso. La bautta di pizzo nero era meravigliosa per finezza di tessuto e per disegno. Per consentirmi di osservarla meglio, venne a mettermisi davanti. Le guardai nelle tasche e vi trovai una tabacchiera, una bomboniera, una fiala, un astuccio di stuzzicadenti, un occhialino e dei fazzoletti che esalavano profumi balsamici. Esaminai con attenzione la ricchezza dei suoi due orologi finemente lavorati e dei ciondoli che portava attaccati alle catene incrostate di diamantini. Nelle tasche laterali le trovai due piccole pistole dall’acciarino piatto a molla, finissima opera inglese.
Giacomo Casanova, Storia della mia vita, Milano, Mondadori, 1984
Il libertino allo specchio: Cagliostro visto da Casanova
Già nel Settecento la fama di Cagliostro è tale che quando Goethe, in soggiorno a Palermo, si reca a visitare i genitori di Vincenzo Balsamo, sedicente conte di Cagliostro, può dire loro in tutta sincerità, e senza tema di essere smentito, che “tutta Europa lo conosce”.
Mentre Casanova scrive a Dux le sue memorie, Cagliostro viene processato dal Sant’Uffizio dopo aver percorso tutta l’Europa preceduto dalla fama di negromante e accompagnato da Lorenza Feliciani, consorte bella quanto bigotta. Fondatore a Lione della massoneria di rito egiziano, già implicato nello scandalo del furto della collana di Maria Antonietta, ospite della Bastiglia quanto Casanova lo era stato dei Piombi, Cagliostro non gode buona fama neppure negli scritti del cavaliere de Seingalt che non perde occasione per attribuirgli, in gioco speculare, quella fama di picaro truffatore della quale è egli stesso artefice e vittima.
Ad Aix-en-Provence, nel luogo topico della locanda, l’occhio esercitato di Casanova riconosce il sedicente conte nelle sembianze di un pellegrino di ritorno con la moglie dal “cammino” a Santiago de Compostela. Scartata l’idea di sedurre Lorenza, peraltro assai lodata per la bellezza “accentuata da un velo di mestizia”, Casanova crea le condizioni per la messa in ridicolo della fama occultistica di Cagliostro, prima descritto mentre si appunta sul mantello le conchiglie, simbolo universale del pellegrinaggio in Galizia, poi osservato nella sua perizia di falsario. L’immagine dei due grandi “vagabondi” del Settecento si fissa una volta per tutte nelle parole del picaro veneziano che, pur riferite al conte negromante, suonano come una parodia di se stesso: “Personalmente però non gli credetti, perciò mi parve uno di quei geni fannulloni che preferiscono la vita vagabonda alla vita laboriosa”.
Dal divertissement all’apologia del crimine
Nelle case di piacere veneziane e nelle alcove parigine il libertino e la dama alternano il piacere dei sensi a quello del testo, e si contendono con ammiccante complicità i romanzi di Dorat e Crébillon figlio, i racconti di Gresset, Chorier, Baffo, Piazza e Vincenzo Rota. Il Sofà, il Verde-verde, l’Accademia delle dame, fino allo pseudogalenico Speziale di qualità, fanno la loro comparsa fra i tavolini e le ottomane, oppure giacciono abbandonati sui sofà confusi tra le operette comiche alla Vadé e gli aggraziati nudi dei racconti mitologici di Desfontaines (1685-1745).
Il tema erotico sfiora ripetutamente nel Settecento sia l’indagine medico-psicologica – è il caso de La monaca di Diderot – sia la polemica anticlericale degli esprits forts – si pensi al Matrimonio di fra’ Giovanni del Pilati – ma non si identifica propriamente con la cultura dei philosophes, anche se da questa viene influenzato. Giocando sull’ambiguità dei travestimenti mondani e di quelli erotici, il romanzo di intrattenimento si diffonde tra le mascherine del bel mondo. Una straordinaria raffinatezza di intuizione mette in scena la psicologia dei caratteri nel delicato tratteggio delle scene galanti e dei dialoghi arguti che hanno i tempi e le movenze del teatro di Marivaux. Se lo Speziale di qualità di Rota raggiunge un equo compromesso fra libertinaggio e morale borghese nella soluzione matrimoniale, che concede alla dama la complicità dell’amante divenuto marito, quando si passi a Sade il travestimento galante lascia posto allo spessore violento dell’oscenità che si dichiara con tutto il suo effetto di aperta provocazione.
Con Sade i motivi antireligiosi del libertinismo si riuniscono a quelli osceni, sicché la scrittura galante di un Crébillon, o quella manifestamente erotica di Chorier nell’Accademia delle dame lasciano il posto alle bestemmie e agli atti criminali dei monaci del convento di Sainte-Marie des Bois nel romanzo Justine.
Quando il libertino veste i panni del monaco, il travestimento ha raggiunto la perfezione, perché il convento nasconde il serraglio nel quale Justine e le altre vittime soddisfano i desideri dei loro carnefici. I quattro monaci benedettini che dominano con il potere assoluto di satrapi orientali il convento-prigione di Justine non sono il bersaglio di una polemica anticlericale illuminista, perché danno voce con le loro riflessioni a un pensiero tanto blasfemo quanto condiviso dall’autore, che apologizza nelle interminabili pronunce oscene l’arbitrio del crimine come soddisfacimento delle fantasie più illimitate.
Una sorta di sensismo criminale guida Sade nel descrivere, con l’eloquenza del monaco Clement, il rapporto tra immaginazione e crimine: “Ora quale sensazione è più viva del dolore? Le sue manifestazioni sono vive e non ingannano; ingannano invece quelle del piacere, perpetua messinscena delle donne, che quasi mai lo provano veramente (...). Per produrre dolore, invece, non sono necessari requisiti: più difetti ha un uomo, più è vecchio, meno è amabile, meglio riuscirà”. Il travestimento monastico aggrava l’espressione di un pensiero materialista le cui premesse implicite nella cultura edonistica che va da Voltaire a La Mettrie, senza tacere del Trattato matematico sulla felicità di Stillingfleet o Sull’indole del piacere e del dolore di Pietro Verri, si risolvono nella paradossale assoluzione di ogni progetto criminale in ragione delle sue premesse edonistiche.
Il primato della natura ribadito dai philosophes fa emergere nell’analisi sadiana l’antico archetipo della ferinità umana, respingendo ai margini della scena intellettuale quelle che il marchese libertino definisce le chimere dell’amore del prossimo: “E sia: la tigre, il leopardo di cui quest’uomo è se vuoi l’immagine, non sono come lui creati dalla natura, creati per adempiere le intenzioni? Il lupo che divora l’agnello di questa madre comune come il ribaldo che distrugge l’oggetto su cui esercita la sua vendetta o la sua lubricità”.
Con Sade il libertino riprende qualcosa della sua pronuncia filosofica secentesca, sebbene essa si realizzi nell’alternanza fra oscenità dissacranti e criminali risoluzioni intellettuali. Per questo, l’esprit fort lascia il posto al bandito al quale Girard riconosce un libertinaggio spinto fino all’attentato alle leggi civili.
Vincenzo Rota
Aneddoto imbarazzante
Lo speziale di qualità o sia Il celebre lavativo
Priego le Donne a non dilettarsi nel leggere libri Filosofici. Cagionano in esse delle astrazioni grandissime. Sperano di rendersi particolari, e spregiudicate, ma corrono il pericolo di pregiudicarsi, e di particolarizzarsi, siccome avvenne alla Filosofessa Felicita. Incomincio. Felicita giovane Francese vaghissima, bellissima, per quanto cercasse con la lettura di purgare il cervello suo da’ pregiudizi, non potè mai guarirlo dalla vanità estrema della sua bellezza. Tal sventura non è punto notabile. Più. Era persuasa quanto altra Donna Francese nulla Filosofa, che un salasso di quando in quando, e un quotidiano serviziale, fossero due cose onnipossenti a conservare una certa delicatezza nel colorito mirabile, e una certa tumidezza attraente. S’era resa famosa osservatrice sopra di se di questi due preservativi. Felicita bella, d’una bellezza preservata, doveva contentarsi. Volle in aggiunta la fama d’essere Filosofa; ciò non si potea combinare; suo danno.
Margherita sua Cameriera, il dì 24 del Giugno 1766 aveva già nelle mani, e pronto il conservatore delle sue bellezze, il provido lavativo. Felicita si pose nel suo letto, e nello scorcio opportuno a riceverlo. Teneva il gran Russò nella destra mano, con la sinistra si tenea alzati i panni. Era scoperta, leggea con un’astrazione, con un rapimento che mai il maggiore. Attendeva con somma pazienza il suo benefattore. La sua positura, le cortine del suo letto, la sua Filosofica applicazione, non le lasciava nè udire, nè vedere ciò che poteva nascere nella camera. Le faccende erano in questo sistema, quando Margherita si risovenne d’aver dimenticata una certa tovaglia necessaria all’opra. Posa il serviziale sopra un sedile vicino al letto. Va a rinvenire la tovaglia in una stanza sopra a quella di Felicita. Spera di non tardar molto. Lascia spalancata la porta, Felicita in quella positura. Felicita è in estasi col suo caro Russò, ha il diretano all’aria.
Egidio giovane Gentiluomo, polito, attillato, gioviale, del Secolo 1766. frequente visitatore di Felicita, è giunto. Egli cammina leggero alla Francese, non ha addottato il gravitare del passo britanno, trova l’uscio aperto si avvanza senza romore.
Qual vista per Egidio! Il più bel diretano del sesso adorabile scoperto, Felicita nello scorcio accennato, sprofondata in un abisso d’immagini Filosofiche, immersa con gl’occhi, col cuore, con tutti i sentimenti nella lettura del delizioso Russò.
Donatien-Alphonse-François de Sade
Considerazioni
Justine, Parte I
Sarebbe il capolavoro della filosofia rendere evidenti i mezzi adoperati dalla provvidenza per raggiungere i propri fini sull’uomo, e trarne piani di condotta che indichino, a questo sventurato individuo bipede, come procedere nello spinoso cammino della vita, se vuol prevenire i capricci bizzarri di quella fatalità cui si danno venti nomi diversi, ma che ancora non si è giunti né a conoscere né a definire.
Se, nonostante il rispetto per le nostre convenzioni sociali e l’accettazione delle dighe da esse imposte, ci è accaduto di non incontrare che rovi, mentre i malvagi non raccoglievano che rose, uomini con un patrimonio di virtù poco sperimentate potranno, tenendo conto di osservazioni simili, calcolar vantaggioso l’abbandonarsi alla corrente anziché resisterle.
Sade, Opere, a cura di P. Caruso, Milano, Mondadori, 1992