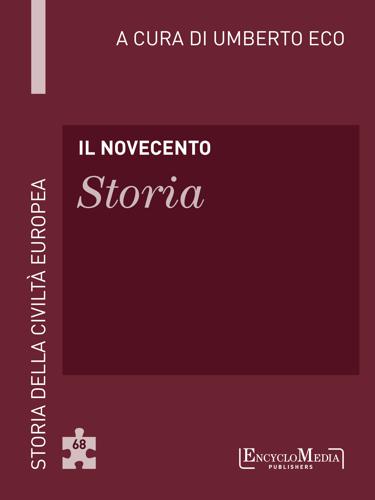La nascita di Israele e la questione mediorientale
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
La nascita del sionismo, avvenuta nell’Europa di fine Ottocento, è comprensibile solo all’interno di un particolare momento storico: le persecuzioni antiebraiche nella Russia zarista e il fallimento dell’emancipazione liberale nella Mitteleuropa. La creazione dello Stato d’Israele nel 1948 ha realizzato il progetto statuale sionista, ma ha sollevato in tutta la sua drammaticità il problema del popolo palestinese, privato della sua terra atavica. Lo Stato di Israele non va considerato solo come il garante politico dell’ebraismo mondiale, ma compendia anche tutte le problematiche indotte da una creazione occidentale nel Medio Oriente arabo-islamico.
Dalla nascita del sionismo alla nascita dello Stato di Israele
“Lo Stato degli ebrei è una necessità mondiale, tanto per gli ebrei quanto per i gentili”: con questa affermazione perentoria, il giornalista ebreo di origini ungheresi Theodor Herzl (1860-1904) lancia sull’arena politica ebraica e mondiale il suo progetto di Stato degli ebrei. La formula approvata dal I Congresso sionista di Basilea (1897) parla di “focolare nazionale assicurato dal diritto pubblico”, una circonlocuzione che esprime il progetto di Stato-asilo per una nazione oppressa, garantito dal “concerto delle nazioni” (quello che il gius-filosofo Schmitt avrebbe definito jus publicum europaeum). La nascita del sionismo, avvenuta nell’Europa di fine Ottocento, non è comprensibile se non all’interno di un particolare momento storico e culturale: le persecuzioni antiebraiche nella Russia zarista (i pogrom) e il fallimento dell’emancipazione illuministica nella Mitteleuropa di lingua tedesca (l’incompatibilità tra cittadinanza politica e identità culturale). Queste due coordinate rimandano direttamente al cuore del sionismo e della nascita di Israele: chi è il “giudeo”? Che cos’è il “giudaismo”? A tali interrogativi di carattere politico, sociale, culturale ed esistenziale il sionismo ha fornito una propria risposta: il giudaismo è anzitutto un popolo, una natio, che ha il diritto e il dovere di perseguire la propria autonoma fioritura in uno Stato-nazione. Tutto questo, dopo l’accantonamento del piano Sinai e Uganda nei primi anni del Novecento, significa Eretz Israel (la Terra di Israele), la terra dei propri padri “ebrei” (Hebrew in inglese), dove il vecchio “giudeo” della diaspora avrebbe superato la nevrotica scissione tra mente e corpo riconquistando quel radicamento alla terra che lo avrebbe salvato da se stesso.
Nel periodo antecedente alla prima guerra mondiale il sionismo pone le basi istituzionali per la politica di alleanze con le grandi potenze (Turchia e Germania) e, allo stesso tempo, intraprende la colonizzazione della Palestina ottomana attraverso la cosiddetta seconda aljià (immigrazione), composta in prevalenza da membri dei partiti socialisti russi. È solo, però, con la guerra che il sionismo, giostrando abilmente sullo scacchiere politico internazionale, riesce a ottenere la promulgazione, nel 1917, della dichiarazione Balfour, che sancisce il favore della potenza coloniale britannica allo stabilimento in Palestina del focolare nazionale ebraico. Nel 1920 la conferenza di San Remo affida alla Gran Bretagna il mandato palestinese, approvato dal Consiglio della Società delle Nazioni nel 1922 e ratificato nell’accordo di pace di Losanna con la Turchia nel 1923. Il compito del mandatario è duplice: creare un “focolare nazionale ebraico” e le istituzioni di autogoverno senza che vengano lesi i diritti civili e religiosi di tutti gli abitanti della Palestina (gli arabi musulmani e cristiani). La dirigenza araba-palestinese, sotto la guida del Gran Muftì di Gerusalemme, non sottoscrive il testo del Libro Bianco di Churchill (1922), contenente l’obbligo duplice del mandatario, giacché ritiene illegittimo e ingiusto il diritto sionista a un focolare nazionale in Palestina. Il mandato britannico durerà sino al 1948, inframmezzato da periodiche ribellioni arabe (1920, 1921, 1929, 1936), dal perseguimento della colonizzazione sionista e dal tentativo britannico di salvaguardare i propri diritti di potenza coloniale nella regione sostenendo ora una, ora l’altra fazione.
La seconda guerra mondiale infligge una svolta decisiva alle sorti del mandato palestinese. Il governo britannico, dopo aver tentato di assicurarsi l’appoggio arabo nella regione con l’emanazione del Libro Bianco di MacDonald (1939), che limita l’immigrazione sionista e l’acquisto dei terreni e fissa la creazione di uno Stato palestinese a maggioranza araba, è costretto a rimettere il mandato nelle mani delle neonate Nazioni Unite. Il piano di una commissione ad hoc (UNSCOP), che preveda la spartizione della Palestina in uno Stato arabo, uno ebraico e un nuovo mandato su Gerusalemme, viene approvato nel novembre 1947 dall’Assemblea delle Nazioni Unite a maggioranza qualificata (risoluzione 181). Nel maggio 1948 il mandatario britannico abbandona definitivamente la Palestina, divenuta già da mesi terra di nessuno in preda alla guerra civile. Subito dopo la proclamazione della nascita dello Stato d’Israele (15 maggio), gli eserciti dei Paesi arabi confinanti entrano in Palestina con l’obiettivo di vanificare l’“entità sionista”. La prima guerra arabo-israeliana si conclude, dopo un paio di tregue, con una serie di armistizi stipulati all’inizio del 1949: lo Stato ebraico ottiene una vittoria schiacciante annettendo parti dello Stato arabo; la parte restante del territorio palestinese viene occupato dalla Transgiordania (poi Giordania) e dall’Egitto. Quella che la memoria palestinese definisce come nakbah (“catastrofe”) crea un problema umanitario di ingenti dimensioni, attutito in minima parte con l’emigrazione all’estero (Ghurba) o con la creazione di campi-profughi nei Paesi arabi sotto l’egida di una commissione ad hoc delle Nazioni Unite (UNRWA).
I difficili rapporti tra Israele e gli Stati arabi confinanti: i ripetuti fallimenti della mediazione internazionale
Gli anni Cinquanta si caratterizzano per l’iterato fallimento, sostenuto dalle Nazioni Unite, dei tentativi di concludere un qualsiasi accordo di pace con i Paesi arabi (vedi il caso di re Abdallah di Giordania, assassinato a Gerusalemme nel 1951). Le tensioni di Israele con i Paesi confinanti, in special modo con l’Egitto, crescono a seguito di operazioni di sabotaggio (come nel caso dell’affare Lavon del 1952) e delle “infiltrazioni” dei fedayn (“combattenti”) palestinesi. La rivoluzione dei giovani ufficiali in Egitto (1952) porta alla ribalta della scena mediorientale la figura del colonnello Gamal Abdel Nasser (1918-1970) del partito socialista Baath, intento a rinsaldare il fronte antisraeliano nell’ottica di un nuovo Medio Oriente arabo e socialista. La crisi di Suez può essere compresa all’interno di una congiuntura ben precisa: l’ultimo colpo di coda dell’imperialismo europeo nella regione (francese e inglese), la riluttanza americana a sostenere il regime nasseriano (mancato finanziamento della diga di Assuan), la rilevanza strategica del canale (nazionalizzato da Nasser) e le prime serie ingerenze sovietiche. La seconda guerra arabo-israeliana dura pochi giorni tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 1956: con l’intervento delle Nazioni Unite, il governo israeliano e le potenze europee appostate sul canale sono costrette a ritirarsi dal Sinai. Il vero vincitore del conflitto diventa Nasser, leader di un nuovo panarabismo laico, terzomondista e antimperialista.
Negli anni Sessanta riemergono con prepotenza tutti i problemi differiti nel 1949: la sorte del popolo palestinese e l’assenza di accordi di pace definitivi tra le parti. Accanto ai velleitari progetti nasseriani (nel 1961 tramonta definitivamente il sogno della Repubblica Araba Unita tra Siria ed Egitto), nel 1964 l’influenza pervasiva del clima terzo-mondista favorisce la creazione dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP). Benché pensata da Nasser per governare la resistenza palestinese e normalizzare la situazione lungo il confine con Israele, l’OLP diventa ben presto il cuore pulsante del nuovo nazionalismo palestinese laico e autonomo. La guerra dei Sei Giorni (giugno 1967) sancisce infatti la crisi dell’egemonia baathista nel Medio Oriente: lo Stato d’Israele occupa nuovamente il Sinai e la striscia di Gaza, in aggiunta alle alture siriane del Golan, alla Cisgiordania e – soprattutto – a Gerusalemme. La risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (novembre 1967) chiede il vago ritiro israeliano dai territori occupati. Il governo israeliano reagisce alla richiesta del palazzo di Vetro ponendo i territori occupati sotto amministrazione militare e favorendo una politica di “annessionismo strisciante” e di “trasferimento strisciante” con l’insediamento di coloni. L’obiettivo di lungo periodo è quello di costringere la popolazione palestinese a emigrare. Di fronte alla proposta israeliana di negoziare un accordo di pace, i paesi della Lega Araba, riuniti a Khartum nella tarda estate 1967, proclamano i tre famosi “no”.
La crisi mediorientale, rinfocolata dalla “guerra d’attrito” tra Israele ed Egitto nel 1969-1970, non viene sbloccata nemmeno in seguito alla mediazione delle Nazioni Unite o del governo statunitense (attraverso il piano Rogers). La morte di Nasser, sostituito da Sadat (1918-1981) nel 1971, indebolisce il fronte arabo e accresce la fiducia israeliana nella sua invulnerabilità bellica. L’OLP, guidata da Arafat (1929-2004) dal 1969, decide di cambiare tattica: dall’insurrezione popolare nei territori alle incursioni armate dei guerriglieri. Nel settembre 1970 il re Hussein di Giordania (1935-1999), temendo il rovesciamento del proprio regime, decide di smantellare con la forza dell’esercito le basi dell’OLP ad Amman. Questo evento (il “settembre nero”) dà il la a una nuova tattica del nazionalismo palestinese: il terrorismo contro i civili ebrei all’estero (dal dirottamento di aerei di linea sino all’assassinio di atleti israeliani durante le Olimpiadi di Monaco del 1972). La guerra del Kippur (ottobre 1973) si conclude con una vittoria politica di Sadat: gli Israeliani si rendono conto di non essere invincibili; la risoluzione 338 del Consiglio delle Nazioni Unite ribadisce il contenuto della 242. In seguito allo shock petrolifero indotto dall’OPEC e all’intervento del segretario di Stato americano Henry Kissinger (1923-), il governo presieduto da Golda Meir (1898-1978) è costretto a sedersi al tavolo dei negoziati: fallita nel dicembre 1973 la Conferenza di pace riunita a Ginevra, Israeliani ed Egiziani iniziano a discutere accordi di disimpegno e di non belligeranza. Nel novembre 1974 Arafat parla di fronte all’Assemblea delle Nazioni Unite, sventolando il ramoscello di ulivo e il kalashnikov. L’anno successivo, l’approvazione della risoluzione 379, che equipara sionismo e razzismo, evidenzia l’isolamento israeliano nel concerto politico internazionale.
La situazione internazionale venutasi a creare dopo la guerra del Kippur provoca ingenti scossoni anche nell’arena politica israeliana. Alle elezioni del 1977 si impone la coalizione del LIKUD guidata dal leader Heruth Menachem Begin (1913-1992): dopo tre decenni la sinistra laburista deve lasciare il passo alla destra populista. L’amministrazione democratica Carter, alla guida degli Stati Uniti, decide di abbandonare la pista kissingeriana dei “piccoli passi” e di coinvolgere direttamente Sadat nella soluzione generale del conflitto mediorientale. Nell’estate 1978, dopo lo storico viaggio del presidente egiziano in Israele, le due parti si ritrovano a Camp David, nel Maryland, per vagliare un accordo di pace. Nel marzo 1979 i due Paesi stipulano una pace separata, in base alla quale Israele si impegna a ritirarsi dal Sinai, senza però fare concrete concessioni sulla questione dei territori occupati. L’assassinio di Sadat nel 1981, l’assenza di dialogo con la controparte palestinese e il tentativo di allentare la morsa siriana fungono da prolegomeni all’invasione del Libano nel giugno 1982. Il paese dei cedri, afflitto da una guerra civile etnico-religiosa, ospita da anni le basi dell’OLP. L’invasione israeliana si conclude con un fallimento: Arafat riesce a partire indenne da Beirut, le Nazioni Unite inviano forze di interposizione, l’alleato cristiano-maronita Amin Gemayel (1942-) non riesce a realizzare i suoi piani egemonici.
I nuovi scenari del conflitto arabo-israeliano: dagli anni Ottanta ad oggi
Con le improvvise dimissioni di Begin nel 1983, scottato dal pantano militare politico e morale libanese, in Israele si apre una stagione decennale di governi di unità nazionale, che prevede la rotazione nella carica di primo ministro tra il laburista Shimon Peres (1923-) e il likudista Yitzhak Shamir (1915-2012). Gli scenari del conflitto mutano repentinamente nel giro di pochi anni: lo scoppio dell’Intifada nel dicembre 1987, lo storico discorso ginevrino di Arafat (in cui riconosce l’esistenza dello Stato di Israele e rinuncia formalmente al terrorismo), la seconda guerra del Golfo contro l’Iraq di Saddam Hussein (sostenuto da Arafat) e la Conferenza Internazionale di Madrid sul Medio Oriente organizzata dal segretario di Stato americano Baker (1991). L’impasse indotta dal mancato riconoscimento ufficiale tra le due parti viene superato solo con la preziosa mediazione diplomatica norvegese, che porta all’elaborazione di una dichiarazione di principi. Nel settembre 1993 il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin (1922-1995) e Arafat firmano a Washington un documento che sancisce il riconoscimento reciproco, l’istituzione di un’Autorità Provvisoria di Autogoverno Palestinese (ANP) in Cisgiordania e nella striscia di Gaza e l’assetto permanente basato sulle risoluzioni 242 e 338 delle Nazioni Unite. Nel corso degli anni successivi emerge con chiarezza la problematicità dello “spirito di Oslo”: entrambe le parti non sono in grado di rispettare le clausole più importanti (abbandono del terrorismo per gli uni e termine della colonizzazione per gli altri). L’assassinio di Rabin nel novembre 1995 e l’offensiva terroristica di Hamas e della Jihad islamica pongono le basi per la vittoria del candidato likudista Benjamin Netanyahu (1949-) alle elezioni del 1996.
La politica dei fatti compiuti intrapresa da Netanyahu, unita agli attentati terroristici di Hamas e della Jihad islamica, finiscono per rendere carta straccia gli accordi di Oslo. Il primo ministro laburista Ehud Barak (1942-), succeduto al likudista nel 1999, cerca di concludere il processo di pace con una serrata finale. Nel luglio 2000 le due parti, ospiti a Camp David del presidente americano Clinton (1946-), non riescono a trovare un accordo sui nodi principali: il rientro dei profughi, lo statuto di Gerusalemme, i confini tra lo Stato israeliano e il futuro Stato palestinese, gli insediamenti dei coloni, l’approvvigionamento idrico e l’inquinamento. In settembre la provocatoria passeggiata del leader likudista Ariel Sharon (1928-2014) sul monte del Tempio di Gerusalemme fa scoppiare la cosiddetta seconda Intifada: non più solo pietre, ma anche attentati terroristici contro civili inermi. Tramontate l’amministrazione Clinton e quella Barak, i rispettivi successori Bush (1946-) e Sharon, posti di fronte all’evento epocale dell’11 settembre, irrigidiscono l’applicazione del teorema della sicurezza “senza se e senza ma”, che prevede l’equiparazione di ogni forma di terrorismo armato (al Qaeda come Jihad islamica). Nel 2004 il decesso di Arafat apre spiragli di dialogo tra le parti: l’ala moderata dell’OLP, posta di fronte al secco aut-aut israeliano, sta cercando di controllare e di “istituzionalizzare” le frange più intransigenti di Fatah, isolando quelle terroristiche contrarie a qualsiasi negoziato politico. Il recente smantellamento degli insediamenti di Gaza deciso dal governo Sharon è, forse, il primo timido segnale in direzione della risoluzione di un conflitto, che dovrà ancora fronteggiare le alte vette degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, del problema idrico, di Gerusalemme e dei profughi.