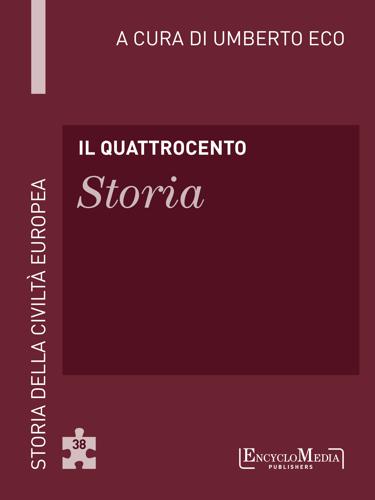La politica dinastica degli Asburgo
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
A partire dal XV secolo, la dinastia asburgica s’insedia stabilmente alla guida dell’impero; l’affermazione del principio ereditario non investe la forma della designazione, che resta elettiva, così come prosegue l’inaridimento dell’istituzione imperiale, cornice di principati sostanzialmente autonomi e strumento di rafforzamento per le dinastie dei sovrani. Le vicende dell’area imperiale, tuttavia, si accostano ai processi in atto nelle maggiori monarchie europee, se si guarda al riordinamento interno ai singoli principati e alla sacralizzazione della stirpe regnante, che rende possibile fare a meno del ricorso alla mediazione pontificia.
L’impero prima degli Asburgo
La tradizione germanica, a partire dall’età altomedievale, indirizza la successione imperiale verso un principio elettivo che resiste ai ripetuti tentativi di consolidamento dinastico.
Una forma di dinastizzazione, invece, si determina all’interno della maggiore aristocrazia tedesca, che riesce a controllare durevolmente – almeno a partire dal XIII secolo – il diritto di eleggere l’imperatore, e che spesso attinge ad aree marginali dell’impero, per selezionare figure atte a incarnare il prestigio dell’istituzione imperiale, ma non a esercitare un’effettiva capacità di governo, sostanziale appannaggio dei principati territoriali.
Nel 1356, con la Bolla d’oro di Carlo IV di Lussemburgo , la prassi elettiva viene codificata e i principi elettori risultano stabilmente individuati fra gli esponenti della maggiore aristocrazia laica ed ecclesiastica tedesca: se, ancora pochi decenni prima, Enrico VII di Lussemburgo poteva accogliere suggestioni di tipo universalistico, la Bolla d’oro indica con chiarezza che l’impero è ormai un fatto meramente germanico, che trova espressione anche nella denominazione ufficiale (Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae).
Il ritorno degli Asburgo: Alberto II
Signori territoriali nel X secolo, conti nell’XI e già imperatori nella seconda metà del XIII, gli Asburgo, ormai duchi d’Austria, tornano a conseguire la dignità imperiale solo nel 1438, per mantenerla, questa volta, fino al crollo imperiale di età napoleonica (1806) e poi di nuovo fino all’instaurazione della repubblica (1919).
Il ritorno alla guida dell’impero è il risultato di una politica dinastica condotta in modo sistematico dagli Asburgo: che siano o meno imperatori, essi ampliano tenacemente i domini originari svizzero-alsaziani in direzione dell’Austria; tentano di creare legami dinastici con la Borgogna; nell’area svizzera sono tanto attivi da provocare la resistenza dei valligiani, da cui prende origine la confederazione elvetica; si muovono più volte verso la Boemia, usando le armi, la diplomazia e le strategie matrimoniali; provano a porre le basi per l’inserimento nella linea di successione del Regno di Ungheria.
In questo solco procede Alberto II d’Asburgo, che eredita giovanissimo il ducato, su cui comincia a governare dopo essersi liberato dalla litigiosa tutela degli zii, aprendosi la strada verso la corona imperiale con un’accorta combinazione di impegno militare e politica dinastica.
Sposata nel 1421 Elisabetta, figlia dell’imperatore Sigismondo di Lussemburgo, Alberto appoggia il suocero nella repressione della rivolta ussita e taborita, in cui si esprimono le tensioni religiose e nazionali della Boemia, passata ai Lussemburgo all’inizio del Trecento. Per oltre dieci anni, Alberto è coinvolto in un conflitto che gli garantisce la designazione alla successione da parte di Sigismondo.
Quando il suocero muore, nel 1437, Alberto è innanzitutto incoronato re d’Ungheria: anche questo regno, infatti, era entrato a far parte dei domini dei Lussemburgo al principio del XIV secolo. Immediatamente dopo, diventa re di Boemia; infine arriva la designazione imperiale (1438). Germania, Austria, Boemia e Ungheria: sotto lo scettro di Alberto II sembrano essere già riuniti i territori che da allora in avanti caratterizzeranno il complesso imperiale. Ma si tratta ancora di una costruzione instabile: in Boemia prosegue il conflitto ussita e antitedesco; in Ungheria, Alberto è osteggiato dall’autonomismo della nobiltà e incalzato dall’espansionismo ottomano, combattendo il quale muore (1439).
Federico III: un perdente di successo?
Re di Germania dopo Alberto viene eletto nel 1440 il cugino Federico III, cui è affidata anche la tutela del nipote Ladislao, nato da poco. Dalla madre, Elisabetta di Lussemburgo, Ladislao eredita le corone di Boemia e di Ungheria, e Federico ne assume la reggenza, senza riuscire a esercitarvi autorità effettiva.
Dopo la morte di Ladislao, nel 1457, la situazione si fa ancora più critica: nel 1458 in Boemia, diventa re Giorgio di Podebrady e in Ungheria è incoronato Mattia Corvino, che arriva fino a condividere la corona boema, a occupare Vienna (1485) e a candidarsi alla successione imperiale. Dopo la morte di Mattia, Boemia e Ungheria sembrano ormai sfuggite agli Asburgo, poiché finiscono entrambe sotto il controllo degli Jagelloni, in via di espansione fra Lituania e Polonia.
Ma nel frattempo la tenace costruzione asburgica non si è arrestata: nel 1448, Federico III definisce in forma concordataria i rapporti con la Chiesa di Roma e nel 1452 è incoronato imperatore; nello stesso anno consolida le proprie posizioni, anche economiche, grazie al matrimonio con Eleonora del Portogallo; sopravvive al fratello, che gli contendeva l’eredità austriaca, ereditandone i domini; infine combina un matrimonio che porta alla casa d’Austria anche i Paesi Bassi: quello del figlio Massimiliano con Maria, figlia di Carlo I di Borgogna, in cerca di appoggio nella guerra contro il re di Francia.
Massimiliano I d’Asburgo
Massimiliano, eletto e incoronato re dei Romani già dal 1486, diventa imperatore dal 1508, con una procedura che esclude definitivamente la tradizionale consacrazione pontificia.
Massimiliano raccoglie e rilancia la politica dinastica dei suoi predecessori, giungendo a dominare su un’estensione territoriale senza precedenti: dal 1482, morta Maria di Borgogna, governa i Paesi Bassi per conto del figlio Filippo; nel 1490 eredita i domini del ramo tirolese della dinastia; quindi riprende l’Austria inferiore agli Ungheresi e più tardi si accorda con gli Jagelloni assicurandosi la successione ai troni di Boemia e Ungheria (trattato di Presburgo, 1515); nel 1493, alla morte del padre, diventa re di Germania ed entra in possesso degli altri domini familiari; nello stesso anno volge le proprie mire in direzione dell’Italia settentrionale, sposando in seconde nozze la figlia del duca di Milano, Bianca Maria Sforza; quindi si imparenta con la monarchia iberica e con i Savoia mediante i matrimoni della figlia Margherita. Il capolavoro dinastico di Massimiliano è però rappresentato dall’unione fra il figlio Filippo e la regina di Castiglia e León, Giovanna: sarà questa, la combinazione che porterà il nipote, Carlo V, a capo della più formidabile concentrazione territoriale della prima età moderna.
Ai successi dinastici non corrisponde però un reale incremento della presa effettiva di Massimiliano sui territori imperiali. La sua intensa attività bellica, la necessità di difendere l’impero su più fronti (compreso quello sud-orientale, esposto alla combattività ottomana) lo rendono particolarmente dipendente dall’appoggio dei principi, ottenuto in cambio di contropartite che cristallizzano l’antico dualismo fra imperatore e stati territoriali, e vanificano i tentativi fatti da Massimiliano (e poi da Carlo V) per riformare l’organizzazione dell’impero, malgrado l’introduzione di qualche efficace strumento di governo e l’avvio di un’efficiente rete burocratica.
I fallimenti imperiali mostrano come i principati territoriali siano ormai troppo radicati, ma confermano anche che l’attitudine delle famiglie imperiali a occuparsi prevalentemente dell’ampliamento dei propri domini dinastici si è spinta troppo oltre, perché l’impero possa avviare un processo di centralizzazione.Le procedure del rafforzamento statale, d’altro canto, sono da tempo in corso all’interno dei principati territoriali, dove si servono di strumenti non dissimili da quelli contemporaneamente impiegati dalle maggiori monarchie europee: la disciplina dei corpi politici interni, il controllo delle cariche ecclesiastiche, il rafforzamento dell’organizzazione militare e delle strutture amministrative e finanziarie.