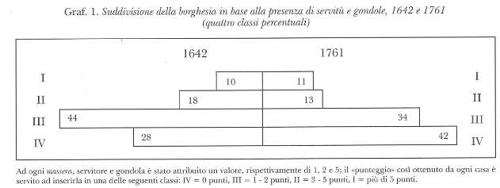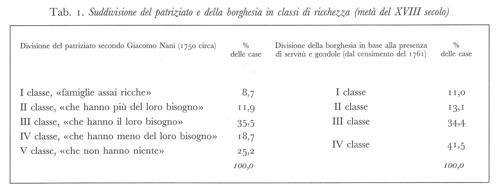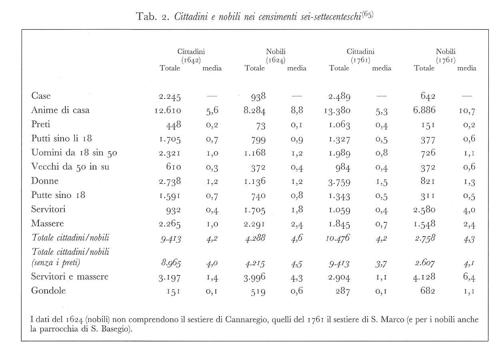La presenza borghese
La presenza borghese
Borghesia, un termine storiografico «aperto»
Pochi concetti storiografici sono stati oggetto di un processo di revisione critica paragonabile a quello che negli ultimi decenni ha interessato i due termini attorno ai quali vertono queste pagine: borghesia e Seicento. Di qui l’opportunità di alcune brevi osservazioni a carattere introduttivo, per giustificare l’angolo di prospettiva dal quale si intende guardare alla presenza borghese nella Venezia seicentesca.
La crisi del concetto di borghesia è venuta alla luce, si può dire, nel momento in cui si è cercato di approfondire in precise situazioni storiche la reale composizione sociale della classe media, il suo sistema di valori, il suo ruolo concreto nei cambiamenti politico-istituzionali nelle società europee dell’epoca moderna (1). Nella maggior parte delle situazioni analizzate — e soprattutto nelle grandi città, culle d’adozione della borghesia — si è visto che sotto questa etichetta può esser fatta rientrare una tale varietà di condizioni sociali, professionali ed economiche da rendere in sostanza inefficace se non improprio l’uso di un’unica categoria che le riassuma tutte. Si è provato ad aggirare questo ostacolo sostenendo l’inopportunità di una suddivisione delle società d’Ancien Régime in base alla capacità economica dei singoli o alla proprietà dei mezzi di produzione. Al concetto di classe si è quindi sostituito quello di «ordine», «ceto », sostenendo, con argomentazioni fondate, che le suddivisioni interne erano piuttosto dovute a differenze di status, di rango. Tale diversa impostazione non ha comunque risolto il problema: il livello intermedio di queste «società di ceti» ha finito comunque per comprendere una congerie di figure sociali eterogenee, senza dimenticare che le differenze economiche contavano pur sempre qualcosa anche nelle società tradizionali.
L’indefinitezza del concetto di borghesia è stata vieppiù sottolineata da quanti si sono interessati agli stili di vita, al sistema di valori, alle aspettative ideologiche e politiche. Quando si è riusciti a focalizzare all’interno della classe media un gruppo sociale sufficientemente omogeneo e strutturato, ci si è resi conto che, forse perché si è trattato quasi sempre di strati medi o medio-alti della middle class, per sistema di valori esso non mostrava differenze significative rispetto all’aristocrazia, né tendeva ad elaborare una coscienza di classe antitetica, mostrando invece evidenti comportamenti imitativi e una propensione all’omologazione. Il ruolo politico dei ceti medi nelle rivoluzioni inglese e francese — quando cioè secondo una lettura classica l’ascesa al potere della borghesia avrebbe concluso il processo di sostituzione della classe aristocratica — è stato poi uno dei punti focali della revisione critica di questi grandi avvenimenti storici. Argomento principe del revisionismo è l’insussistenza di un rapporto diretto tra borghesia e gruppi politici che «fecero» le rivoluzioni; per mentalità, interessi, predisposizione, è stato argomentato, erano sovente proprio i borghesi i più fidati sostenitori dell’Ancien Régime, di cui garantivano il funzionamento mediante il controllo di alcuni gangli vitali come l’amministrazione, la finanza, le professioni liberali. Il supposto ruolo antagonista della borghesia rispetto al sistema sociale e politico dominato dalla monarchia e dall’aristocrazia sarebbe quindi frutto di una visione teleologica non corrispondente alla realtà storica (2).
All’interno di questo processo di revisione critica è entrato tanto più in crisi uno dei passaggi cardine della lettura tradizionale delle trasformazioni sociali dell’epoca moderna, il secolo XVII, nella sua interpretazione di fase di rallentamento del processo di transizione dal feudalesimo al capitalismo che avrebbe comportato nell’Europa meridionale ed orientale significativi fenomeni di rifeudalizzazione, sia dal punto di vista economico che sociale. A questo schema hanno fatto implicito riferimento anche autori non marxiani, come Fernand Braudel cui si deve la formulazione del paradigma storiografico del «tradimento della borghesia», che nel Seicento avrebbe rinnegato se stessa entrando nelle fila della nobiltà o passando dal commercio alla proprietà terriera (3). Una formula senza dubbio suggestiva, che confondeva però un fenomeno congiunturale — ipotizzabile per i soli paesi mediterranei — con la mobilità ascensionale strutturale tipica delle classi medie, quella tendenza comune ai mercanti, come scriveva Adam Smith, a diventare «country gentlemen» (4).
Anche in questo ambito, ricerche recenti hanno confermato alcuni aspetti del quadro, come l’indiscutibile passaggio del ruolo-guida dell’economia europea dai paesi mediterranei a quelli nordici, confutandone altri, come il valore totalmente negativo di «declino», «decadenza» che il Seicento rappresentò ad esempio per l’economia e la società dell’Italia centrosettentrionale. Lo spostamento degli interessi dalla città alla campagna (che avrebbe avuto un’accelerazione nel Seicento) è stato reinterpretato come una doverosa riscoperta dell’ambiente economico rurale e non come un meschino ripiegamento delle élites economiche verso la rendita immobiliare. La stessa crisi economica che attraversò il nostro paese nel Seicento è stata riconsiderata, riducendone la durata, ridimensionandone l’aspetto quantitativo, ponendone piuttosto in luce le conseguenze qualitative — non tutte negative come si è detto — che comportò (5).
La dissoluzione dello schema di lettura tradizionale delle trasformazioni delle società europee basato su una certa idea, abbastanza precisa e quindi rigida, di borghesia, ha coinvolto solo in parte la storia di Venezia e del suo corpo sociale, che hanno sempre rappresentato un unicum difficilmente assimilabile ad altre realtà. Gli schemi tradizionali di articolazione del corpo sociale, in una città circondata dalle acque dove praticamente ogni metro è «spazio urbano», dove, come ripetevano i cronachisti medievali, «non si ara, non si semina, non si vendemmia», appaiono già ben prima dell’epoca moderna insufficienti. Il grande impero commerciale veneziano creato lungo i secoli tardomedievali ha come protagonista il patrizio-mercante, singolare figura di capitalista ante litteram. Le stesse istituzioni marciane appaiono concepite in funzione di questa corale intrapresa commerciale: agli inizi del Cinquecento, quando gran parte degli stati europei fatica ad uscire da una dimensione feudale, per il diarista patrizio Domenico Malipiero tutti i mercanti veneziani formano «una grande e ben ordinata compagnia di cui il Senato [è] l’organo direttivo» (6), un’espressione che ricorda quella usata da Marx ed Engels per definire tre secoli dopo il potere statale moderno, «un comitato che amministra gli affari comuni di tutta la classe borghese» (7). L’esperienza di un patriziato cittadino dedito ad attività imprenditoriali non era certamente unica anche solo nel quadro dell’Italia settentrionale della prima età moderna, tuttavia l’importanza e le dimensioni della mercatura nell’emporio marciano resero il patrizio veneziano — assieme forse solamente al nobile genovese — una figura sociale affatto particolare, con molti dei caratteri del borghese moderno.
Se ricercare nella Venezia del Quattro e Cinquecento le tracce di una «borghesia nascente» si rivelerebbe dunque operazione difficile e contraddittoria, tale compito può apparire meno complicato per il secolo successivo. Tra XVI e XVII secolo, infatti, si suole collocare la svolta che portò la classe dirigente veneziana ad abbandonare pressoché definitivamente il commercio, volgendo i propri investimenti verso la rendita finanziaria e fondiaria, dedicandosi a tempo pieno alla cura dello stato aristocratico, ed assumendo stili di vita, mentalità e comportamenti tipici delle élites nobiliari europee. Sebbene, come rendono conto altri interventi in questo volume, questa opinione sia stata in parte rivista o ridimensionata nella storiografia recente, comunque l’idea di una Venezia-città mercantile dove si respirava aria di «civile libertà», dove la classe nobiliare dimostrava una moderatezza altrove ignota, dove insomma un’oligarchia ereditaria presentava alcuni dei caratteri dello spirito borghese moderno, fu uno degli aspetti del mito di Venezia che perdurò lungo tutto il Seicento.
Senza l’appoggio di grandi schemi storiografici, per aggirare le insidie di una città mutevole che mostra ora il suo volto più aristocratico ora la sua primigenia natura mercantile, converrà ripartire da una modesta domanda, chiedendosi chi nella Venezia del Seicento fosse considerato borghese e chi no, secondo commentatori veneziani, secondo l’opinione di visitatori e trattatisti stranieri.
Una versione ufficiale: la classe media secondo i Veneziani
Gli scrupoli «scientifici» degli storici appaiono del tutto anacronistici se si interrogano riguardo alla struttura sociale della Serenissima le fonti veneziane seicentesche. In maniera pressoché unanime veniva infatti asserito, e ciò sia da commentatori di estrazione patrizia che da osservatori di status non nobile, come un dato comunemente accettato che gli abitanti della città si dividevano in nobili, cittadini, popolani: «Questa tripartita divisione viene in Venetia ad ogni passo ascoltata», scrive l’avvocato Nicolò Crasso attorno al 1650 nelle sue «annotationi» alla riedizione dei due famosi trattati cinquecenteschi sulla Repubblica del Contarini e del Giannotti (8).
Tre ordini formavano quindi la gerarchia sociale cittadina dando vita ad una tripartizione del cui assetto simmetrico e funzionale si compiacevano gli osservatori veneziani, preoccupati soprattutto di evidenziare l’«armonia» della città e del suo reggimento. Tre ordini, però, dalla natura profondamente diversa, con differenti criteri di legittimazione ed appartenenza e dalla dimensione demografica considerevolmente dissimile; tale asimmetria sostanziale era ben nota, ma non era d’ostacolo agli scrittori seicenteschi di politica che consideravano la disuguaglianza come un dato costitutivo delle società umane. Può avere un senso sfrondare della sua valenza ideologica questa visione per cercare, con una precisione analitica forse estranea alla mentalità del tempo, di ricostruire la vera natura delle categorie sociali operanti nella Venezia del Seicento? Crediamo di sì: cogliere le differenze, le discrasie insite nell’autorappresentazione di una struttura sociale può aiutare a capire i suoi meccanismi di ricambio, i modi attraverso i quali l’intero corpo sociale si trasformava e quindi in definitiva le regole su cui esso poggiava.
Dei tre ceti veneziani, quello superiore, la classe aristocratica, veniva identificato secondo un criterio che si potrebbe definire storico-giuridico: appartenenti alla nobiltà erano i membri delle famiglie iscritte nel Libro d’oro del patriziato, cioè quelle casate che tra XIII e XIV secolo avevano affermato la propria posizione egemonica al vertice della scala sociale cittadina e alla guida dello stato. Dalla fine del Trecento alla metà del Seicento il ricambio «esterno» di questo gruppo sociale, vale a dire l’immissione di nuove famiglie nelle fila del patriziato, come è noto venne bloccato. Per quanto riguarda invece il ricambio «interno», nel corso del XVI secolo si affinarono le procedure di registrazione dei figli dei patrizi e le norme che regolavano i matrimoni di nobili con donne di altro ceto. Si tratta di due aspetti interessanti su cui varrà la pena di ritornare, riguardo ai quali è opportuno per intanto sottolineare come si trattasse di due momenti di «filtro» che coinvolgevano lo strato sociale inferiore alla nobiltà: i figli di patrizi «non provati» all’avogaria di comun — che erano quindi frutto o di relazioni illegittime o di matrimoni con donne «popolari» — appartenevano infatti per consuetudine alla cittadinanza, lo stesso ceto da cui in pratica dovevano provenire le donne che potevano legittimamente, sposando un nobile, contribuire a perpetuare una casata patrizia.
Tratteggiata la natura dello status nobiliare e le sue regole di appartenenza, non è superfluo ricordare le sue prerogative, che consistevano primariamente nell’esercizio del potere e quindi nella guida dello stato, un privilegio che come aveva annotato il segretario Giannotti e come si sarebbe azzardato a ricordare anche l’avvocato Crasso non si ritrovava sancito in alcuna legge positiva, in nessuno statuto, «se bene sappiamo [...] essere pienamente osservato» (9).
All’estremità opposta della scala sociale, il ceto popolare costituiva per molti versi l’antitesi della nobiltà, per la sua dimensione demografica — tra le cento e le centocinquantamila persone nel corso del secolo, contro le quattro-seimila unità dei nobili nello stesso periodo —, per le sue prerogative sociali che erano praticamente nulle o ridotte ad alcuni aspetti simbolici, per la sua stessa natura ed i suoi criteri di appartenenza. Se il titolo nobile era qualcosa che poteva essere comprovato burocraticamente e socialmente in forma positiva, la condizione popolare appare definibile solo in negativo, come condivisa da tutti coloro che non erano né nobili né cittadini, insomma una sorta di contenitore vuoto nel quale venivano fatti rientrare quanti non disponevano di uno status preciso e superiore. Anche per questo motivo i suoi filtri di selezione erano praticamente inesistenti: vi appartenevano per il solo fatto di risiedere a Venezia i nativi della Dominante e i sudditi del Dominio, ai quali venivano parificati gli stranieri che dopo aver soggiornato per un congruo numero di anni e pagato le fazioni cittadine ottenevano una forma ridotta di cittadinanza, detta «per privilegio». I ritmi di ricambio del ceto popolare dipendevano in definitiva dalle fluttuazioni demografiche, dall’andamento dei flussi migratori, quindi dai grandi movimenti dell’economia e della popolazione.
Per descrivere lo strato intermedio — quello che interessa di più ai fini di questo studio — tornano utili le pagine della più bella descrizione seicentesca dello stato veneziano, il trattato di un nobile originario di Candia, Zuan Antonio Muazzo, scritto nell’ultima parte del secolo. Dopo aver ribadito la tripartizione della società veneziana, il Muazzo spiega come si solevano individuare i cittadini: «appresso di noi passano propriamente sotto questo nome [...] quelli che, oltre l’antica origine da Veneti, menano vita civile e sono capaci di alcuni offitij e ministerij a questo ordine solamente riservati, tra quali li più rigguardevoli sono la cancelleria Ducale, li notariati dell’Avogaria, e molti altri. Questi comunemente si dicono Cittadini Originarij» (10).
Il titolo di cittadino originario veniva riconosciuto a chi avesse giustificato alle autorità competenti la nascita in città, legittima, di «sé, padre et avo», l’astensione per le stesse tre generazioni da arti meccaniche e l’inesistenza di pene per reati gravi. È superfluo riepilogare il processo che condusse alla formazione di questo ordine (11); più utile può essere ricordare che la condizione riconosciuta giuridicamente di abitante privilegiato della città, un istituto tipico delle città medievali, era ancora ampiamente diffusa nell’Europa seicentesca, dove veniva variamente denominata con vocaboli derivanti dall’etimo tardolatino burgum. Così ad esempio il de la Haye, ambasciatore francese a Venezia, per presentare il significato di «cittadini» nel suo trattato del 1668 spiega «sono quelli che noi chiamiamo borghesi» e una decina d’anni dopo un altro francese, Amelot de la Houssaie, usa la medesima espressione «la Cittadinanza, c’est à dire, la Bourgeoisie» (12). L’identificazione cittadini originari/borghesia ha quindi una sua giustificazione storico-etimologica, che non va però confusa con il significato che, dal XIX secolo almeno in poi, la parola borghesia ha assunto nel vocabolario politico comune.
Nel 1569 questo ceto aveva raggiunto un importante traguardo, ottenendo la formalizzazione legislativa del titolo di cittadino originario, la cui procedura di riconoscimento era significativamente affidata alla stessa magistratura che gestiva il Libro d’oro patrizio, l’avogaria di comun. Da questa data in poi il riconoscimento di tale condizione fu sempre possibile, sicché rispetto alla classe patrizia il ricambio dall’esterno di questo ceto fu ininterrotto, anche se la qualità particolarmente severa dei requisiti richiesti lo rese limitato e diluito nel tempo. Se i criteri di legittimazione della cittadinanza originaria veneziana non rappresentavano un aspetto di per sé originale, singolare è invece l’area di privilegio ed il ruolo che quest’ordine seppe ritagliarsi nella struttura dello stato marciano. In pratica, ma si avrà modo di ritornare su questo punto, una serie importante di uffici nell’amministrazione centrale dello stato vennero riservati in esclusiva ai cittadini originari, che giunsero ad avere un profilo sociale ed una identità di gruppo molto forti, per certi aspetti non inferiori a quelli del patriziato.
Pur con le differenze nei criteri di identificazione, nei meccanismi di ricambio e negli ambiti di privilegio sociale tra i tre ordini che si è cercato di descrivere, la divisione della società veneziana in nobili, cittadini e popolani sembra comunque rispondere ad un coerente criterio definitore: ogni abitante si collocava nella gerarchia sociale a seconda dell’antichità e della qualità del rapporto che come persona (o come famiglia per la nobiltà) poteva vantare rispetto alla città, alle sue istituzioni, alla sua storia. Si trattava di un rapporto eminentemente giuridico — cioè inerente al diritto, alle sue norme — ma con rilevanti ricadute sul piano sociale, derivanti dalla riconoscibilità di una persona, di una famiglia, come «antica» della città.
Di questa lettura della società veneziana il Muazzo, con una precisione descrittiva sconosciuta ai precedenti apologeti della Repubblica, dà forse la versione più completa, avventurandosi in una suddivisione dei vari gradi della cittadinanza intesa nel suo significato più ampio. Al primo posto colloca, come è logico attendersi, quella «originaria»; al secondo mette i figli illegittimi dei nobili, ammessi a tutti gli uffici riservati ai cittadini originari ad esclusione della cancelleria ducale, a loro interdetta — aggiungiamo noi — forse per la contiguità che vi avrebbero avuto con i magistrati patrizi. Seguono quindi i nativi della città che, ancorché nati da padre forestiero, erano ammessi a tutti gli uffici non riservati agli originari; i forestieri che in virtù di una «cittadinanza per privilegio» venivano ad essere considerati «come Veneti»; infine i forestieri veri e propri che, se nel passato avevano scontato il divieto di commerciare nel Levante e con i Tedeschi, al presente godevano di «libero traffico, e ne’ contratti, ne’ testamenti e nelle successioni sono alla condizione de’ Veneti» (13).
Era questo il criterio più adatto per rappresentare le gerarchie della società veneziana? Trovava questa suddivisione un corrispondente nella realtà effettuale? Non era piuttosto il tentativo di esorcizzare la fluidità del corpo sociale, la sua irriconducibilità a categorie fisse, creando un’immagine ideologica basata su rassicuranti scansioni giuridiche? Le osservazioni di alcuni viaggiatori stranieri e le pagine dei detrattori seicenteschi della Repubblica concorrono a sollevare questi dubbi.
Lo spartiacque della professione civile
Per i cantori cinque-seicenteschi delle virtù dello stato aristocratico, la dimensione del sociale si riduceva normalmente ad un’elencazione gerarchica degli «ordini» cittadini, a cui di solito seguiva la descrizione delle prerogative concesse ad ogni ceto e una riflessione conclusiva sulla soddisfazione dei sudditi della Repubblica. Giovanni Botero, agli inizi del Seicento, compendia questo cliché: «I cittadini tutta la Secretaria, tutta la cancelleria nelle mani tengono» annota nella sua Relatione della Republica Venetiana, «sì che entrando ne’ Consigli, andando con gli Ambasciatori, participiano di tutti gli secreti, et affari della republica [...] amministrano le scuole maggiori [...]. Con queste et con altre prerogative ciascuno resta contento del suo stato» (14).
In una serie di opere di osservatori esterni tese a confutare la fama della Repubblica aristocratica e in alcuni scritti anonimi che testimoniano le crescenti tensioni interne al patriziato, la descrizione idilliaca dei rapporti tra i ceti lascia il posto ad una visione più dialettica, meno statica della società veneziana. A cominciare dalla stessa suddivisione in categorie.
Una Relatione della Città e Republica di Venetia, supera ad esempio, all’inizio degli anni Settanta del XVII secolo, la tradizionale tripartizione e accenna, invero in maniera un po’ confusa, ad un’altra possibile scala: «Si divide tutto il Popolo di Venetia in Gentil’huomini, Cittadini, Mercanti et Arteggiani». Vengono riprese le consuete definizioni per i primi due ordini («li primi sono li Padroni, li secondi persone Civili per sangue, per lettere e per ricchezze»), senza tuttavia rendere conto di questa interessante bipartizione dell’ordine intermedio in due sottoclassi, di cittadini e mercanti (15).
Pochi anni dopo sono due trattatisti francesi, Amelot de la Houssaie e il Saint-Didier, a riprendere questa prospettiva. «Le Corps des Citadins [scrive il primo] comprend le Secretaires de la Republique, les Avocats, les Notaires, les Medecins, les Marchands de Soie et de Drap et les Verriers de Muran», copiato pari passo dal secondo con la sola sostituzione ai mercanti di seta e drappi degli «Ouvriers d’Etofes d’or et de soye» (16). Secondo questi testi quindi, il requisito della cittadinanza non era sufficiente ad individuare il ceto intermedio, in cui sarebbero rientrate anche le professioni liberali (avvocati, medici, notai), una categoria di mercanti, quelli dediti al commercio di tessuti preziosi o pregiati, e addirittura una classe di persone, i vetrai di Murano, impiegati in attività artigianali: tutte professioni per accedere alle quali la cittadinanza originaria non era un requisito indispensabile.
Alla base di tale rappresentazione stava insomma un diverso criterio selettivo, non quello tipico delle città-stato medievali legato all’antichità del rapporto del singolo con gli statuti cittadini, quanto piuttosto considerazioni di ordine sociale inerenti alla «civiltà» della professione, all’«onorevolezza» del mestiere che si valutava in base al grado di distanza rispetto alle «arti meccaniche», considerazioni che erano venute rafforzandosi nel corso del Cinquecento ed avevano condotto ad una ridefinizione socio-politica delle classi dirigenti della Terraferma veneta. Che questo fosse un principio operante nella Venezia seicentesca lo confermano le leggi che permisero o regolarono il ricambio della classe aristocratica. Come si è accennato, nel 1589 veniva fissata la condizione per il reclutamento delle «donne capaci di procreare figli abili al maggior Consiglio»: il criterio basilare era che non dovessero essere «di padre et avo che avessero esercitato arte meccanica». Nel 1646, poi, quando concretamente si discusse di aprire il Libro d’oro ad un certo numero di famiglie, gli unici requisiti richiesti, a parte un sostanzioso contributo per la guerra di Candia, furono la nascita da legittimo matrimonio e la provata astensione da arti meccaniche del padre e dell’avo (17).
Se il ricambio interno ed esterno del ceto aristocratico, vale a dire uno dei meccanismi più delicati della società veneziana, la principale barriera alla mobilità ascensionale della popolazione, veniva fatto dipendere da quest’ordine di elementi ciò significa che anche per la società veneziana è vero quanto ha scritto Colin Lucas: «L’articolazione primaria nella società d’ancien régime non era costituita dalla distinzione fra privilegiati e terzo stato; ma piuttosto fra coloro che traevano sostentamento dal lavoro manuale e coloro che potevano farne a meno» (18). Non deve stupire che a Venezia, città mercantile, artigianale, industriale, tale criterio fosse attivo quanto in altre realtà cittadine, maggiormente legate al mondo della terra e alle sue gerarchie sociali. Anzi, come ha scritto Ugo Tucci, «verso i mestieri che richiedevano soltanto abilità manuale [...] la tradizione mercantile legata alla pratica quotidiana della scrittura e della razionale tenuta dei conti [...] manifestò un distacco forse maggiore che altrove» (19).
Per alcune particolari attività la condanna contro l’«arte meccanica [che] rende l’animo grossolano e rintuzza il giudizio», come scriveva nel 1625 Lodovico Zuccolo (20), veniva però sospesa, grazie alla «qualità» delle merci e dei prodotti con cui l’artigiano veniva a contatto. Potevano addirittura abilitarsi alla cittadinanza originaria, che aveva procedure di selezione molto formalizzate e che di conseguenza rappresentava il livello giuridicamente più affinato della classe media, tre categorie di lavoratori meccanici: i «patroni di fornase» di Murano, i «varoteri» cioè i pellicciai, e gli orafi (21). Sebbene si trattasse di mestieri che ad un determinato livello potevano esser svolti senza un coinvolgimento diretto, tuttavia è evidente come almeno per l’avviamento alla professione richiedessero un periodo di praticantato manuale, e sovente anche molto lungo. Ciò nonostante chi li svolgeva godeva di una reputazione sociale effettivamente superiore a quella degli artigiani comuni. «Questa è arte civile e nobile» dichiarava, senza enfasi retorica, alla sua prova di cittadinanza un patron di fornase «e caschemo gentilhuomini francesi, gentilhuomini romani, cittadini veneziani originari», anzi tale attività «non si può [...] dir arte, ma archimia» (22).
Se lo spartiacque interno alla società veneziana era costituito dall’onorevolezza della professione esso passava esattamente al centro dell’attività mercantile, suddividendola tra mercanzia grossa e piccola: a grandi linee nella prima rientrava il commercio all’ingrosso, nella seconda quello al dettaglio. Il «tener bottega» si trovava di conseguenza sul filo di tale bipartizione, una situazione che nel caso dei processetti per il riconoscimento della cittadinanza dava luogo ad approfondimenti interessanti, rivelatori della mentalità con cui si guardava alla mercatura. Diventava ad esempio determinante la presenza nella bottega di garzoni, il cui numero sembrava ai magistrati patrizi inversamente proporzionale alla necessità di un coinvolgimento pratico negli affari di bottega; o l’aver portato o meno la traversa, il grembiule, che di un simile coinvolgimento era il segnale lampante. Sintomi decisamente favorevoli di una condizione sociale e professionale civile erano descrizioni come quella del mercante che s’impegnava solo a «vender e scader», di quello che si recava in bottega, «attendeva, dava una passeggiata e partiva», che «si tratteneva passeggiando all’uso dei mercanti grossi» oppure, come in una testimonianza del 1673, del padrone di bottega che «stava fuori del banco con la sua romana attorno nobilmente, né vendeva niente affatto, stava sentato sopra una banchetta e la sera gli contavano il denaro» (23).
Può essere interessante chiedersi se questa divisione — che non aveva carattere rigido, «ma piuttosto quello di una frontiera estendentesi su una terra di nessuno, occupata da categorie sociali di transizione» (24) — si sia mossa conquistando spazi nuovi o non abbia piuttosto ristretto la condizione civile ad un numero minore di privilegiati. Le leggi che toccavano questo problema possono fornire qualche indizio. Nel 1589, come si è detto, veniva formalizzata l’interdizione al matrimonio con patrizi verso le figlie dei «meccanici». Si trattò di un passaggio che segnava una chiusura? In realtà anche prima di questa data le donne di estrazione non civile venivano considerate indegne a sposare un patrizio, e tutto sommato la legge del 1589 consentì comunque ad un ampio novero di Veneziani dai natali non illustri di avere dei nipoti nobili: delle centonovantadue spose non nobili di patrizi della prima metà del Seicento elencate in un manoscritto, solo una piccola parte proveniva da famiglie cittadinesche o inserite nella cancelleria; la maggioranza usciva dalle fila del meno civile, ma senza dubbio più dovizioso, ceto dei mercanti (25).
Anche per quanto riguarda la procedura di riconoscimento della cittadinanza originaria la fissazione per legge in forma esplicita del requisito dell’astensione per tre generazioni da arti meccaniche ebbe luogo tardi, nel 1641. Questo ritardo non va però confuso con un irrigidimento dei criteri di selezione, perché l’«onorevolezza» per tre generazioni era sempre stata considerata un requisito importante, anzi forse quello decisivo per la concessione del titolo di originario. Studiando nel concreto le approvazioni a quest’ordine, si è potuto osservare come nel corso del Seicento l’autorità patrizia operò invece un graduale allentamento nella rigidità della selezione. Non che sia stato messo in discussione il criterio di onorevolezza: semplicemente venne trattato con una maggiore elasticità chi poteva essere legittimamente sospettato di averne derogato, e più di una volta fu concesso il titolo sotto una forma minorata, non atta ad «abilitar alla cancelleria ducale» (26).
Proprio dagli ambienti della cancelleria ducale — che della fascia superiore del ceto medio, la cittadinanza originaria, si può dire fosse la «crema» — provennero accenni risentiti contro questa sorta di «allargamento verso il basso» dell’ordine cittadinesco. Il cancellier grande Angelo Zon, agli inizi del Settecento, denunciava al consiglio dei dieci la «sagacità» dei molti che a suo dire riuscivano ad entrare nell’ordine con la frode, «facendo passar con titolo di negotiante anco quelli delle Arti più basse» (27). Già alla metà del Seicento l’avvocato Zuan Francesco Busenello, figlio e fratello di membri della cancelleria, era insorto, a suo modo, contro la degradazione delle procedure di reclutamento dell’ordine cittadinesco:
E se si trova l’arte manoal
Del pare, nono e bisnono in la schiatta,
Ghe sia la grazia per sta volta fatta
D’esser fra i cittadini original.
El possa senza tara comparir
In mezzo alla zente più stimada:
Anzi ghe sia la gratia despensada,
Starlo, col parla lu, tutti a sentir [...] (28).
L’impressione — ché solo di impressione si tratta poiché non tutti i fenomeni sociali possono essere valutati quantitativamente — è dunque che nel corso del Seicento lo spartiacque che separava coloro che vivevano di professione civile da quanti esercitavano un mestiere indegno si sia spostato verso il basso, se non a comprendere nuove figure professionali perlomeno a trattare con maggiore benevolenza alcuni impieghi di frontiera, in bilico tra onorevolezza e «meccanicità». L’ipotesi che di conseguenza si affaccia, di fronte alla prospettiva di un allargamento della concezione vigente, effettiva di classe media, è quella di una sua possibile articolazione interna, tra una fascia superiore di cittadini originari che tendevano ad identificarsi con il gruppo che serviva nella cancelleria ducale e una fascia inferiore che raggruppasse professionisti liberali, mercatura onorevole, rentiers e quant’altri avessero fama sociale di astensione dalle arti meccaniche. Qualcosa che assomiglia alla descrizione della società veneziana fatta — nel 1709 — da Casimir Freschot, che elencava quattro ordini sociali: i nobili, i segretari, i cittadini «qui n’ont point d’emplois que dans les Secretairies, au nombre desquels on range les Avocats, procureurs, Medecins et ceux qui vivent de leurs rentes, ou d’un traffique ou metier Noble, comme les marchands en or et en soye, les Jouailliers et Orfevres», ed il popolo comune (29).
Sarà un’ipotesi da vagliare dopo aver approfondito la conoscenza dei singoli gruppi professionali del ceto medio. Per intanto conviene passare dal campo della trattatistica e dell’analisi legislativa ad un livello di osservazione della società molto più diretto, quello consentito dallo studio dei censimenti.
La presenza borghese secondo i censimenti
È stato Émile Durkheim, agli inizi del secolo, a parlare dei censimenti come rappresentazioni collettive (30). Si tratta di una definizione che calza per le sei rilevazioni della popolazione della Dominante che ebbero luogo tra 1607 e 1761, purtroppo quasi tutte distribuite nella prima parte del XVII secolo (1607, 1624, 1633, 1642), core un vuoto di novant’anni tra il censimento del 1670 e l’ultimo prima delle Anagrafi Venete, nel 1761. A ciò è da aggiungere la dispersione di numerosi registri di sestiere, per cui più che un quadro d’insieme i censimenti sei-settecenteschi sembrano un polittico a cui siano venuti a mancare molti pannelli (31).
Su commissione dei provveditori alla sanità la raccolta dei dati era affidata in ogni contrada al parroco che doveva annotare «casa per casa» gli abitanti della parrocchia. Per le modalità di svolgimento dell’operazione la magistratura si affidava al buon senso del prevosto e ai due coadiutori che, in ogni parrocchia, erano abilitati a coadiuvarlo: un nobile e un cittadino. Il censimento del 1607 fu con ogni probabilità il primo durante il quale fu possibile avvalersi di un fascicolo prestampato su cui elencare ordinatamente le informazioni richieste: per ogni «casa» — termine da intendersi nel significato specifico di household, ménage, aggregato domestico — nome e cognome del capo di casa, numero dei componenti divisi per categorie d’età, servitù, ospiti forestieri, gondole. Ogni nucleo familiare doveva trovar posto in una delle tre parti in cui era diviso il fascicolo: prima venivano i nobili, la cui riconoscibilità non richiedeva ulteriori indicazioni, quindi i cittadini ed infine gli artefici, individuabili per esclusione rispetto alla categoria intermedia, l’unica di cui veniva data una definizione analitica: «Per cittadini» indicavano i provveditori, «metterete Avvocati, Medici, Notari et altri che esercitano professione civile et anco li Preti che non sono Nobili, quando però sono capi di casa» (32).
Al vaglio della verifica pratica dei censimenti, la definizione «giuridica» del ceto medio veneziano si rivela dunque del tutto inutile, inoperante. La classe media veniva definita in base al solo criterio sociale della «professione civile», formula che permetteva di includervi anche il clero secolare di estrazione non nobile per il solo fatto di non esercitare alcuna arte meccanica. L’osservazione di Peter Burke, secondo cui a «Venezia la divisione tradizionale della società in tre ‚stati’ — il clero, la nobiltà e il terzo stato — era ancora presa abbastanza seriamente da costituire un fatto sociale», appare di conseguenza impropria (33).
Si tratta di documenti affidabili? Sono rappresentazioni veritiere, non solo quantitativamente ma anche dal punto di vista qualitativo, della struttura della società veneziana del XVII secolo? Burke richiama l’attenzione sui due coadiutori del parroco: la loro presenza, che doveva essere necessaria per ottenere dai loro pari quelle informazioni riservate che avrebbero potuto essere negate ad un semplice impiegato, è una garanzia di attendibilità (34). Scorrendo i registri qualche dubbio rimane, soprattutto dal punto di vista numerico, ma di tale sospetto non si può ritenere immune alcun documento statistico coevo. Il fatto che i rilevatori cambiassero di contrada in contrada può rendere disomogenea la serie, al tempo stesso può però costituire una verifica della tenuta generale dell’accezione di «cittadino». Piuttosto, se si considera che i nobili erano universalmente riconosciuti e che gli «artefici» venivano indicati sul fascicolo con il solo nome proprio seguito dalla professione, la principale minaccia all’affidabilità di questi documenti proviene dalla possibilità che artigiani e popolari fossero inseriti nella categoria superiore; tra i cittadini della parrocchia di S. Maria Formosa nel 1642 si trovano ad esempio annotati un «Andrea caregher» ed un «Berto intagliador»: si tratta di un errore di iscrizione (come sembra probabile) o di un’accezione estensiva di condizione civile dovuta ai compilatori di quella parrocchia? Perché il cittadino-rilevatore — che doveva essere tra i più stimati della contrada — avrebbe dovuto sistematicamente accondiscendere affinché case di rango inferiore fossero iscritte al suo pari?
Un’analisi a tappeto è stata compiuta sui registri del 1642, con l’integrazione di quello di S. Polo del censimento del 1633, data quest’ultima che non è stata scelta per l’indagine per la contiguità con l’epidemia pestilenziale del 1630-1631 (35). Il profilo complessivo che se ne ricava è quello di una borghesia nell’accezione più ampia ed onnicomprensiva del termine: un mondo la cui caratteristica prima era una grande diversificazione interna delle professioni, del rango sociale, della ricchezza, una dimensione sociale che, pur contraddistinta dal comune requisito della «civiltà», ammetteva condizioni economiche e stili di vita profondamente diversi, al cui interno cioè la distanza tra il livello di reddito, poniamo, di un ufficiale di basso rango e il treno di vita di un mercante grosso era eclatante, paragonabile a quella che separava le maggiori casate patrizie dai nobili più poveri (36).
La distribuzione professionale non è ricostruibile per intero. L’indicazione del mestiere — o nel caso dei rentiers l’espressione «vive d’entrata» — appare saltuariamente. Ne sono quasi sempre sprovvisti, ad esempio, i capi di casa che prestavano servizio come notai o segretari della cancelleria ducale: il loro ruolo pubblico doveva essere ben noto e solo per i maggiori tra di essi l’incarico di segretario del consiglio dei dieci o di cancellier grande viene esplicitato, ma per dar risalto alla loro presenza nella contrada. Più spesso appaiono accompagnati dall’indicazione della professione medici, avvocati e solicitadori, e pubblici notai, il cui rango sociale derivava per intero dalla loro professione, non essendo spesso di famiglia originaria o nota in città. Indicazioni saltuarie compaiono anche per il folto gruppo degli «ufficiali intermedi» dell’amministrazione statale, e per una serie di professioni — il sensale, il contabile, il maestro di scuola — che all’esercizio civile non affiancavano frequentemente i segni di una condizione economica di rilievo, come la presenza di servitù.
Con maggiore frequenza sono invece indicati professionalmente i mercanti, nella dizione semplice o con la specifica del tipo di mercatura — mercante da legname, mercante da formenti, da vin, da seda, da cordoani, da panni lana, ecc. — e i bottegai — speziali da medicine, merciai, drappieri, ecc. Quest’ultime erano quelle «arti di consumo e di commercio» considerate al limite tra onorevolezza e mondo meccanico, i cui membri sovente faticavano a dimostrare all’avogaria di comun l’astensione effettiva da un’attività pratica, manuale. Qui li ritroviamo iscritti in massa nella categoria dei «cittadini», con la sola esclusione dei membri più poveri che talvolta compaiono nella categoria degli artefici.
Qualche caso dubbio, rilevabile per l’indicazione della professione, emerge, come un Piero Picioli «fante» a S. Zuane Novo. La carica di fante, ufficiale addetto a mansioni di sorveglianza, di polizia o generiche di inserviente, era «ufficio di ministero» che non abbisognava della cittadinanza e poteva essere ricoperto da chiunque, anche da un suddito; in questo caso si trattava però della fanteria «delli eccellentissimi Capi», cioè del corpo specializzato delle guardie dei capi del consiglio dei dieci, un motivo che giustificava evidentemente una collocazione privilegiata. Oppure un «Pizin tornidor» a S. Maria Formosa, dove si è visto venir annotati tra i cittadini altri artigiani; nella casella apposita appaiono però ben tre servitori — categoria di personale più rara a trovarsi rispetto alle generiche serve di casa, le massere — il che potrebbe giustificare una promozione sociale dovuta alla condizione economica più che al rango professionale.
Una ricerca nominativa, favorita da un maggiore dettaglio delle informazioni, ha consentito di giungere almeno per una parrocchia alla distribuzione professionale dei «cittadini». Si tratta di S. Canciano nel sestiere di Cannaregio, una delle parrocchie che costituivano il punto d’arrivo di merci e materie prime provenienti dalla Terraferma, quindi con depositi, magazzini, spazi per lo stoccaggio e strutture commerciali per la ridistribuzione in città. Il suo lembo settentrionale comprendeva una parte delle Fondamenta Nuove, edificate a fine Cinquecento: significativamente i catastici vi registrano una maggiore presenza di proprietari non nobili che patrizi, con investimenti anche consistenti (37).
Dei quarantacinque «cittadini» che il censimento del 1642 elenca, quattordici presentano la semplice indicazione «mercante», che in altri tre casi è seguita dal genere di commercio: mercante da malvasia è Zuane Coleti, mercante da zucheri Gasparo d’Iva, mercante piacentino, invece, Tomaso Caotorta. Nessun mercante risulta, dalla serie dell’avogaria, esser stato approvato cittadino originario, alcuni hanno cognomi palesemente foresti, almeno tre sono stranieri: Emaeria Vias, Stefano Vaneste, un mercante fiammingo presente a Venezia almeno dagli ultimi anni del Cinquecento (38) e Zuane di Cristoforo Otths (o Ott), di una famiglia di ricchissimi mercanti tedeschi. Tre sono i negozianti: un droghier alla colombina, un merciaio pure all’insegna della colombina e un cordariol alla borsa.
Un Andrea Polverini, che dal censimento risulta «cartariol al passo [?]», appare figura significativa di quel ceto di mercanti non nobili che tra Cinque e Seicento si sostituirono al patriziato nell’esercizio attivo della mercatura (39). Il padre, Nicolò, aveva negoziato in mare «de ogni sorte di mercantia», tenendo pure bottega e, forse in vecchiaia, «vivendo d’entrata». Andrea, che aveva continuato l’attività mercantile, avrebbe sposato nel 1643 Cecilia Catti, sorella dei ricchi mercanti di lana di origine tedesca, tra i primi in grado di acquistarsi nel 1646 la nobiltà. Nel 1667, quando Andrea risulta ormai vivere di rendita, il figlio Nicolò si provava cittadino originario, forse con l’intenzione di inserirsi nell’amministrazione pubblica (40).
Il secondo gruppo, per numero, è quello dei funzionari pubblici. Per Marco Pasqualigo, agente in Zecca, e Antonio Preularo, nodaro all’esaminador, viene specificato l’incarico. Quest’ultimo, a rigor di logica, per sostenere simile nodaria, avrebbe dovuto disporre del titolo di cittadino originario che invece non risulta aver conseguito: il titolo di «eccellentissimo» con cui viene presentato, denominazione di rango riservata ai laureati, fa così pensare ad un suddito inserito nell’amministrazione in virtù di una competenza specifica. Con il titolo distintivo di «clarissimo» vengono invece indicati alcuni parrocchiani di cui non viene fornita indicazione professionale ma che è possibile rinviare, in vario modo, all’esclusivo ambiente della cancelleria ducale: Zuane Stefani dovrebbe essere quel Zuan Francesco quondam Sebastiano Stefani che in quello stesso 1642 venne nominato estraordinario di cancelleria, primo passo di una lunga carriera; Zuan Andrea Polverini era fratello e nipote di segretari di cancelleria, anche se la sua occupazione ci sfugge; la «clarissima signora Faustina Amai» dovrebbe essere Faustina di Francesco Amadi, di una famiglia divisa tra gli incarichi di cancelleria — con la specializzazione ereditaria nelle ziffre cioè nel linguaggio cifrato che serviva per corrispondere con gli inviati della Repubblica all’estero — e l’attività mercantile; Bernardo Sandeli era anch’egli notaio straordinario di cancelleria. Zuan Carlo Costantini ricopriva invece il posto di notaio all’avogaria di comun, un ufficio «intermedio» dell’amministrazione ma in una magistratura di grande importanza, anche simbolica, per la sua funzione di «garante» della costituzione repubblicana; il nonno di Zuan Carlo già ricopriva questa prestigiosa nodaria cent’anni prima e la casata dei Costantini, con una decina di generazioni di membri funzionari statali, costituiva un caso esemplare di dedizione allo stato che faceva ben meritare quel «clarissimo» assegnato a Zuan Carlo. Agustino Vianol, infine, veniva presentato con la sua carica dell’epoca, quella di segretario del senato.
Il «clarissimo» Zuan Batta Mocenigo apparteneva invece al gruppo particolare dei figli naturali dei patrizi che, come si è detto, potevano vantare «per antica consuetudine» una parificazione sociale ai cittadini originari; in verità era il padre di Zuan Batta, Cesaro, ad aver avuto un padre patrizio, il nobil huomo Marin. La contiguità con il patriziato continuava, seppure sotto una forma tipica di questa sottoclasse: Cesaro, come spesso accadeva, aveva sposato una figlia naturale di patrizio, Cornelia di Giacomo Barbarigo. Alla prova di cittadinanza di Zuan Batta nel 1625 avevano poi prestato testimonianza due nobili, Bortolomeo Cavazza e Zuan Andrea Baffo, e un avvocato, un particolare questo che fa pensare ad un avviamento del giovane alla carriera forense, uno sbocco professionale consueto per questa categoria particolare di cittadini (41).
Tre medici, «eccellentissimi signori», componevano il gruppo assai ristretto — data la posizione periferica della contrada — dei professionisti civili. Due importanti personaggi di origine straniera contribuivano poi ad alzare il tono, già elevato, della borghesia di S. Canciano: Ferdinando Tassis, «mistro della posta dell’imperator», e Giovanni Paulo Widmann (o Vidman) «conte e baron» tedesco, figlio di quel Giovanni trasferitosi a Venezia nel 1586 con una fortuna accumulata nel campo dello sfruttamento delle risorse minerarie, del commercio del rame e del ferro; i suoi figli sarebbero stati tra i primi a provarsi nobili alla riapertura nel 1646 del Libro d’oro (42).
Sotto la voce «donne» si potrebbero raggruppare altri capi di casa che non presentano indicazione professionale. Per la signora Veronica Cherini un’indicazione in realtà è presente, quella di vedova, mentre nulla è intuibile per Monica Negroni, forse esponente della famiglia che deteneva proprietà in parrocchia a fine Cinquecento (43). Di Faustina Amadi qualcosa si è già detto.
L’ultima categoria professionale, con cinque esponenti, è quella dei religiosi, dal piovan Sebastian Rinaldi, a «monsignor» Alvise Stella, ad altri tre sacerdoti semplicemente indicati come «reverendi»; se questi sono descritti come capi di casa, altri quattro vengono compresi in famiglie «cittadine» della contrada. I censimenti permettono di valutare con esattezza la consistenza demografica di questo particolare gruppo di persone: nel 1642 il clero secolare (quello regolare avendo una registrazione d’altro tipo) costituiva il 9% della popolazione adulta «cittadina» e se si considerano i soli maschi al di sopra dei diciotto anni — che solitamente vengono considerati la popolazione attiva dal punto di vista lavorativo — questa percentuale sale al 13%. Secondo la prospettiva dei censimenti, i sacerdoti possono essere quindi legittimamente considerati uno dei gruppi professionali portanti, se non altro numericamente, della classe borghese veneziana.
La città borghese
Dopo aver dato una qualche concretezza fatta di individui, di persone realmente vissute, all’idea altrimenti astratta di classe media, può esser utile chiedersi se esistesse, nella Venezia del Seicento, una «città borghese». Una simile domanda, in effetti, rischia di sembrare una provocazione sia rispetto all’immagine di città-fondaco diffuso, città-miniera a cielo aperto che ancora nel Seicento funziona come ingrediente del mito letterario della Dominante, sia rispetto all’idea di spazio senza barriere, dalle opposizioni inesistenti o stemperate all’interno di un ambiente urbanistico ed architettonico liquido, armonico, normalmente associata a Venezia.
Un ulteriore ostacolo ad un’individuazione degli spazi propri della borghesia veneziana è dato quindi dall’idea di una Venezia policentrica, disegno urbano a cui era estraneo il concetto, anche sociale, di periferia. Idea fuorviante, come ha dimostrato Ennio Concina ricostruendo attraverso il tessuto della proprietà immobiliare il profilo di una città già fortemente strutturata, nel XVI secolo, attorno al centro funzionale dell’asse Rialto-S. Marco. A ridosso di questo nodo, che coincideva con lo «spazio del potere immobiliare patrizio», era situato un «arco di contrade occidentali» con una presenza percentualmente rilevante di famiglie cittadinesche, che fungevano — con le loro strutture aggregative tipiche della classe media come le Scuole grandi — da tramite tra le «viscere» realtine della città e le sue diverse periferie funzionali e popolari (44).
Dare una definizione sociale secca del cuore della città è per Venezia, come per tutte le grandi città europee della prima età moderna, impossibile (45). Grande mercato popolare all’aperto, sede delle principali magistrature economiche, finanziarie e fiscali dello stato e quindi secondo luogo d’incontro della politica patrizia dopo la Piazza ed il Palazzo, a Rialto si ritrova ogni mattina anche buona parte della classe media. Tra le cose da non perdere in città secondo la fortunata guida del Coronelli (1697) era «il rendez-vous de’ Mercanti ogni mattina a Rialto, che è la Borsa di questa città» (46), ma tutta l’area realtina era punteggiata dei luoghi professionali di ritrovo dei borghesi veneziani: tra la calle della Sicurtà e il sottoportico del Banco Giro agivano, tra i mercanti, i sensali da cambio e da segurtà, poco più in là, ai piedi del ponte, vi era la ruga degli Orefici, sulle due rive del Canal Grande controllavano i loro carichi d’olio e di vino ricchi mercanti.
Oltre il ponte iniziavano le Mercerie, dove le botteghe degli speziali, dei merciai, degli artigiani di lusso davano vita ad una sorta di unico cosmopolita mercato al coperto; le mille insegne diverse vi formavano «uno spazio urbano di una figuratività propria del mondo di artigiani e mercanti» (47). L’abate napoletano Diego Zunica a fine Seicento vi osserva «tanti oggetti di stravagante bellezza, che dir non si può». La sua descrizione abbandona il tono stupefatto degli osservatori rinascimentali per soffermarsi su «come i Padroni delle Merci [...] non invitino il passaggiero alla compera». Non come accade a Napoli e a Roma, dove i negozianti assalgono «chi dispensa una sola occhiata su le loro botteghe»: a Venezia «muti sono i Mercatanti, e senza esibizione». Ma «ecco decifrato il mistero», a Napoli e Roma «le Merci non sono sì preziose e sì ottime che si lodino da se medesime; in Venetia sì» (48). Perso il primato dell’esclusività esotica è la compostezza la carta da giocare per il commercio di qualità cittadino?
Attorno a S. Marco si moltiplicano i luoghi di lavoro e di incontro del funzionariato statale, dei professionisti civili: in Palazzo, ogni mattina sono al loro banco gli ufficiali, nei dintorni della Piazza si infittiscono i cancelli dei notai pubblici, i mezzadi degli avvocati, soprattutto quest’ultimi nelle parrocchie tra S. Marco e, a ovest, il Canal Grande. In questo teatro di professioni, affari, figure sociali, i borghesi circolano apparentemente indistinti rispetto ai patrizi, portano la medesima veste nera, dalle maniche larghe al gomito e strette ai polsi, dette comunemente «maneghe a comeo», entro le quali si possono riporre fazzoletti, guanti, quadernetti o piccoli libri. «Ils vont vestus de la mesme façon» annota de la Haye, e «a moins que d’étre fort accoustumé et fort connoissant, il est empossible de les discerner d’avec les Gentilshommes». Solo quando si è frequentata la nobiltà e conosciuto «l’esprit et le genie qui les possede, on en fait aisement le discernement. Les Citadins n’ont pas la teste si élevée, ny le front si découvert; leur contenance n’est pas si libre, ils ont la veue un peu plus basse, et saluent avec plus de soumisson» (49).
A questo atteggiamento di accondiscendente, rispettosa soggezione, dovevano sentirsi estranei i mercanti che indulgevano più frequentemente a vestire «alla forestiera», cioè sia con una maggiore acquiescenza alle mode straniere, sia mantenendo la foggia tradizionale del paese d’origine. Questa differente visibilità del ceto dei mercanti esprimeva implicitamente un orgoglio di gruppo diverso rispetto a quello dei cittadini originari, degli ufficiali «organici» rispetto all’oligarchia patrizia? Sembrerebbe, da piccoli indizi, di sì; ad esempio dal comportamento di uno dei fratelli Lini, ricchi droghieri di origine bergamasca che a fine Seicento investivano i 100.000 ducati d’obbligo per sedersi tra i banchi del patriziato in maggior consiglio. Secondo un cronachista anonimo, «assistendo alla bottega con cappello e ferraiolo uno dei fratelli non ha voluto finora mettere la veste di nobile, forse per non havere la soggezione del Consiglio, né del broglio et assiste tuttavia personalmente alla bottega, che scrive» (50).
Al di sotto della rete urbana creata dalle occupazioni borghesi vi era il palinsesto degli spazi residenziali del ceto medio, senza i quali il disegno della città borghese non acquisisce concretezza. I censimenti, più che i catastici della proprietà che restituiscono piuttosto la geografia dell’investimento immobiliare, forniscono in questo caso informazioni di prima mano, che si è pensato di riassumere visivamente nella cartina sopra pubblicata, dove è riportata per ogni parrocchia la percentuale dei «cittadini» sul totale degli abitanti della contrada secondo il censimento del 1642.
La classe media risulta presente in tutte le contrade — Ghetto escluso, ovviamente — ma, ancorché estesa, la sua è una presenza non uniforme. Trascurabile percentualmente è il numero di «cittadini» in alcune periferie dai molti insediamenti artigianali e paraindustriali come la Giudecca, e nei quartieri «forti» della presenza popolare, S. Pietro di Castello o S. Nicolò, dove rappresentano appena lo 0,4% della popolazione. Tuttavia, anche in sestieri lontani dalla city degli affari e del Palazzo, come S. Croce o Dorsoduro, qua e là compaiono scampoli di una presenza cittadina periferica più fitta, come a S. Lucia, a S. Basegio, o all’estremità opposta, nella parrocchia di S. Biagio a Castello.
Il cuore della presenza borghese è costituito da un’ampia area il cui baricentro è l’asse Rialto-S. Marco. Vi sono compresi l’intero sestiere di S. Polo, alcune contrade di S. Croce, la parte orientale di Cannaregio e quella occidentale di Castello, una buona parte delle parrocchie di S. Marco. Vi si ritrova quell’«arco di contrade occidentali» da S. Barnaba a S. Marcilian di cui parla Concina, l’intera riva settentrionale della città luogo di arrivo dei flussi di rifornimento, e più in generale le contrade limitrofe al centro economico e politico cittadino. Si potrebbe parlare di un’unica grande, centrale, città borghese, se non fosse che proprio un nucleo interno di parrocchie — da S. Giovanni Elemosinario a S. Bortolomio, S. Zulian, S. Luca, S. Moisè — presentano valori percentuali inferiori alla media complessiva, costituiscono insomma il «ventre molle» della presenza borghese. In esse la residenzialità è specializzata, settorializzata, sebbene mai esclusiva (tranne a S. Marco, la contrada che sostanzialmente coincide con la Basilica ed il Palazzo, dove i diciannove capifamiglia «cittadini» sono tutti preti): a S. Salvador ad esempio sono almeno cinque gli speziali, a S. Moisè la presenza è qualificata — un medico, un notaio, sette avvocati, quattro solicitadori, un mercante, un segretario del senato — ma scarna quantitativamente rispetto a quella aristocratica e popolana.
Dove la classe cittadina dimostra i massimi livelli di concentrazione, sfiorando in alcuni casi il terzo della popolazione, è in un numero limitato di contrade: S. Zuan Degolà e S. Boldo di qua del Canal Grande, dove forse ha giocato un ruolo statistico la limitata numerosità della popolazione, S. Antonin a Castello, infine nella parte occidentale del sestiere di S. Marco dove un nucleo compatto di parrocchie compongono la città residenziale dei funzionari statali, dei professionisti forensi. Dove la descrizione professionale aiuta, la specializzazione professionale di quest’area si dimostra considerevole: a S. Maria Zobenigo, su quarantaquattro capi di casa cittadini, sedici sono gli avvocati e cinque i solicitadori.
Questa «città borghese» racchiude ovviamente tutti i ceti professionali, tutte le classi economiche che, si è detto, compongono la multiforme middle class veneziana fotografata dai censimenti. Con un ulteriore passaggio, assumendo come indicatore il numero di servitori e massere impiegate in ogni casa e le gondole di proprietà, è possibile affinare ulteriormente l’universo statistico della categoria «cittadini» ed isolarne una fascia superiore di «borghesia ricca» composta da duecentoventiquattro «cittadini» — pressappoco due abitanti su mille — che disegnano un profilo di residenzialità leggermente sfalsato rispetto a quello dell’intera categoria (51). La loro presenza è inferiore a quanto sarebbe logico aspettarsi nelle aree borghesi di S. Polo e S. Marco mentre si fa uniforme nel quadrante settentrionale, tra Castello e Cannaregio. Le contrade di massima concentrazione sono S. Maurizio e S. Maria Zobenigo a S. Marco, S. Boldo e S. Agostin a S. Polo, e soprattutto S. Fosca, S. Marcilian e S. Felice a Cannaregio, sestiere quest’ultimo che, come aveva osservato Giuseppe Gullino studiando la proprietà immobiliare, ospita, assieme a S. Marco, la borghesia agiata più numerosa (52). Le parrocchie tradizionali degli avvocati e dei grands commis dello stato da una parte, le aree commerciali dell’approvvigionamento cittadino verso nord dall’altra, costituiscono dunque i due poli della città della ricca borghesia.
Per leggere le possibili trasformazioni di questo disegno si è spogliato il censimento del 1761 che consente una verifica, purtroppo dopo oltre un secolo, della residenzialità della classe media (v. cartina) (53). Dal confronto tra le due ricostruzioni viene confermato quel processo di accentuazione delle differenze sociali tra aree diverse della città, con l’ispessirsi del diaframma tra siti centrali e periferie, che ebbe luogo tra XVII e XVIII secolo (54). La presenza della classe media si affievolisce in quelle contrade esterne che pure a metà Seicento presentavano una densità borghese superiore alla media cittadina. Il cuore della presenza «cittadina» rimane intatto nel suo disegno complessivo, confermando come la ristrutturazione urbanistica sei-settecentesca sia un fenomeno che non altera le caratteristiche insediative portanti della città, ma qualche trasformazione significativa è ravvisabile. Si sgretola il nucleo duro ad alta presenza borghese nella parte occidentale del sestiere di S. Marco, e le contrade a maggiore densità «cittadina» percentuale tendono piuttosto a formare una sorta di cordone perimetrale rispetto al corpo della city, un effetto anche questo della riorganizzazione funzionale in atto, della progressiva gerarchizzazione sociale degli spazi urbani.
Modificazioni di rilievo, rilevano gli storici dell’architettura, avvengono tra Cinque e Settecento non solo nel tessuto urbanistico della città, ma nei modi in cui la classe media concepiva l’abitazione. Un aspetto preliminare è dato dalla tendenza o meno alla stanzialità cittadina delle famiglie borghesi, questione non secondaria considerata l’influenza di questo tipo di comportamento sui modelli abitativi. L’esempio, pur limitato, della parrocchia di S. Canciano, su cui si è compiuto un approfondimento nominativo, fornisce dati inequivocabili: confrontando i quarantacinque capi di casa cittadini elencati nel 1642 con i quarantotto presenti nel censimento del 1670 solo sei sono i cognomi ricorrenti: quelli di alcuni ricchi mercanti, come il Polverini, quello dei de Tassis, a cui vanno aggiunti i Widmann che rimangono nel palazzo acquistato da pochi decenni in contrada ma che ormai risultano nella categoria di censimento dei patrizi (55). Rispetto alla classe patrizia, i «cittadini» dimostrano insomma una mobilità residenziale nettamente maggiore.
È difficile comporre una «tipologia abitativa» della classe media, e oltretutto collocarla nel periodo qui considerato, il Seicento. Un primo esempio, più che un modello abitativo in senso stretto, è l’esemplificazione dell’inserimento di una famiglia cittadinesca in una contrada: l’insieme delle proprietà della famiglia cittadinesca dei Gonella nell’area di S. Giobbe a Cannaregio comprendeva terreni, edifici destinati ad attività manifatturiere, case d’affitto ed uno dei più rinomati palazzi cinquecenteschi, passato quindi alla famiglia Valier e distrutto da un incendio nel Settecento. Si trattava di una presenza fortemente strutturata su interessi economici, commerciali e manifatturieri, che culminava nel palazzo, il cui prospetto sulla fondamenta era l’esibizione di una posizione sociale attinta in virtù di una capacità economica che nasceva «dietro», tra i magazzini, i capannoni e le abitazioni dei lavoranti. Palazzo Algarotti, sulle Fondamenta Nuove a S. Canciano, edificato nel Settecento insieme con una raffineria di zucchero e tre case per i lavoranti (56), esprime il medesimo dualismo tra le modalità spaziali commerciali-manifatturiere e quelle della sociabilità borghese di una famiglia che mantenne, anche nell’attività dei suoi membri, diverse identità professionali.
Il «palazzo» — dizione questa che non a caso comincia a comparire nel secondo Seicento come definizione esplicita di residenza censita (57) — assume tutta la sua valenza simbolica di raggiungimento di una condizione sociale superiore nelle vicende familiari delle famiglie borghesi, di estrazione spesso forestiera, che dalla metà del secolo raggiungono il titolo nobiliare. Molte di queste acquistano residenze signorili pochi anni prima della cooptazione, all’inizio o durante quella fase di ripiegamento dalle attività direttamente produttive che in molti casi si conclude con il raggiungimento dello status patrizio e l’abbandono dell’imprenditorialità attiva (58). I dubbi, le riserve su tale passo sono espressi bene nel testamento di un borghese di cui si è già fatta la conoscenza, Giovanni Widmann di S. Canciano: negli anni Trenta la sua famiglia viveva in affitto in un palazzo di proprietà dei Saviotti, nei pressi di campo S. Maria Nova; nel suo testamento raccomandava ai figli di procedere, qualora se ne presentasse l’occasione, all’acquisto del palazzo già riccamente fornito di mobilia: se non fosse stato per questo, rifletteva il ricco mercante tedesco «stenterei a farlo per le molte conseguenze che portano con sé simili case grandi» (59).
I cambiamenti più appariscenti nei moduli residenziali della classe media intervennero però ad un livello inferiore di abitazioni, e in un periodo precedente. Il modello che risulterà di gran lunga prevalente nei secoli moderni si sviluppa infatti nel Rinascimento, a cavallo tra Quattro e Cinquecento. È un nuovo tipo di organizzazione abitativa, plurifamiliare ma salvaguardante l’individualità dell’accesso di ogni abitazione, il «principio abitativo» della porta di casa singola su strada. Trova applicazione in tipologie diverse di edifici — singolo, binato, schiere, blocchi — ed è essenzialmente composto da due piani nobili sovrapposti, legati dalla soluzione delle «scale leonardesche»: due scale che si inseguivano a vite doppia per servire due alloggi paritetici. È questo il modello abitativo destinato a rispondere alle esigenze di un artigianato ricco, di una lower middle class di negozianti e impiegati pubblici, di una classe media di professionisti liberali (60).
La versatilità di questa soluzione diede luogo ad una miriade di adattamenti pratici. Nelle due schiere parallele di case tra le fondamente dei Cereri e delle Procuratie a S. Maria Maggiore edificate a mezzo il Cinquecento, ed ancora oggi abitate, trovano posto una ventina di unità abitative di cui otto, situate sulle testate degli edifici, più ampie e che godono di una posizione privilegiata. Nel 1581 le abitazioni migliori sono affittate per cifre di un certo rilievo, attorno ai 50 ducati annui: agli estensori di un’interessante scheda storico-architettonica di questo edificio sono parse abitazioni «di tipica classe media che suscita talvolta l’impressione di essere in piena fase di ascesa ed espansione economica» (61). Uno schema dal carattere più prettamente borghese è quello di un edificio posto in calle degli Avvocati, a S. Angelo. Sei case, distribuite in tre fabbriche ed organizzate secondo lo schema dei due appartamenti sovrapposti con scale incrociate, ospitavano avvocati, notai, la famiglia Marini «di cancelleria», insomma inquilini che potevano permettersi affitti che alla fine del Cinquecento sfioravano i 100 ducati. È un modello costruttivo, come si è detto, che si attagliava alle esigenze e alle possibilità della classe media, ed infatti «molte altre case di simile impostazione, e non lontane per l’onere finanziario, sembravano piuttosto destinate a mercanti ed imprenditori» (62).
L’abbandono progressivo della formula della casa da stazio comporta quindi nel corso del Seicento la progressiva diminuzione, che emerge nella terminologia catastale, dell’ammezzato, metà o mezado.
A partire dal nuovo secolo comincerà invece a divenire di uso corrente la nozione di «appartamento», non a caso contemporaneamente al sorgere di una nuova soluzione abitativa, quella delle case plurifamiliari con accesso a scale comuni (63). Riflessi di una trasformazione sociale che implicava distinzioni più accentuate tra gli strati sociali e che inevitabilmente si riverberava sul rapporto tra l’individuo e l’abitazione, tra le classi e la città.
Consumi familiari, costumi familiari
L’indicazione, fornita dai censimenti, del numero di servitori, massere e gondole presenti in ogni casa merita qualche approfondimento. I consumi relativi alla servitù costituivano, come è noto, una voce importante tra le spese delle famiglie dei ceti economici superiori nell’epoca moderna, anche per la visibilità che un certo numero di servitori o una «gondola fornita» avevano. Può tale classe di consumi ritenersi un indicatore, ovviamente solo approssimativo, della capacità economica, della ricchezza? Con le dovute cautele, e guardando più al profilo generale che ai singoli casi, crediamo di sì. Considerando che un servitore costituiva un’unità lavorativa più costosa rispetto alla massera, e che una gondola era appannaggio di pochi, è sembrato utile costruire in base a questo tipo di informazioni una sorta di stratificazione economica della classe media. I criteri con cui si è proceduto sono ovviamente opinabili, e comunque non corrispondono a distinzioni effettive, esistenti: sono un artificio statistico che serve a considerare le suddivisioni interne alla classe media e i suoi cambiamenti tra due punti di osservazione, il 1642 e il 1761.
Il Graf. 1 rende conto di tali trasformazioni. Nel 1642 nel 28% delle case non vi era personale di servizio; la percentuale maggiore di case «cittadine» risulta tuttavia rientrare nella classe III di consumi, quella per intendersi in cui erano presenti al massimo due massere o un servitore. Questo livello di consumi per la servitù sembra segnare uno scalino effettivo, perché le case che impiegavano più personale erano molte meno, il 28% complessivamente, da noi suddivise in altre due fasce. Lo strato superiore — quello che poteva permettersi una gondola o un numero consistente di massere e servitori — era composto da quei duecentoventiquattro capi di casa che si sono descritti come la ricca borghesia cittadina. La loro estrazione professionale era tutto sommato ristretta: avvocati, mercanti, importanti burocrati dell’amministrazione pubblica provenienti da famiglie di lunga tradizione di servizio e sovente di origine mercantile, dottori (la cui presenza in questa fascia è forse sovradimensionata per la necessità di disporre di una gondola per muoversi in città), persone che vivevano d’entrata. Tra di essi erano forse i mercanti — di cui un numero considerevole di origine forestiera e straniera — il gruppo professionale più presente.
La stessa operazione, compiuta sul censimento del 1761, consente di fotografare una realtà assai distante nel tempo, tuttavia i cambiamenti appaiono contenuti. Le due prime fasce comprendono una percentuale pressoché identica di case «cittadine», il 24% del totale, di conseguenza la parte «povera» o «appena benestante» della classe media comprende come centoventi anni prima tre case su quattro. È interessante il rovesciamento che è avvenuto tra la III e la IV classe statistica, per cui se il profilo della distribuzione delle spese per la servitù nel 1642 è «a botte», nel censimento del 1761 è invece «a piramide», prospettando l’ipotesi di un generale impoverimento della borghesia veneziana.
Qualche anno prima del rilevamento del 1761 un patrizio di una famiglia «vecchia», Giacomo Nani, aveva analizzato la stratificazione sociale delle famiglie del suo ordine, suddividendo le case nobili in cinque classi. Se si accetta di equiparare la IV classe dei borghesi, cioè quelle case che non avevano nemmeno una serva, con le ultime due classi del patriziato, vale a dire con i nobili poverissimi o quelli che avevano «meno del loro bisogno», la stratificazione compiuta dal Nani osservando nella realtà il suo ceto e quella, artificiale, della classe media ricostruita attraverso i censimenti, diventano paragonabili (64).
Questa, apparentemente bizzarra, comparazione suggerisce alcune riflessioni. Innanzitutto che in entrambi gli ordini le ricchezze erano sì distribuite in maniera diseguale, per cui la base della piramide era nettamente più larga del suo vertice (soprattutto per quanto riguarda il patriziato), ma con una certa gradualità, senza cioè che i gradini intermedi fossero «svuotati». In sostanza, le diseguaglianze economiche non comportavano un’eccessiva polarizzazione sociale, un elemento che deve aver contribuito a rendere tutto sommato accettabili, o comunque risolvibili senza compromettere l’identità dei due ordini, le tensioni interne ai due gruppi (di cui si sa qualcosa di preciso solo riguardo al patriziato). Va comunque sottolineato come il 41,5% della classe media e il 43,9% di quella patrizia si mantenessero su un livello di vita che doveva essere paragonabile a quello di un medio artigiano, di un buon salariato: qualcosa di nettamente diverso insomma da quanto si è solitamente abituati ad associare all’idea di patriziato o di borghesia. Se si tiene conto che questi due ordini nel loro complesso, nel 1761, rappresentavano il 10% circa della popolazione cittadina, si può dedurre come, anche comprendendo una fascia di popolani agiati, il novero dei ricchi e di quella che si è abituati a considerare per livelli di reddito «classe media» fosse nella Venezia della seconda metà del Settecento qualcosa di molto ristretto ed esclusivo.
Purtroppo sarebbe interessante paragonare la middle class veneziana non solo rispetto al patriziato ma anche rispetto al mondo popolare, ai cui atteggiamenti sociali e costumi familiari la gran massa dei borghesi veneziani doveva avvicinarsi di più, se non altro perché il ricambio tra i due ceti non era ostacolato da procedure burocratiche o impedimenti diversi da quello della «professione civile». Altri dati presenti nei censimenti offrono invece un confronto più serrato sulla composizione familiare delle case «cittadine» e patrizie.
La fotografia della casa «cittadina» secondo il censimento del 1642 restituisce un’immagine tutto sommato prevedibile di famiglia urbana dell’età moderna, un aggregato domestico nucleare il cui numero medio dei componenti era di poco superiore a quattro. Sebbene i censimenti non riportino il rapporto parentale esistente tra i componenti la casa, è intuibile come il tipo di aggregato domestico più frequente fosse quello semplice, costituito quindi dalla coppia coniugale più uno, due putti, a cui si aggiungeva talvolta un parente, un anziano, magari un prete; nella maggioranza dei casi era presente una massera, meno frequentemente un servitore, molto raramente, in sei casi su cento, una gondola. Il numero di case che avevano come capofamiglia un sacerdote, il 13 % circa, complica un po’ la lettura dei dati, ma nella sostanza il profilo della casa «cittadina» è quello di un aggregato nucleare, neolocale, che non poteva che prediligere quel tipo di abitazione autonoma, a più vani, che si è osservato emergere come tipologia residenziale preferita dalla classe media.
In cosa si distingue la casa «cittadina» da quella patrizia, secondo l’immagine di questa che emerge dal censimento del 1624? Quest’ultima dimostra un numero di «figli» leggermente superiore (1,64 in media invece di 1,46) ed anche un maggiore numero di adulti, elemento questo che può esser stato ridimensionato dopo la peste del 1630-1631. Si tratta comunque di adulti maschi, effetto di quel costume della «fraterna», cioè della convivenza di più fratelli di cui uno solo sposato, caratteristico del patriziato veneziano (66). Nettamente superiore, dato il rango sociale e la capacità economica, è la presenza di servitù e gondole. Se si sposta lo sguardo al 1761, per entrambi i ceti le continuità sono maggiori delle diversità, tuttavia alcune di queste meritano una riflessione. Nelle case dei «cittadini» il rapporto tra giovani sotto i diciotto anni ed adulti si è ulteriormente accentuato a favore di questi ultimi: cinquantatré putti per cento adulti nel 1642, trentaquattro per cento nel 1761. A cosa è imputabile questo invecchiamento della popolazione borghese? Una prima spiegazione può essere semplicemente statistica: moltiplicandosi il numero delle case con a capo un ecclesiastico che spesso viveva da solo o con altri adulti — nel 1761 ben il 30% degli aggregati «cittadini» —, la presenza media di giovani risulta conseguentemente depressa.
Qualche ruolo devono poi aver giocato cause «naturali», come la vicinanza del primo censimento alla peste manzoniana che sfoltì soprattutto le classi d’età avanzata, o una certa tendenza di lungo periodo alla diminuzione dei tassi di mortalità delle classi intermedie (67). Determinante deve esser invece considerata la pratica di mandare a studiare i figli fuori città, ad esempio nei collegi delle città di Terraferma: un comportamento assai diffuso soprattutto nel ceto dei professionisti liberali e tra la burocrazia specializzata. Tra le ragazze non era infrequente la via del chiostro, anche se non sembra possibile quantificare se tale soluzione abbia coinvolto tra Sei e Settecento un maggior o un minor numero di figlie della classe media (68). Non sembra opportuno invece avanzare il sospetto che tale invecchiamento sia imputabile alla comparsa di comportamenti «moderni» quali il controllo della natalità, la restrizione delle nascite: quell’ 1,46 di presenza media per casa di putti e putte sotto i diciotto anni nel 1642, cioè dopo solo nove anni dalla fine di un’epidemia pestilenziale, testimonia che casomai tali comportamenti dovevano essere già in atto nella prima metà del Seicento.
Per quanto riguarda poi la presenza di servitù nelle famiglie borghesi, la distribuzione per casa mostra una diminuzione generale del numero di serve, un fenomeno che si era già segnalato, rinviandolo ad un possibile impoverimento generale della classe intermedia.
Purtroppo questi dati non possono essere inquadrati — come è stato fatto in vari studi per la classe aristocratica — in un insieme organico di informazioni sulle caratteristiche delle famiglie, sui costumi matrimoniali, sugli usi successori della classe media. Della famiglia borghese veneziana si sa molto poco, nessun studio specifico, a parte un interessante articolo sulle doti e le successioni cittadinesche nel Cinquecento (69), è stato ancora pubblicato. Le informazioni che compaiono nella bibliografia veneziana sono in realtà relative quasi esclusivamente a case o personaggi che per il rilievo economico o la reputazione sociale che vantavano appaiono piuttosto eccezionali che rappresentativi dell’intera classe media. Spesso poi informazioni sulle famiglie borghesi sono riportate solo in quanto funzionali allo studio di qualcos’altro: è esemplare in questo senso la questione dei matrimoni tra nobili e donne non patrizie, che è stata analizzata quasi esclusivamente in base a quanto se ne poteva ricavare sul ceto patrizio. Riguardo all’ordine cittadinesco ci si è solitamente limitati ad osservare che l’unione con una casa patrizia era un traguardo dal concreto significato di promozione sociale; per raggiungere questo scopo i borghesi venivano incontro alle esigenze patrimoniali del patriziato fornendo le nubende con doti assai ricche. Un insieme complesso di relazioni sociali, affettive ed anche psicologiche che coinvolgevano sia le famiglie nobili che quelle borghesi viene così ridotto all’etichetta «strategia matrimoniale», ed il groviglio di dinamiche che cela ricondotto «stanti gli incontestabili effetti patrimoniali conseguenti, alla luce meridiana del calcolo razionale» (70).
Sebbene socialmente gratificante, il matrimonio di qualche nubile borghese con un marito della classe superiore non rappresentava però l’evenienza matrimoniale più tipica, né quella rappresentativa delle istanze della classe media, il cui ruolo viene troppo spesso esaurito alla mera funzione di soccorso delle calanti fortune patrimoniali del patriziato. La classe media era ambito sociale troppo ampio e diversificato per presentare una tipologia semplice, univoca di comportamenti matrimoniali. Il criterio «sociale» della scelta del coniuge, in base al quale si puntava grazie al matrimonio ad acquisire in virtù di un legame di affinità uno status superiore, sembra ad esempio esser stato meno diffuso del criterio «professionale», funzionale a consolidare o migliorare la posizione professionale dei membri della casa, secondo il quale la sposa per il figlio proveniva solitamente dall’ambiente di lavoro del padre. L’osservazione che l’endogamia professionale nel Cinquecento fosse ristretta quasi unicamente alla fascia delle famiglie inserite nella cancelleria ducale (71) non sembra applicabile al Seicento, quando invece si fanno più frequenti i matrimoni interni ai singoli gruppi professionali: gli avvocati, i medici, i mercanti, i funzionari statali, ecc. Si tratta di un’osservazione impressionistica che difficilmente può trovare conferme numeriche data la difficoltà di misurare quest’ordine di comportamenti, ma che rientra in un fenomeno più generale su cui si avrà modo di ritornare: l’aumento progressivo all’interno della classe media nel corso del XVII secolo dell’importanza dei diversi gruppi professionali.
Considerazioni storiografiche in parte simili valgono per lo studio delle modalità di trasmissione del patrimonio. Restringendo l’osservazione alle sole famiglie ricche, magari quelle che poterono acquisire a metà Seicento il titolo patrizio, o all’esclusivo gruppo delle «famiglie di cancelleria», è inevitabile sottolineare come i comportamenti di queste fasce privilegiate tendessero a ricalcare i moduli successori ed ereditari del patriziato, quindi l’uso del fedecommesso, la convergenza dei beni non soggetti a questo vincolo sul figlio prescelto per continuare la discendenza, la restrizione dei matrimoni con il costume della convivenza dei fratelli, la monacazione delle figlie, ecc. Opportunamente si è parlato in alcuni casi di veri e propri clans familiari, la cui coesione interna era resa ancora più salda dalla tensione dell’ascesa sociale (72).
Se questi erano comportamenti frequenti tra la upper middle class, e più facilmente documentabili data la visibilità di tali casate, la norma delle tradizioni in uso tra quella che si è visto essere numericamente la parte di gran lunga maggioritaria della classe media sfugge quasi completamente. È probabile che piuttosto fossero diffusi atteggiamenti come quelli tipici rilevati per la classe popolare dove «la trasmissione ereditaria del mestiere costituiva uno dei pochi elementi di continuità della famiglia» (73). Nella piccola borghesia, nelle fasce meno «strutturate» della classe media, doveva insomma essere l’individuo a prevalere sulla famiglia, e non viceversa come tra le fila del patriziato o della borghesia privilegiata.
La classe degli ufficiali tra basso funzionariato e «noblesse de robe»
La classe degli ufficiali statali costituiva una parte cospicua ed importante del ceto medio veneziano, di cui riproduceva in piccolo una delle caratteristiche salienti, la diversità interna di status sociale e di condizione economica esistente tra i propri componenti. La legge del 1569 che aveva costituito il punto d’arrivo del processo di formazione dell’ordine cittadinesco, ribadendo l’obbligo che tutti gli uffici intermedi fossero riservati ai cittadini originari, aveva incardinato questa classe di abitanti alla struttura portante della burocrazia statale. Una miriade di leggi e deliberazioni diverse regolamentava poi nel concreto l’esercizio della funzione pubblica, per cui alle soglie del XVII secolo la collocazione della classe degli ufficiali nello stato e nella società marciana appariva ormai ben delineata.
Al livello superiore di questo gruppo professionale, i funzionari della cancelleria ducale formavano senza dubbio il corpo meglio definito giuridicamente e socialmente. Come ha descritto Giuseppe Trebbi (74), il loro ufficio consisteva nell’organizzare e seguire il lavoro dei principali organi di governo patrizi, nei quali, proprio in virtù della loro non appartenenza al ceto patrizio, ricoprivano incarichi altamente specializzati di grande responsabilità, che richiedevano una fedeltà ed una dedizione allo stato repubblicano paragonabile a quella dei nobili di maggiori responsabilità politiche. Anche per questo motivo la carriera di questi funzionari, il cui numero oscillò tra ottanta e cento nel corso del secolo, era rigorosamente regolamentata e l’organizzazione gerarchica del corpo non a caso ricalcava quella patrizia, con a capo i segretari che servivano in senato, quelli del consiglio dei dieci, ed un cancellier grande le cui funzioni si avvicinavano a quelle del doge patrizio (75). La difficoltà e l’onere anche economico di una carriera di cancelleria facilitavano, in un gruppo così ristretto, le pratiche clientelari, sia interne al corpo, sia per ricercare l’appoggio di patrizi influenti. Il tutto dava luogo ad una mentalità burocratica molto elitaria, che connotava questo gruppo di funzionari dalla forte coesione interna.
Nel corso del Seicento importanti cambiamenti nel sistema di reclutamento della cancelleria testimoniano come anche il ruolo sociale di questo gruppo di funzionari dovette mutare (76). La diminuzione d’importanza dell’esame tecnico-culturale a cui erano soggetti coloro che aspiravano ad entrarvi, l’aumento dei casi di assunzione o promozione «per gratia», cioè al di fuori della normativa esistente, la perdita di valore della formazione comune dei giovani nella scuola della cancelleria e la diffusione della pratica di instradarli alla professione al seguito dei parenti in servizio, indicano come il carattere impersonale, meritocratico della carriera di un funzionario di cancelleria venne progressivamente attenuandosi, per lasciar spazio ad un criterio molto più personale, che tendeva a porre in secondo piano l’abilità e i meriti personali rispetto alla tradizione familiare di servizio e ai meriti di congiunti ed antenati.
Nel frattempo, a cavallo tra XVI e XVII secolo, erano cambiate alcune condizioni di fondo nel rapporto tra funzionariato cancelleresco e classe aristocratica. Il riequilibrio di potere che ebbe luogo tra senato e consiglio dei dieci comportò di fatto un ridimensionamento del ruolo della cancelleria, dove i più importanti segretari in virtù della loro inamovibilità erano giunti ad avere una sorta di «potere politico» che, a detta degli «avversari» del consiglio dei dieci, sarebbe stato in grado di condizionare l’«eccelso Tribunale» (77). Eliminata l’inamovibilità dei segretari del consiglio dei dieci, stroncato sul nascere il tentativo dei funzionari di riunirsi in assemblea (78), la posizione della cancelleria all’interno dell’amministrazione dovette risultare ridotta, sebbene comunque essenziale al funzionamento del sistema. Non è un caso che in questa fase cominciarono a delinearsi quei cambiamenti nei criteri di reclutamento che portarono di fatto ad una gestione interna del ricambio professionale da parte dei funzionari stessi, che a fine secolo provenivano completamente dalle «famiglie di cancelleria»: fu, in sintesi, una specie di «serrata» cancelleresca.
Nel 1633 il gruppo dei funzionari di cancelleria ottenne un riconoscimento che, seppure poco visibile, rivestiva un considerevole significato simbolico. I figli o nipoti di notai o segretari della cancelleria ducale per accedere ai posti riservati ai cittadini originari non dovevano più provare presso l’avogaria di comun il proprio status giuridico, diventava sufficiente il semplice certificato di battesimo comprovante la discendenza da un funzionario di cancelleria. Con questo riconoscimento, con la posizione di sempre più inattaccabile autonomia gestionale all’interno della cancelleria ducale, di fatto all’interno della cittadinanza originaria si venne a creare una fascia privilegiata di famiglie di importanti burocrati, l’«ordine della cancelleria» come ormai si diceva comunemente a fine Seicento.
Rispetto ai funzionari della cancelleria, gli ufficiali inseriti nel resto dell’amministrazione formavano un gruppo professionale molto meno definito ed organizzato (79). Una distinzione preliminare è d’obbligo. Agli inizi del Seicento esisteva al di sotto della cancelleria una differenza abbastanza netta all’interno del funzionariato dell’apparato centrale della Serenissima: una fascia di incarichi superiori per importanza delle mansioni e rilievo dell’ufficio — nodari, scrivani, scontri, quadernieri, ragionati, masseri, ecc. — erano distribuiti in virtù di una legge del 1444 dal tribunale patrizio della quarantia criminal, per elezione, ai soli cittadini originari. Una fascia di uffici inferiori, detti «di ministero», venivano invece assegnati dai singoli magistrati patrizi, e normalmente non richiedevano il titolo di cittadino originario: è il caso del posto di fante che, come si è visto dai censimenti, di regola non veniva annoverato tra gli incarichi civili.
Dei primi, che costituivano la «burocrazia intermedia» della Serenissima, se ne contavano nel 1632, secondo la prima rilevazione generale che venne fatta, oltre quattrocentocinquanta. Sebbene la legge stabilisse che fossero assegnati per un periodo della durata di quattro anni solamente, in pratica molti in virtù dei titoli più disparati li ricoprivano continuativamente. Anche coloro che non riuscivano in qualche modo ad accaparrarsi un ufficio, rendendolo magari ereditario, normalmente gravitavano all’interno della medesima magistratura; sicché in questi uffici era venuto specializzandosi un ceto di ufficiali che in virtù della permanenza prolungata negli stessi posti potevano vantare un’esperienza di servizio e una conoscenza dei meccanismi amministrativi di gran lunga superiori a quella dei patrizi che si trovavano a ruotare continuamente tra magistrature diverse. Questo gruppo di ufficiali dimostrava sovente un’identificazione assai stretta con l’incarico ricoperto, che sconfinava in una concezione patrimoniale dell’ufficio e che dava luogo a non infrequenti fenomeni di trasmissione ereditaria della professione, comune soprattutto tra ufficiali che ricoprivano mansioni molto specializzate come nella magistratura fiscale dei dieci savi alle decime, o socialmente delicate come i notai dell’avogaria di comun (80).
Il primo luglio 1636, per pressanti esigenze di bilancio, venne deliberata la vendita generale di tutti gli uffici della Repubblica, cancelleria esclusa, man mano che si fossero liberati i diritti gravanti su di essi. Non era la prima volta che lo stato veneziano si rassegnava a questa scelta; già ai tempi della crisi della guerra di Cambrai per rimpinguare l’erario si era proceduto in questo senso, con una differenza sostanziale: gli uffici intermedi erano stati offerti alle sole famiglie cittadinesche che li ricoprivano o possedevano; ora invece essi sarebbero stati venduti all’asta, al miglior offerente.
La vendita proseguì, con alti e bassi, fino al 1709, per essere nuovamente ripresa in seguito. Le sue conseguenze su questa fascia di uffici e sul gruppo degli ufficiali che li ricopriva furono diverse ed importanti. Si dissolse il meccanismo di reclutamento che aveva consentito ai cittadini originari di costruire in buona parte su questi incarichi il proprio profilo di ceto e questo gruppo sociale invece di approfittarne acquistando gli uffici nei quali serviva da tempo di fatto si mise da parte consentendone l’acquisto ad un ampio ventaglio di persone, di estrazione popolare ma anche suddita, provenienti dalle professioni più diverse ma con una prevalenza abbastanza netta di negozianti e mercanti. Molti si limitarono ad acquisire l’ufficio delegandone la funzione ad un sostituto: il rapporto economico che si instaurava tra questi due soggetti e la necessità da parte del sostituto di incassare al più presto l’«affitto» da corrispondere al proprietario cambiarono la concezione comune dell’ufficio e il posto pubblico venne sempre più spesso considerato semplicemente come un investimento o una fonte di reddito.
La definizione di ufficio così come agli inizi del secolo l’aveva formulata il giurista francese Charles Loyseau «dignité ordinaire avec fonction publique» (81) non si adattava più a quest’ordine di incarichi pubblici. Dal punto di vista delle dinamiche sociali, la vendita seicentesca degli uffici intermedi contribuì alla perdita di peso della cittadinanza originaria in quanto ceto, e favorì il ricambio dal basso della classe media.
Un particolare tipo di ufficio intermedio, quello di ragionato, conobbe nel corso del XVII secolo un’interessante evoluzione. Con questa denominazione si indicava una serie di incarichi contabili a cui dal 1581 si poteva aspirare solo dopo esser stati ammessi ad una sorta di particolare albo professionale, il collegio dei ragionati (82).
Si trattava di uffici di grande responsabilità con mansioni assai specialistiche, data la complessità delle procedure e del sistema di registrazione contabile di un apparato finanziario articolato come quello della Serenissima. Proprio per questo motivo rimane abbastanza inspiegabile come mai le autorità patrizie non scelsero di riservare i posti del collegio dei ragionati ai soli cittadini originari che superassero la prova tecnica di ammissione, limitando così questi incarichi delicati al solo, fedele e specialistico, ceto della cittadinanza. Venne invece concesso di entrarvi anche ai nativi della Dominante o ai sudditi con residenza in città da almeno una decina d’anni, forse per consentire a quelli del Levante, da dove provenivano alcuni ufficiali contabili assai abili nel ramo complicato della contabilità d’armata, di potervisi inserire; di fatto, però, tale scelta costituì una prima limitazione, già a fine Cinquecento, delle prerogative cittadinesche negli incarichi intermedi.
Nel corso del Seicento all’interno del collegio dei ragionati si strutturò un gruppo di funzionari il cui comportamento richiama sotto molti aspetti quello dei notai e segretari di cancelleria. Sotto una forte pressione corporativa venne in pratica loro delegato il controllo delle procedure di reclutamento che persero sempre più carattere meritocratico e impersonale, lasciando spazio ad un tipo di selezione ad personam: come per la cancelleria, questo significò un’accentuazione dei meccanismi di ricambio interni al corpo, che non sarebbero comunque mai diventati esclusivi. Il risultato dovette essere, sul piano amministrativo, un effettivo miglioramento generale della qualità del servizio contabile; su quello sociale, il formarsi di un gruppo di famiglie dalla spiccata caratterizzazione professionale e dalla tendenza alla trasmissione ereditaria del mestiere. Famiglie dalle quali provennero funzionari abilissimi, come quel Girolamo Costantini che mise a punto i primi bilanci generali della Repubblica e perfezionò le Anagrafi (83).
Il comparire nel corso del Seicento di un gruppo di ufficiali contabili dal profilo professionale preciso e dai legami assai stretti con il sistema politico-amministrativo ebbe in definitiva due conseguenze principali: contribuì da un lato ad arginare la perdita di identità che a causa delle vendite degli uffici intermedi colpì il ceto degli ufficiali, da un altro, poiché l’accesso a questa professione non fu come per gli incarichi di cancelleria interamente monopolizzato dalle famiglie dei funzionari, rappresentò un canale di promozione sociale abbastanza veloce che rimase aperto, e che venne sfruttato soprattutto da famiglie di mercanti, sensali, fattori, negozianti che avevano una certa familiarità con le scritture contabili.
Alla fine del Seicento la classe degli ufficiali statali non aveva in definitiva perso le grandi differenziazioni interne che presentava un secolo prima. Il suo strato superiore, il gruppo delle «famiglie di cancelleria», sebbene ridimensionato politicamente, sebbene non privilegiato nelle cooptazioni che partirono da metà secolo e che finirono col non tenere alcun conto dei meriti di servizio alla Repubblica, ciò nonostante e forse come reazione a questo, aveva acquisito una distinzione sociale ancora più netta. I suoi comportamenti familiari e sociali richiamavano quelli tipici della nobiltà superiore: una forte endogamia di gruppo, la pratica di destinare un figlio per generazione al servizio pubblico al sostegno del quale dovevano concorrere gli altri fratelli, una crescente tendenza all’utilizzo del fedecommesso per salvaguardare patrimoni basati sempre più sulla rendita, non più rinvigoriti dal commercio (84).
L’istanza più ardita che provenne da quest’ambiente fu quella di apparire come una sorta di noblesse de robe, ovverosia di seconda nobiltà. Deve esser stato con ogni probabilità un cittadino di cancelleria l’autore nel secondo Seicento di uno scritto significativamente anonimo dal titolo rivelatore, Delli gentilhuomini del secondo ordine in Venetia, in cui la contiguità con il ceto patrizio veniva descritta in maniera tale da annullare quasi le differenze sociali:
Questi [i cittadini] nell’habito, nel modo di vivere, nelle pratiche, nei costumi, nelle habitationi, nelli parentadi, in tutto con i Patrizi si conformano e le case degli uni, e degl’altri sono ben spesso, in testimonio della piacevole libertà di quella Repubblica, o di stretta amicizia o d’affinità congionte (85).
Una serie di famiglie di ufficiali variamente inseriti nell’amministrazione in posti comunque di un certo peso — ragionati, notai e scrivani in qualche magistratura
importante, priori dei lazzaretti, gastaldi ducali e delle Procuratie, ecc. — mostrano invece una maggiore elasticità nei comportamenti familiari e sociali. Sebbene l’attenzione alla qualità sociale dei legami matrimoniali rimanesse alta, in queste casate non si disdegnava una moglie che proveniva da una famiglia di negozianti, magari di ricchi marzeri, o mercanti di lana; le differenze tra i percorsi professionali prescelti dai fratelli erano nettamente maggiori; la mercatura spesso non veniva del tutto abbandonata in nessuna generazione; la proprietà immobiliare extraurbana era considerata più uno status symbol che una forma di investimento a cui legare la parte preponderante del patrimonio; l’uso del fedecommesso era raro, la partibilità diffusa ed estesa in qualche caso anche alle figlie femmine. Insomma, la dedizione al servizio pubblico e l’identificazione con i destini dello stato aristocratico non generava in questo gruppo rilevanti fenomeni imitativi rispetto all’élite patrizia.
Una fascia più ampia di famiglie comprendeva infine il ceto degli ufficiali intermedi di livello inferiore. In questo strato le vendite seicentesche degli uffici dovettero determinare un ricambio sostanziale, permettendo a molti soggetti di entrare per la prima volta — in qualità di proprietari o sostituti — nell’impiego pubblico, mentre in alcuni casi l’ascesa sociale avveniva dall’interno dell’apparato pubblico, dai posti «di ministero». Per comprendere la dimensione sociale di questa fascia inferiore della classe media, come si è detto, conviene rifarsi ai comportamenti, ai costumi della parte più agiata del ceto popolare.
Medici, avvocati, notai
Lo studio del ceto dei professionisti liberali è innanzitutto un problema di fonti: se il profilo sociale della classe degli ufficiali affiora grazie alla nutrita documentazione che rimane del rapporto tra funzionariato ed amministrazione pubblica, molte meno basi d’appoggio si hanno per le professioni liberali, che sono state analizzate più sotto l’aspetto tecnico-istituzionale che non sotto quello sociale.
Nel Seicento i due collegi veneziani dei medici fisici e dei chirurghi, le due grandi partizioni in cui era divisa la professione medica nell’età moderna, per le gravi perdite subite durante la peste del 1630-1631 vennero riuniti sotto la direzione di un solo priore. Non sembra si debba considerare questo come un sintomo di crisi della categoria medica in quanto tale, anzi nel 1641 il senato istituì presso la Pubblica Libreria una lettura di medicina che dal 1671 si poté avvalere del nuovo teatro anatomico di S. Giacomo dall’Orio, costruito grazie al lascito di un patrizio. Dopo due anni il collegio dei chirurghi riacquistava la sua autonomia (86).
La possibilità per gli aspiranti medici di disporre del dottorato rilasciato dallo stesso collegio veneziano, in deroga all’obbligo per i professionisti veneziani di addottorarsi a Padova, non sembra aver determinato cambiamenti nel bacino di provenienza dei medici fisici, che anche nel Seicento provenivano in buona parte dalla Terraferma o da paesi esteri (87). La mobilità di questa categoria — una caratteristica tipica della professione — era incoraggiata dalle stesse autorità che in più casi ebbero a favorire medici foresti invitandoli ad esercitare e insegnare sul suolo della Repubblica, e comunque non fissarono mai alcun requisito specifico di nascita o residenza per coloro che aspiravano ad entrare nei collegi cittadini (88). Degli otto medici ricordati a fine Settecento da Francesco Bernardi come i più famosi del XVII secolo, uno solo, Battista Gemma, era veneziano, due erano bellunesi, Eustachio Rodio e Giovanni Colle, Zaccaria dal Pozzo feltrino, Girolamo Tebaldo opitergino, Santorio Santorio istriano, Pietro Sivos gallo e Giovanni Veslingio tedesco (89). Quello dei medici era quindi un ambito professionale decisamente «aperto», dove le procedure di accesso al collegio svolgevano una qualche funzione di filtro ma dove la concorrenza — anche con pratici e ciarlatani — doveva essere forte.
Una città come Venezia offriva molteplici possibilità di impiego ai collegiati, che nel primo trentennio del secolo erano tra i sessanta e i settanta; accanto alla libera professione esistevano infatti varie possibilità di «lavoro dipendente», come i posti di «medico di contrada» sovvenzionati dalle fraterne per garantire un’assistenza ai poveri, quelli pagati dalle Arti per garantire le cure ai confratelli indigenti, oltre naturalmente agli incarichi alle dirette dipendenze dello stato al seguito della flotta, nell’esercito, in missioni speciali, ecc. Se i posti più poveri fruttavano poche decine di ducati all’anno e venivano quindi coperti dai professionisti meno rinomati o da neolaureati, i più celebri tra i fisici richiedevano onorari esorbitanti, sciolti da ogni vincolo che non fosse quello dell’accordo tra il malato e i suoi familiari ed il medico. Nel caso intervenissero contestazioni sulla parcella, le autorità solevano rivolgersi per la perizia al collegio competente, che si basava su una speciale tabella detta del mendo in cui il corpo era diviso in 24 carati ad ognuno dei quali era assegnato un preciso valore legale.
Sebbene il reddito professionale potesse variare considerevolmente, la maggior parte dei collegiati rientrava nelle fasce medio-alte della borghesia veneziana. Tuttavia si ha la sensazione che rispetto ai secoli precedenti fosse diventato più difficile accumulare grandi patrimoni solo in virtù della professione medica, come era riuscito nella prima metà del Quattrocento al padovano Leonardo Bertapaglia che esercitando a Venezia «s’arricchì in tal modo che e nella città e nel territorio innalzò magnifiche fabbriche», o al suo concittadino Ercole Saxonia che nella seconda metà del secolo successivo guadagnò in città «immense ricchezze» (90). Forse non è un caso che tra le famiglie che dal 1646 sborsarono i 100.000 ducati per acquistare la nobiltà nessuna avesse fondato la propria ricchezza sulla sola professione medica.
Anche all’interno del gruppo professionale medico vi erano ovviamente suddivisioni di status che rispecchiavano funzioni professionali diverse. «Completa facoltà diagnostica e terapeutica» (91) aveva il medico fisico, mentre il chirurgo poteva intervenire autonomamente, senza la prescrizione del fisico, solo nei casi più lievi. Vi era poi una nutrita serie di operatori sanitari che non esiteremmo a collocare tra coloro che esercitavano arti vili, come i barbieri che avevano una propria fraglia (92), se non fosse che le Anagrafi del 1766 annotano tra gli «impieghi civili e arti liberali» accanto a centoquaranta medici, centocinque chirurghi «e suoi membri»: stueri, cioè addetti a bagni pubblici dove si curavano i calli e varie malattie epidermiche, conciaossi, norsini che si dedicavano alla cura degli organi genitali e mettevano cinti per ernie, e cavadenti (93). Si tratta di un’imprecisione senza significato o nel corso del Settecento l’ambito della professione medica si allargò a comprendere anche questi bassi operatori?
Chi godeva senza dubbio di uno status elevato erano i farmacisti, gli spezieri da medicine, la cui Arte aveva a Venezia una lunga tradizione, una reputazione internazionale e severe procedure di accesso. L’esclusiva data ai farmacisti nella preparazione dei medicinali comportava un controllo reciproco tra questi e i medici: ai farmacisti spettava verificare se colui che prescriveva il farmaco fosse inserito nella lista distribuita annualmente degli abilitati alla professione (94). Molti farmacisti, data la necessità di acquistare all’estero droghe e prodotti di base e la possibilità di rivendere medicamenti come la famosissima teriaca, superavano in realtà la tradizionale divisione tra spezieri da medicine e da grosso e si immischiavano talvolta in commerci di zucchero, cera ed altri prodotti tipici delle drogherie, con ricavi cospicui (95). In continuo, larvato antagonismo con la classe medica, il gruppo professionale degli speziali aveva un profilo sociale abbastanza definito, accentuato dalla tradizione della trasmissione ereditaria del mestiere e dei suoi segreti; la possibilità di percepire guadagni sostenuti contribuiva a dissolvere i dubbi su una professione che lambiva il commercio al minuto, tant’è che nei censimenti risultano numerosi gli speziali iscritti a pieno titolo tra i «cittadini».
Con gli avvocati si sale decisamente in alto nella scala sociale della classe media. Nella prima metà del Cinquecento una legge aveva fissato requisiti assai blandi per la pratica dell’avvocatura, sicché le diverse leggi che agli inizi del Seicento si lagnavano che praticamente chiunque, per ignorante che fosse, si buttasse ad esercitare la professione forense possono essere prese alla lettera. D’altronde, riflette Gaetano Cozzi, insistere troppo sulla preparazione degli avvocati cosiddetti «straordinari» avrebbe comportato obblighi particolari anche per gli avvocati «ordinari» che erano patrizi e che, sebbene senza il loro patrocinio fosse impossibile agire in giudizio, raramente disponevano del titolo universitario. La decisione agli inizi del Settecento di pretendere il dottorato in giurisprudenza presso lo Studio di Padova sancì quindi di fatto la scomparsa dell’avvocatura ordinaria patrizia (96).
Anche lo scalino inferiore della professione forense, quello di causidico o solicitadore, rimase per buona parte del XVI secolo vagamente regolamentato: solo nel 1620 il legislatore stabilì che per accedervi fosse indispensabile la nascita in città, oppure nel Dominio con dieci anni almeno di residenza a Venezia, requisiti che non impedirono ad esempio agli Ebrei di dedicarsi a questa professione, dove acquisirono un peso non indifferente (97).
Nei suoi criteri di accesso e selezione anche la carriera forense risulta esser stata considerevolmente «aperta», con prospettive di progressione veloce dipendenti per gran parte dalla sola abilità del singolo. Lo stesso sistema normativo veneto favoriva ciò: il processo civile, ad esempio, si svolgeva quasi per intero verbalmente, con i giudici intenti ad ascoltare le perorazioni degli avvocati che, data la diffusa insofferenza per i tecnicismi e la scarsa preparazione giuridica di molti magistrati patrizi, ricorrevano piuttosto ad argomentazioni pratiche sostenute con tutti gli artifizi dell’oratoria e della mimica (98). Così i processi diventavano una sorta di spettacolo che divertiva i forestieri, una delle attrazioni della città da non perdere secondo la guida del Coronelli di fine Seicento (99). A prescindere dalle sue conseguenze giuridiche, è evidente come un tale sistema rendesse palese, scoperta la concorrenza tra i professionisti, per i quali dovevano risultare premianti, oltre ad una conoscenza pratica del diritto veneto, buone doti di scaltrezza e di psicologia umana. Il ricambio interno del gruppo fu quindi sempre sostenuto e la strada del foro rappresentò uno dei percorsi di ascesa sociale più diretti della Venezia del Sei-Settecento, con minori ostacoli di carattere familiare o «di ceto» rispetto ad altre carriere borghesi.
In tale contesto, è comprensibile come l’avvocatura rappresentasse una delle professioni del ceto medio che consentiva i massimi e più veloci guadagni. Gli esempi non mancano, e riguardano ancora una volta le casate che acquistarono a metà Seicento la nobiltà. Bartolomeo Belloni, che si aggregò nel 1647, era figlio «di un avvocato criminale di primo grado nel foro Veneto che guadagnò tesori». Camillo Barbaran, di una nobile famiglia vicentina, «povero per non dire scalzo venne a Venezia a fare l’avvocato, sicché s’adoprò così bene che avanzò quanto basta per aggregarsi alla nobiltà» (100), cioè per sborsare l’equivalente di circa 135 chili di monete d’oro, ritenuto l’obolo sufficiente per sedere in maggior consiglio. E gli esempi potrebbero continuare.
Quanti erano gli avvocati veneziani? Il loro numero non era predeterminato, né i censimenti permettono di avvicinarsi ad una cifra, ancorché approssimativa. Giovanni Nicolò Doglioni, agli inizi del Seicento nelle sue Cose maravigliose dell’inclita città di Venetia, oltre a quattro «avvocati eccellentissimi [...] nobili», nomina fra gli avvocati cittadini più famosi «Luigi Balbi, Gio. Finetti, Michiel Marini, Bortolamio Moro, i due Tiraboschi fratelli Tadio e Gio. Battista, Filippo Pincio, Horatio Gella, Marin dall’Occha e altri infiniti, pur troppo noti a ciascuno» (101). L’impressione è che il loro numero fosse in costante aumento e che soprattutto nel Settecento, come testimoniano le memorie del più famoso tra di essi, Carlo Goldoni (102), gli avvocati veneziani diventassero un’infinità: ben duecentosessantotto, più duecentocinquantuno intervenienti, secondo le prime Anagrafi nel 1766 (103).
Se la «risonanza» di un certo gruppo professionale indica in qualche modo la rilevanza della sua posizione sociale allora, considerata la scarsità degli accenni a riguardo, l’ultima categoria di professionisti civili, i notai pubblici, doveva occupare un livello non elevato nella gerarchia interna alla middle class veneziana. Per diventare «nodaro veneto» ed essere ammesso al collegio che constava di sessantasei posti, una legge del 1514 aveva richiesto il titolo di cittadino originario, ma in realtà molti notai cinquecenteschi disponevano di status inferiori, come quello della cittadinanza acquisitiva. La legge del 1632 che riformò le procedure di accesso alla professione stabilì infatti che fosse sufficiente provare una sorta di cittadinanza originaria ridotta a due soli gradi, sé e il padre, forse per aumentare le possibilità di ricambio interno del corpo. Curiosamente, dalla fine del secolo si moltiplicarono le domande di cittadinanza originaria vera e propria di aspiranti notai che dichiaravano di richiedere tale titolo in quanto indispensabile per avviarsi alla carriera notarile (104). Si trattò forse di un riflesso indotto dal desiderio di omologazione con la fascia giuridicamente meglio definita del ceto medio, quella dei cittadini originari? Del bisogno di precisare la propria identità sociale riavvicinandosi al ceto burocratico da cui, in epoca medievale, la professione notarile si era staccata?
Nonostante le tariffe ufficiali degli atti rimanessero invariate dal 1517 al 1632 e da questa data al 1740, secondo uno studio recente la professione notarile che nel Cinquecento consentiva ristretti margini di guadagno si fece via via più remunerativa (105). Vari elementi, come le ristrettezze economiche del collegio notarile e la sua mancanza di una sede fissa, indicano che tuttavia nel XVII secolo la professione notarile mantenne un profilo economico e sociale inferiore rispetto alle altre arti liberali, per accedere alle quali era ad esempio indispensabile il titolo accademico (medicina) o dalle quali si potevano ricavare guadagni ben più consistenti (avvocatura). Senza dubbio gli associati dei principali studi cittadini che si spartivano una clientela altolocata e facoltosa godevano di uno status elevato, ma accanto ad essi vi erano notai che si specializzavano su altri segmenti di clientela, nel mondo dell’artigianato, del commercio al minuto, con cui finivano per condividere ambiente e stili di vita (106). Per un ricco professionista che rogava nel suo cancello a S. Marco, insomma, c’era qualche notaio che attendeva i clienti fuori dei tribunali, come Francesco Alcaini (1580-1603) che avviò la sua attività esercitando nell’atrio del tribunale del forestier, o altri che rogavano in giro per la città come Nicolò Maria Arduini (1692-1726) che si fermò nel suo cancello a S. Marco solo quando prese il suo posto il figlio Francesco (1720-1756) (107).
Per più aspetti i professionisti liberali possono essere considerati il «cuore» anche della borghesia seicentesca veneziana. L’aver legato la propria professione ad un sapere specialistico di alto profilo tecnico, lo svolgere la propria attività in un ambiente competitivo senza rilevanti vincoli protezionistici, l’aver raggiunto una posizione sociale in virtù delle proprie capacità e conoscenze e, di conseguenza, considerare il successo come un traguardo strettamente personale sono alcuni degli aspetti che rendono la figura del medico, dell’avvocato, del notaio particolarmente «moderna», quasi esemplarmente «borghese» nella concezione comune del termine. Certo, accanto a questi, sussistono elementi che rinviano ad una concezione meno individualistica di sé e della propria posizione sociale, come la tendenza diffusa alla trasmissione ereditaria della professione (che pure è un aspetto diffuso ancor oggi tra questi gruppi professionali), o la non infrequente multiprofessionalità di alcuni di questi borghesi, ad esempio avvocati che passavano con disinvoltura dal foro al fondaco.
Tale «modernità» — un concetto di per sé sfuggente — era dunque appena abbozzata, incerta, per più versi contraddittoria. Sebbene, complessivamente, la presenza di questi gruppi dovette essere tra Sei e Settecento crescente sia sotto il profilo economico che sotto quello più strettamente sociale, essi risultano del tutto incapaci di produrre una qualsiasi istanza culturale o politica alternativa, una qualche rappresentazione della società che consenta loro di acquisire una seppur embrionale «coscienza di classe». Casi di ostentazione di sé e della propria professione — come quello del medico ravennate Tommaso Rangone che a metà Cinquecento si fece ritrarre da Jacopo Sansovino tra libri e mappamondi sul portale d’ingresso della chiesa di S. Zulian di cui restaurò a proprie spese la facciata — rappresentano un’eccezione estranea all’atteggiamento pubblico di obbediente riservatezza a cui si confinò il ceto dei professionisti liberali veneziani. La carica innovativa insita nella loro funzione professionale non riuscì insomma a superare la barriera delle mura domestiche, la soglia del cancello, dello studio.
Il mondo del commercio
Tra i gruppi professionali che componevano il ceto medio i mercanti costituivano senza dubbio l’insieme più eterogeneo e sfuggente, per via della diversa provenienza delle varie «nazioni» o «comunità» che vivevano ed operavano a Venezia nel XVII secolo e per la loro impossibilità di integrarsi compiutamente nel tessuto sociale cittadino, rimanendo come incapsulate in esso (108). Per addentrarsi in questo gruppo sociale sarebbe dunque necessario scrollarsi di dosso una volta di più il «pregiudizio giuridico» della cittadinanza come carattere distintivo del ceto medio, e considerare a pieno titolo tra i borghesi veneziani il mercante armeno o quello tedesco, il sensale greco, il banchiere ebreo, ecc. La compresenza di etnie, costumi, usanze commerciali e lingue diverse contribuì a mantenere al fondaco realtino quella dimensione cosmopolita che il ridimensionamento del commercio internazionale veneziano rischiava inevitabilmente di ridurre, ma rende oggi assai difficile isolare un denominatore comune per questa fascia della middle class lagunare. L’eterogeneità sociale del mondo mercantile veneziano colpì l’inglese Richard Lassels, che visitò Venezia verso il 1670: «In this Piazza [cioè Rialto] I found alwaies a world of strangers perpetually walking and talking of bargains and traffick, as Greek, Armenians, Albanians, Slavonians, Polonians, Jewes and even Turks themselves; all in their several habits, but all conspiring in this one thing, to sell dear and buy cheap» (109).
Crescita dell’imprenditoria straniera e avversione verso il commercio da parte del patriziato accompagnarono la ristrutturazione del commercio veneziano tra Cinque e Seicento, nel quadro dello spostamento continentale del fulcro dei traffici mondiali verso i paesi nord-atlantici (110). È inutile ritornare sul progressivo allontanamento dell’aristocrazia lagunare dalla pratica attiva della mercatura, un fenomeno che è stato studiato quasi fin troppo, in considerazione non tanto del suo innegabile interesse quanto dello spazio che è stato di conseguenza sottratto all’analisi di altri gruppi mercantili che si sostituirono al patriziato. Centrando l’attenzione solo sulla classe che concludeva il suo ciclo di imprenditorialità attiva, l’immagine complessiva della Venezia tardoseicentesca ne è risultata sproporzionata ed incoerente: una città avviata verso un’irresistibile decadenza commerciale in cui però — inspiegabilmente — la dogana da mar registrava grosso modo a fine Seicento gli stessi volumi di traffico di un secolo prima (111).
Già nel Cinquecento il processo continuo di ricambio proprio dei ceti commerciali aveva portato sulla piazza veneziana nuove forze provenienti dalla Terraferma suddita o da stati esteri: erano mercanti che spesso mantenevano con il proprio luogo d’origine un rapporto assai vivo, anche d’affari, e che dopo un certo periodo — solitamente inversamente proporzionale alla ricchezza accumulata — ottenevano o «per grazia» o per aver risieduto in città il numero prestabilito di anni, il titolo della cittadinanza acquisitiva (112). Erano poi presenti da secoli varie comunità di mercanti stranieri, per i quali però più che il luogo dove concentrare la propria attività Venezia continuava a rappresentare «innanzi tutto una scuola» (113). All’appello del grande commercio mancavano ancora gli Ebrei, che solo dalla fine del secolo poterono allargare la propria sfera d’azione al commercio marittimo. Furono proprio gli Israeliti, alla cui presenza è dedicato il saggio di Donatella Calabi in questo volume, l’esempio più eclatante dello spazio conquistato dalle nazioni mercantili straniere che seppero acquisire un ruolo determinante sulla piazza veneziana dedicandosi soprattutto al commercio d’Oltremare e acquisendo una posizione dominante in alcuni settori specifici, come nel traffico dell’olio (114). È sintomatico quanto scrive un panflettista anonimo sul periodo delle cooptazioni: «in Piazza di Rialto un Triumvirato d’un Ebreo, di un Grego e di un Latino mercatavano questa Nobiltà assumendosi loro l’obbligo d’ammassare l’esibizione col maggiore vantaggio privato che potessero» (115). Al di là della veridicità o meno di questo episodio, il solo fatto che lo si ritenesse plausibile testimonia quale ruolo rivestissero ormai i mercanti stranieri in una città oppressa dalle spese della guerra di Candia e svuotata di gran parte della liquidità.
Se il primo cambiamento fu dunque dato dal fatto che in proporzione nettamente maggiore rispetto al passato il mercante era un forestiero, spesso di altra lingua e religione, il secondo elemento di cui tener conto è che nel Seicento le grandi ricchezze non si formavano più esclusivamente o prevalentemente dai traffici su larga scala ma, come è stato osservato analizzando il gruppo dei nuovi nobili seicenteschi, piuttosto dal commercio d’approvvigionamento della città, che garantiva ricavi cospicui e sicuri (116). A ciò è collegata un’altra trasformazione strutturale, l’espansione della rete del commercio al minuto che passò da circa quattromilacinquecento punti vendita nel 1661 ad oltre seimila nel 1740 (117). Tale polverizzazione del dettaglio può essere variamente interpretata: come un riflesso dell’aumento generale dei consumi a scapito degli investimenti — l’idea di una Venezia che morì «dans la douceur de vivre» di Braudel (118) —, oppure semplicemente come una redistribuzione dei profitti dell’intermediazione commerciale tra un numero maggiore di soggetti. Difficilmente però l’allargamento del gruppo sociale dei commercianti al dettaglio, che dovette aver luogo anche come conseguenza della diminuzione delle attività manifatturiere e del grande commercio internazionale, non comportò un impoverimento generale di tale categoria, un abbassamento del suo livello di redditività media.
Tenuto conto di queste trasformazioni generali sarebbe interessante procedere a qualche approfondimento, ma la mancanza pressoché totale di studi che considerino gli aspetti sociali della mercatura nel Seicento costringe solo a qualche semplice riflessione generale. Nei suoi tratti salienti la carriera di un mercante benestante in questo secolo rimase la stessa del suo predecessore quattro-cinquecentesco: una preparazione scolastica di base talvolta con qualche appendice tecnica, un avviamento precoce alla professione al seguito di qualche parente o corrispondente negli ambiti verso cui si sarebbe diretta in seguito la professione, la tendenza a far coincidere il luogo di residenza della famiglia con il centro degli interessi mercantili, una gestione aziendale che coinvolgeva familiari e parenti, la diversificazione degli investimenti una volta raggiunto un certo livello patrimoniale, l’aspirazione a raggiungere qualche segno esteriore di uno status superiore come un palazzo, una residenza in campagna, una collezione di quadri, la preoccupazione di garantire una trasmissione efficace del patrimonio ricorrendo a precise strategie successorie.
Le trasformazioni cinque-seicentesche nel commercio veneziano incisero nel ricambio di questo ceto anche più profondamente, toccando ad esempio i meccanismi attraverso cui una famiglia di mercanti abbandonava il commercio e si indirizzava verso altri settori d’impiego? Secondo Ugo Tucci la «crisi della mercatura» incentivò il passaggio di molti mercanti all’amministrazione (119), un’osservazione che coincide con quanto è già stato rilevato a proposito delle vendite seicentesche degli uffici intermedi nei quali si inserirono spesso bottegai e commercianti. È difficile però dire se si sia trattato di un cambiamento strutturale, irreversibile, o non piuttosto di un passaggio congiunturale; in ogni caso la velocità di ricambio di questo ceto dovette aumentare rendendo la condizione del mercante in qualche modo più precaria di un tempo e il costume della trasmissione ereditaria del mestiere meno radicato.
Informazioni allettanti provengono dai testamenti di alcuni dei mercanti veneziani più famosi del XVII secolo, come Alberto Gozzi (120) o Giovanni Widmann (121). Vi si ravvede una tendenza decisa allo spostamento degli interessi verso l’acquisto della terra, assieme all’utilizzazione di pratiche quali il fedecommesso, il matrimonio ristretto, la monacazione delle figlie femmine; una concezione del ruolo sociale proprio e della famiglia del tutto simile a quella di famosi mercanti cinquecenteschi al loro pari di origine immigrata, come Giacomo Regazzoni (122) o Bartolomeo Bontempelli (123). Guardando a questi casi il «tradimento della borghesia» veneziana diventa una formula sbrigativa ma con una sua indubbia efficacia. In realtà la dimensione sociale del commercio veneziano nei secoli XVII e XVIII è un mondo ancora in grandissima parte sconosciuto, per penetrare il quale gli esempi più fulgidi corrono il rischio di essere più fuorvianti che utili.
Venezia nel Seicento: una società aperta?
Sebbene nel corso del XVII secolo la natura degli ordini sociali veneziani non si sia modificata, alcuni importanti cambiamenti nei meccanismi che regolavano l’accesso agli strati superiori della società ebbero luogo. L’immissione tra le fila del patriziato di oltre un centinaio di nuove famiglie costituì un fatto di considerevole rilevanza perché per un periodo lungo, dal 1646 al 1718, divenne di nuovo possibile a membri delle classi inferiori iscrivere il proprio nome sull’albo d’oro patrizio, sebbene ad un costo esorbitante. Il fatto che oltre alla disponibilità finanziaria non vennero in pratica richiesti altri requisiti se non quello dell’astensione dalle arti sordide, che a giudicare da molte considerazioni scandalizzate di parte aristocratica dovette essere vagliato con un’ampia elasticità, appare in contraddizione con l’immagine di una classe di governo tetragona ad ogni immissione dal basso di forze fresche. Alexander F. Cowan reputa tale fatto eccezionale, e «in una società diversa, l’ascesa di persone del popolo nei ranghi dell’élite sarebbe stata impossibile, oltre che impensabile» (124). In realtà molti dei nuovi nobili per quanto di origini umili erano sufficientemente ricchi da poter essere annoverati pressoché ovunque tra quella upper middle class che soleva pervenire a forme acquisitive della nobiltà, ciò nonostante l’arrivo tra i banchi del maggior consiglio di personaggi che avevano smesso da poco la traversa con cui servivano in bottega è senza dubbio un fatto di cui tener conto.
Se il diaframma che divideva classe media ed aristocrazia — e quindi cittadini che non godevano di diritti politici dal ceto dirigente — si assottigliò, anche la frontiera che separava il mondo delle arti e dell’industria dal ceto medio si mostrò più mobile, forse anche più che nel secolo precedente: lo si è rilevato ad esempio osservando una minor rigidità nelle procedure di selezione dei cittadini originari, o la possibilità aperta dalla vendita degli uffici intermedi per molti popolari di entrare in un ufficio pubblico e svolgere una «professione civile». Nel contempo, seppure soggetto a precisazioni normative, il reclutamento dei professionisti liberali rimase nel complesso aperto e ancorato a principi meritocratici.
Cosa comportarono questi cambiamenti per il profilo complessivo e gli assetti interni dei diversi ordini sociali? Lo spostamento verso il basso della «soglia d’accesso» al ceto medio non dovette apportare significativi cambiamenti quantitativi: se si prende in considerazione la categoria statistica dei «cittadini» nei diversi censimenti seicenteschi, pur muovendosi a fisarmonica seguendo le grandi fluttuazioni della popolazione lagunare la borghesia mantenne un peso relativo tra il 6 e il 7%, con la sola eccezione del 1633 quando, per l’incidenza maggiore della peste sulle classi più umili, superò il 9% (125).
Se il ceto medio numericamente rimase stabile, allora per l’abbassamento della sua soglia d’accesso e per il contemporaneo passaggio al corpo aristocratico delle famiglie più doviziose il suo status generale e soprattutto la sua condizione economica complessiva dovettero diminuire, come è stato confermato dalla riduzione del personale in servizio nelle famiglie «cittadine» registrato sui censimenti sei-settecenteschi. Davanti a tale «degradazione» della classe media i settori socio-professionali che al suo interno presentavano una maggiore autocoscienza di gruppo reagirono consolidando la propria area di privilegio, accentuando il controllo sul ricambio interno, adottando comportamenti endogamici che sottintendevano un atteggiamento difensivo di autoprotezione e di rafforzamento dell’identità sociale. Tali gruppi professionali — la cancelleria, i medici, gli avvocati, ma anche alcune categorie di mercanti — acquisirono nel Seicento un rilievo sociale progressivamente più importante. Carriere come quella avvocatesca, professioni come quella di ragionato, traffici specializzati in settori cruciali dell’approvvigionamento urbano come il legno, il vino o i bovini, rappresentarono alcune tra le vie di ascesa sociale più veloci del secolo e consentirono di raggiungere anche in solo un paio di generazioni i piani più alti della gerarchia sociale.
Che la vecchia tripartizione della società veneziana fosse alla fine del secolo già superata e che la classe media presentasse ormai al suo interno differenze così sensibili da richiedere un’ulteriore suddivisione è in definitiva qualcosa di più di un’ipotesi affacciatasi seguendo alcuni osservatori d’inizio Settecento. Fu lo stesso processo di specializzazione progressiva delle professioni in un mercato dalla divisione del lavoro sempre più accentuata, anche su scala internazionale, a rendere molto più disomogeneo il ceto intermedio veneziano, per il quale il vecchio criterio di distinzione in base alla cittadinanza — retaggio della città-stato medievale — non costituiva più il fulcro della propria identità sociale.
L’idea che dal punto di vista sociale la nota dominante nella storia di Venezia nel secolo XVII sia quella della continuità e della tenuta, e quindi di conseguenza della staticità e della conservazione, appare in definitiva uno schema interpretativo superato, ormai inutilizzabile, che oltretutto si scontra logicamente con un altro luogo comune storiografico, quello della «pace sociale» che avrebbe regnato in laguna. Il fatto che lungo il secolo Venezia ebbe un tasso complessivo di conflittualità sociale nettamente inferiore a quello registrato in molti altri stati italiani ed europei costituisce ben inteso un’evidenza difficilmente controvertibile, ma non si capisce come ciò avrebbe potuto aver luogo senza che le tensioni latenti nel corpo sociale fossero assorbite mediante un continuo riequilibrio delle diverse componenti, senza una dialettica che ricomponesse di continuo le conflittualità esistenti tra i gruppi. Guardando la società veneziana del XVII secolo attraverso la lente della sua borghesia essa appare insomma una realtà stabile perché mobile, e mobile in quanto aperta, senza barriere invalicabili all’ascesa sociale e con meccanismi in grado di attutire in qualche modo una, sempre rovinosa, caduta.
In questa «società aperta» esistevano, come ovunque, aree di tensione, anche estese, tra i diversi gruppi. Una prima zona d’attrito è individuabile tra la fascia alta della borghesia e i nobili poveri, il cui numero aumentò sensibilmente nel secondo Seicento anche a seguito dell’immigrazione dei patrizi residenti a Candia dopo la perdita dell’isola. Il risentimento di questa parte della nobiltà sia verso i cittadini di cancelleria, tradizionalmente legati alla parte più potente del patriziato, sia verso il ceto dei ricchi borghesi senza alcuna tradizione in grado di acquistare il titolo nobiliare è ampiamente documentabile e sembra crescere contemporaneamente alle cooptazioni (126). Tuttavia, i meccanismi che favorivano la composizione delle tensioni — dai matrimoni tra ricche borghesi e nobili altolocati ma poveri, alle occasioni civiche in cui il ruolo di entrambi i ceti era rappresentato e quindi rigenerato (127), alle quotidiane occasioni di collaborazione all’interno dell’amministrazione, ecc. — erano tali che quell’attrito non assunse mai forme eclatanti.
Un’eco più remota proviene da una seconda area di contrasto, quella tra i cittadini che avevano lunga tradizione di servizio nell’amministrazione e che come si è detto aspiravano a considerarsi quasi una seconda nobiltà, e le classi emergenti di estrazione commerciale e popolare. La satira, il dileggio, l’invettiva contro il parvenu costituivano uno dei linguaggi più tipici nella dialettica sociale del Seicento, come testimoniato nelle strofe del poeta Zuan Francesco Busenello, ad esempio dove insorge contro l’inflazione dei titoli:
Del Lustrissimo vol i cittadini,
Pretende del Clarissimo el mercante,
Del molto illustre vuol ogni furfante,
Magnifico signor se dà ai fachini.
Un pezzo de villan dalla vallada
Un capel de castor porterà in testa;
Un ch’ha portà sportella mette vesta;
Un zavatter ha pan e vin d’entrada (128).
O dove canzoneggia il plebeo che accede, senza averne i titoli, alla cittadinanza originaria:
Tutti va drio de lu con la baretta,
In man: l’è galantomo, l’è onorato
La casa soa xe nobile de fatto,
No occore che nissun co lu se metta.
El spende alla grandezza, el vol portar
La so riputation fin alle stelle,
El fa le cose sì pulite e belle
Che contra d’elio no se pol parlar.
Se el ga una putta, trovarghe bisogna
Qualche cittadinazzo per mario,
Ché la dota farà sconder quel rio
Che pol alla so casa far vergogna.
L’è coverto col manto dei tesori,
Che el luse come un specchio fina in cao:
No ghe vardè da drio se l’è macchiao,
Ché perderè la vista ai so splendori (129).
Il tema assume in questo caso un interesse particolare in relazione alla biografia dell’autore che, avvocato di buona fama e fortuna, era figlio e fratello di segretari di cancelleria. Spalancatesi le porte del Palazzo a chi potesse versare il contributo di 100.000 ducati, il Busenello aveva intravisto la possibilità di entrare tra le fila di quel patriziato che per varie generazioni i suoi antenati avevano servito in incarichi di vertice nella burocrazia centrale. «Svisceré el scrigno [...] non fè compare mio che la ve scappa», gli scriveva l’amico patrizio Giacomo Badoer:
Vignì pur via che v’aspettemo tutti
In sala granda co le balle in man.
Ve ne daremo tante da christian
Che del gran peso anderà gobbi i putti (130).
Ma le legittime aspirazioni di Zuan Francesco dovevano trovare un ostacolo insormontabile nel fedecommesso che il padre aveva stabilito sul patrimonio avito, un’usanza come si è detto diffusa tra le famiglie del ceto di cancelleria che con simili vincoli cercavano di porre argine all’impoverimento derivante dagli onerosi incarichi che comportava tale carriera. In questo senso la stizzosa polemica del Busenello contro gli arrampicatori sociali all’interno della sua stessa classe può essere considerata come una spia dei sentimenti diffusi in quel ceto di funzionari che assistevano giornalmente allo «svilimento» dell’ordine intermedio e, pur avendo dimostrato lunga fedeltà alla causa repubblicana, vedevano acquistare il titolo patrizio da famiglie che non sarebbero senza dubbio riuscite ad ottenere nemmeno il titolo della cittadinanza originaria.
Il tema frequente nelle pagine dell’avvocato cittadinesco della venalità dei costumi moderni, della sostituzione della ricchezza alle antiche tradizioni, dell’esibizione del lusso e dell’ostentazione del denaro in un mondo dove ormai «chi no ha no è» e «chi è senza l’haver mai no sarà» (131), al di là delle vicende personali del Busenello e della retorica moralistica dell’epoca richiama un’ulteriore trasformazione nelle gerarchie sociali della Venezia tardoseicentesca. Dietro l’ormai vetusto paravento della definizione giuridica di cittadino, dietro l’ancor effettivo discrimine che separava professioni civili e arti vili, le spinte verso un ordinamento diverso del corpo sociale si moltiplicavano ed acquisivano sempre maggiore concretezza e visibilità. Delle tre gerarchie che come ha riassunto Lawrence Stone ordinavano le società d’epoca moderna (132), quella di prestigio e di status, quella politica legata alle funzioni giudiziarie, militari ed amministrative e quella economica determinata dalle condizioni finanziarie, di reddito e patrimonio, fu quest’ultima ad aumentare il suo peso nella società veneziana nel corso del Seicento e a ridisegnare anche il profilo della classe media. Le trasformazioni intervenute nella burocrazia confermano questa tendenza: la vendita degli uffici pubblici e la pratica della sostituzione, non solo non furono segnali di un ritorno ad una «concezione medievale» dell’ufficio (133), ma anzi favorirono la depersonalizzazione della funzione pubblica e contribuirono a rinforzare, all’interno dello stato aristocratico, il «principio informatore della immagine del mondo borghese: cioè il calcolo dei vantaggi e degli svantaggi» (134).
Un ultimo aspetto rimane da valutare, se lo spazio politico-istituzionale occupato dalla borghesia veneziana nel Seicento ebbe a mutare e se le trasformazioni di cui si è cercato di rendere conto comportarono la nascita o il rafforzamento di una qualche forma di coscienza politica di questa classe. L’unica indicazione in questo senso è significativamente provenuta nel corso del secolo dalla parte che si è descritta come più strettamente organica allo stato aristocratico e alla sua filosofia, la cancelleria ducale, che tra Cinque e Seicento riuscì a acquisire un peso anche politico non indifferente.
Se si è disposti a leggere nella crescita della cancelleria tardocinquecentesca un riflesso dell’avanzata dell’ordine dei cittadini originari nel suo complesso, allora dovette verificarsi anche a Venezia il fenomeno sociale che contrassegnò l’evoluzione moderna di molti paesi europei: la crescita di una «piramide borghese» di possessori di incarichi civili ereditari al cui vertice si trovava una noblesse de robe e che costituiva, come ha osservato Norbert Elias, il «polo opposto alla piramide della nobiltà» (135). A differenza che in altri stati, però, lo spostamento del potere verso questo gruppo in ascesa venne interrotto precocemente nel corso del XVII secolo, con il ridimensionamento del potere dei segretari di cancelleria in virtù della «correzione» del consiglio dei dieci del 1628-1630, scalzando il monopolio dei cittadini originari nella burocrazia intermedia, abbassando il tono sociale della cittadinanza originaria, assicurando un accesso istituzionalmente regolato al potere alla fascia più ricca della borghesia ed assicurando privilegi diversi, autonomia e possibilità di lauti guadagni a vari gruppi professionali. Il carattere della borghesia veneziana settecentesca, attenta ai bagliori dei lumi europei ma remissiva e funzionale rispetto ai destini dello stato aristocratico, avrebbe trovato la sua origine in questo passaggio.
1. È impossibile render conto della bibliografia sul tema. Per un approccio cf. Oscar Di Simplicio, Classi, ordini e ceti nelle società d’«Ancien régime», in La storia, a cura di Nicola Tranfaglia-Massimo Firpo, III, L’Età moderna. 1. I quadri generali, Torino 1987, pp. 459-485.
2. Un riepilogo del dibattito in Francesco Benigno, Specchi della rivoluzione: revisionismi storiografici a confronto, «Storica», 1, 1995, nr. 2, pp. 7-54.
3. Fernand Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, II, Torino 1986, pp. 775-776.
4. Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, Torino 1975, p. 536.
5. Cf. Paolo Malanima, La perdita del primato, relazione al Convegno di studi «La popolazione italiana nel Seicento», a cura della SIDES, Firenze, 28-30 novembre 1996, in corso di stampa.
6. Citato in Gaetano Cozzi, Politica, società, istituzioni, in Id. - Michael Knapton, Storia della Repubblica di Venezia nell’età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517, Torino 1986 (Storia d’Italia, diretta da Giuseppe Galasso, XII/1), p. 121 (pp. 3-271).
7. Karl Marx-Friedrich Engels, Manifesto del Partito Comunista, Milano 1978, p. 102.
8. Gasparo Contarini, Della Repubblica et magistrati di Venetia libri cinque [...] con un ragionamento [...] di m. Donato Giannotti fiorentino colle annotationi sopra li suddetti autori di Nicolò Crasso [...], Venezia 1650, p. 389.
9. Ibid., p. 391.
10. Gian Antonio Muazzo, Historia del governo antico e presente della repubblica di Venezia, in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 966 (= 8406), c. 87.
11. Matteo Casini, La cittadinanza originaria a Venezia tra i secoli XV e XVI. Una linea interpretativa, in AA.VV., Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Venezia 1992, pp. 133-150.
12. R. de la Haye, La politique civile et militaire des Vénitiens, Paris 1668, pp. n.n. dell’Avant propos; Abraham Nicolas Amelot de la Houssaie, Histoire du Gouvernement de Venise, I, Paris 1677, pp. 121-122.
13. G.A. Muazzo, Historia del governo, cc. 87 ss.
14. Giovanni Botero, Relatione della Republica Venetiana, Venetia 1605, cc. 42v-43.
15. Relatione della città e Republica di Venetia, Colonia 1672, p. 27.
16. A.N. Amelot de la Houssaie, Histoire du Gouvernement, p. 44; Saint-Didier (Alexandre Toussaint de Limojon), La Ville et la république de Venise, Paris 1680, p. 153.
17. Roberto Sabbadini, L’acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (sec. XVII-XVIII), Udine 1995, p. 15.
18. Colin Lucas, Nobili, borghesi e le origini della Rivoluzione francese, in Il mito della rivoluzione francese, a cura di Massimo Terni, Milano 1981, p. 192 (pp. 187-234).
19. Ugo Tucci, Carriere popolane e dinastie di mestiere a Venezia, in Gerarchie economiche e gerarchie sociali, secoli XII-XVIII (XII settimana di studi, Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Prato 1980), Firenze 1990, p. 827 (pp. 817-851).
20. Lodovico Zuccolo, Dialoghi [...] ne’ quali con varietà d’eruditione si scoprono nuovi e vaghi pensieri filosofici, morali e politici, Venetia 1625, p. 246.
21. Nella parte che segue si rinvia, ove non diversamente indicato, a Andrea Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia in età moderna: i cittadini originari (sec. XVI-XVIII), Venezia 1993, pp. 68 ss.
22. A.S.V., Avogaria di Comun, b. 399, fasc. 74.
23. A. Zannini, Burocrazia e burocrati, pp. 73-74.
24. C. Lucas, Nobili, borghesi, p. 192.
25. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 90 (= 8029), cc. 217-221.
26. A. Zannini, Burocrazia e burocrati, pp. 84-88.
27. Citato ibid., p. 85.
28. Arthur Livingston, La vita veneziana nelle opere di Gian Francesco Busenello, Venezia 1913, p. 286.
29. Casimir Freschot, Nouvelle Relation de la ville et république de Venise, Utrecht 1709, p. 366.
30. Citato in Peter Burke, Scene di vita quotidiana nell’Italia moderna, Roma-Bari 1988, p. 35.
31. Cf. Giovanni Favero - Maria Moro - Pierpaolo Spinelli - Francesca Trivellato - Francesco Vianello, Le anime dei demografi. Fonti per la rilevazione dello stato della popolazione di Venezia nei secoli XVI e XVII, «Bollettino di Demografia Storica», 15, 1991, pp. 23-110.
32. Aldo Contento, Il censimento della popolazione sotto la Repubblica Veneta, «Nuovo Archivio Veneto», 20, 1900, pt. II, p. 222 (19, 1900, pt. I, pp. 5-42, pt. II, pp. 179-240; 20, 1900, pt. I, pp. 5-96, pt. II, pp. 172-235).
33. Peter Burke, Venezia e Amsterdam. Una storia comparata delle élites del XVII secolo, Ancona-Bologna 1988, p. 25.
34. Id., Scene di vita, p. 38.
35. I registri dei sestieri di S. Croce, Cannaregio, S. Marco e Castello del censimento del 1642 sono in A.S.V., Provveditori alla Sanità, bb. 570, 571; quello del sestiere di Dorsoduro in Venezia, Museo Correr, ms. Donà delle Rose 351; quello del sestiere di S. Polo del 1633 in A.S.V., Provveditori alla Sanità, b. 569.
36. È il concetto di base del classico Lucien Febvre, La vita borghese, in Id., Studi su Riforma e Rinascimento e altri scritti su problemi di metodo e di geografia storica, Torino 1966, pp. 292-318.
37. Ennio Concina, Venezia nell’età moderna. Struttura e funzioni, Venezia 1989, p. 121.
38. Wilfrid Brulez, Marchands flamands à Venise, I, (1568-1605), Bruxelles-Rome 1965, sub nome.
39. Ugo Tucci, La psicologia del mercante veneziano nel Cinquecento, in Id., Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano, Bologna 1981, pp. 43-84.
40. A.S.V., Avogaria di Comun, b. 388, fasc. 43.
41. Ibid., b. 377, fasc. 24.
42. Eva S. Rösch Widmann, I Widmann. Le vicende di una famiglia veneziana dal Cinquecento all’Ottocento, Venezia 1980.
43. E. Concina, Venezia nell’età, p. 121.
44. Ibid., passim.
45. Cf. Donatella Calabi, Il mercato e la città. Piazze, strade, architetture d’Europa in età moderna, Venezia 1993.
46. Vincenzo Coronelli, Guida de’ forestieri per succintamente osservare tutto il più riguardevole nella città di Venetia, Venetia 1697, pp. n.n.
47. E. Concina, Venezia nell’età, p. 50.
48. Diego Zunica, La calamita d’Europa. Attrattiva de’ forestieri, Venetia 1696, p. 72.
49. R. de la Haye, La politique civile, p. 53.
50. Citato in R. Sabbadini, L’acquisto della tradizione, p. 112.
51. Per i criteri con cui si è condotta questa operazione cf. infra.
52. Giuseppe Gullino, Quando il mercante costruì la villa: le proprietà dei Veneziani nella Terraferma, in Storia di Venezia, VI, Dal Rinascimento al Barocco, a cura di Gaetano Cozzi - Paolo Prodi, Roma 1994, p. 910 (pp. 875-924).
53. I registri di cinque sestieri del censimento del 1761 sono in A.S.V., Provveditori alla Sanità, bb. 573-574; quello mancante di S. Marco è stato integrato con informazioni tratte dalle Anagrafi Venete del 1766, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Anagrafi Venete, vol. I.
54. E. Concina, Venezia nell’età, p. 207.
55. I dati per il censimento del 1670 del sestiere di Cannaregio in Venezia, Museo Correr, ms. Donà delle Rose 351.
56. E. Concina, Venezia nell’età, pp. 100-101, 122.
57. Ibid., p. 205.
58. Cf. R. Sabbadini, L’acquisto della tradizione, pp. 141-160.
59. Citato ibid., p. 146.
60. Cf. Paolo Maretto, La casa veneziana nella storia della città dalle origini all’Ottocento, Venezia 1986.
61. Giorgio Gianighian-Paola Pavanini, Dietro i palazzi. Tre secoli di architettura minore a Venezia, 1492-1803, Venezia 1984, pp. 88-91. Sullo stesso edificio cf. Egle R. Trincanato, Venezia minore, Venezia 1948, pp. 325 ss.
62. G. Gianighian - P. Pavanini, Dietro i palazzi, p. 104.
63. E. Concina, Venezia nell’età, p. 205.
64. I dati relativi al patriziato sono tratti da Volker Hunecke, Der venezianische Adel am Ende der Republik 1646-1797. Demographie, Familie, Haushalt, Tübingen 1995, p. 384; sul Nani cf. Piero Del Negro, Giacomo Nani: appunti biografici, «Bollettino del Museo Civico di Padova», 60, 1977, pp. 115-147, e Id., Il patriziato veneziano al calcolatore. Appunti in margine a «Venise au siècle des lumières» di Jean Georgelin, «Rivista Storica Italiana», 93, 1981, pp. 838-848.
65. I dati sui nobili sono tratti da V. Hunecke, Der venezianische Adel, p. 400; i dati sui cittadini sono elaborazioni dai censimenti.
66. Id., Famiglia fraterna e ménage nel patriziato veneziano del sei-settecento, relazione al Convegno internazionale «Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali», Bologna, 6-8 ottobre 1994, in corso di stampa.
67. Daniele Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica, Padova 1954, pp. 172-173.
68. Volker Hunecke, Kindbett oder Kloster. Lebenswege venezianischer Patrizierinnen im 17. und 18. Jahrhundert, in Lebenswege von Frauen im Ancien Régime, a cura di Gisela Bock, «Geschichte und Gesellschaft», 18, 1992, nr. 4, pp. 446-476.
69. Anna Bellavitis, La famiglia «cittadina» veneziana nel XVI secolo: dote e successione. Le leggi e le fonti, «Studi Veneziani», n. ser., 30, 1995, pp. 55-68.
70. Gigi Corazzol, Varietà notarile: scorci di vita economica e sociale, in Storia di Venezia, VI, Dal Rinascimento al Barocco, a cura di Gaetano Cozzi-Paolo Prodi, Roma 1994, p. 789 (pp. 775-791).
71. A. Bellavitis, La famiglia «cittadina».
72. Cf. a proposito Antonio Menniti Ippolito, Fortuna e sfortune di una famiglia veneziana nel Seicento. Gli Ottoboni al tempo dell’aggregazione al patriziato, Venezia 1996.
73. U. Tucci, Carriere popolane, p. 851.
74. Giuseppe Trebbi, La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII, «Annali della Fondazione Luigi Einaudi», 14, 1980, pp. 65-125.
75. Matteo Casini, Realtà e simboli del Cancellier Grande veneziano in età moderna (Secc. XVI-XVII), «Studi Veneziani», n. ser., 22, 1991, pp. 195-251.
76. Si farà implicito riferimento ad A. Zannini, Burocrazia e burocrati, pp. 119-181.
77. Gaetano Cozzi, Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento, Venezia-Roma 1958, pp. 229-283.
78. G. Trebbi, La cancelleria veneta, p. 124.
79. Si farà implicito riferimento ad A. Zannini, Burocrazia e burocrati, pp. 181-246.
80. Cf. Roland Mousnier, Le trafic des offices à Venise, in Id., La plume, la faucille et le marteau. Institutions et Société en France du Moyen Âge à la Revolution, Paris 1970, pp. 387-401.
81. Citato in Id., La vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Paris 19712, p. 7.
82. Si rinvia ad Andrea Zannini, Il sistema di revisione contabile della Serenissima. Istituzioni, personale, procedure (secc. XVI-XVIII), Venezia 1994.
83. Su cui Fabio Besta, Appunti sulla compilazione dei bilanci generali di fatto, in Bilanci generali della repubblica di Venezia, ser. II, III, Bilanci dal 1736 al 1755, Venezia 1903, pp. LXXXII-XC (pp. VII-XCV).
84. Alcuni esemplari percorsi familiari nelle voci del Dizionario Biografico degli Italiani e nelle biografie dei residenti veneziani che accompagnano i volumi in corso d’uscita delle Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli curate dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
85. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 27 (= 7761), cc. 97-103.
86. Pompeo G. Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica, III, Il decadimento, Trieste 19297, p. 65.
87. Cf. Richard Palmer, The Studio of Venice and Its Graduates in the Sixteenth Century, Trieste 1983.
88. Giustiniana Migliardi o’Riordan Colasanti, Le professioni sanitarie, in Difesa della sanità a Venezia, secoli XIII-XIX, Catalogo della mostra documentaria a cura del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e dell’Archivio di Stato di Venezia, Venezia 1979, pp. 80-82.
89. Francesco Bernardi, Prospetto storico-critico dell’Origine, facoltà, diversi stati, progressi, e vicende del Collegio Medico-chirurgico e dell’arte chirurgica in Venezia [...], Venezia 1797, p. 47.
90. Ibid., pp. 33, 46.
91. Nelli-Elena Vanzan Marchini, I mali e i rimedi della Serenissima, Vicenza 1995, p. 164.
92. Giovanni Marangoni, Associazioni di mestiere nella Repubblica Veneta (vittuaria - farmacia - medicina), Venezia 1974, pp. 201-211.
93. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Anagrafi Venete, vol. I.
94. N.-E. Vanzan Marchini, I mali e i rimedi, p. 165.
95. Richard Mackenney, Tradesmen and Traders. The World of the Guilds in Venice and Europe, c. 1250-c. 1650, London-Sidney 1987, pp. 88-89.
96. Gaetano Cozzi, Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII, Torino 1982, pp. 325-326.
97. Id., Giustizia «contaminata». Vicende giudiziarie di nobili ed ebrei nella Venezia del Seicento, Venezia 1996, in partic. pp. 83-84.
98. Id., Repubblica di Venezia, p. 327.
99. V. Coronelli, Guida de’ forestieri, pp. n.n.
100. Citato in R. Sabbadini, L’acquisto della tradizione, pp. 42-43.
101. Leonico Goldioni (Giovanni Nicolò Doglioni), Le cose maravigliose dell’inclita città di Venetia, Venetia 1603, p. 191.
102. Gianni Zennaro, Tra foro e teatro: Goldoni, avvocati, processi e libertini nel secolo diciottesimo, Poggibonsi 1984.
103. Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Anagrafi Venete, vol. I.
104. A. Zannini, Burocrazia e burocrati, p. 103.
105. Maria Pia Pedani Fabris, «Veneta auctoritate notarius». Storia del notariato veneziano (1514-1797), Milano 1996, p. 161.
106. Cf. al riguardo G. Corazzol, Varietà notarile, pp. 778-779.
107. M.P. Pedani Fabris, «Veneta auctoritate notarius», pp. 129-134.
108. È stato osservato ciò anche per le comunità di immigrati dalla Terraferma suddita: Gigi Corazzol, Livelli a Venezia nel 1591, Pisa 1986, p. 77.
109. Richard Lassels, The Voyage of Italy, Paris 1670, p. 403.
110. Cf. Domenico Sella, L’economia, in Storia di Venezia, VI, Dal Rinascimento al Barocco, a cura di Gaetano Cozzi-Paolo Prodi, Roma 1994, pp. 651-711, e il contributo di Luciano Pezzolo in questo volume.
111. Domenico Sella, Commerci e industrie a Venezia nel secolo XVII, Venezia-Roma 1961, p. 72; Massimo Costantini, La regolazione dei dazi marittimi e l’esperienza del «portofranco» a Venezia tra il 1662 e il 1684, in La finanza pubblica in età di crisi, a cura di Antonio Di Vittorio, Bari 1993, p. 83.
112. U. Tucci, La psicologia.
113. Ibid., p. 78.
114. Salvatore Ciriacono, Olio ed ebrei nella repubblica veneta del ’700, Venezia 1975; Ivo Mattozzi, Crisi, stagnazione e mutamento nello Stato veneziano sei-settecentesco: il caso del commercio e della produzione olearia, «Studi Veneziani», n. ser., 4, 1980, pp. 199-276.
115. Distinzioni segrete che corrono tra le Casate Nobili di Venezia, in Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. it. cl. VII. 2226 (= 9205), c. 45r-v.
116. Alexander Francis Cowan, Venezia e Lubecca, 1580-1700, Roma 1990, pp. 101-102.
117. D. Beltrami, Storia della popolazione, p. 219.
118. Fernand Braudel - Pierre Jeannin - Jean Meuvret - Ruggiero Romano, Le declin de Venise au XVIIe siècle, in Aspetti e cause della decadenza economica veneziana nel secolo XVII. Atti del convegno 27 giugno-2 luglio 1957, Venezia, isola di San Giorgio Maggiore, Venezia-Roma 1961, pp. 24-86.
119. U. Tucci, Carriere popolane, p. 825.
120. Richard Tilden Rapp, Real Estate and Rational Investment in Early Modern Venice, «Journal of European Economie History», 8, 1979, pp. 269-290.
121. E.S. Rösch Widmann, I Widmann, passim.
122. Luciano Pezzolo, Sistema di valori e attività economica a Venezia, 1530-1630, in L’impresa. Industria commercio banca secc. XIII-XVIII (XXII settimana di studi, Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Prato 1990), Firenze 1991, pp. 986-988 (pp. 981-988).
123. Sul quale Ugo Tucci, Bontempelli, Bartolomeo, in Dizionario Biografico degli Italiani, XII, Roma 1970, pp. 426-427; R. Mackenney, Tradesmen and Traders, p. 110; G. Corazzol, Varietà notarile, pp. 780-789.
124. A.F. Cowan, Venezia e Lubecca, p. 98.
125. A. Zannini, Burocrazia e burocrati, p. 92. Sui cittadini nei censimenti cf. ora Anna Bellavitis, «Per cittadini metterete...». La stratificazione della società veneziana cinquecentesca tra norma giuridica e riconoscimento sociale, «Quaderni Storici», 89, 1995, pp. 359-383.
126. A. Zannini, Burocrazia e burocrati, pp. 259-265.
127. Cf. Matteo Casini, I gesti del principe. La festa politica a Firenze e Venezia in età rinascimentale, Venezia 1996.
128. A. Livingston, La vita veneziana, p. 275.
129. Ibid., p. 286, il componimento prosegue con i versi riportati nel luogo corrispondente alla n. 28.
130. Ibid., p. 286. Sul Busenello cf. Martino Capucci, Busenello, Giovanni Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, XV, Roma 1972, pp. 512-515.
131. A. Livingston, La vita veneziana, p. 285.
132. Lawrence Stone, Social Mobility in England, 1500-1700, «Past and Present», 25, 1966, pp. 16-55.
133. Federico Chabod, Usi e abusi nell’amministrazione dello Stato di Milano a mezzo il ’500, in AA.VV., Studi storici in onore di Gioacchino Volpe, I, Firenze 1958, pp. 93-194.
134. Gerhard Schneider, Il libertino. Per una storia sociale della cultura borghese nel XVI e XVII secolo, Bologna 1974.
135. Norbert Elias, La società di corte, Bologna 1980, p. 370.