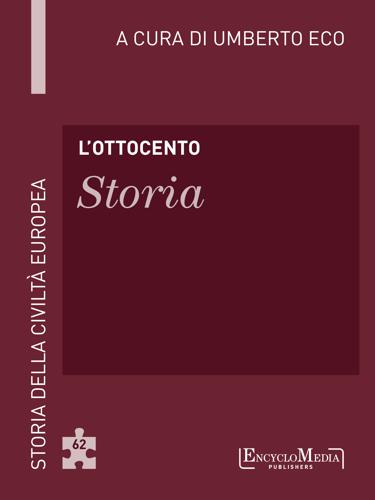La Spagna prima e dopo Franco
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
All’incirca tra la metà del XIX secolo e fino agli anni Settanta del Novecento, il pendolo della politica spagnola oscilla tra restaurazione liberaldemocratica, sempre però condizionata da un modello costituzionale puro che garantisce il ruolo centrale della monarchia, e regimi di tipo bonapartista e, più tardi, fascista, fondati sulla gerarchia militare o sul partito unico (la Falange). Nel novembre del 1975 muore Franco, l’ultimo dittatore fascista dell’Europa del Novecento, e, nei termini della legge del 1969, si apre la successione al vertice dello Stato per Juan Carlos di Borbone. Il sovrano prende la guida dello Stato e diviene protagonista di una complessa azione politica che nel 1976 riporta in Spagna la democrazia. L’adesione all’Unione Europea, la forte accelerazione della modernizzazione civile ed economica, rendono la nuova Spagna una delle protagoniste della vita europea contemporanea.
Crollo dell’impero coloniale e crisi economiche e sociali: la Spagna all’inizio del secolo
Come conseguenza della perdita dell’impero coloniale americano, la Spagna non riesce a sviluppare i fermenti costituzionali e liberali che, molto prematuramente rispetto al resto d’Europa, ha visto nascere al suo interno. All’incirca tra la metà del Diciannovesimo secolo e fino agli anni Settanta del Novecento, il pendolo della politica spagnola oscilla tra restaurazione liberaldemocratica, sempre però condizionata da un modello costituzionale puro che garantisce il ruolo centrale della monarchia, e regimi di tipo bonapartista e, più tardi, fascista, fondati sulla gerarchia militare o sul partito unico (la Falange). All’avvio del Novecento, l’economia spagnola presenta un carattere dualistico. Da un lato un settore tradizionale, con un’ampia presenza di agricoltura di sussistenza legata alla piccola e piccolissima proprietà della terra; un latifondo nobiliare in cui sono presenti patrimoni vastissimi come quelli dei “grandi di Spagna” (l’alta nobiltà che per secoli aveva gestito l’enorme impero spagnolo); un patrimonio ecclesiastico che, sia pure considerevolmente ridotto rispetto ai secoli precedenti, costituisce tuttavia una forza economica ancora cospicua. All’interno di questo settore tradizionale le tensioni sociali si sono fatte assai forti, tanto che nella seconda metà dell’Ottocento vi si sviluppa l’anarchismo. Dall’altro lato un settore moderno, con alcuni campi divenuti vitali per l’economia spagnola: in primo luogo quello legato, in Andalusia, alla coltivazione e produzione di vini e colture pregiate, che lavorano per il mercato internazionale; connesso all’esistenza di un impero coloniale, che fornisce materie prime a buon mercato, si è inoltre sviluppato in Catalogna – la regione di Barcellona – un’importante attività industriale, mentre i maggiori centri urbani costituiscono ormai aree civili di notevole vitalità. Sul piano internazionale, è indubbio che la Spagna goda ancora, tra le potenze europee, di un cospicuo prestigio, come testimonia l’avvio della reggenza diretta di Alfonso XIII. Nei primi anni del suo regno viene infatti siglato l’accordo per il Marocco (1904), a cui seguono la conferenza di Algesiras (1906) e gli accordi di delimitazione del 1912 sempre con la Francia. La Spagna, grazie a questi accordi, stabilisce il suo protettorato sulla fascia costiera settentrionale del Marocco. Il punto più delicato per la vita interna spagnola è l’assenza di un serio sforzo di modernizzazione dello Stato e della vita politica. Lo ostacola, la recrudescenza del regionalismo catalano e dell’anarchismo, che ha una particolare eco anche internazionale con la “settimana tragica” di Barcellona, nel luglio del 1909, e la vicenda dell’esecuzione dell’anarchico Francisco Ferrer. D’altra parte, il re deve affrontare una serie di minacce alla sua vita (1905-1906) e a quella dei suoi ministri (assassinio del ministro José Canalejas, nel 1912), che danno scarso peso, rispetto alle spinte in senso contrario, al tentativo di re Alfonso di assecondare la transizione verso un regime parlamentare. Nonostante la Spagna si proclami neutrale nella prima guerra mondiale, nel corso del 1917 viene attraversata anch’essa da una grave crisi economica e sociale. La politica perseguita dal re non porta i risultati sperati neppure in politica estera, poiché proprio nel recente acquisto marocchino si assiste alla vittoria dei ribelli di Abd el-Krin, nel 1921. Sono questi insuccessi a risospingere il pendolo della politica spagnola verso soluzioni autoritarie. Il sovrano accetta il colpo di Stato del generale Miguel Primo de Rivera (1870-1930) nel settembre del 1923, che scioglie il parlamento e lo sostituisce con un direttorio formato da militari e da tecnici. Non a torto, perciò, lo storico napoletano Giuseppe Galasso sostiene che il caso spagnolo risulta essere emblematico: lo Stato non è interessato dalle tensioni terribili della guerra e quindi si può ritenere poco toccato da quelle del dopoguerra. Come per altri Paesi europei, anche per esso si rivelano esplosivi, però, i problemi tradizionali: regionalismi, scarso sviluppo economico, questione contadina gravissima, difficoltà nelle residue colonie nord-africane, estremismi di destra e di sinistra, pressioni clericali, forza e influenza dei militari, tradizione anarchica, debole modernizzazione delle strutture pubbliche. Ecco perché la svolta autoritaria di de Rivera incontra resistenze minori di quanto si potrebbe pensare. L’attività di governo del generale è notevole: pacifica il Marocco, ristabilisce il credito nazionale, migliora le infrastrutture attraverso la realizzazione di una serie di opere pubbliche, cerca di attuare una modernizzazione economica e finanziaria del Paese, anche se trascura la questione operaia e si ferma al limite della riforma agraria. Non riesce però ad assicurare al nuovo regime né l’appoggio delle forze che se ne sentono escluse, né, in particolare, quello degli intellettuali, e neppure quello dei militari, insoddisfatti di una soluzione autoritaria che a essi appare parziale e incoerente. Una nuova crisi finanziaria sopraggiunge a peggiorare la situazione. Le opposizioni alla sua politica e il fallimento di tutti i suoi sforzi spingono il dittatore a lasciare il potere, nel gennaio del 1930, mentre anche Alfonso XIII, profondamente coinvolto nell’esperienza autoritaria di de Rivera, è costretto ad allontanarsi dalla Spagna dopo la vittoria elettorale dei partiti repubblicano e socialista nel 1931. La formazione di un governo di sinistra repubblicano-socialista, presieduto da Manuel Azana produce il tentativo di introdurre riforme di tipo liberaldemocratico che rafforzino la modernizzazione del Paese. Le difficoltà per il governo Azana nascono sia per la resistenza dei ceti colpiti da quei provvedimenti, sia per l’insoddisfazione dei partiti rivoluzionari che li ritengono insufficienti.
La vittoria del centrodestra: la nascita di uno Stato sul modello fascista
Alla fine di novembre del 1933, le elezioni politiche segnano la vittoria dei partiti di centrodestra, i quali provvedono immediatamente a vanificare buona parte delle riforme del governo Azana. Alla reazione dei partiti di estrema sinistra, che nella regione delle Asturie si trasforma in una vera e propria rivolta dei minatori anarchici, il governo risponde con una violenta repressione che produce tremila morti. In una situazione così radicalizzata interviene, agli inizi del 1936, la nuova vittoria elettorale del fronte delle sinistre, di cui per la prima volta fanno parte anche comunisti e anarchici. La guida del governo tocca al socialista Francisco Largo Caballero (1869-1946). Si rinnovano immediatamente le violenze degli estremisti. In particolare viene assassinato il fondatore della Falange spagnola de Rivera, e l’episodio serve a fine luglio alle truppe del generale Francisco Franco, insediate in Marocco, per un nuovo “pronunciamento” dell’esercito. L’esercito dei rivoltosi, riesce a passare nel continente, grazie anche all’assistenza militare dell’Italia e della Germania, mentre il governo repubblicano mobilita la resistenza popolare e i quadri militari rimastigli fedeli. Inizia così la guerra civile. A sostegno del governo repubblicano scende in campo l’Unione Sovietica che invia aiuti militari, sia pure incomparabilmente minori di quelli offerti dai governi italiano e tedesco. Si formano brigate internazionali di democratici, socialisti, comunisti e anarchici che combattono per la repubblica. Mentre la conduzione della guerra da parte dei franchisti si dimostra sufficientemente coerente, nella parte repubblicana la guerra civile produce una forte divaricazione tra democratici e comunisti da una parte, e anarchici e trotzkijsti dall’altra. Intanto i franchisti, che hanno dato una vernice fascista al loro movimento, sono riusciti a riunire le loro forze dislocate a ovest e a sud del Paese, minacciando Madrid, difesa dai repubblicani e dalle brigate internazionali. Dopo un’ultima offensiva degli antifascisti, che non ha esito, la guerra può considerarsi perduta per i repubblicani. Nel marzo del 1939 il conflitto si conclude con la vittoria dei falangisti, che creano uno Stato sul modello fascista. Solo alla Chiesa riesce di esercitare una certa influenza, del resto entrambe le istituzioni (Chiesa e Falange) agiscono in sintonia: Franco riconosce il cattolicesimo come religione di Stato e restituisce alla Chiesa tutti i suoi privilegi, per cui rilancia il culto, crea cappellanie nelle scuole, nei sindacati, nell’esercito. Sul piano organizzativo statale, Franco crea una struttura statale accentrata e un regime imperniato sul sistema del partito unico, del quale egli viene proclamato caudillo, ossia duce, fondendo in una Falange nuova, detta anche Movimiento Nacional, tutti i partiti. Con la Carta del lavoro (Fuero del Trabajo) del 9 marzo 1938 si istituisce il sindacato unico. Il conflitto mondiale frena le realizzazioni sociali ed economiche e, d’altra parte, l’immiserimento legato alla guerra consente al regime di soffocare con maggiore facilità le opposizioni. In effetti, si intensifica la repressione, che già dopo la vittoria dei falangisti era stata durissima, con migliaia e migliaia di fucilazioni al mese e circa 250 mila persone in media ristrette in prigione o in campo di concentramento: fino al 1942 si calcola la cifra di circa 2 milioni di persone colpite dai provvedimenti repressivi.
In politica estera, alla vigilia del conflitto mondiale, il generale Franco proclama la neutralità spagnola e tardivamente e con riluttanza aderisce al patto Anticomintern. Nei confronti della Germania e dell’Italia dichiara la sua amicizia, ma usa tutta la sua abilità per sfuggire a qualunque impegno irreversibile a fianco delle due potenze dell’Asse, per cui si astiene dal partecipare alla seconda guerra mondiale, limitandosi a inviare una divisione di volontari sul fronte russo (Divisiòn azul). Nel corso del 1942 la sua politica estera cambia perché comincia a dubitare della vittoria tedesca, dubbi confermati dallo sbarco degli Angloamericani nell’Africa settentrionale. Già nel suo colloquio a Siviglia con António de Oliveira Salazar (febbraio del 1942) il caudillo riafferma la neutralità iberica e rassicura gli Inglesi. La Divisiòn azul viene ritirata dalla Russia e perfino sul piano interno Franco inaugura una modesta liberalizzazione del suo regime, per cui crea le corti consultive (le Cortes Espanolas) nel marzo del 1942, i cui membri (procuradores), nominati dal governo o eletti dalle varie corporazioni economiche o culturali, compiono una notevole azione legislativa. Nel luglio del 1945 proclama il fuero de los Espanoles, che definisce i diritti garantiti ai cittadini. Ma questa politica di riavvicinamento all’Occidente anglosassone non impedisce che il Paese risulti del tutto isolato all’indomani della conclusione del secondo conflitto mondiale che vede vittoriose le potenze antifasciste. Franco si trova bandito dal mondo democratico. Nel dicembre del 1946 l’ONU chiede agli Stati membri di richiamare gli ambasciatori da Madrid. Gli Stati Uniti rifiutano alla Spagna il beneficio del piano Marshall, di conseguenza le difficoltà economiche spagnole si aggravano, nonostante, sul piano politico interno, l’ostracismo delle democrazie contro il regime franchista sortisca un effetto imprevisto e susciti negli spagnoli un forte sentimento nazionale, così da spingerli a unirsi al caudillo. Questi con l’intento di garantire al suo regime la durata, nell’aprile del 1947 pubblica una “legge di successione” che definisce la Spagna “Stato cattolico, sociale e rappresentativo”, somigliante a una monarchia di cui Franco diviene il reggente a vita.
Il lento disgelo: la fine dell’isolamento e il ritorno della democrazia
Sia la reazione spagnola che non sembra andare nella direzione sperata dall’ONU, sia la divisione sopravvenuta tra le potenze antifasciste in due blocchi contrapposti e l’avvio della guerra fredda, portano l’Occidente a una progressiva attenuazione dell’isolamento franchista e alla ripresa delle relazioni diplomatiche con la Spagna. Successivamente essa entra nella FAO, novembre del 1950, poi nell’UNESCO (1952) e infine viene ammessa a far parte dell’ONU, nel dicembre del 1955. Una serie di accordi bilaterali nel settembre del 1953 consentono alla Spagna di entrare nel sistema militare atlantico.
L’altra faccia del disgelo del mondo occidentale verso la Spagna franchista è quella economica. Gli Stati Uniti concedono a Franco un aiuto finanziario molto importante che, insieme alla crescita rapida e notevole del turismo, consentono al Paese, nel corso degli anni Sessanta, un considerevole sviluppo industriale. Nel 1965 il reddito nazionale aumenta dell’8,2 percento, la più alta percentuale registrata in quell’anno in Europa. L’attività agricola, invece, non ha lo stesso decorso e rimane in una situazione stagnante. Il processo di modernizzazione delle strutture economiche e sociali, che interessa la Spagna a partire dal 1950 ha inevitabili ricadute sul piano politico. La Falange si avvia verso il declino, perdendo la funzione di guida e di controllo del regime (decreto del 1957). Al contrario, l’Azione Cattolica, in seguito al concordato tra lo Stato e la Chiesa del 1953, assume un posto di rilievo e allo stesso modo l’Opus Dei (un’organizzazione religiosa e politica fondata nel 1928 e dichiarata istituto secolare nel 1947) che favorisce l’intervento della Chiesa nel controllo delle classi dirigenti. Anche l’opposizione politica, dispersa dopo la guerra civile, riprende a riorganizzarsi sia clandestinamente sia in forme paralegali. Queste ultime riguardano soprattutto gli ambienti liberali e carlisti, i secondi presenti maggiormente nella Navarra, nelle Province Basche e nella Catalogna. Entrambi i gruppi politici, da un’opposizione basata sul problema successorio passano alla richiesta della restaurazione delle libertà democratiche e sindacali, a fianco dei socialisti e dei democratici cristiani (1966). Il regime si dimostra, invece assai meno tollerante verso anarchici e comunisti e anche l’opposizione operaia e sindacale viene fronteggiata con fermezza. In conseguenza di uno sciopero di 200 mila minatori nelle Asturie il regime decreta lo stato di emergenza. Tuttavia dal 1965 si moltiplicano nelle aziende le commissioni operaie, che però non sono riconosciute ufficialmente. Un altro fenomeno che evidenzia l’evoluzione politica e sociale è l’appoggio dato alle rivendicazioni sociali, che proviene da esponenti della Chiesa cattolica, in cui hanno fatto breccia lo spirito del Concilio Vaticano II e del papato di Giovanni XXIII, e dal mondo delle università.
Tali novità si riflettono negli atteggiamenti del governo che nel 1966 avvia una politica di tolleranza religiosa e, dopo aver modificato un articolo della Costituzione, concede libertà di culto a tutte le altre confessioni non cattoliche. Contemporaneamente si accentuano le aperture del regime verso forme di liberalizzazione: si allenta il controllo sulla stampa; le discussioni politiche si svolgono apertamente; la riforma costituzionale del novembre del 1966 stabilisce la divisione dei poteri fra il capo dello Stato, re o reggente, e il capo del governo; l’allargamento della composizione delle Cortes rende possibile l’elezione a suffragio universale di cento membri. Nel luglio del 1969 proprio le Cortes, riunite in sessione plenaria, approvano la legge che stabilisce, nel caso che Franco cessi di ricoprire la carica di capo dello Stato, che Juan Carlos di Borbone (1938-) assuma il titolo di principe di Spagna e futuro sovrano del Paese. Nell’ottobre successivo viene costituito un ministero, che vede aumentato il numero dei tecnocrati dell’Opus Dei a svantaggio dei ministri espressione della Falange. Ministro degli Esteri diventa Gregorio Lopez Bravo, che ammorbidisce i rapporti con la Gran Bretagna, resisi tesi per la questione di Gibilterra alla quale nel 1966 era stato posto un blocco come protesta contro l’esistenza su suolo spagnolo di una enclave britannica. Bravo inoltre tenta di avvicinare la Spagna al MEC e di migliorare le relazioni con i Paesi comunisti.
Né va sottovalutato come la Spagna franchista, tra il 1956 (Marocco spagnolo), il 1964 (Ifni), il 1968 (Guinea equatoriale) e il 1975 (Sahara occidentale) si liberi, sia pure in maniera contraddittoria e senza lasciare tracce significative, dei possedimenti coloniali in Africa. L’8 giugno 1973 Franco palesa il possibile ritiro imminente dalla vita politica, incaricando come primo ministro l’ammiraglio Luis Carrero Blanco (1903-1973), che però, nel dicembre dello stesso anno, viene ucciso dagli autonomisti baschi in un attentato. Al suo posto viene designato Carlos Arias Navarro (1908-1989), considerato un duro del regime. Ma il processo di trasformazione indotto dall’allontanamento di Franco dal potere riprende con vigore proprio per merito di Navarro, che il 12 aprile 1974 annuncia una politica di liberalizzazione che prevede: l’elezione dei sindaci e dei responsabili municipali; l’elezione di una parte maggiore dei membri delle Cortes; l’ampliamento dei diritti concessi ai lavoratori nei sindacati controllati dallo Stato; la libertà di formare associazioni politiche.
Nel novembre del 1975 muore Franco e, nei termini della legge del 1969, si apre la successione al vertice dello Stato per Juan Carlos di Borbone. Il sovrano prende la guida dello Stato e diviene protagonista di una complessa azione politica che nel 1976 riporta in Spagna la democrazia e, l’anno successivo, in un clima di riconciliazione nazionale, designa alla guida del governo un tecnocrate del Movimiento Adolfo Suárez (1932-2014), dopo le dimissioni di Arias Navarro. Il primo ministro fonda a questo punto un nuovo partito: l’Unione del Centro Democratico. Con il patto di La Monclea, dell’ottobre del 1977, Suarez, che ha vinto le prime elezioni libere del dopo Franco, sottoscrive un compromesso con tutte le forze parlamentari, compresi i comunisti, per frenare la crisi economica: questa azione politica riporta dei buoni risultati, infatti il tasso d’inflazione diminuisce dal 26 percento circa al 15 percento in un anno. Il regime democratico si completa con l’emanazione della Costituzione, il 28 dicembre 1978, dopo che la stessa viene approvata con il 66 percento dei voti degli elettori. Il re diviene formalmente il capo dello Stato e la corona di Spagna diviene ereditaria. La Costituzione spagnola prevede il potere esecutivo esercitato dal governo, il potere legislativo affidato alle Cortes, formate dal Congresso dei deputati (da 300 a 400 membri) e dal Senato (4 senatori per provincia, più i senatori delle comunità autonome e dei possedimenti spagnoli) entrambi eletti a suffragio universale. Il governo è responsabile davanti al Congresso dei deputati, che concede la fiducia all’esecutivo su proposta del re. La Costituzione prevede anche la separazione dello Stato dalla Chiesa cattolica, la quale rinuncia ai privilegi che le aveva accordato il concordato del 1953. Se nelle elezioni del marzo del 1979 Adolfo Suarez vede confermata la sua guida del governo, consolidando le posizioni del partito, nelle comunali dell’aprile successivo le sinistre vincono nelle grandi città. Ovviamente, i problemi che hanno portato alla dissoluzione del falangismo dopo la morte del caudillo, non sono dissolti dal ritorno alla democrazia, in particolare la minaccia sempre incombente del terrorismo basco, e quella più recente della recessione economica, causata dalla crescita della disoccupazione in particolare nel corso del 1980. La crisi assume una dimensione politica in seguito a dissensi interni al partito di maggioranza, che portano Suarez a dimettersi nel gennaio del 1981 e a staccarsi dal suo partito per fondarne un altro qualche tempo dopo, il Centro Democratico Sociale. Un mese dopo le dimissioni del capo del governo, le Cortes sono occupate da un gruppo di militari capeggiati dal colonnello Antonio Tejero Molina (1932-), ma il tentativo di colpo di Stato viene prontamente represso grazie all’intervento del re Juan Carlos. Il nuovo governo guidato da Leopoldo Calvo Sotelo (1929-), dell’Unione del Centro Democratico, approva la legge sul divorzio e l’entrata della Spagna nella NATO il 30 maggio 1982; poi il re, su indicazione del capo del governo, scioglie le Cortes e il Partito Socialista Operaio (PSOE) vince le elezioni del 28 ottobre 1982, sulla base di un programma moderato. Alla guida del nuovo governo è chiamato il leader socialista Felipe Gonzáles che deve affrontare una difficile situazione economica, con un quinto della popolazione disoccupata e l’inflazione superiore al 10 percento. Il 1° gennaio 1986 la Spagna entra nella CEE e il 22 giugno dello stesso anno i socialisti, pur con una leggera flessione (dal 46 percento al 44 percento), vincono le elezioni, assicurandosi la maggioranza assoluta dei seggi in entrambe le Camere. Le scelte compiute dalla giovane democrazia spagnola si dimostrano vincenti. Tra il 1986 e il 1990 la Spagna è protagonista di una notevole crescita economica, realizzando il più alto tasso di sviluppo fra i paesi della CEE.
Nel corso del 1987 il clima sociale conosce un certo deterioramento a causa di una nuova serie di attentati terroristici dell’ETA e per le proteste degli studenti che si battono per la scuola pubblica gratuita. Alla fine dell’anno successivo, uno sciopero generale, indetto dalla centrale sindacale socialista (UGT), paralizza il Paese. Alle elezioni europee del 1989, nonostante le difficoltà, i socialisti raggiungono il 40 percento dei voti e, sulla scia del buon risultato elettorale, Gonzáles chiede e ottiene elezioni anticipate per l’ottobre successivo, che confermano ai socialisti la maggioranza in parlamento. Ma che si sia aperta una fase nuova nella vita politica spagnola emerge dai risultati delle elezioni del 1991, poiché i socialisti perdono il controllo del Comune di Madrid e di quello di Siviglia. D’altra parte, la recessione smorza l’euforia nel Paese, la peseta, entrata nello SME nel giugno del 1989, viene svalutata a più riprese e il tasso di disoccupazione nel 1993 tocca il 22 percento.
Non senza legittimo orgoglio il Paese si mobilita nei preparativi per l’Esposizione Universale di Siviglia, dal 20 aprile al 12 ottobre 1992, in occasione delle celebrazioni del 500° anniversario della scoperta dell’America, si istituzionalizzano i vertici ibero-americani che legano la Spagna ai Paesi dell’America Latina, ricalcati su quelli del Commonwealth britannico. Il Paese si prepara all’avvenimento costruendo una serie di grandi opere infrastrutturali, in particolare nel sud (un nuovo aeroporto; il primo treno spagnolo ad alta velocità tra Siviglia e Madrid; il potenziamento della rete autostradale). Sempre nel 1992 le Olimpiadi di Barcellona contribuiscono a consacrare il ruolo della Catalogna nell’economia del Paese. Anche Madrid, che nello stesso anno viene designata capitale culturale europea, acquisisce un nuovo prestigio. Il governo da parte sua, viene coinvolto in una serie di scandali, che interessano alti dirigenti del Partito Socialista e ne ledono la credibilità. Gonzáles ottiene ancora una volta lo scioglimento delle Camere e l’anticipo delle elezioni legislative, presentandosi al Paese con un programma elettorale che riconosce la massima priorità alla lotta contro la disoccupazione e alla corruzione. Nonostante la nuova destra del Partito Popolare, guidata da José Maria Aznar (1953-), ottenga il 34,8 percento dei consensi, per la quarta volta consecutiva, nell’aprile del 1993, il PSOE conquista la maggioranza, che questa volta però non è assoluta in parlamento, per cui Gonzáles è costretto a chiedere l’appoggio parlamentare degli autonomisti baschi e catalani, che tuttavia non entrano nell’esecutivo. Il condizionamento sulla politica governativa non tarda a manifestarsi e assume aspetti imprevedibili, come emerge da un nuovo scandalo che coinvolge il PSOE nel dicembre del 1994: alcuni membri dei Gruppi Antiterrorismo di Liberazione (GAL), un movimento clandestino nato per contrastare l’ETA, considerato responsabile di almeno 27 omicidi di militanti baschi, tra il 1983 e il 1987, dichiarano di avere ricevuto direttive da esponenti socialisti, membri all’epoca del governo. Nell’agosto dell’anno successivo nazionalisti catalani ritirano il loro appoggio a Gonzáles, che non avendo la maggioranza non riesce a far approvare il bilancio. Le elezioni legislative anticipate del marzo del 1996 assegnano la vittoria al Partito Popolare. Il leader Aznar non potendo contare sulla maggioranza assoluta è costretto a stipulare un’alleanza con i nazionalisti catalani, successivamente estesa ai nazionalisti baschi moderati del Partito Nazionalista Basco (PNV) e alla Coalizione delle Canarie, sancita da un accordo che rafforza i poteri delle regioni autonome. L’ETA risponde al rafforzamento dell’autonomismo delle regioni storiche spagnole sferrando un ennesimo attacco terroristico, ma questa volta la popolazione, anche delle regioni che i separatisti pretendono di rappresentare, scende in piazza a protestare. Nel settembre del 1998, l’ETA annuncia una tregua “unilaterale e illimitata”, che offre la possibilità al governo Aznar di aprire negoziati con l’organizzazione. La tregua viene proclamata qualche tempo dopo l’emissione della sentenza sui GAL, e procura un notevole e insperato prestigio al governo, anche se a poco più di un anno di distanza l’ETA annuncia e realizza la ripresa della lotta armata. Contemporaneamente Aznar conferma la scelta europeista del suo governo e nel maggio del 1998 la Spagna fa il suo ingresso nell’area dell’euro, mettendo fine al ritardo del Paese nella partecipazione alla costruzione europea e testimoniando i buoni risultati ottenuti anche sul piano economico. Il Partito Popolare esce perciò vittorioso dalle consultazioni elettorali del marzo del 2000, con la conquista del 44 percento dei voti e della maggioranza assoluta dei seggi al Parlamento nazionale.
In politica estera Aznar, in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, fa della lotta al terrorismo uno dei punti cardine della presidenza spagnola all’UE, nel primo semestre del 2002. L’appoggio agli Stati Uniti e alla lotta al terrorismo non viene meno anche di fronte alla decisione del presidente Bush di rovesciare il regime di Saddam Hussein. Assieme all’Inghilterra di Blair, la Spagna sostiene l’intervento armato statunitense in Iraq, in opposizione agli altri partner europei, Francia e Germania in primo luogo, contrari alla guerra. L’invio di 1300 uomini costituisce il contributo spagnolo alla seconda guerra occidentale contro Saddam, nonostante l’opinione pubblica nazionale sia fortemente schierata contro la guerra. Alle elezioni municipali parziali del maggio del 2003 il Partito Socialista ottiene una vittoria, seppur risicata, sul Partito Popolare in termini di consenso, ma sono le elezioni politiche, previste per il marzo del 2004, a divenire l’appuntamento più importante dello svolgimento politico spagnolo. Non vi è dubbio che il contenzioso tra popolari di Aznar e socialisti sia cospicuo, sia sul piano della politica interna che internazionale e tuttavia il credito politico del capo di governo spagnolo è intatto e gli osservatori, oltre che i sondaggi preelettorali, sono generalmente a favore di Aznar. L’11 marzo 2004, una serie di esplosioni su convogli ferroviari in arrivo alle stazioni madrilene, in particolare ad Atocha, creano il caos nella capitale spagnola e producono 192 morti e migliaia di feriti. È il più grave attentato verificatosi nell’Europa del secondo dopoguerra. Il governo Aznar compie in quel drammatico frangente alcuni errori che si dimostrano fatali. Indica immediatamente nell’ETA il responsabile della strage, nonostante questa organizzazione si sia dichiarata estranea alla vicenda e analisti governativi abbiano indicato l’evidente diversità delle modalità stragiste rispetto alle tradizioni terroristiche basche. Emergerà poi la responsabilità del terrorismo islamico di Al Qaeda. In tre giorni si verifica un mutamento profondo degli orientamenti dell’elettorato spagnolo, che nelle elezioni del 15 marzo affida il 43 percento del proprio consenso e la maggioranza assoluta in parlamento al PSOE di José Luis Rodriguez Zapatero (1960-), che diventa il nuovo primo ministro. Tra i suoi atti iniziali, l’impegno, da lungo tempo inserito nel programma del partito, per il ritiro delle truppe spagnole dall’Iraq. A seguire, l’avvio di un programma di riforme sul piano dei diritti civili che vedono in primo piano la scelta di legalizzare i matrimoni gay, divenuta legge nel luglio del 2005, che crea una frattura tra lo Stato e la Chiesa cattolica, i cui vertici e le organizzazioni di base manifestano netto dissenso con le scelte legislative socialiste. Sul piano europeo, il governo Zapatero supera le perplessità del precedente governo Aznar nei confronti del progetto di costituzione europea e, dopo il ritiro delle truppe spagnole dall’Iraq, si riavvicina alle opzioni più o meno velatamente antiamericane di Francia e Germania.