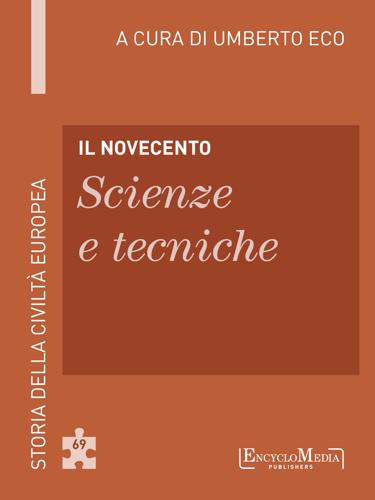La teoria del legame chimico
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Lo sviluppo della teoria del legame chimico nel corso del Novecento è legata a due scoperte fondamentali: l’elettrone e la meccanica quantistica. Con l’affermazione della teoria elettronica del legame chimico, le reazioni furono progressivamente interpretate come la rottura o la costituzione di unioni provocate dal trasferimento di elettroni. Protagonista di questa rivoluzione è Linus Pauling, che definisce la natura dei legami chimici forti e deboli e spiega il legame covalente e quello ionico.
Una ricerca a cavallo di due secoli
Le teorie novecentesche del legame chimico affondano le loro radici nella seconda metà del XIX secolo e, in particolare, nel contesto che vide la nascita della teoria della valenza. Tale teoria formulata da Hermann Kolbe ed Edward Frankland, assegna a ciascun atomo una certa valenza, esprimibile con un numero definito, che rappresenta la capacità di combinarsi con gli altri atomi. Ad esempio, un atomo di antimonio, di azoto e di fosforo si combinano sempre con tre o cinque radicali organici, mentre uno di mercurio, di zinco e di ossigeno con due. La teoria della valenza dimostra, in sostanza, che il potere di combinazione di un atomo è indipendente dal carattere degli atomi che si uniscono. Archibald Scott Couper concepisce un sistema di visualizzazione bidimensionale delle molecole e delle loro valenze, evidenziando con un semplice tratto i legami esistenti fra gli atomi. Nel 1861, il chimico russo Aleksandr Michajlovic Butlerov introduce quindi il termine struttura per indicare questo nuovo modo di rappresentazione. Friedrich August Kekulé von Stradonitz sintetizza gli sviluppi di queste ricerche, unendo i dati sulle valenze degli elementi con le nuove concezioni sulla struttura delle molecole organiche. Kekulé propone il valore 4 per indicare la valenza del carbonio e, nel 1865, scrive la formula del benzene, caratterizzata da sei atomi di carbonio legati fra loro in modo da formare un anello a configurazione esagonale (caratterizzante tutti gli idrocarburi) con legami doppi e singoli alternati; tale configurazione sarà alla base di fondamentali sintesi organiche nel settore dei farmaci, dei coloranti, delle materie plastiche e degli esplosivi. Kekulé definisce la chimica organica come la chimica dei composti del carbonio.
Nel 1874 il chimico olandese Jacobus Hendricus van t’Hoff (1852-1911) studia la questione delle valenze nel carbonio e sostiene che i quattro legami dell’atomo di tale elemento si dispongono nello spazio tridimensionale verso i vertici di un tetraedro regolare, il cui centro è rappresentato dallo stesso atomo di carbonio. In questo caso, i legami dell’atomo di carbonio sono disposti in modo simmetrico intorno all’atomo. Se invece le valenze vengono saturate da quattro gruppi differenti si introduce un’asimmetria. Dunque è alla presenza di un atomo di carbonio asimmetrico che va attribuita la diversità di proprietà ottiche riscontrata, a suo tempo, da Jean-Baptiste Biot e da Louis Pasteur. Il chimico francese Joseph-Achille Le Bel formula contemporaneamente una teoria analoga a quella di van t’Hoff.
La scoperta dell’elettrone e le reazioni chimiche
La teoria della valenza conosce uno sviluppo fondamentale soltanto nei primi decenni del Novecento, successivamente alla scoperta dell’elettrone. Questa scoperta, a sua volta, è strettamente legata a quella dell’osservazione del comportamento dei gas rarefatti in presenza di scariche elettriche, scariche che producono radiazioni luminescenti (di colore blu scuro) intorno al catodo. Nel 1869 Johann Wilhelm Hittorf giunge alla conclusione che dal catodo vengono emessi raggi di natura ignota che si propagano in linea retta. Nel 1871 Cromwell Fletwood Varley, sulla base di un’interpretazione corpuscolare della materia, sostiene che la luminescenza è dovuta a particelle cariche negativamente. Nel 1876 Eugen Goldstein attribuisce a tale radiazione il nome di raggi catodici. Non molto tempo dopo, William Crookes , cercando di fornire un’interpretazione del fenomeno nell’ambito della teoria cinetica, ipotizza che i raggi catodici possano essere dovuti alle molecole del gas che nell’urto con il catodo acquistano una carica negativa. Il dibattito si protrae fino al 1895, quando le esperienze di Jean-Baptiste Perrin dimostrano la natura corpuscolare dei raggi catodici.
Nel 1897 il fisico e matematico inglese Joseph John Thomson scopre la possibilità di deflettere i raggi catodici grazie all’azione di un campo elettrico. Valutando l’orientamento della deviazione, Thomson riesce a dimostrare che tale radiazione consiste di particelle cariche negativamente. Egli chiama tali particelle elettroni, utilizzando il nome che l’irlandese George Johnstone Stoney aveva proposto, nel 1891, per designare l’unità fondamentale della carica elettrica. Grazie all’intensità della deviazione, Thomson è in grado anche di calcolare il rapporto tra la massa e la carica elettrica delle particelle costituenti i raggi catodici. La massa dell’elettrone risulta circa 1600 volte più piccola della massa dell’atomo di idrogeno.
Non molto tempo dopo la scoperta di Thomson, il chimico tedesco Wilhelm Heinrich Abegg inizia a ipotizzare che le reazioni chimiche possano essere interpretate come il risultato del trasferimento di elettroni da un atomo all’altro. Nel 1916 il chimico americano Gilbert Newton Lewis , considerando la disposizione degli elettroni negli atomi, osserva che tali disposizioni sembrano particolarmente stabili quando il livello esterno ne contiene otto (oppure due, nel caso speciale dell’elio). Egli riesce così a sviluppare il concetto del legame di coppia, elaborato in maniera indipendente anche da un suo connazionale, Irving Langmuir . Essi ipotizzano, ad esempio, che nella molecola del cloro (Cl2) ciascun atomo metta in comune un elettrone che va a completare la configurazione del loro livello esterno, dotato di sette elettroni. Le formule elettroniche vanno così ad affiancarsi, da questo momento in poi, alle formule di struttura. Nella costruzione del suo modello relativo al legame chimico, Lewis non fa tuttavia ricorso alla teoria dei quanti.
Nel 1927 Walter Heinrich Heitler e Fritz Wolfgang London sostengono la possibilità che il legame chimico dipenda direttamente dai principi della meccanica quantistica. I loro studi, pubblicati sulla rivista “Zeitschrift für Physik”, si concentrano comunque sul caso più semplice possibile, quello della molecola di idrogeno. Heitler e London sono stati allievi di Erwin Schrödinger , il quale, nel 1926, tenta una teoria (meccanica ondulatoria), che riesca a spiegare i fenomeni microscopici all’interno di una visione deterministica della realtà. Schrödinger cerca così di descrivere un’equazione di propagazione delle onde, basandosi sui metodi matematici tradizionali impiegati nell’ottica e nella meccanica razionale classica.
Nel 1933 Huber Maxwell James e Albert Sprague Coolidge compiono un sensibile passo avanti nella direzione aperta da Heitler e London, riuscendo a calcolare, con l’uso della meccanica quantistica, la lunghezza di legame e l’energia di dissociazione della molecola di idrogeno. Nel frattempo, fra il 1927 e il 1929, il tedesco Friedrich Hund e lo statunitense Robert S. Mulliken pongono le basi per la teoria degli orbitali molecolari, che rappresenterà una parte essenziale della chimica quantistica.
La sintesi di Pauling
Nonostante la loro indubbia importanza, le ricerche di Heitler e London, non riscuotono un particolare favore tra i chimici del tempo, soprattutto per il fatto che il linguaggio matematico in cui erano presentate era di non facile comprensione. Fu merito del giovane chimico statunitense Linus Carl Pauling, se gli studi di Heitler e London riescono a superare le barriere disciplinari e nazionali.
Nel 1926 Pauling, che proviene dal California Institute of Technology (CalTech), si trova a Monaco presso l’istituto di Arnold Sommerfeld, grazie a una borsa di studio della Guggenheim Foundation. Pauling ha così la possibilità di entrare immediatamente in contatto con il lavoro di Heitler e London e di comprenderne le inaudite prospettive di ricerca. Rientrato negli Stati Uniti, Pauling fonda la moderna teoria del legame chimico.
Il merito principale di Pauling è quello di riuscire a unire il modello quantomeccanico di Heitler e London con le regole stabilite da Lewis nel 1916 sul rapporto fra legame chimico e coppia di elettroni. Il 7 febbraio 1931 Pauling presenta alla rivista “Journal of American Chemical Society” un fondamentale articolo intitolato The Nature of the Chemical Bond. Applications of Results Obtained from the Quantum Mechanics and from the Theory of Paramagnetic Susceptibility to the Structure of Molecules. L’articolo descrive, attraverso illustrazioni, tutta una serie di diagrammi polari degli orbitali atomici e degli orbitali ibridi che da quel momento in poi entreranno in tutti i manuali di chimica generale.
Fra le molte altre cose, Pauling precisa la natura dei legami chimici forti e deboli, scoperti dal fisico olandese Johannes D. van der Waals, delineando, all’interno dei legami forti, il meccanismo del legame covalente (o metallico) e di quello ionico, e illustrando la coordinazione tetraedrica del carbonio. Nel 1939 Pauling pubblica The Nature of the Chemical Bond, and the Structure of Molecules and Crystals, la prima grande sintesi delle sue ricerche, sulla quale si forma un’intera generazione di chimici. Il libro, dedicato espressamente a Lewis, costituisce il frutto di una serie di conferenze tenute da Pauling presso la Cornell University nel semestre autunnale del 1937.
Con l’affermazione della teoria elettronica del legame chimico, le reazioni saranno progressivamente interpretate come la rottura o la costituzione di unioni provocate dal trasferimento di elettroni.