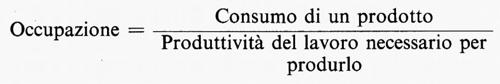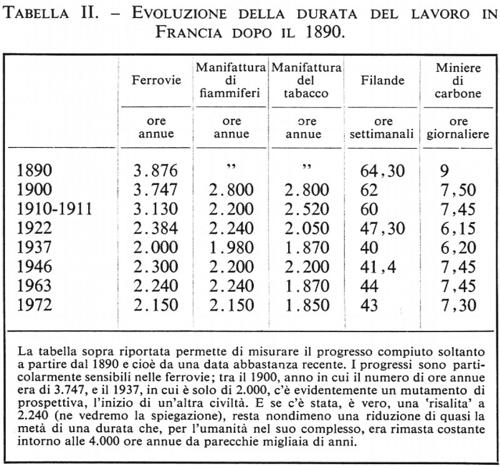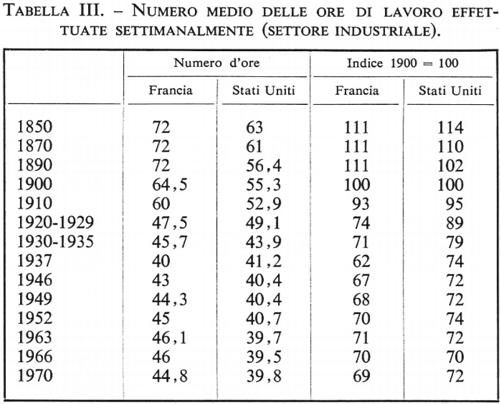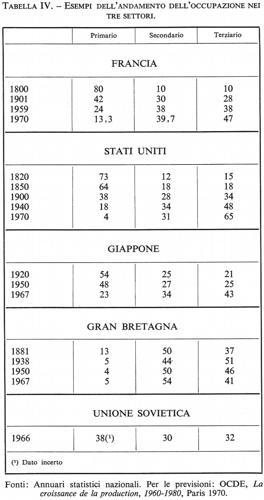Lavoro
Lavoro
di Jean Fourastié e Gino Giugni
LAVORO
Lavoro di Jean Fourastié
sommario: 1. Introduzione generale. a) Il ‛fatto' del lavoro è millenario, il termine ‛lavoro' è recente. b) Concezione tradizionale e concezione contemporanea del lavoro. 2. Considerazioni generali sul lavoro. Storia del lavoro umano. a) L'umanità senza il lavoro. b) Lavoriamo per produrre. c) Come lavoriamo. d) Le scienze, le tecniche e la produttività del lavoro. 3. L'organizzazione del lavoro. La divisione del lavoro. Costrizioni, gerarchie, subordinazione. a) Preparazione del lavoro e organizzazione del lavoro. b) Effetti della produttività del lavoro. c) Settore primario, secondario e terziario. d) Costrizioni, gerarchie, subordinazione. 4. La durata del lavoro. a) L'evoluzione della durata del lavoro. b) Lavoro e tempo libero. c) La ripartizione delle ore di lavoro e di libertà. d) L'opzione ‛durata del lavoro/livello di vita' e le ‛40.000 ore'. 5. Occupazione, disoccupazione e sottoccupazione. a) L'evoluzione della struttura dell'occupazione. b) Disoccupazione e sottoccupazione. c) Lotta contro la disoccupazione e la sottoccupazione. 6. Prospettive del lavoro. a) I problemi già affrontati. b) Gli sviluppi in corso. c) I problemi dell'avvenire. □ Bibliografia.
1. Introduzione generale
a) Il ‛fatto' del lavoro è millenario, il termine ‛lavoro' è recente
Tentiamo di dare una definizione del lavoro: esso è costituito da tutte le attività umane necessarie alla sopravvivenza, cioè alla conservazione della vita umana in un ambiente che, senza queste attività, sarebbe assai sfavorevole per l'uomo. Non c'è vita senza lavoro; questo è vero per gli uomini come per gli animali: anche le specie più elementari sono obbligate a ‛lavorare' per sopravvivere. Devono ricercare il loro nutrimento, sceglierlo in mezzo a una moltitudine di materie e di esseri in maggioranza inutili e ostili; per la maggior parte del tempo devono attaccare e distruggere gli esseri (animali e vegetali) che ‛consumano'; devono inoltre difendersi, a loro volta, da quegli esseri che, al contrario, li ricercano per ‛consumarli'.
L'uomo non si limita però a consumare cibo, ed è l'unico tra gli animali a essere caratterizzato da una molteplicità di bisogni che esigono un'appropriazione e una trasformazione della natura. Col passare del tempo, gli uomini sono diventati sempre più ambiziosi riguardo a ciò che chiamano il ‛minimo vitale'. In origine gli ominidi si contentavano, come gli altri animali, di una vita vegetativa, in cui il lavoro serviva unicamente a procurarsi il cibo; ma più aumentava l'efficienza del lavoro, più diventava loro possibile accedere a condizioni di vita meno elementari. Gli uomini, dunque, sono oggi capaci di lavorare non solo per assicurarsi la sopravvivenza, ma anche per acquisire beni che, ai nostri antenati, sarebbero potuti sembrare inutili, se non addirittura scandalosi, immorali o grotteschi (per es.: il comfort moderno, i film e i libri erotici, lo smalto per le unghie dei cani di lusso).
Il termine ‛lavoro' deriva da parole che significano difficoltà e persino pena o sofferenza; gradualmente, una parola che, nelle lingue europee, designava ogni tipo di difficoltà è diventata il termine oggi usuale per indicare lo sforzo compiuto per la produzione economica di beni e di servizi. Che quest'accezione sia così recente in tutte le lingue è un fatto assai istruttivo, derivante essenzialmente da due circostanze. In primo luogo i nostri antenati non distinguevano ciò che noi oggi chiamiamo lavoro dal non-lavoro. Non esisteva un impiego del tempo, non esistevano orari; gli uomini non avevano un'idea precisa della durata; per esempio, non sapevano mai esattamente la loro età; lo storico francese L. Febvre ha descritto in maniera eccellente il ‛tempo dormiente' e indeterminato in cui vivevano i nostri antenati. In tali condizioni era impossibile suddividere il tempo, come facciamo noi, in tempi ‛specializzati' e misurati.
Cosa ancora più importante, ai nostri antenati non veniva in mente l'idea di distinguere tra lo sforzo destinato a ciò che noi chiamiamo la produzione e ogni altro sforzo, tra un certo tipo di fatica o di difficoltà e tutti gli altri. Ripartire la vita tra lavoro, sonno, festa, tempo libero, pasti, ecc., sarebbe sembrato loro non soltanto inutile e senza interesse, ma ridicolo, arbitrario e nocivo. Il gioco, antenato del tempo libero, era per esempio un modo di iniziarsi all'azione e di padroneggiarla. Il gioco è un'attività molto importante, un fattore essenziale non solo della condizione umana, ma anche della condizione animale. Il gioco serve a misurarsi gli uni con gli altri, è un'integrazione della vita che, nell'antichità, era molto più spontanea che ai nostri giorni; continuando anche in età avanzata, era indissolubilmente intrecciato con gli altri atti della vita, e in particolare con quegli sforzi che oggi chiamiamo lavoro.
b) Concezione tradizionale e concezione contemporanea del lavoro
Esse sono radicalmente diverse. E ben vero, tuttavia, che si tratta in entrambi i casi di attività necessarie alla vita (alla sopravvivenza e all'esistenza). Lo scopo è dunque il medesimo. Ma i ‛mezzi' sono concepiti in modo del tutto differente. Il lavoro tradizionale era una ‛preghiera', un atto rituale; il processo fisico non era altro che il riflesso di un atteggiamento mentale che aveva come oggetto la modificazione di una realtà concepita come ‛soprannaturale'. Il lavoro era molto più faticoso, ma era anche molto meglio accetto, essendo la manifestazione formale di un'adesione spirituale all'ordine del mondo. Il lavoro contemporaneo è invece, com'è noto, una tecnica, un atto puramente naturale, senz'altro effetto che quello di modificare la realtà fisica naturale: è privo di ripercussioni sul ‛soprannaturale'.
Per i nostri antenati, la realtà naturale non era altro che l'apparenza di una realtà soprannaturale, che dava alla prima ordine ed esistenza. Il corpo è ‛animato' dall'anima; un corpo senz'anima è un cadavere ‛inanimato'. Il mondo della vita sembrava loro distinto dal mondo della materia in virtù dell'animazione impressa dallo spirito - soprannaturale - il quale è la verità e la potenza. La vita è caratterizzata dal movimento; questa vita, questo movimento non sono dovuti alla materia, al corpo fisico, ma alla presenza di un'anima nel corpo fisico. La morte è la perdita dell'anima. Questa nozione veniva applicata a ogni essere vivente. Tutto ciò che vive, vive grazie all'anima, cioè grazie a realtà soprannaturali, a ‛spiriti'.
Questa rappresentazione del mondo, che distingue lo spirito dalla materia, può essere paragonata al nostro modo attuale di concepire l'energia. Oggi diremmo che in ogni corpo vivente dev'esserci dell'energia; l'energia non è però ‛spirito': è una forma, in verità molto misteriosa, della materia; è il risultato di una disintegrazione della materia.
Perché un granello di frumento germogli, sono necessarie forze che lo valorizzino. I nostri antenati spiegavano questo spettacolo abituale che avevano sotto gli occhi attraverso il soprannaturale. Soltanto il soprannaturale - l'anima, lo spirito - può modificare il reale, far germogliare il frumento, far nascere un bambino. In questa concezione del mondo, lavorare significa per l'uomo tentare di dominare le forze soprannaturali, o per lo meno tentare di ottenere un accordo di quelle forze spirituali che trasformano la natura e che, partendo da un granello di frumento, danno altri venti o trenta granelli di frumento. Di qui la concezione ‛magica' del lavoro propria dei nostri antenati: si trattava di conciliarsi le potenze soprannaturali per ottenerne quelle azioni che esse sole potevano compiere. È necessario assicurarsi la benevolenza degli spiriti soprannaturali per poter modificare il reale inanimato in modo vantaggioso per l'uomo.
Il lavoro tradizionale era quindi una preghiera rivolta da una persona a una persona, un atto religioso; il lavoro più duro, più ripugnante comportava ‛entusiasmo'. Oggi, l'entusiasmo per il lavoro è diventato inconcepibile. In altri tempi, anche uno schiavo costretto a fare lavori penosi, di cui non avrebbe goduto i frutti, aveva la soddisfazione di compiere un atto religioso. Lavorando, pensava di partecipare all'ordine del mondo e, a un tempo, con i suoi meriti, con le sue prove, di elevarsi nella gerarchia in esso implicita.
La nozione di giustizia era radicalmente differente da quella odierna. Essere giusto equivaleva a dare a ciascuno la posizione, l'autorità e la funzione che gli spettavano nell'ordine del mondo: il re e l'imperatore erano riconosciuti come tali, il capofamiglia come pater familias, il cittadino come cittadino, lo schiavo come schiavo, ciascuno faceva ciò che la propria posizione gli imponeva di fare.
Oggi noi siamo privati di quel ruolo sacro che i nostri antenati svolgevano in una natura ‛stregata' dal soprannaturale. Il lavoratore è ridotto a svolgere un ruolo meccanico in un mondo laicizzato, che deve bastare a se stesso. Al di sopra della realtà dura e piatta non c'è più un cielo.
Questa introduzione, che forse può sembrare a certi lettori estranea all'argomento, permette invece di comprendere la gravità dei problemi del lavoro nel mondo attuale. Il considerarli dal solo punto di vista della tecnica e dell'efficienza equivale a votarsi a errori gravidi di conseguenze. L'uomo vive ‛mentre' lavora, ed è vano sperare in un'umanità che sopravviva come tale, se la ricerca degli obiettivi economici a breve o medio termine mutila l'uomo, nel lavoro, della sua dignità di uomo e della sua fede nella finalità del mondo. Non voglio certo dire che l'umanità debba ritornare alle sue ingenue concezioni magiche del lavoro; ma neppure può accettare in modo duraturo una concezione puramente tecnica, analitica ed economica della propria esistenza e, di conseguenza, del proprio lavoro.
L'umanità ha appena vissuto e sta vivendo, unitamente a un progresso scientifico ed economico che supera in modo stupefacente le sue millenarie speranze, un trauma culturale e spirituale. Gli ingegneri, gli uomini d'azione, i Ford, i Citroën, che hanno dato inizio a questo sviluppo prodigioso e oggi lo accelerano, debbono sapere che la massa del popolo, pur beneficiando del miglioramento del livello di vita e dell'allungamento della durata della vita che le tecniche industriali e mediche permettono, si trova oggi sempre più spaesata e disorientata nell'ambiente razionale, meccanicizzato e organizzato che lo ‛sviluppo' sostituisce rapidamente all'ambiente naturale. Rappresentando con Atala gli elementi sentimentali, affettivi, poetici e sensibili che costituiscono il cuore dell'uomo (Atala, un'indiana Natchez, è un personaggio ben noto di un celeberrimo racconto di Chateaubriand), si può dire, per esemplificare la crisi del nostro tempo, che ‛Atala lavora alla Citroën'.
Per riconciliare Atala con il suo lavoro, con il genere di vita, le gerarchie, le organizzazioni, gli organigrammi che la Citroën le impone in nome dell'efficienza e del livello di vita, non bastano tutte le scienze fisiche e umane: non solo le tecnologie industriali, ma la psicologia, la biologia, la sociologia, la storia, l'etnologia ecc. È vano e pericoloso pensare che si possa separare il lavoro dalle altre attività dell'uomo e dare all'umanità un equilibrio vitale senza darglielo anzitutto nel lavoro. I problemi del lavoro sono problemi umani.
Questi problemi sono numerosi e non possiamo pensare di affrontarli tutti qui. I trattati di diritto, di tecnologia, di organizzazione e di sociologia del lavoro abbondano in tutte le lingue. La bibliografia sull'argomento è vastissima.
Enumeriamone rapidamente le principali suddivisioni classificandole, abbastanza arbitrariamente, in quattro gruppi: a) implicazioni degli aspetti fisici e biologici, specialmente in materia di sicurezza del lavoro, d'igiene, di prevenzione delle malattie e di incidenti sul lavoro; b) diritto del lavoro, diritto delle assicurazioni sociali e poi della previdenza sociale, che sono diventati uno dei settori principali dell'insegnamento e della prassi del diritto; esso comprende in particolare lo studio del contratto di lavoro, dei contratti collettivi, delle assicurazioni contro gli incidenti di lavoro e la disoccupazione; comprende anche gli importanti capitoli relativi al diritto sindacale, agli scioperi, ecc.; c) economia del lavoro, che implica la nozione di impresa e di produzione nazionale; comprende i problemi di ripartizione dei frutti della produzione, dunque i salari e i profitti, l'ampiezza del ventaglio dei redditi - dal manovale al direttore generale -, le relazioni tra salari, potere di acquisto, livello di vita e produttività; d) sociologia del lavoro, che comprende i grandi capitoli della psicologia dei gruppi e delle organizzazioni, le ‛relazioni umane nel lavoro', i conflitti collettivi, i problemi di responsabilità, di ‛partecipazione' alle decisioni, di gerarchia, di circolazione dell'informazione, ecc.
In questo articolo il lavoro sarà esaminato dal punto di vista economico e sociale, dunque dal punto di vista della vita quotidiana dell'uomo medio, degli sviluppi recenti e delle prospettive per il prossimo avvenire.
2. Considerazioni generali sul lavoro. Storia del lavoro umano
In passato il lavoro era la vita stessa. Si è potuto dire: ‟L'uomo è nato per il lavoro così come l'uccello è nato per cantare" (Saci), poiché nulla è stato dato gratuitamente all'uomo. Rousseau ha potuto vantare la bellezza della natura che può esser fonte d'ispirazione per i poeti; ma, secondo un'espressione un po' semplicistica, essa ‛non nutre l'uomo'. La risposta all'interrogativo ‛perché lavoriamo?' è semplice: lavoriamo per produrre, per sopravvivere.
Tutto quello che consumiamo è creazione del lavoro umano, anche quei beni che giudichiamo i più ‛naturali', come il grano, le patate o la frutta.
a) L'umanità senza il lavoro
Esiste una netta tendenza a collocare nel passato l'età d'oro dell'umanità. Secondo quest'idea, tutto sarebbe stato dato gratuitamente all'uomo in una sorta di paradiso terrestre, mentre ai giorni nostri, al contrario, tutto sarebbe diventato guasto e difficile. Questa tendenza, che assume nel pensiero di Rousseau una colorazione popolare e persino rivoluzionaria, è rimasta viva nello spirito dell'uomo medio. Dappertutto si sente parlare ancora dei vantaggi dei prodotti naturali; e d'altra parte molti oggi pensano sinceramente che la vita d'altri tempi fosse più ‛sana' di quella attuale.
In realtà possiamo affermare, e tutte le attuali scoperte della storia e della preistoria lo confermano, che la natura allo stato naturale è una dura matrigna per l'umanità. Il latte cosiddetto ‛naturale' di vacche allevate in modo ‛naturale' può dare la tubercolosi e la vita chiamata ‛sana', in altri tempi, sotto il profilo della mortalità (in particolare della mortalità infantile) dava risultati spaventosi: un bambino su tre moriva prima di raggiungere l'anno di età e, dei due rimasti, uno solo superava in Francia, Italia e Inghilterra - ancora fino al 1750 - i 25 anni d'età.
A un'umanità senza lavoro e soprattutto senza tecnica, il globo terrestre consentiva unicamente una vita limitata e vegetativa. Alcune centinaia di milioni di individui sopravvivevano a un livello di vita animale nelle regioni subtropicali.
Tutti gli attuali consumi degli uomini sono resi possibili, infatti, da invenzioni del lavoro umano, anche quelli generalmente ritenuti i più ‛naturali', come i consumi di cereali, patate e frutta. I cereali sono stati trasformati e migliorati attraverso un lento lavoro, con la selezione di alcune graminacee; il nostro grano odierno, per esempio, è così poco ‛naturale' che, se gli uomini sparissero dalla faccia della terra, sparirebbe anch'esso in meno di 50 anni, così come tutti gli altri cereali. La stessa sorte seguirebbero tutte le altre piante coltivate: alberi da frutta, rosai, verdure, ecc., come pure il bestiame da macello; questi perfezionamenti profondi, questi miglioramenti introdotti dall'uomo resistono soltanto perché sono difesi contro la natura; essi hanno valore per l'uomo, ma hanno valore solo per suo mezzo.
E che dire poi degli oggetti manufatti, dei tessili, della carta, degli apparecchi televisivi, delle lavatrici, di tutti i prodotti artificiali creati, fabbricati dal solo lavoro umano! Che concludere da tutto quest'insieme di cose, se non che l'uomo è un essere vivente, i cui bisogni non sono in accordo totale con il mondo in cui vive? Per armonizzare i bisogni della sua vita con la natura è necessaria una lotta, una trasformazione, un lavoro.
Per meglio chiarire la cosa, è necessario paragonare l'uomo agli animali, compresi quelli più evoluti nella gerarchia biologica. Un mammifero, un bue, un lupo, un gatto o una capra si contentano dei soli prodotti naturali: per un montone non c'è niente di meglio dell'erba, per un gatto affamato non c'è niente di meglio di un topo; e, una volta sazi di cibo, gli animali non pensano certo a procurarsi oggetti come orologi, pipe o cappelli. Soltanto l'uomo ha bisogni non naturali. E questi bisogni non naturali sono immensi. La terra non può produrre tutto quello che l'uomo desidera consumare: egli ha infatti bisogno di pane, di pesce (pescato e cotto), di ciliege (che però non siano selvatiche), eccetera. Ma bisognerebbe anche, per accontentarlo, che le case sorgessero dalla terra in modo naturale, come le piante, con riscaldamento centrale, bagno e televisione.
Per precisare ancor meglio i fatti, si può affermare che, sul nostro globo terrestre, l'ossigeno è il solo elemento naturale che possiamo sfruttare senza lavoro. È infatti la natura che soddisfa, senza restrizioni e senza sforzo, a uno dei nostri bisogni essenziali: la respirazione. Perché l'umanità potesse sopravvivere senza il lavoro, sarebbe necessario che la natura desse all'uomo tutto quello di cui sente il bisogno così come gli dà l'ossigeno dell'aria (non si può citare l'acqua, perché occorre attingerla, trasportarla e, a volte, filtrarla).
b) Lavoriamo per produrre
Perché lavoriamo dunque? Per trasformare la natura, che allo stato naturale non può soddisfarci, in elementi artificiali capaci di appagare i nostri più svariati bisogni. Lavo riamo per trasformare l'erba selvatica in grano e poi in pane, le rose di macchia in rosai, i ciottoli in acciaio e poi in automobili.
Comprendiamo, allora, come si tratti di un compito difficile, che è ben lontano dal soddisfare con facilità i nostri bisogni; c'è, infatti, un gran divario tra quello che la natura allo stato naturale ci offre e quello che noi desidereremmo ricevere!
Da quando sono comparsi sulla terra - la loro storia ha già 500 milioni di anni - gli ominidi hanno appreso, dapprima lentamente e poi, da circa un secolo, in modo tumultuoso, ad accrescere il loro potere di trasformare la natura; hanno lavorato, hanno creato tecniche, hanno specializzato il proprio lavoro.
Il divario esistente tra i nostri bisogni potenziali - cioè il volume dei beni che saremmo capaci di consumare se la natura ce li fornisse allo stesso modo in cui ci fornisce l'ossigeno - e i beni effettivamente prodotti attraverso il nostro lavoro - cioè strappati alla natura e resi consumabili - è così considerevole che tutti i sistemi economici finora osservati e osservabili sul nostro pianeta comportano un meccanismo di razionamento.
c) Come lavoriamo
Possiamo facilmente comprendere come il globo terrestre non possa sostentare, se non a malapena, la vita umana. È infatti necessario, per sopravvivere, modificare la natura e, talvolta, anche distruggerla. Ma l'uomo, ridotto alle sole sue forze, è un essere debole; per migliaia di anni, schiacciato dal solo compito di tentare di sopravvivere, è stato ridotto a una vita vegetativa in cui venivano adoperate soltanto le sue facoltà biologico-animali. E questa, senza dubbio, è ancora la situazione di metà dell'umanità dei nostri giorni.
Il progresso è arduo: non è facile ‛realizzare l'umanità'. Ed è attraverso un'evoluzione estremamente lenta che gli uomini hanno appreso a sfruttare la natura con una certa efficienza. Gli abitanti dell'India e della Cina non sanno ancora cavar fuori dalla terra se non dieci o quindici quintali di grano o di riso per ogni anno di lavoro. Ora, con un lavoro infinitamente meno faticoso e meno lungo - ma sempre nel corso di un anno - un lavoratore americano che coltivi ‛da solo' 100 ettari, ne ricava non dieci quintali, ma trenta tonnellate, cioè trenta volte più del lavoratore asiatico. Quest'enorme differenza tra l'Oriente e l'Occidente illustra la potenza della produttività del lavoro. Il fatto che una gran parte dell'umanità sia ancor oggi non solo incapace di scoprire queste tecniche, ma anche scarsamente in grado di utilizzarle o di imitarle quando vengano scoperte, mostra quanto tempo occorra allo spirito scientifico sperimentale per nascere, per svilupparsi e per prevalere nella prassi abituale. Ma da 100-150 anni la scienza sperimentale comincia a rivelare la sua fecondità modificando profondamente la maggior parte delle nostre tecniche di lavoro.
d) Le scienze, le tecniche e la produttività del lavoro
Il lavoro dell'uomo è valorizzato dallo spirito scientifico; dalla conoscenza del mondo ingegneri, innovatori e scienziati deducono tecniche, cioè metodi di lavoro sempre più efficienti. Ma l'evoluzione ha richiesto lunghi secoli, o piuttosto millenni; se miliardi di uomini sono nati sulla terra, pochissimi sono stati infatti gli innovatori, pochissimi hanno dato all'umanità nuove tecniche.
La ricerca dell'efficienza del lavoro è difficile, lenta e complessa. Questa ricerca conduce, o costringe, gli uomini a costituire gruppi di lavoratori specializzati, chiamati ‛imprese': la produttività obbliga in tal modo l'umanità a ricorrere alla divisione del lavoro, la quale obbliga a sua volta allo scambio. Lo scambio si fa sempre tra due prodotti differenti, per esempio tra dei vestiti e un apparecchio radiofonico, tra una certa quantità di carne e dei tegami, ecc.; la determinazione del tasso di scambio non è cosa semplice e dà luogo a problemi di giustizia sociale, risolti in modo più o meno soddisfacente. Tale è tuttavia l'efficienza della divisione e della specializzazione del lavoro, che l'umanità si impegna sempre più in questa direzione. Ciascuno di noi, quindi, ciascun operaio produce sempre più, nell'impresa, cose che non consuma e, inversamente, sempre più consuma cose che non ha prodotto.
Si comprende facilmente come i gruppi umani e le nazioni che hanno accettato le costrizioni, lo scotto della divisione del lavoro, le organizzazioni gerarchiche e i molteplici altri obblighi che ne derivano, abbiano acquistato molto presto sugli altri gruppi e nazioni grandi vantaggi economici e politici, e ciò proprio a motivo dell'efficienza che della divisione del lavoro è la principale conseguenza. Questo è uno dei tratti essenziali della storia contemporanea, che è dominata da quei fenomeni cui si dà il nome di ‛crescita' o ‛sviluppo'. Oggi, questi fenomeni hanno cominciato a rivelare la loro ‛faccia nascosta', le loro conseguenze impreviste. I vantaggi della crescita (e in particolare quelli relativi al livello di vita, alla salute, alla durata media della vita) sono stati, è vero, confermati (è questa la faccia visibile del fenomeno, l'obiettivo desiderato e voluto); ma la divisione del mondo tra paesi sviluppati e paesi non sviluppati, tra i quali l'abisso si approfondisce anziché colmarsi, i limiti fisici che la crescita incontra in alcuni paesi sviluppati, le insoddisfazioni che persistono e si sviluppano nei paesi più progrediti, sono tutti fatti che pongono all'umanità di oggi gravi sfide. L'organizzazione mondiale del lavoro non può più essere presa in considerazione unicamente dal punto di vista dell'efficienza del lavoro orario.
3. L'organizzazione del lavoro. La divisione del lavoro. Costrizioni, gerarchie, subordinazione
Nonostante quanto abbiamo appena scritto, è evidente che l'efficienza del lavoro resta uno degli obiettivi più importanti (anche se non deve più essere considerato come il solo determinante). Si comprende dunque facilmente come l'organizzazione del lavoro e le costrizioni che ne derivano - i conflitti tra spontaneità e creatività da una parte, pianificazione e calcolo razionale dall'altra - siano uno dei problemi principali del lavoro contemporaneo.
a) Preparazione del lavoro e organizzazione del lavoro
Gli scienziati, con le loro ricerche, aiutano oggi l'uomo nel suo compito di valorizzazione del proprio lavoro; è infatti dalla scienza che derivano le tecniche. Queste tecniche vengono applicate a due stadi del lavoro: il primo relativo alla preparazione, il secondo all'esecuzione.
La preparazione è indubbiamente la più feconda delle due operazioni: il pensiero e la riflessione guidano la mano dell'uomo. Nel caso dell'agricoltura, è necessario studiare in anticipo la natura del terreno, il clima, la coltura, il concime, le lavorazioni, le epoche della semina, i procedimenti. Si tratta di definire con precisione: a) il prodotto; b) il lavoro, cioè il quadro particolareggiato delle operazioni necessarie per la produzione.
Nel caso dei prodotti dell'industria, bisogna orientare il lavoro in modo da permettere il più possibile procedimenti automatici e, dunque, l'impiego di macchine. Di qui le tecniche di organizzazione del lavoro: scegliere i procedimenti e le macchine e quindi armonizzarli; calcolare gli investimenti e gli ammortamenti; minimizzare la quantità di lavoro necessaria per il totale della produzione, cioè minimizzare il prezzo di costo (sotto il controllo del profitto). Le macchine hanno un costo: sono state fabbricate, comportano un lavoro preliminare, non immediatamente produttivo. Gli investimenti rappresentano, in un paese sviluppato, circa il 20% del totale della produzione nazionale; senza di essi, la produttività del lavoro può essere accresciuta solo attraverso l'organizzazione. Sebbene l'organizzazione e il metodo predominino in genere sull'investimento, ci sono tuttavia numerosi settori dell'economia, come la siderurgia, le industrie meccaniche ed elettriche, l'industria tessile, in cui gli investimenti sono fondamentali.
Gli uomini non sanno organizzare il proprio lavoro spontaneamente: seguono tradizioni millenarie, riprendono antichi gesti, praticati dai loro antenati, la cui efficienza è spesso minima. Noi oggi sappiamo che si tratta di abitudini che apportano al lavoro ostacoli piuttosto che valide soluzioni.
Vi sono, dunque, atteggiamenti e mentalità che ritardano il progresso. È una legge del pensiero umano che esso trovi raramente la soluzione più semplice di primo acchito; deve sperimentare una quantità di soluzioni complicate e poco efficienti prima di scoprire la più semplice, la più efficiente. La scienza dell'organizzazione del lavoro permette di superare questi svantaggi e di arrivare più rapidamente, attraverso esperienze feconde, a soluzioni accettabili. L'esame di un laboratorio o di un'officina rivela per lo più numerosi esempi di cattiva organizzazione, che un consulente scientifico può, progressivamente, scoprire e correggere.
b) Effetti della produttività del lavoro
Tutti questi progressi (divisione del lavoro, sua organizzazione, utilizzazione delle macchine) hanno lo scopo di aumentare l'efficienza dei lavoratori; ne deriva un'economia di lavoro umano e, dunque, la riduzione del costo reale dei prodotti.
La produttività del lavoro è il rapporto tra il volume della produzione e la durata del lavoro umano necessario a ottenerlo. Le numerose misure di produttività escogitate da ingegneri, contabili e statistici mostrano due cose: a) i progressi degli ultimi cinquant'anni nelle nazioni occidentali sono, in certi settori dell'economia, considerevoli; per esempio, la durata del lavoro umano necessario per fornire un'illuminazione di 10 lumen è stata ridotta, in Francia, dal 1750 al 1960, da 400 a 1; b) questi progressi variano però irregolarmente da una produzione all'altra e anche da un periodo all'altro. Basta vedere la tab. I, per valutare le divergenze che si sono manifestate tra la produzione di uno specchio e quella di un quintale di grano (si prende qui, come esempio, la Francia, ma l'andamento è lo stesso in tutta l'Europa occidentale).
Da qualche decennio, il lavoro degli uomini si differenzia in modo radicale rispetto al suo passato millenario. Esso consiste sempre meno in un dispendio di energia muscolare e sempre più nella manipolazione di simboli: esige un'attenzione intellettuale crescente. L'uomo, il cui pensiero si è per millenni nutrito di sogni e d'immaginazioni, si vede ora incessantemente messo a confronto con una realtà esterna che lo domina.
Il lavoratore è sottoposto alle esigenze della tecnica: la meccanizzazione, l'automazione introducono nella vita e nel lavoro durate e ritmi che modificano i tempi fisiologici; i determinismi della divisione del lavoro si oppongono allo Spirito di sintesi proprio dell'uomo che, tagliato fuori dalla ‛natura naturale', dalle proprie origini biologiche, si vede spesso dotato di un eccesso di potenza che non è preparato a utilizzare.
c) Settore primario, secondario e terziario
Le diverse produzioni presentano, riguardo alla produttività del lavoro, comportamenti differenti. Sono terziarie le produzioni poco influenzate dalla produttività. Sono secondarie quelle che lo sono in grande misura. Si riserva il termine di primarie alle produzioni agricole; la storia mostra che nelle produzioni primarie il progresso tecnico è abbastanza lento nei primi decenni di progresso economico, ma può diventare in seguito rapidissimo: dal 1950 - nei paesi sviluppati - i progressi nell'agricoltura eguagliano, o anche superano, i progressi nell'industria.
Questa classificazione in tre comportamenti tipici spiega molti fenomeni economici. Si comprende l'afflusso crescente dei lavoratori nel settore terziario, dove i tempi di produzione non possono diminuire e, al contrario, la diminuzione o la stabilità della manodopera impiegata nei due settori dove la produttività del lavoro cresce fortemente. L'evoluzione dell'occupazione è regolata dall'equazione:
d) Costrizioni, gerarchie, subordinazione
La divisione del lavoro prese l'avvio decine di millenni or sono, essendo sempre esistiti uomini più adatti di altri a intagliare le selci o i raschiatoi d'osso. Ma con l'introduzione delle macchine, con la Scoperta e l'utilizzazione del vapore, comincia un'era di rivoluzione industriale; nello stesso tempo, la divisione del lavoro entra in una nuova fase e prende un nuovo slancio. Le manifatture comportavano da sempre mansioni parcellizzate, ma si trattava di ben poca cosa a paragone della parcellizzazione propria del lavoro moderno. Le macchine si specializzano ogni giorno di più; ogni razionalizzazione ‛scientifica' del lavoro si accompagna a una frantumazione delle mansioni, che aumenta il rendimento dei lavoratori.
Nelle fabbriche d'automobili, per esempio, le mansioni si riducono a operazioni assai limitate e ripetute; certune non durano che alcuni secondi. Accade lo stesso in quasi tutte le moderne imprese di produzione; c'è ben poco rapporto tra il lavoro della sarta di altri tempi e quello di un'operaia in una fabbrica di confezioni. Nella fabbrica, l'ufficio studi stabilisce, una volta composto il modello, schede particolareggiate con l'elenco delle diverse mansioni che saranno poi svolte alla catena. L'apprendistato è allora assai ridotto: basta qualche ora per l'addestramento di un'operaia cosiddetta ‛qualificata'.
Si potrebbero dare mille esempi di questa situazione, tanto nel campo dell'industria metallurgica che in quello delle industrie alimentari, della fabbricazione di armi, ecc. (F.W. Taylor; A.G. Stachanov).
Le qualità richieste agli operai di oggi non sono più le stesse di altri tempi: né l'immaginazione, né lo spirito creativo trovano più posto nei gesti compiuti e ripetuti alla catena di montaggio. La velocità, la precisione, la destrezza costituiscono invece una nuova gamma di qualificazioni. Capacità di attenzione continua sono anche richieste nei numerosi casi nei quali il lavoro consiste essenzialmente nell' osservazione di macchine. Si pone allora la questione della soddisfazione nel lavoro; le mansioni parcellizzate, alle quali molti operai sono inchiodati, sembrano ingenerare la noia e la fatica, mentre la soddisfazione sembra spesso legata a una certa complessità interna dei gesti da compiere. La questione non può esser risolta con principi semplicistici, dato che molti lavoratori preferiscono una mansione facile, ripetuta e abituale, a lavori più complessi. Nell'opera Le travail en miettes, G. Friedmann registra le reazioni di numerosi operai qualificati; certi operai di una fabbrica di materiali radioelettrici preferiscono i lavori semplici, che comportano un piccolo numero di operazioni elementari; se aumenta la difficoltà dei lavori, diminuisce il loro rendimento. In altre imprese, al contrario, altri operai qualificati cercano un lavoro che richieda maggiore iniziativa. Bisogna considerare una complessa combinazione di fattori, alcuni attinenti alla psicologia collettiva, altri alla psicologia individuale.
D'altra parte, fin d'ora e ancor più in un futuro assai vicino, l'automatismo libera e libererà l'operaio da molti dei suoi gesti monotoni. Il lavoro alla catena, ai nostri giorni, è ben lontano da quello che era nel 1935, quando Charlie Chaplin ne fece una celebre satira. Ed è altrettanto certo che in 40 anni il progresso economico, se ha dato all'operaio qualificato il livello di vita che avevano antecedentemente i quadri superiori, è però ben lontano dall'avergli dato le iniziative e le motivazioni proprie di questi ultimi. Ed è qui, senza dubbio, il tratto principale della ‛crisi' odierna dell'operaio qualificato.
Attualmente, molte officine non hanno potuto essere ancora completamente automatizzate. Il lavoro dell'operaio qualificato resta necessario in misura assai notevole (circa un terzo dell'occupazione nell'industria). Ora, tale lavoro ha scarso significato per l'operatore troppo specializzato, che si sente poco responsabile nei confronti della sua mansione elementare. Il lavoro dell'operaio qualificato, pur guadagnando incessantemente in tecnicità, perde però, più che non guadagni, in fatto di autonomia e di originalità: le qualità, cioè, che lo rendevano interessante.
Questa organizzazione razionale del lavoro, basata su calcoli di efficienza, controllata quotidianamente attraverso i calcoli contabili dei prezzi di costo e sanzionata automaticamente dal profitto, obbliga l'uomo a un comportamento quotidiano che è ben lontano dalla fantasia, dalla spontaneità, dalla libertà d'iniziativa. Le organizzazioni efficienti sono quelle in cui i processi sono regolati in anticipo, attraverso ricerche complesse e lunghe, e poi imposti agli esecutori. Le critiche che possono loro rivolgere questi ultimi si rivelano quasi sempre superficiali.
Il cronometraggio tayloriano e i suoi succedanei, volti all'efficienza immediata, vanno a caccia dei ‛tempi morti'.
Si comprende facilmente come la selezione naturale abbia agito e continui ad agire in favore degli individui e, a lungo andare, dei gruppi e dei popoli che praticano queste competizioni brevi e incruente, seguite da durature sottomissioni. Per la specie umana fu dapprima la rivalità con altre specie animali che comportò tale selezione e poi le rivalità tra gruppi umani. Oggi, è l'efficienza economica che privilegia le società nelle quali la massa del popolo si sottomette all'ordine razionale dell'organizzazione scientifica. Ê chiaro che la sottomissione degli operai qualificati ai dirigenti e dei dirigenti ai managers cesserebbe in un batter d'occhio, se le società basate sulla spontaneità e sull'anarchia fossero più efficienti delle società basate sul calcolo e sulla gerarchia.
4. La durata del lavoro
In passato gli uomini lavoravano dall'alba al tramonto, per tutta la durata del giorno e, se momenti di ricreazione, di distensione erano strettamente mescolati alla fatica, non v'era certo né vero tempo libero, né svago nel senso attuale del termine.
Ma a poco a poco questa situazione si venne modificando, allorché i beni di consumo necessari alla sopravvivenza, prodotti in abbondante quantità grazie al progresso delle tecniche di produzione, si fecero meno rari.
a) L'evoluzione della durata del lavoro
Tuttavia, all'inizio dell'era industriale, il miglioramento del livello di vita rimase la preoccupazione dominante. Pure, è con la nascita dell'industria e la conseguente civiltà urbana, con l'urbanizzazione, che è nato il tempo libero, il tempo cioè di cui usiamo a nostro piacimento. Il tempo libero si colloca in una civiltà caratterizzata da un tempo frazionato e continuamente contato. Se l'orologio individuale aveva già fatto la sua apparizione nel sec. XVI, a quell'epoca però non era altro che un ornamento riservato a pochi elegantoni, gioiello costoso quanto inutile; solo molto più tardi esso ricevette la sua vera consacrazione: nelle manifatture e nelle amministrazioni. Come ha scritto G. Hourdin ‟non è certo un caso se l'imprenditore del XIX secolo appariva nelle litografie di Daumier con la catena d'oro sul pancione: vuol mostrare che in tasca ha l'orologio e che conosce il valore del tempo" (La civilisation des loisirs, Paris 1961, p. 52).
Come controparte degli orari esatti, delle ore contate, si sviluppa la nozione del tempo ‛che si ha a disposizione per sé'. Questa nuova organizzazione della giornata, avvenimento importante nella vita degli uomini, si è instaurata molto presto, dopo la creazione delle officine, ma i suoi effetti sono stati lenti poiché, dopo dieci o dodici ore giornaliere nelle officine disagevoli del passato, gli ‛svaghi' avevano poco valore; non si poteva anzi decentemente dar loro questo nome.
È utile ricordare qui alcune pagine di L.-R. Villermé, del 1840, che illustrano la natura del lavoro nelle filande del nord e dell'est: ‟A Mulhouse, a Dornach, ecc. [...] le filande e le tessiture meccaniche si aprono generalmente alle cinque del mattino per chiudersi la sera alle otto, qualche volta alle nove. D'inverno, l'entrata viene ritardata di frequente fino all'alba, ma non per questo gli Operai ci guadagnano un minuto. La loro giornata è quindi di almeno quindici ore, durante le quali hanno una mezz'ora per il pranzo e un'ora per la cena; questo è tutto il riposo loro accordato. Di conseguenza, non fanno mai meno di tredici ore e mezza di lavoro al giorno [...]. A Thann e a Wesserling, le condizioni sono identiche; a Bischwiller, il lavoro effettivo arriva a 16 ore". A Sainte-Marie-aux-Mines, ‟la giornata è di 14 ore, con una sospensione di un'ora e mezzo [...]. A Saint-Quentin, varia da 14 a 15 ore, alle quali si deve aggiungere il tempo dedicato allo spostamento la mattina e la sera" (L.-R. Villermé, Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, Paris 1840, p. 21). Questi orari valevano tanto per gli uomini che per le donne, e trovano conferma nelle indagini sulle fabbriche di Reims, d'Amiens, di Lille, di Torino, di Milano, di Liverpool... E non è ancor tutto! Anche la giornata lavorativa dei ragazzi era assai lunga; Villermé si sforzò di ottenere per loro miglioramenti di orario. Egli scriveva in Francia per tentare di denunciare gli ‛abusi' del liberalismo, e portava come modello l'Austria, dove ‟grazie alle premure del governo, non si possono assumere ragazzi nelle manifatture prima dell'età di otto anni compiuti, e per una durata che non deve oltrepassare le dieci ore giornaliere" (ibid., p. 22). Poco dopo la pubblicazione di queste righe, intervenne in Francia la legge del marzo 1841, che limitava a otto ore giornaliere il lavoro dei ragazzi dagli otto ai dodici anni.
È passato poco più di un secolo dal tempo di Villermé! Non c'è bisogno di istituire un paragone particolareggiato tra la vita di lavoro di uno dei nostri ‛cari piccoli' oggi e quella dei ‛giovani' del 1840; per tacere delle condizioni penose, insalubri, in cui si trovavano in generale tutti i lavoratori.
Dal 1850, e soprattutto dopo il 1920, la durata del lavoro è stata ridotta in due modi: dapprima con la diminuzione dell'orario giornaliero per l'uomo adulto, e questo è il fenomeno più appariscente; poi con l'estensione dell'età scolare.
La tab. III indica il numero di ore di lavoro settimanali, nel settore industriale, in Francia e negli Stati Uniti.
Nel periodo 1919-1939 si colloca la fase più importante per la riduzione della durata del lavoro; in questo periodo sono state infatti approvate leggi che hanno rivoluzionato il mondo operaio e abitudini secolari: in Francia, per esempio, le leggi dell'aprile 1919, che istituiscono la giornata di otto ore, e quelle del giugno 1936, che garantiscono le ferie pagate e pongono il principio della settimana di quaranta ore. Si scorgono chiaramente i diversi orientamenti. Nel 1937, si è creduto in Francia di poter ridurre di molto la durata del lavoro, il che ha condotto il paese a una stagnazione, anzi a una recessione economica che è stata senza dubbio una delle cause della sua disfatta nel 1940; è stato perciò necessario ritornare a valori un po' più alti, paragonabili a quelli degli altri paesi d'Europa.
Si constata così che, in media, si è lavorato più in Francia che negli Stati Uniti prima della guerra del 1914, e in Francia meno che negli Stati Uniti tra le due guerre. C'è qui un'anomalia, poiché è appunto dopo il 1920 che la Francia si è impoverita. Dopo il 1945, invece, le necessità della ricostruzione e della modernizzazione hanno fatto risalire fino a 46 ore, in Francia, la durata abituale del lavoro. L'operaio lavora, tuttavia, sensibilmente meno nel 1973 che non nel 1910; sono soppresse circa 17 ore la settimana, ossia quasi il 30%. Egli ha inoltre almeno 21 giorni, e spesso 28, di ferie pagate ogni anno. Il tempo libero concesso all'uomo adulto è uno degli elementi fondamentali del tenore di vita; questo elemento è mutato nello stesso senso in tutti i paesi industriali.
Ecco qual era, nella Comunità Economica Europea, la durata media del lavoro settimanale, nel settore industriale, nel 1966:
Come si può constatare, la Francia occupa il secondo posto in questa graduatoria del 1966, subito dopo il Lussemburgo. Le tendenze attuali, come quelle future, andranno nuovamente verso la maggiore riduzione possibile dei tempi di attività (certi salariati arrivano persino a reclamare la riduzione per poter fare delle ore di straordinario, il che sembra, a prima vista, una specie di contraddizione; sennonché queste ore hanno, psicologicamente, un carattere differente dalle altre, essendo oggetto di una libera scelta).
b) Lavoro e tempo libero
In un prossimo futuro avremo ‛forse' la civiltà del tempo libero; non siamo però ancora a questo stadio, ma ci troviamo piuttosto a una specie di svolta, in un periodo di transizione in cui si pongono mille problemi. G. Douart, nel suo libro L'usine et l'homme cita un esempio, tra vari altri, della situazione presente e della scelta possibile tra tempo di lavoro e tempo libero, ricordando la testimonianza di un operaio edile: ‟La vita è cara [...] mi son voluto procurare onestamente il mio comfort, a forza di straordinari. Per il frigorifero e la televisione mi sono sbarazzato di inutili perdite di tempo: le riunioni sindacali, le passeggiate in centro, le bevute con gli amici. Per un'automobile, ho venduto le mie ore di bricolage, le mie serate di giardinaggio, le partite di pesca: come se quelli che si sono battuti per strappare le 40 ore lo avessero fatto per permettermi di fare gli straordinari. Per dei mobili Ségalot, ho barattato le letture, il cinema e tutti quei momenti benedetti in cui mi perdevo in fantasticherie senza avere un padrone alle spalle. Per un appartamento moderno, ho dato ascolto alle confidenze: da Untel, di ore al 50% ne puoi fare quante ne vuoi; da Machin, puoi fare del ‛lavoro nero' la domenica; e così ho rinunciato ai week-ends nei quali, con la moglie e i ragazzi, si andava a fare il bagno, ci si stendeva sulla sabbia e si ascoltava il vento tra i pini! Per il denaro ho trascurato il sonno, le mie ferie, e mi sono fatto rubare la salute. Non sono più che una macchina per lavorare [...]. Così ho venduto tutto, perduto tutto: l'accordo con mia moglie, la mia vita di famiglia, l'amore dei miei figli. Non sono più né un padre né un marito. Tu, che ad ogni costo vuoi il benessere materiale, non comprano col tuo tempo libero, non vendere mai quello che fa di te un uomo; è una verità vecchia quanto il mondo e sempre vera, che il denaro non dà la felicità!" (O. Douart, L'usine et l'homme, Paris 1967, p. 270).
Questa citazione mostra quanto, nell'odierno mondo del lavoro, si sia ancora lontani dalla civiltà del tempo libero. E sarebbe facile moltiplicare gli esempi: certe commesse con bassi salari che la domenica fanno un ‛lavoro nero', diventando per un giorno sguattere o cameriere, oppure domestiche a ore; operai, imbianchini, idraulici, meccanici, che al loro orario di lavoro abituale aggiungono delle serate, dei sabati.
È certo che l'uomo cerca, prima di tutto, di migliorare il proprio livello di vita. E i progressi tecnici, che possono permettere di produrre di più con minore sforzo, rendono possibile un aumento dei consumi. Sembra ciononostante che, almeno in Francia, non sia vicino il momento in cui i limiti di tale aumento saranno raggiunti.
Orbene, quest'aumento della produttività può offrire all'uomo varie possibilità: o produrre di più mantenendo il lavoro costante, o lavorare di meno per una produzione eguale, o ancora lavorare di meno per una produzione minore. In realtà, noi non sappiamo molto bene ciò che vogliamo e ancor meno ciò che è meglio per noi. Quel che è certo è che la durata degli orari è subordinata a decisioni volontarie: il problema non è più quello di restare nell'officina, in ufficio, nei campi per tutta la giornata, senza interruzione. A poco a poco ci si comincia a liberare dalla schiavitù del lavoro, mentre fa la sua comparsa un bisogno concorrenziale: il miglioramento del genere di vita, di cui la diminuzione del lavoro è un elemento essenziale. Ed è per questo che ormai, almeno nei paesi industrializzati, non si tratta più tanto di aumentare la produzione, quanto di trovare un equilibrio armonioso, in grado di soddisfare la duplice aspirazione dell'uomo: elevare il livello di vita e migliorare la qualità della vita; armonia difficile perché contraddittoria: bisogna infatti, più o meno, sacrificare l'uno per avere l'altra. È qui operante un'opzione volontaria, anzitutto a livello personale: ogni individuo è infatti libero di scegliere un lavoro piuttosto che un altro; in parecchi casi può optare tra diverse possibilità: il denaro, il tempo libero, la soddisfazione. Tra il capo di un'impresa con un considerevole giro d'affari, che non può prendersi senza apprensione qualche giorno di vacanza (con il telefono a portata di mano), e il vagabondo che dorme tranquillamente sulle rive della Senna c'è tutta una gamma di possibilità. C'è poi un'altra opzione, collettiva questa volta, a livello della fabbrica, della bottega, dell'ufficio, o anche della nazione (per es. la legge dell'aprile 1919, che istituisce la giornata di otto ore).
Nella sua scelta, l'uomo è diviso tra il desiderio di consumare e la preoccupazione di dover produrre. È evidente che la soluzione ottimale sarebbe per molti quella di viver bene senza dover svolgere attività obbligatorie.
c) La ripartizione delle ore di lavoro e di libertà
Un altro problema è legato alla durata del lavoro: quello del modo in cui si possono distribuire nel tempo le ore di libertà. La soluzione desiderata può variare da un individuo all'altro e i risultati possono essere assai differenti a seconda delle diverse modalità scelte. Non è certo la stessa cosa avere per sé un'ora ogni giorno, tornando dal lavoro, oppure avere la possibilità di rilassarsi, ad esempio per sei ore, una volta la settimana. Le soluzioni possibili a questo riguardo sono matematicamente assai numerose.
A partire dal 1936 la diminuzione del tempo lavorativo aveva preso un notevole slancio: parecchie ore al giorno, due settimane all'anno e, in seguito, con il prolungamento dell'età scolare e l'abbassamento dell'età pensionabile, si è avuta una riduzione del numero di anni lavorativi nell'intera vita; è in questo quadro che possono venir considerate molteplici soluzioni. Lo scopo, per numerosi salariati, è l'abbreviamento della vita lavorativa attraverso un precoce pensionamento. Altri ritengono tuttavia più interessante prolungare per tutti la scolarità. B. de Jouvenel (Arcadie. Essai sur le mieux vivre, Paris 1968, p. 83) propone a questo riguardo la seguente alternativa: ‟Supponete che di qui a vent'anni nel tal paese le fasi di una vita umana si succedano secondo il modello seguente: scuola fino a quindici anni; 35 ore lavorative alla settimana; tre settimane di ferie più una, in media, di malattia; pensionamento a 62 anni: tutto questo equivale a 78.960 ore lavorative in una vita. Contrapponete ora il modello seguente: scuola fino a 20 anni; pensionamento a 68 anni; settimana di 38 ore, con cinque settimane di ferie e tre settimane di scuola, più una settimana, in media, di malattia: ossia in totale 78.432 ore. Il secondo modello sarebbe, mi sembra, più civile del primo: una popolazione più istruita godrebbe meglio il suo tempo libero".
Quest'ultima sistemazione, beninteso, richiederebbe un considerevole sforzo nell'insegnamento; d'altra parte, questo sembra proprio corrispondere alle tendenze del mondo di domani: sempre meno tempo per la fabbricazione degli oggetti, ma sempre più tempo dedicato alla formazione della mente.
Circa gli effetti che potrebbe avere un prolungamento o una differente suddivisione delle ferie annuali, non si dispone di dati sufficienti che permettano precise conclusioni. È certo che il mese di vacanze in estate, dal punto di vista psicologico, ha un'innegabile attrattiva, mentre sembrerebbero spesso preferibili, per lo stato di salute dei lavoratori, brevi periodi di riposo durante il semestre invernale. Ma questo dipende evidentemente dalle condizioni climatiche del luogo di riposo.
Così pure, una minore durata del lavoro giornaliero è senza dubbio più valida di un prolungamento delle settimane di vacanza, e non solo per l'equilibrio fisiologico, ma anche per le possibilità di studio, di promozione sociale, di perfezionamento professionale e personale.
Non possiamo indicare qui tutto quello che sarebbe possibile o desiderabile riguardo alla ripartizione del tempo; le soluzioni sono infinite. Bisogna notare tuttavia l'interesse che presenta l'orario unico, che permette, lasciando per il pasto un intervallo molto breve, di avere per sé un periodo di tempo lungo e senza interruzioni. Ci sarebbe anche molto da dire a proposito del lavoro a mezzo tempo - soltanto mezza giornata con un limitato numero di ore al giorno - che sembra una soluzione valida per certe situazioni intermedie: la madre di famiglia che ha ancora il peso dei figli piccoli, le persone in età pensionabile che desiderano conservare un'attività, gli artisti... che sono alla ricerca di se stessi, certi handicappati fisici, ecc. Parleremo più avanti degli ‛orari flessibili' (v. sotto, cap. 6, § b).
Conviene qui aprire una parentesi per affermare che non esiste e non dovrebbe esistere una totale uniformità dei tempi di lavoro nei diversi mestieri. Nei campi, per esempio, l'agricoltore ha ancora un lavoro da uomo libero; essendo generalmente padrone di se stesso (ben presto non ci saranno altro che padroni nell'agricoltura), egli è padrone del suo ritmo; può chiacchierare con i vicini, fare una pausa a suo piacere quando ha fame, quando è stanco o quando vuol parlare con una bella ragazza; la sua situazione è più vicina alla condizione tradizionale e il suo tempo libero, ch'egli dichiara a volte inesistente, è mal definito, non regolamentato. Non è certo questo il caso delle attività industriali, in cui un più duro lavoro impone necessariamente orari delimitati, con precise pause di tempo libero.
I diversi ritmi di lavoro dovrebbero essere legati alla diversità di durata delle varie attività. Potrebbe dunque rivelarsi necessario in avvenire, se si dovessero realizzare nuove riduzioni della durata del lavoro, non introdurle uniformemente in tutte le attività. Per esempio, può darsi che si sarà indotti a diminuire gli orari specialmente nelle attività basate sulla forza muscolare, su lavori fisici pesanti, con occasioni di affaticamento nervoso (rumori, odori, ritmo continuo...), mentre ci si potrebbe regolare differentemente per mestieri ‛più leggeri': guardiani di museo, giovani di studio, impiegati di banca o di assicurazioni, ecc.
D'altro canto, non deve contare solamente la fatica fisica per stabilire i tempi di riposo: certi uomini, gravati da schiaccianti responsabilità ne hanno anch'essi un urgente bisogno, non foss'altro che per riflettere, dato che si trovano spesso presi in un ingranaggio di compiti che richiede 60 o 70 ore settimanali, e sono ben lontani dall'avere i mezzi di distensione a disposizione del loro usciere o del loro fattorino.
Attualmente, esistono differenze importanti tra i diversi mestieri; lasciando da parte i settori nazionalizzati, i cui orari sono stati ridotti, la gerarchia dei settori di attività è la seguente: al primo posto ci sono l'edilizia e i lavori pubblici, dove la durata giornaliera del lavoro è massima; poi vengono l'estrazione dei minerali, le industrie del legno, la costruzione di macchine e di veicoli, la produzione dei metalli (questi settori hanno durate di 49-47 ore settimanali). Per contro, nelle industrie tessili, nelle banche, nelle assicurazioni, nelle agenzie e nell'abbigliamento le durate sono solo di 44-41 ore. Questo gruppo ha una forte proporzione di manodopera femminile. Sussistono infine differenze su scala regionale: per esempio, si lavora di più nel nord-est della Francia, nella regione parigina, che nel sud-ovest.
d) L'opzione ‛durata del lavoro/livello di vita' e le ‛40.000 ore'
Le cifre citate sono importanti. Si è spesso parlato, per il futuro, della possibilità di ridurre a 40.000 ore l'intera vita di lavoro (v. Fourastié, 1972). Quali probabilità abbiamo di vivere quei tempi? Entro quali scadenze le nazioni dell'Europa occidentale potranno istituire orari del genere?
Si sa che, allo stato attuale delle cose, una riduzione di due ore settimanali delle durate medie ‛costa' circa il 2,7% del livello di vita. Ora, la crescita del livello di vita, nelle nostre nazioni, varia da una decina d'anni tra il 3 e il 4% (è preferibile per l'avvenire mantenere il ritmo del 3%). Si può dunque ammettere che ogni riduzione di due ore della durata settimanale del lavoro ritardi di quasi un anno l'innalzamento del livello di vita o, più esattamente, assorba un anno di aumento della produttività; pressoché le stesse conseguenze hanno una settimana e mezzo di ferie annue, il prolungamento di un anno dell'età media scolare e la diminuzione di un anno dell'età media di pensionamento. Ora, le 40.000 ore presuppongono: 33 anni di lavoro in tutta la vita contro i 50 attuali; 12 settimane di ferie annue contro le nostre 4 attuali; 30 ore di lavoro settimanale contro le 48. Di modo che, se scegliessimo una riduzione della durata del lavoro piuttosto che un accrescimento del livello di vita, dovremmo bloccare l'attuale livello di consumi per i tempi seguenti: a) 17 anni, per la riduzione del numero degli anni di lavoro da 50 a 33; b) 6 anni, per ottenere le 8 settimane supplementari di ferie pagate; c) 9 anni, per la riduzione di 18 ore della durata settimanale del lavoro.
Il totale risultante supera i 30 anni. Le 40.000 ore verrebbero dunque ottenute poco dopo l'anno 2000. Naturalmente, questo calcolo non vuol determinare altro che una possibilità affatto aleatoria, e la data indicata è da prendere in considerazione soltanto per valutare la probabile velocità dell'evoluzione.
5. Occupazione, disoccupazione e sottoccupazione
Tutto quanto precede conferma che l'esercizio di un'attività da parte dell'uomo va analizzato sotto due aspetti: l'uno individuale e l'altro collettivo. Riguardo all'individuo, il lavoro professionale risponde al bisogno di esercitare le facoltà del corpo e dello spirito; inoltre, in un mondo in cui il consumo di beni e di servizi non è possibile senza una preliminare trasformazione, difficile e onerosa, della natura, il lavoro individuale rappresenta la partecipazione normale dell'individuo all'opera collettiva. Riguardo alla collettività, il lavoro degli individui è, d'altra parte, necessario alla vita e alla sopravvivenza dei gruppi umani.
a) L'evoluzione della struttura dell'occupazione
Poiché i bisogni primari sono quelli legati alla nutrizione, nelle società primitive, dove le tecniche di produzione erano assai rozze e conseguentemente la produttività del lavoro molto debole, la quasi totalità del lavoro umano si doveva concentrare sull'agricoltura. Le altre attività necessarie alla sopravvivenza del gruppo (vestiario, abitazione, culti religiosi o magici, e poi, progressivamente, amministrazione, polizia, giustizia) non assorbivano che un numero molto scarso di individui. Senza risalire alla preistoria né ai gruppi più primitivi dell'attuale Amazzonia, si può ammettere che nella maggior parte delle nazioni ‛civili' l'agricoltura, nel XVI o nel XVII secolo, occupasse dall'80 all'85% dei lavoratori, l'artigianato e le manifatture dal 5 al 7% e le altre attività, che oggi vengono chiamate terziarie, quanto restava, cioè circa il 10%.
Man mano che il progresso tecnico ha fatto sentire i suoi effetti, l'umanità ne ha utilizzato i frutti dapprima per nutrirsi meglio; in particolare le carestie sono a poco a poco scomparse dalle nazioni occidentali. Ma il progresso della produttività agricola ha superato molto presto il fabbisogno alimentare degli uomini. Se i bisogni umani si fossero limitati al nutrimento, avremmo assistito allora a una riduzione graduale, ma in definitiva massiccia, della durata del lavoro. Per esempio, verso il 1700 un agricoltore francese, italiano o americano non arrivava a nutrire, in media, che 2,2 persone (il che significava che 10 lavoratori agricoli arrivavano, in media, a nutrire, oltre se stessi, altre 12 persone). Oggi, pur assicurando un nutrimento molto più abbondante e molto più equilibrato, comprendente in particolare una proporzione molto maggiore di carne (che richiede, a egual numero di calorie, una quantità di lavoro umano quasi 10 volte maggiore che non i cereali), un agricoltore americano nutre quasi 75 persone e un agricoltore francese più di 20. Queste cifre mostrano che, nell'ipotesi sopra enunciata, gli Stati Uniti avrebbero potuto ridurre la durata del lavoro nella proporzione di 75 a 2,2 e la Francia nella proporzione di 20 a 2,2. Ciò significa che negli Stati Uniti si potrebbe lavorare solo circa mezz'ora per ogni giorno lavorativo e in Francia 1 ora e 20 minuti!
Se le cose non stanno così, si deve al fatto che gli uomini si sono rivelati avidi di consumare una quantità di altri beni e servizi che non erano prodotti nei secoli passati o che lo erano solo in quantità assai scarse (per esempio, i manufatti di ogni genere, le automobili, gli aeroplani, ecc.). Il risultato è stato che la popolazione attiva in eccedenza nell'agricoltura (settore primario) ha cercato e ha trovato occupazione nell'industria (settore secondario) e poi nel settore terziario. L'incremento del settore secondario è stato nel corso del XVIII e XIX secolo così spettacolare da far dare al movimento il nome di ‛rivoluzione industriale'. E, a partire all'incirca dal 1900, nelle nazioni più progredite gli aumenti di produttività nel settore secondario sono tali che bastano ad assicurare il consumo, che pure è sempre in forte crescita. L'occupazione nell'industria rimane dunque stazionaria, nelle nazioni evolute, a cifre che non sorpassano di molto il 50% e sono anche molto inferiori nelle nazioni il cui commercio estero non sia basato sui prodotti industriali. Essendo quindi pressoché fermo il settore secondario, il terziario assorbe la totalità dei lavoratori che continua a perdere l'agricoltura. La tab. IV ci dà un'immagine statistica di questo movimento.
b) Disoccupazione e sottoccupazione
Leggendo le righe precedenti, può sembrare che i trasferimenti della popolazione attiva si verifichino senza difficoltà in un economia idillicamente progressiva, in cui gli uomini si troverebbero trasferiti senza scosse e senza sofferenze dal settore primario a quello terziario. Disgraziatamente non è affatto così. Non esiste infatti alcun meccanismo automatico che assicuri questo trasferimento nella specifica concretezza della vita quotidiana. Soltanto la rovina delle imprese, la disoccupazione e la sottoccupazione obbligano gli uomini a cambiare mestiere. Senza entrare nei particolari di questi processi complicati che sono di competenza della scienza economica, si comprende abbastanza facilmente come si tratti di processi dolorosi, che dipendono essenzialmente dall'intervallo che esiste inevitabilmente tra il momento in cui l'occupazione di un uomo nel proprio mestiere diventa inutile e il momento in cui egli troverà un'altra occupazione o un altro mestiere.
Sono questi i processi che danno luogo a ciò che nei paesi sviluppati si chiama disoccupazione. La lotta contro la disoccupazione o, inversamente, la lotta per la piena occupazione, è stata e resta uno degli aspetti più importanti della politica sociale contemporanea. L'obiettivo della piena occupazione figura a chiare lettere nella Carta delle Nazioni Unite.
Gli elementi essenziali della lotta contro la disoccupazione sono l'informazione e l'orientamento professionale da una parte, le misure finanziarie atte a facilitare le riconversioni dall'altra. Circa il primo punto troviamo gli sforzi per adattare la scuola ai mestieri richiesti dallo sviluppo economico e per ridurre, al contrario, le formazioni professionali tipiche dei mestieri superati, come pure le misure amministrative e i regolamenti relativi alla ‛formazione professionale accelerata'; inoltre, la costituzione di pubblici uffici di collocamento e gli aiuti materiali intesi a favorire la mobilità geografica della manodopera hanno dato notevoli risultati. Le misure finanziarie ed economiche riguardano soprattutto le imprese: riconversione di attività, creazione di nuove attività in territori precedentemente agricoli, ecc.
Nei paesi sviluppati, infine, le indennità individuali di disoccupazione, che non sono tuttavia che un ripiego, sono diventate quasi uguali a piccoli salari e permettono di attendere la pensione a tutta una categoria di lavoratori anziani, difficilmente riconvertibili.
Nei paesi non sviluppati e nei paesi dell'Est a regime comunista, il problema dominante non è la disoccupazione, ma la sottoccupazione. In effetti, non essendo l'impresa sottoposta al controllo dei suoi prezzi di costo da parte del profitto, la tendenza a conservare lavoratori inutili o poco utili è incoercibile. L'assenza di disoccupazione ha dunque come contropartita un eccesso di manodopera per un lavoro determinato. Non è possibile limitare questi eccessi se non attraverso ispezioni e controlli amministrativi, che sono evidentemente molto difficili e comportano in pratica decisioni di natura politica.
Nei paesi sottosviluppati non socialisti, la sottoccupazione assume un carattere più doloroso: gli uomini in soprannumero nelle campagne, dove già non trovano che un impiego insufficiente, affluiscono verso le città, dove si trovano ugualmente in soprannumero. Mancando imprese sufficienti per assorbirli, si ammassano nelle bidonvilles, in cui sopravvivono suddividendosi salari irrisori. Il problema della sottoccupazione, drammatico in tutto il Terzo Mondo, è l'aspetto più importante del conflitto tra progresso economico e progresso demografico.
c) Lotta contro la disoccupazione e la sottoccupazione
La paura della disoccupazione tecnologica è una reazione naturale dell'uomo che vede la macchina sostituirlo nel suo lavoro. Questa paura comparve sin dall'introduzione delle prime macchine nelle officine e basta citare i massacri di Peterloo in Gran Bretagna per ricordare quanto violenta sia stata, all'inizio del sec. XIX, la rivolta dei lavoratori contro le macchine, e quanto crudele la repressione.
Questa paura trova il suo fondamento nei licenziamenti che vengono effettuati in numerose imprese in seguito all'installazione di nuove macchine o a una migliore organizzazione del lavoro negli stabilimenti. Siffatte misure impressionano, giustamente, non soltanto i lavoratori che ne sono oggetto, ma anche i loro compagni, che cercano di difendersi da un tale pericolo.
I progressi rapidi dell'automazione risvegliano la paura di una disoccupazione non più limitata ad alcuni casi particolari, ma massiccia e generale.
La naturale paura degli operai non sembra tuttavia giustificata. Anzitutto, è fondamentale sapere che non ogni progresso tecnico si traduce necessariamente in una riduzione del bisogno di manodopera. Circa gli effetti sull'occupazione, bisogna distinguere nettamente due categorie di progresso. Gli uni, i progressi ‛recessivi', costituiscono un ampliamento della sfera dell'uomo rispetto a quella della natura: ne sono un esempio, in agricoltura, tutte le tecniche che danno all'uomo la possibilità di ricavare dal suolo la stessa quantità di prodotti con minore manodopera e in minor tempo. I progressi ‛processivi', invece, costituiscono un ampliamento della sfera della natura rispetto a quella dell'uomo. Così, la scoperta di materie prime amplia il quadro dell'economia, e lo sviluppo industriale che ne risulta porta alla creazione di nuovi posti di lavoro. La scoperta di un nuovo prodotto: l'automobile o la radio, per esempio, agisce nella stessa direzione. Lo sviluppo dell'industria automobilistica in un paese come la Francia, in cui non ha tuttavia la stessa importanza che negli Stati Uniti, si è tradotto in una richiesta considerevole di manodopera: si stima infatti che il numero di persone che vivono dell'automobile, siano essi operai nelle officine di fabbricazione delle vetture, conducenti o garagisti, sia superiore a un milione (1 persona attiva su 20).
I progressi recessivi permettono all'uomo di soddisfare con meno lavoro i propri bisogni precedenti; quelli processivi, al contrario, soddisfano bisogni che non potevano essere soddisfatti per l'innanzi (si dice, talvolta, in modo inesatto, che il progresso crea nuovi bisogni); danno vita, dunque, a nuovi lavori.
Ora, si stabilisce un equilibrio tra i progressi processivi e quelli recessivi? Il progresso tecnico, a parità di occupazione, accresce il volume della produzione. Ma l'effetto di una produzione crescente sul consumo dipende dal grado di saturazione del mercato. In un'economia poco sviluppata, dove la popolazione soffre di sottoalimentazione, un progresso tecnico nell'agricoltura si traduce in un accrescimento del consumo dei prodotti alimentari. In un'economia più sviluppata, dove la popolazione ha un'alimentazione sufficiente, lo stesso progresso non porterà a una crescita del consumo.
A partire dal 1935, cominciò a farsi strada l'opinione che lo Stato poteva lottare contro la disoccupazione e la sottoccupazione. Da una parte, negli Stati Uniti, furono varati grandi programmi di interventi pubblici; dall'altra J. M. Keynes, economista di fama mondiale, raccomandò vivamente di stimolare le economie in fase depressiva attraverso provvedimenti monetari e finanziari. Nel 1944, il libro di W. H. Beveridge Full employment in a free society ebbe una grande risonanza.
Dopo la guerra, la responsabilità dello Stato in materia di occupazione è stata affermata in tutte le nazioni del mondo. Fin dal 1942, il Regno Unito aveva adottato il principio del Piano Beveridge. La Carta delle Nazioni Unite fa della piena occupazione uno degli obiettivi di tutta la politica economica e sociale. Nel 1962, il Congresso degli Stati Uniti approvò il Man-power development and training act. La Costituzione francese dà esplicitamente allo Stato l'incarico di adoperarsi per la piena occupazione.
Da allora l'azione rivolta verso la piena occupazione fu condotta su due linee. La prima, in cui domina l'empirismo e una quantità di iniziative differenti si sovrappongono senza una pianificazione preliminare, fu adottata quasi esclusivamente dai paesi anglosassoni fin verso il 1965. La seconda, più sistematica, legata alla previsione dello sviluppo economico, imperniata su una previsione dell'occupazione per settori di attività collettiva e per tipi di qualificazione individuale, fu elaborata a partire dal 1950 soprattutto in Francia, nel quadro del Commissariat général au plan.
Fra gli interventi destinati a garantire e a sviluppare l'occupazione, si possono dunque distinguere quelli che sono specifici di questo o quel problema del lavoro e quelli che si rivolgono all'economia nel suo insieme.
Allorché i governi cominciarono a prender coscienza delle loro responsabilità e dei loro poteri in materia di occupazione, la loro tendenza spontanea fu il ricorso a interventi specifici, ‛puntuali', imposti dal luogo, dal tempo e dalle circostanze propri del problema da risolvere: le prime iniziative assunsero la forma di aiuti ai disoccupati e campagne di lavori pubblici. Ai nostri giorni, l'arsenale dei mezzi specifici si è largamente accresciuto.
Data per scontata l'instabilità fondamentale dell'occupazione in periodi di progresso tecnico ed economico, uno dei primi requisiti di ogni azione è un'informazione, la più vasta e la più precisa possibile, dei candidati all'occupazione, dei datori di lavoro, degli insegnanti e dei poteri pubblici circa il mercato del lavoro, la sua situazione locale e la sua probabile evoluzione.
Per il singolo, quest'informazione deve vertere non solo sulle prospettive del mercato locale o regionale del lavoro (o anche nazionale e, al limite, mondiale), ma sulle sue stesse capacità personali di svolgere, o di prepararsi a svolgere, una certa mansione. Di qui il ricorso a consulenti per l'orientamento professionale, idonei a informare contemporaneamente sulle offerte di lavoro da parte dei datori di lavoro e sulle attitudini psicologiche e fisiche degli uomini, delle donne e dei giovani in cerca di lavoro. Oggi, tutte le grandi nazioni hanno creato, e poi sviluppato sotto nomi diversi (Agence Nationale de l'Emploi, Bureaux Nationaux ou Regionaux de l'Emploi, Information for Career Guidance, ecc...), organismi sparsi su tutto il territorio, destinati a favorire un collegamento, sia sul momento che in prospettiva, tra l'offerta e la domanda di lavoro. È però evidente che la complessità delle economie più progredite e la rapidità della loro evoluzione rendono questo adeguamento sempre imperfetto.
In molti casi questi problemi si acuiscono notevolmente su scala regionale. L'intervento tende allora sia ad accrescere la mobilità della popolazione dalle regioni meno favorite verso le altre, sia a stimolare l'economia delle regioni arretrate (per es., la pianificazione regionale in Francia; negli Stati Uniti s'è avuta una quantità di interventi diversi, che vanno dal Trade expansion act del 1962 e dal Revenue act del 1964 all'Indian affairs mobility program).
Questi interventi, a seconda dei paesi, delle regioni e dei tempi, prendono forme assai diverse, che cambiano continuamente. In certi casi, come nella Gran Bretagna a partire dal 1960 e soprattutto dal 1965, il problema essenziale non è più quello di ridurre la disoccupazione, ma di accrescere l'efficienza di quelli che lavorano.
Gli interventi suddetti, anche se condotti a fondo e con la massima sensibilità, non possono annullare né la disoccupazione né gli effetti dolorosi del mutamento di occupazione. Certi economisti arrivano anche a considerare come incompatibili la piena occupazione e la stabilità dei prezzi; altri giudicano che la piena occupazione comporti necessariamente un notevole rallentamento del progresso economico. Comunque sia, i tassi più bassi di disoccupazione restano, nelle nazioni occidentali, superiori all'1%. Questo minimum di disoccupazione si spiega con gli inevitabili trasferimenti e con una reale ‛incapacità di adattamento' di certi uomini a un lavoro regolare.
Tutte le nazioni sviluppate cercano oggi di attenuare le sofferenze umane attraverso vari sistemi di sussidi ai disoccupati, di sicurezza sociale, di imposte sul reddito negative, di assicurazioni contro la disoccupazione, di aiuti alla riqualificazione o alla riconversione, ecc.
Alcuni di questi aiuti finanziari o tecnici vengono elargiti alle stesse imprese, per spronarle a riconvertirsi senza procedere a licenziamenti di manodopera ma organizzando esse stesse il planning di riqualificazione del personale.
Dopo Keynes si è compreso che, a questi molteplici interventi puntuali, si potevano aggiungere politiche globali della fiscalità, della moneta e del credito. Ma solo recentissimamente si è cominciato ad affermare il bisogno di una vera politica dell'occupazione, collegata a - e fondata su - una politica economica d'insieme.
È chiaro, per chi abbia letto l'inizio di questo articolo, che i difficili e mutevoli problemi dell'occupazione e della sottoccupazione non possono essere separati dall'insieme dei problemi dello sviluppo economico e sociale. Fu questa, a partire dal 1945 e soprattutto dal 1950, l'idea-forza dei Plans francesi, lo spirito dei quali era stato definito da J. Monnet. Sia lo spirito informatore che i metodi sono esposti nei Rapports della Commissione per la manodopera del Commissariat gènéral au plan (cfr. in particolare quelli del 1954, 1958, 1961 e 1966); questi rapporti hanno però avuto scarsa influenza e scarsa risonanza all'estero, dove, malgrado la notorietà della pianificazione francese, le idee keynesiane conservano tutto il loro prestigio e dove, di conseguenza, le procedure monetarie sembrano la forma più compiuta e più ‛globale' possibile di politica dell'occupazione.
Il perdurare e persino, si può dire, l'aggravarsi del ‛marasma' economico britannico, e soprattutto, forse, la comparsa di una perniciosa inflazione monetaria negli Stati Uniti, che ineluttabilmente si estende all'intero mondo occidentale, spingono almeno dal 1968 la maggior parte dei grandi paesi alla revisione della loro politica dell'occupazione, e anche di tutta la loro strategia monetaria, economica e sociale. Quel che A. Stoffier ha chiamato future shock e Z. Brzezinski l'‛eta tecnetronica' riguarda sicuramente anche la politica dell'occupazione: la crisi profonda della civiltà industriale avanzata obbliga a integrare i problemi dell'occupazione e della sottoccupazione in un contesto infinitamente più vasto di quello costituito dagli uffici di collocamento, dagli incoraggiamenti alla mobilità, dai prezzi, dalla fiscalità e dalla moneta.
È dunque verso una strategia d'insieme, comprendente non soltanto i problemi monetari e finanziari, ma la globalità dei problemi economici, sociali e culturali, che sembrano doversi orientare le politiche dell'occupazione. Ne sono indizi, per esempio, gli emendamenti successivamente apportati negli Stati Uniti al Man-power development and training act e al Vocational education act, l'istituzione delle Conferenze industriali tripartite in Giappone e la nozione di ‛relazioni industriali', sviluppatasi, come si è detto, nella Gran Bretagna.
Più in generale, il posto dato ai problemi dell'occupazione nelle grandi ricerche prospettiche delle Commissioni economiche dell'ONU e dell'OCDE testimonia lo sforzo intrapreso per collocare i problemi dell'occupazione in un quadro economico e sociale molto più ampio che in passato.
6. Prospettive del lavoro
Le pagine precedenti permettono di comprendere facilmente che il lavoro umano, in pieno mutamento, continuerà a evolversi assai profondamente nel corso dei prossimi anni. Si può tentare di classificare in tre categorie le questioni sul tappeto: i problemi già affrontati e più o meno mal risolti; i problemi già posti in modo serio ma non risolti; infine i problemi appena formulati.
a) I problemi già affrontati
I problemi già affrontati, ma mal risolti, sono innumerevoli. Ricorderemo solo i più importanti, tutti comunque dominati dall'opzione: durata del lavoro/livello di vita. Il problema è sapere se manterremo la durata del lavoro così com'è oggi, o se la ridurremo e in che misura: donde la necessità di una scelta, in quanto sappiamo che ridurre la durata del lavoro, data una certa produttività, significa ridurre anche la produzione e perciò il livello di vita. Questo problema è già stato prospettato prima ed è in realtà classico; qui bisogna però ripetere che le decisioni da prendere sono legate a una concezione della felicità e dell'equilibrio della vita. La tendenza attuale resta quella di sacrificare il genere di vita al livello di vita; essa ingenera una vita frenetica, durante la quale l'uomo consuma con frenesia quanto egli stesso produce con frenesia. È molto probabile che si sia vicini ai limiti tollerabili da parte dell'uomo medio e che l'avvenire vedrà, partendo dagli eccessi, un ritorno ai valori della saggezza.
Da almeno un ventennio le preoccupazioni di umanizzare il lavoro sono dappertutto all'ordine del giorno. È da parecchio tempo, infatti, che Friedmann ha denunciato gli inconvenienti del ‛lavoro in frantumi'. Tale lavoro - specializzato, come abbiamo detto, per motivi d'efficienza - risulta in effetti mal sopportato da uomini il cui livello di vita e il cui livello culturale non cessano di aumentare. Il nostro tempo presenta il paradosso di milioni di operai qualificati il cui livello di vita ha lo stesso ordine di grandezza di quello dei quadri superiori di 30 anni or sono, ma il cui lavoro resta elementare, parcellizzato, ripetitivo, a compartimenti stagni, limitato.
La frantumazione del lavoro non è, d'altra parte, il solo fattore di insoddisfazione; anche lo stato di soggezione dell'operaio nel suo lavoro viene avvertito con grande disagio. Un caso particolare è indicativo al riguardo: il mestiere di domestica tuttofare non è affatto parcellizzato; continua ad abbracciare tutti gli atti della vita quotidiana di cui ha necessità la vita familiare; eppure è oggetto di una disaffezione così profonda che il personale domestico sarebbe già praticamente scomparso nei paesi ricchi se non fosse stato in parte alimentato dall'immigrazione. Oggi una ragazza preferisce un lavoro ‛in frantumi' da operaia qualificata al lavoro variato della casa, nonostante salari spesso superiori. La causa sta nel rifiuto di un rapporto servile.
Finora si è più o meno tentato di risolvere empiricamente questi problemi con una quantità di mezzi differenti, come la gerarchia dei salari, il cottimo a unità, il cottimo a compito e una quantità di altri congegni salariali, l'avanzamento, la selezione, l'orientamento, la formazione professionale. L'uso sempre fluttuante di questi mezzi ingenera una profonda instabilità non soltanto dei salari, ma anche dei regolamenti di fabbrica e della stessa definizione delle mansioni. Le qualifiche, per esempio, sono incessantemente in movimento; altro esempio: i livelli di remunerazione sono anch'essi incessantemente rimessi in discussione. Per dare un'idea dell'ampiezza del movimento, basterà notare che una domestica a ore, in una città come Parigi, guadagnava nel 1910 la quarta parte di quel che guadagnava un manovale, mentre oggi guadagna circa il 20% in più.
Non si può trovare alcuno schema generale in grado di semplificare la descrizione delle oscillazioni e dell'instabilità che ne risulta. La ‛meritocrazia' (che consisterebbe nel dare una maggiore remunerazione a una maggiore efficienza) si mescola irrazionalmente allo squilibrio tra l'offerta e la domanda in certi mestieri e in certe specialità. Tutto sommato, non si può far altro che constatare l'instabilità cronica di un mal definito empirismo.
b) Gli sviluppi in corso
In questo empirismo privo di una linea generale d'evoluzione, prevalso dal 1920 al 1970, due orientamenti hanno cominciato, da qualche anno, a farsi strada. Essi sono ancora troppo recenti perché si possa giudicare la loro vitalità profonda; fanno nondimeno bene sperare. Sono per lo più designati con i termini di ‛orario flessibile' e di ‛antitaylorismo'.
Il sistema degli orari flessibili consiste nel dare ai lavoratori la libertà di scegliere i propri orari di lavoro, pur nel quadro, evidentemente, di una regolamentazione e di una durata globale prefissata. Per esempio, il salariato che ha una giornata di 8 ore potrà cominciare il suo lavoro in un momento di sua scelta, tra le ore 8 e le 10 del mattino. Se comincia alle 9,07, lavorerà quindi fino alle 17,07. Il regime presuppone un periodo di tempo (nel nostro caso, dalle 8 alle 10 e poi dalle 16 alle 18) in cui l'ufficio, o l'officina, ‛girano' con gli effettivi incompleti: questo è il principale inconveniente del sistema dal punto di vista della produzione, cioè dal punto di vista dell'impresa. Si ottiene però, come contropartita, un vantaggio importante: diminuisce cioè l'assenteismo e scompaiono i ‛rosicchiamenti' d'orario. Tutto il personale timbra il cartellino, dal manovale al presidente, e ciascuno viene pagato in base al suo orario reale.
Il salariato perde evidentemente i suoi vantaggi in fatto di rosicchiamento d'orario che sono però, in molte imprese, di lieve entità. Egli guadagna enormemente, al contrario, in fatto di indipendenza e di elasticità. Diventa inutile prendere un treno che parte mezz'ora prima perché il seguente arriva quattro minuti dopo; diventa inutile correre quando si è in ritardo; diventa inutile la richiesta di autorizzazioni ad assentarsi per piccoli impegni. L'esperienza dimostra che i salariati, spesso reticenti prima di farne l'esperienza, si attaccano presto all'orario flessibile, tanto che diventa impossibile ritornare al regime precedente. L'evoluzione avviene, in genere, nel senso di una elasticità sempre maggiore; e l'impresa, alla fine, deve resistere a una tendenza all'allargamento dei varchi. Vengono anche sperimentati, attualmente, regolamenti che consentono ai lavoratori di trasferire crediti di ore da una settimana all'altra, persino da un mese all'altro. Per esempio, nel caso sopracitato di una giornata di 8 ore, un salariato potrebbe fare una settimana di 50 ore, e nella settimana successiva fare soltanto 3 giorni di 10 ore.
Ci si deve rammaricare del nome di ‛antitaylorismo' dato alla tendenza a diminuire la rigidità del lavoro alla catena e, più in generale, del lavoro che richiede mansioni ripetitive. C'è infatti da presumere che, nelle circostanze attuali, se fosse ancora tra di noi, Taylor sarebbe un pioniere dell'antitaylorismo. Si tratta infatti di definire il lavoro industriale non più in funzione del rozzo manovale del 1900, ma in funzione delle capacità d'attenzione, d'adattamento, di comprensione e d'iniziativa dei giovani operai d'oggi. Questi ultimi sono infatti da una parte molto più istruiti e dall'altra molto più creativi dei loro bisnonni di 70 anni or sono. Sono molto più esigenti nei riguardi dell'impresa, ma sono anche capaci di dare ad essa un contributo molto maggiore. Partendo da questo fatto, si tratta quindi di organizzare il lavoro in funzione di squadre che abbiano un'autonomia relativamente larga, sia nella loro costituzione che nella ripartizione delle mansioni tra i membri. Se la sfera di attività è abbastanza vasta, i membri della squadra possono occupare a turno i differenti posti di lavoro, rompendo così almeno in parte la monotonia del lavoro o riducendone la pesantezza. Beninteso, un tale orientamento non trasformerà certo in un piacere permanente il lavoro industriale. Si può tuttavia pensare ch'esso sia un anello importante di un'evoluzione destinata senza dubbio a non aver mai termine.
Un'altra notevole tendenza di questi ultimi anni è quella alla mensilizzazione del salario. Si sa che, tradizionalmente, e in particolare dall'inizio della rivoluzione industriale, gli operai erano pagati a ore, mentre gli impiegati venivano pagati a mese. Questa differenza era una di quelle che separavano ‛i colletti blu' dai ‛colletti bianchi'; e per gli operai si materializzava in un computo molto più rigoroso delle ore di lavoro effettivo e in una moltitudine di regolamenti che rendevano la loro occupazione assai instabile. Per tutto il primo periodo del sec. XX c'è stata un'evoluzione convergente, tendente non solo ad accrescere la stabilità dell'occupazione e la retribuzione dei lavoratori ‛a mese', ma anche ad avvicinare lo status dei lavoratori ‛a ora' a quello dei lavoratori ‛a mese'. Un passo ancor più decisivo è stato fatto alcuni anni or sono: lo status di lavoratori ‛a mese' è stato accordato a un numero crescente di operai. Così, in Francia si è passati, dal 1970 al 1973, da una situazione in cui meno del 10% degli operai aveva lo status di lavoratori ‛a mese', a una situazione in cui tale status è prerogativa di quasi i quattro quinti.
Si può così pensare che la distinzione tra operai e impiegati, per tanto tempo cruciale, sparirà quasi completamente. Quest'evoluzione è parallela a quella che ravvicina da una parte le condizioni di lavoro e dall'altra i livelli culturali di tutti i salariati. Resta nondimeno il fatto che in alcuni paesi, come la Francia, la remunerazione degli impiegati e dei quadri rimane nettamente più alta di quella degli operai, mentre questo non accade in altri paesi, quali la Germania, gli Stati Uniti e i paesi dell'Europa orientale.
Questi fatti danno un'idea dei cambiamenti in atto, sia nella realtà sia nelle idee, che rendono i problemi del lavoro uno dei settori attualmente in più rapida evoluzione in una società in pieno rivolgimento. In essi le organizzazioni internazionali quali per esempio, l'Ufficio Internazionale del Lavoro (BIT) e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCDE) svolgono un ruolo molto importante. L'OCDE, che raggruppa, com'è noto, le nazioni occidentali, il Giappone, la Finlandia, l'Australia e la Iugoslavia (con statuto speciale) convocò nel 1974 un'importantissima Conferenza sul lavoro nelle società industriali. L'Ufficio Internazionale del Lavoro, che raggruppa praticamente tutte le nazioni del mondo, a partire dal 1919 ha svolto un ruolo molto importante riguardo sia alla regolamentazione che alla realtà effettiva del mondo del lavoro. Oltre alle sue sessioni abituali e in occasione del suo cinquantesimo anniversario, il BIT ha lanciato la preparazione del suo Programma mondiale dell'occupazione, la cui maggiore preoccupazione è quella di adattare l'economia dei paesi in via di sviluppo alla formidabile crescita demografica che li caratterizza fin dal 1960 e che è destinata ad aumentare ancora dal 1975 al 1985.
c) I problemi dell'avvenire
Per ampie che siano queste ricerche e per numerose e diverse che siano le ricerche analoghe intraprese e perseguite in tutti i grandi paesi industriali e in parecchi dei paesi in via di sviluppo, esse sembrano destinate a prendere uno slancio ancora maggiore nel prossimo avvenire e a richiamare ancor più l'attenzione. Il fatto è che il lavoro è un fattore essenziale della condizione umana e la presente crisi della civiltà comporta quindi un nuovo atteggiamento dell'uomo nei suoi confronti.
Come si è detto nell'introduzione, il lavoro era da millenni un elemento della condizione umana, in un senso simile a quello in cui potremmo dire ch'esso lo è per gli animali: un processo vitale che non si può distinguere dalla vita stessa e che mette in opera le forze stesse della vita. Le tecniche scientifiche ci hanno insegnato a distinguere il lavoro dalle altre manifestazioni della vita e a giudicarlo secondo criteri di efficienza.
Al limite, un lavoro così concepito può essere nello stesso tempo molto efficiente e molto costrittivo per l'uomo che lo compie, molto ‛specializzante' e molto ‛disumanizzante'. È chiaro che l'umanità non potrà accettare indefinitamente di sottoporre il lavoro al solo criterio dell'efficienza; e questo sia perché, avendoci l'efficienza consentito l'accesso a un alto potere di consumo, non si può più concepire che uomini con un alto livello di vita (pari a quello delle classi dirigenti di ieri) accettino un lavoro da robot (come gli operai qualificati di oggi); sia perché i problemi di efficienza sono destinati a passare in secondo piano, dato che la rarefazione delle materie prime e dello spazio vitale obbligherà l'umanità, più presto di quanto essa lo desideri, a metter fine alla crescita economica.
I problemi del lavoro, quindi, dovranno esser pensati daccapo nella prospettiva stessa della vita. Daccapo l'uomo chiederà al suo lavoro un modo di essere, un modo di esistere.
Guardando la gente quando fa dello sport, per esempio uomini e donne sui campi di sci, ho pensato spesso al contrasto esistente tra l'attività volontaria e l'attività salariata. Nel primo caso la gente fa volentieri lunghi spostamenti molto gravosi per poter poi compiere faticosi e pericolosi esercizi; nel secondo, le stesse persone, protestando contro il loro sfruttamento da parte dell'impresa o dello Stato, compiono un lavoro remunerato e molto meno faticoso. Il contrasto, senza alcun dubbio, è dovuto anzitutto alla libertà d'iniziativa e poi all'ambiente. Non si potrebbe, non si potrà mai trovare nel lavoro professionale la duplice soddisfazione di compiere, in un ambiente gradevole, azioni che realizzino l'individuo, la ‛persona'?
Allo stato attuale delle cose, queste soddisfazioni le troviamo già certamente in certi mestieri privilegiati e in persone privilegiate, persone cioè che presentano un adattamento particolarmente buono al loro mestiere (per es. uomini di lettere, professori, artisti, ma anche ingegneri, commercianti, uomini politici, sindacalisti militanti, ecc.). Si potrà senza dubbio estendere la gamma di questi mestieri, soprattutto se si accetta, come si è detto sopra, di non far più della produttività l'unico criterio per l'organizzazione del lavoro.
Sembra tuttavia chiaro, per quanto si può umanamente prevedere, che molti mestieri resteranno poco attraenti, fisicamente e psichicamente faticosi. Per questi mestieri i soli compensi prevedibili restano le alte remunerazioni e la breve durata del lavoro. Per i più duri, come quelli dei metallurgici o degli spazzini delle città (finché non si sarà potuto sostituire con canalizzazioni urbane gli attuali sistemi di autocarri con cassoni ribaltabili), si prenderà certamente in considerazione l'idea di servizi civili, analoghi al nostro servizio militare.
Ma c'è un fattore che può dare a questi gravi problemi una svolta inattesa e, in fin dei conti, abbastanza bizzarra. Come oggi si vedono, per esempio, i minatori di carbone e gli operai degli altiforni denunciare la faticosità del loro lavoro e nello stesso tempo rifiutare un mutamento o uno scambio (preferendo, in ultima analisi, monetizzare in salario il loro disagio), allo stesso modo vedremo molto probabilmente che la rarefazione del lavoro gli conferirà nella mente degli uomini una considerazione, un prestigio molto differenti da quelli di cui gode al giorno d'oggi. Presto o tardi, dato che le tecniche scientifiche non cesseranno di perfezionarsi mentre al contrario la crescita economica dovrà rallentare e poi arrestarsi, la durata del lavoro necessario alla produzione nazionale si ridurrà a valori bassi. Già oggi vediamo la gente ricercare volentieri il ‛lavoro nero' (oltre gli orari regolamentari). Quando la durata del lavoro sarà ridotta a 40.000 ore in una intera vita, è probabile che il lavoro diventerà molto ricercato.
bibliografia
Begué, J., La montée des emplois tertiaires, in ‟Économie et statistique", 1969, II, pp. 33-41.
Bloch, G., Praderie, M., La population active dans les pays développés, Paris 1966.
Bureau International du Travail (BIT), Le monde du travail, face à l'age nouveau, Genève 1969.
Chalendon, M. (a cura di), L'horaire variable ou libre. L'aménagement des temps de travail au niveau de la journée. Rapport du groupe d'études réuni à la demande du Premier Ministre, Paris 1972.
Crozier, M., Le monde des employés de bureau, Paris 1965.
Fourastié, J., Les 40.000 heures, Paris 1972.
Fourastié, J., Pourquoi nous travaillons, Paris 1973.
Friedmann, G., Où va le travail humain?, Paris 1951 (tr. it.: Dove va il lavoro umano?, Milano 1955).
Friedmann, G., Le travail en miettes. Spécialisation et loisirs, Paris 1956 (tr. it.: Lavoro in frantumi. Specializzazione e tempo libero, Milano 1960).
Friedmann, G., Naville, P., Traité de sociologie du travail, Paris 1962 (tr. it.: Trattato di sociologia del lavoro, Milano 1963).
Grossin, W., Le travail et le temps. Horaires, durées, rythmes. Une enquête dans la construction mécanique et électrique dans la région parisienne, Paris 1969.
Herzberg, F., Le travail et la nature de l'homme, Paris 1971.
Lacroix, J., Bartoli, H., Destanne de Bernis, G., Perroux, F., Le travail, Paris 1963.
Organisation pour la Cooperation et le Développement Économique (OCDE), Main d'oeuvre et affaires sociales. Programmes travailleurs/employeurs. Les nouvelles attitudes et motivations des travailleurs. Rapport d'une réunion d'experts nationaux, Paris 1972.
Rustant, M., Les Français travaillent-ils trop?, in ‟Analyse et prévision", 1970, III, pp. 535-561; IV, pp. 609-628.
Taylor, F. W., Shop management, New York-London 1911 (tr. it.: L'organizzazione scientifica del lavoro, Milano 1952).
Taylor, F. W., The principles of scientific management, New York-London 1911.
Vernières, M., Travail et croissance. Essai sur le rôle du facteur travail au cours du processus de croissance, Paris 1972.
Diritto del lavoro di Gino Giugni
sommario: 1. La legislazione sociale e il diritto del lavoro. 2. La dottrina. 3. I contenuti. 4. Il contratto di lavoro: origine e costruzione giuridica. 5. I limiti dell'autonomia individuale. 6. La libertà e l'organizzazione sindacale. 7. Il contratto collettivo di lavoro. 8. Lo sciopero. 9. Le innovazioni delle strutture e delle tecniche giuridiche. 10. Le frontiere attuali del diritto del lavoro. 11. Le ideologie e i modelli normativi. □ Bibliografia.
1. La legislazione sociale e il diritto del lavoro
La formazione del diritto del lavoro come area normativa o disciplina speciale è un fenomeno tipico di questo secolo. Le prime leggi protettive, che costituiscono la più immediata risposta alla ‛questione sociale' e riguardano particolarmente il lavoro delle donne e dei fanciulli o la materia degli infortuni, fanno invero la loro comparsa nel pieno sec. XIX. Il primo Factory act inglese è del 1833; la prima legge francese sul lavoro dei fanciulli è del 1841. Il più tardivo avvento della legislazione sociale negli altri paesi dipende da vari fattori, riferibili o meno ai tempi di sviluppo del sistema produttivo industriale; in Italia esso è dovuto certamente allo sviluppo industriale tardivo; negli Stati Uniti si spiega con la forte resistenza opposta dalle classi proprietarie in nome dei principi di non intervento e di libertà contrattuale; nella Germania guglielmina, invece, la legislazione sociale nasce nella penultima decade del sec. XIX, ma è coeva con le leggi speciali antisocialiste.
Già in questo periodo si delineano un modello liberale d'intervento, di cui è antesignana l'Inghilterra, e uno di tipo autoritario e paternalistico, che caratterizza la Germania imperiale. Il modello liberale corrisponde in genere a condizioni di egemonia politica della borghesia industriale; l'altro, al protrarsi del potere dei ceti agrari e delle caste militari, nonché al parziale perdurare di strutture produttive corporative. L'intervento sociale nell'ambito di regimi autoritari troverà la più coerente espressione nei regimi fascisti.
Questi primi interventi legislativi, pur essendo ricchi di contenuti innovativi di per sé idonei a porre le prime basi per un nuovo diritto, non danno luogo tuttavia a una compiuta elaborazione scientifica fino al nuovo secolo. Essi appaiono in un primo tempo come massi erratici nel gran mare del diritto e in specie del diritto civile. Con singolare sincronia, invece, nei primi dieci anni del sec. XX escono opere sistematiche di alto impegno, dovute ad autori prestigiosi o destinati a diventare tali, che pongono le fondamenta del diritto del lavoro. Rammentiamo in proposito tra i più significativi: Ph. Lotmar e H. Sinzheimer in Germania, P. Pic e (per il diritto dei sindacati) M. Leroy in Francia, L. Barassi e G. Messina in Italia. D'altro lato il famoso Industrial democracy di S. e B. Webb, studio non ispirato da metodologia giuridica, o l'opera delle scuole istituzionalistiche americane (J. R. Commons, J. C. Adams), influenzate dall'europeo ‛socialismo della cattedra', svolgono nei rispettivi paesi un ruolo analogo, e cioè quello di porre sotto la lente dell'osservazione scientifica il nuovo tessuto istituzionale che si era venuto formando soprattutto nella seconda metà del sec. XIX: le leghe operaie, i concordati o contratti collettivi, lo sciopero, il contratto o il rapporto di lavoro.
Il processo di sviluppo delle istituzioni sarà comunque più accelerato che non il flusso di indagini e la sistemazione teorica, e sarà esso, soprattutto, a porre in crisi il rigoroso impianto individualistico del diritto borghese, e di quello civile in particolare. Notevole sarà fin dagli inizi la circolazione internazionale dell'informazione legislativa, mentre emergerà presto anche una pronunciata tendenza all'internazionalizzazione del problema. Tale tendenza vedrà la sua prima manifestazione nel 1890, con la Conferenza internazionale di Berlino convocata da Guglielmo II, e culminerà nel 1919 a Versailles con la costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, patrocinata dal presidente Wilson.
Profondo sarà infine l'impatto di fattori politici di portata storica, quali l'avvento delle dittature in Germania e in Italia da un lato, e il New Deal statunitense dall'altro; o anche delle esigenze sociali poste in essere dalle due guerre mondiali. Il fascismo e il nazismo, in particolare, ebbero un effetto distruttivo sulle istituzioni come sulle dottrine, ma le prime apparvero più capaci di immediato recupero che non le seconde. Negli Stati Uniti il New Deal rovesciò completamente e durevolmente l'atteggiamento dello Stato federale nei confronti dei rapporti sindacali. L'emergenza bellica indusse molti paesi ad adottare misure di controllo e di protezione, che sopravvissero ad essa.
In mezzo a tali sequenze di avvenimenti, mentre l'evoluzione degli istituti legali, della giurisprudenza e dei contratti collettivi mutava il modo di essere di questa importante area di relazioni sociali ed economiche, la dottrina, pur abbondante e, nel complesso, sensibile e originale, avrebbe continuato a vedere nel diritto del lavoro un diritto nuovo o ‟un diritto enfant che è tenuto per mano dal vegliardo diritto civile" (v. Scelle, 1922). La verità è che il diritto del lavoro appariva sempre nuovo perché cambiava e cambia continuamente, con un ritmo dinamico certamente più accentuato di quello di altri rami del diritto (ma non di tutti: si pensi al diritto dell'economia o a quello tributario). Ciò che non veniva percepito adeguatamente era l'insufficienza della metodologia dominante, la cosiddetta dogmatica, ossia la tecnica costruttiva procedente per grandi sistemazioni concettualizzanti, a tenere il passo con il fenomeno del cambiamento.
2. La dottrina
Se la nascita di questo nuovo ramo della scienza giuridica può essere datata con certezza e appare quasi contemporanea in alcuni paesi, l'evoluzione sarà diseguale nell'ambito di essi e delle varie aree della cultura giuridica. Una posizione dominante viene comunque assunta subito dalla dottrina tedesca, che eserciterà per lungo tempo una grande influenza, in particolare nell'area latina. Il periodo preweimariano è qualificato da autori come Lotmar e Sinzheimer. Il primo, che era un romanista, seguì una metodologia storico-dogmatica. Il secondo, uno tra gli esponenti più rappresentativi del socialismo giuridico, accanto a Renner e a Radbruch, fu anche membro dell'Assemblea di Weimar e contribuì all'elaborazione della Costituzione; nel tempo apparve sempre più orientato verso le metodologie sociologiche. Nel periodo weimariano nuove scuole fioriscono (ancora Sinzheimer, e poi W. Kaskel, E. Jacobi e molti altri). L'impatto del nazismo però è distruttivo, tanto più che non pochi di questi autori appartenevano alla razza ebraica.
In Italia, l'avvento del fascismo e dello Stato corporativo genera un'abbondante produzione di monografie e di testi che, abbandonando in massima parte i temi che erano stati di L. Barassi (soprattutto il contratto di lavoro), faranno da chiosa ai fasti del regime, anche se in qualche caso saranno raggiunti notevoli livelli di analisi (N. Jaeger) e anche poco permeati dall'ideologia ufficiale (G. Chiarelli). In Francia sembra dominare un orientamento limpidamente esegetico; alcuni autori proporranno la confluenza del diritto del lavoro nel diritto sociale, terzo genere accanto al diritto pubblico e al privato (G. Gurvitch): tale idea vivrà una breve stagione e lascerà una traccia più che altro verbale (‛diritto sociale' è talvolta l'equivalente di diritto del lavoro, particolarmente in Francia e in America Latina). Nei paesi anglosassoni prevale invece in un primo tempo un metodo strettamente ancorato alle esigenze empiriche di commento al diritto vigente.
Fuori dell'orto giuridico, tuttavia, l'impiego del metodo storico o storico-economico dà risultati di rilievo per la scienza giuridica; val la pena di rammentare la scuola del Wisconsin creata da J. R. Commons. Di notevole importanza, come canale tra l'economia e il diritto, è l'opera di sodalizi scientifici come il Verein für Sozialpolitik (si ram- menti il nome di L. von Brentano) e l'American Economic Association. Il nesso si spezzerà più tardi con il prevalere di indirizzi formalistici nell'ambito delle varie e specifiche scienze sociali.
La circolazione internazionale della dottrina, a differenza di quella sull'informazione legislativa (v. sopra, cap. 1), è però a quel tempo scarsa, e si può dire che ogni diritto del lavoro vive nella sua provincia nazionale, se si eccettua la sensibile influenza della dottrina tedesca fino alla caduta della Repubblica di Weimar. È nel secondo dopoguerra che cominciano a porsi le basi per la formazione di una scienza transnazionale del diritto del lavoro, assimilabile per questo aspetto al diritto civile o a quello costituzionale. Ciò avviene in parte per la politica di ravvicinamento perseguita dalle organizzazioni internazionali e da quelle europee in particolare, ma soprattutto grazie all'influenza di O. KahnFreund, allievo di Sinzheimer, emigrato dalla Germania in Inghilterra per ragioni razziali e posto perciò in condizione di confrontare due culture giuridiche così diverse in contesti economici di altrettanto avanzata industrializzazione. L'opera di Kahn-Freund, anche quand'è volta a far comprendere le ragioni dell'atteggiamento empirico dei giuristi inglesi, impiega, dove occorre, categorie concettuali di provenienza eurocontinentale, e ciò rende possibile la comparazione e la costruzione di discorsi metodologicamente uniformi. Un'altra conseguenza è che la stessa dottrina giuslavoristica inglese diventa, come si vede nell'opera di K. W. Wedderburn, più omogenea al diritto eurocontinentale.
In quest'ultimo (e nell'area linguistica spagnola, inclusiva di quella latino-americana) le tendenze in atto sono diverse e, naturalmente, anche contrastanti. Nella Repubblica Federale Tedesca si ha per un periodo il predominio di giuristi formati sotto il nazismo e orientati secondo un metodo formalistico temperato da un uso piuttosto disinvolto della giurisprudenza degli interessi (H. C. Nipperdey); cospicue appaiono ancora le influenze dell'organicismo gierkiano (A. Nikisch). Ambedue queste tendenze interpretano in modo notevolmente moderato il clima di restaurata libertà sindacale ma appaiono certamente in sintonia con gli orientamenti conservatori prevalenti nella nuova Germania. Negli anni sessanta rinasce la scuola di Sinzheimer attraverso la mediazione di Kahn-Freund (Th. Ramm), e si sviluppa la critica politica delle concezioni giuridiche (W. Däubler); l'influenza di Kahn-Freund è anche visibile in Scandinavia (F. Schmidt). In Francia la prima opera sistematica è quella di P. Durand, a cui seguono autori con forte sensibilità comparativistica, portati quindi a inserirsi nel contesto della scienza comune del diritto del lavoro di cui si parlava prima (G. Lyon Caen).
In Italia, dopo un periodo tutto sommato benefico di influenza delle metodologie civilistiche (efficaci come sbarramento alle ideologie fasciste, e anche forti di un alto livello tecnico: per tutti, Fr. Santoro Passarelli e L. Mengoni), si assiste negli anni sessanta a un radicale rinnovamento conseguente all'affermarsi di metodologie sociologiche e di ‛politica del diritto' (G. Giugni, F. Mancini, U. Romagnoli). Oggi è opinione comune che il diritto del lavoro italiano sia uno dei campi sperimentali più fertili per il rinnovamento metodologico di tutta la scienza giuridica (soprattutto del diritto civile e della procedura civile). Una notevole importanza sembra infine destinata ad assumere quest'area della scienza giuridica in Spagna, dopo la fine della dittatura franchista; assai notevole vi appare l'influenza della dottrina italiana, come pure di quella tedesca e francese.
Il diritto del lavoro, dunque, come dimostra questo capitolo di storia della cultura giuridica pur appena tratteggiato, non è il commento tecnico di questa o quella legge nazionale, ma è un campo fertile di esperienze e di rinnovamento della cultura giuridica. In esso il superamento del tradizionale metodo dogmatico, in una con l'impiego della critica politica e sociologica, l'apertura interdisciplinare, la comparazione internazionale, appaiono oramai elementi distintivi costanti.
3. I contenuti
In un primo tempo (più o meno a cavallo tra i due secoli) il diritto del lavoro ha per oggetto la posizione di una serie di consistenti limiti all'autonomia dei soggetti, diretti a contenere le forme più intense di sfruttamento: restrizioni all'occupazione dei fanciulli e delle donne, durata massima dell'orario di lavoro, riposi settimanali, ecc. Questa sfera del diritto del lavoro viene chiamata legislazione del lavoro o sociale o protettiva. Posto che i vari divieti da essa previsti sono sanzionati penalmente e che, in genere, alla loro osservanza sono preposti servizi ispettivi facenti parte dell'amministrazione dello Stato (factory inspectors in Gran Bretagna, ispettori del lavoro in Francia e in Italia), si riconosce l'appartenenza di questa sfera al diritto pubblico.
Un altro aspetto che viene regolato fin dagli inizi è quello indennitario per gli infortuni e le malattie professionali. Il meccanismo dell'assicurazione obbligatoria, una novità per l'epoca (Germania 1884; Italia 1898), è impiegato per coprire il rischio d'impresa per l'infortunio del lavoratore, un principio che andava affermandosi nella giurisprudenza, ma che non costituiva una soddisfacente protezione del lavoratore soprattutto nei casi di fallimento o di cessazione dell'impresa. Con cadenze molto diverse da paese a paese (primo, la Germania imperiale, ultimi, e tuttora lontani dai livelli degli altri paesi, gli Stati Uniti) si diffondono forme di copertura: di altri rischi: vecchiaia, invalidità, disoccupazione, malattie non professionali. Quando la tecnica assicurativa tende a essere sostituita dalla copertura della finanza pubblica, e quando il diritto alle prestazioni non ha più la sua fonte in un rapporto di lavoro ma nella condizione di membro della comunità sociale, si ha il passaggio dal sistema delle assicurazioni sociali a quello della sicurezza sociale, come realizzato in Gran Bretagna nel secondo dopoguerra (Piano Beveridge). In questo caso, la materia dei rischi esce dal campo del diritto del lavoro ed entra in quello dell'intervento pubblico diretto alla soddisfazione dei bisogni sociali. Tale processo è in fase avanzata anche in Italia (M. Persiani).
La regolamentazione legislativa del contratto o rapporto di lavoro compare più tardivamente nella forma legislativa, e sovente è limitata a particolari aspetti, o a particolari rapporti, come quello degli impiegati, oggetto di speciale cura come ceto di servizio della classe industriale. Tuttavia, giurisprudenza e dottrina, anche in carenza totale o parziale di norme esplicite, sono subito impegnate sul terreno dell'individuazione della fattispecie del lavoro dipendente e delle regole da applicare ad esso. È anzi questo il terreno di formazione del diritto del lavoro come sistema scientifico ed è qui una delle parti più importanti e vitali di tale disciplina.
In genere è stato considerato estraneo al diritto del lavoro il rapporto di pubblico impiego, anche se (v. sotto, cap. 10) tale esclusione è sempre meno condivisa.
Infine, la branca più accidentata, anche perché la più sensibile al mutamento politico e all'interazione dei rapporti e delle forze sociali, è il diritto sindacale. Esso riguarda le condizioni di esistenza giuridica delle organizzazioni costituite dai lavoratori e dai datori di lavoro per il perseguimento dei loro interessi, nonché l'attività delle stesse, con particolare riguardo alla stipulazione e agli effetti dei contratti collettivi; e, infine, le forme dell'autotutela, che del diritto sindacale costituiscono una caratteristica saliente e unica. Questo insieme normativo si forma all'inizio con la rimozione di divieti o di altri impedimenti giuridici alla costituzione e attività delle coalizioni sindacali, o allo svolgimento di talune forme di autotutela, e soprattutto dello sciopero. Più tardi esso si può evolvere in una disciplina di tipo garantistico, che frequentemente viene accolta nel corpo dei principî costituzionali. Un tipo di intervento che compare in Svezia e negli Stati Uniti negli anni trenta e si diffonde altrove soprattutto negli anni settanta è quello di promozione dell'attività sindacale.
La linea di spartiacque tra i vari sistemi è comunque il riconoscimento e l'effettività del principio di libertà sindacale. Da esso, che è carattere proprio e distintivo di regime, dipendono caratteristiche differenziali pressoché totali, quali non si riscontrano negli altri rami del diritto del lavoro, dove è anzi in atto una tendenza a marcate uniformità, anche tra regimi sociopolitici diversi.
Al di là di queste ripartizioni, poi, si può affermare che il diritto del lavoro percorre in senso orizzontale quasi tutte le divisioni tradizionali della scienza giuridica, configurando così un diritto internazionale del lavoro, pubblico e privato, un diritto penale, un diritto processuale del lavoro. Il diritto processuale merita una specialissima menzione, perché esso appare quasi sempre costruito su normative speciali o addirittura su giurisdizioni speciali, con partecipazione sindacale (corti del lavoro, probiviri), oppure su sistemi arbitrali regolati dalla contrattazione collettiva. L'importanza del meccanismo processuale è dovuta non soltanto alla funzione di quest'ultimo di realizzare l'effettività delle norme, ma anche al fatto che le decisioni enunciate da tali giurisdizioni speciali o nell'ambito di tali procedimenti ad hoc, in numerosi ordinamenti, hanno posto in essere il primo corpo normativo sostanziale (E. Redenti) o ne alimentano tuttora il rinnovamento. È oggi corrente, nella Repubblica Federale Tedesca, la definizione di tali corti come ‛i veri maestri del diritto del lavoro'. Appare anche degna di menzione la tendenza alla valorizzazione dell'elemento collettivo, pur in una struttura processuale che era stata costruita a misura della lite tra soggetti individuali, e del potere dispositivo ad essi attribuito.
4. Il contratto di lavoro: origine e costruzione giuridica
Nella citata quadripartizione del diritto del lavoro (diritto sindacale, diritto del contratto o del rapporto di lavoro, legislazione sociale, previdenza sociale), in realtà i due settori rappresentativi ai fini di un esame critico delle peculiarità di questa disciplina sono il primo e il secondo. Quella che fu storicamente introdotta come legislazione sociale, infatti, può essere utilmente trattata come limite all'autonomia delle parti nel contratto di lavoro. A sua volta, il diritto previdenziale si è distaccato dal ceppo originario e si muove velocemente in una direzione propria.
La vicenda del contratto di lavoro è una delle più significative dell'esperienza giuridica contemporanea. Lo scambio tra lavoro e mercede, pressoché ignorato dalla codificazione napoleonica (che vi dedica solo due articoli), oggi, se ponderato sulla durata del rapporto che ne discende, è il contratto statisticamente più frequente e certamente quello socialmente più importante. La cessione di opera contro un compenso è alle origini della stessa rivoluzione industriale che si avvale del lavoro salariato, caratterizzato, a differenza di quello servile, dalla massima mobilità, e non soggetto ai vincoli giuridici che erano posti dall'antico regime vuoi nelle strutture feudali, vuoi in quelle delle arti o corporazioni o gilde. Se la società per azioni è la struttura giuridica che ha consentito la raccolta e l'impiego dei capitali, il contratto di lavoro è l'istituto che ha reso possibile l'organizzazione della produzione su scala mai conosciuta, e quindi la riproduzione del capitale stesso.
Il passaggio dai rapporti di soggezione personale, in cui si svolgeva il lavoro per conto altrui nei sistemi feudali, alla libera contrattazione della merce lavoro segue moduli molto diversi tra loro, che lasceranno tracce nella stessa conformazione finale del contratto di lavoro. Nei paesi latini, la frattura è forse più netta, per la forza dirompente della codificazione; in quelli tedeschi permangono fino alla prima guerra mondiale tipi di rapporti di natura personale e quasi servile (come regolati dalle Gesindeordnungen di vari Stati); in America Latina si avverte a lungo l'influenza dell'encomienda; nella common law, lento e graduale, ma sicuro, è il passaggio dal contratto di servizio (master and servant) a quello di lavoro (contract of employment). La necessità di dare al lavoro salariato un'adeguata veste giuridica è a ogni modo avvertita dovunque. I giuristi dell'inizio del secolo (Lotmar, Barassi), in armonia con le tendenze dell'epoca, cercheranno di dimostrare che il contratto di lavoro era già scritto nel libro della perenne saggezza giuridica dei Romani. In realtà, la locatio conductio romana, come è stato validamente dimostrato (L. Amirante), non ha nulla in comune con il contratto di cessione d'opere da svolgere sotto le direttive di un imprenditore e nell'ambito di un'organizzazione produttiva predisposta a tal fine da quest'ultimo. L'operazione compiuta da questi giuristi fu di individuare la fattispecie, e di lavorare sullo schema della locazione (di cose e di servizi), il solo contemplato dai codici di impronta napoleonica o dal diritto romano attualizzato in alcuni ordinamenti (in Germania prima del 1900), per ricavarne una serie di regole di condotta (per es., la garanzia del preavviso di recesso) idonee a fornire un minimo di tutela al contraente prestatore d'opere, compatibile con la massima mobilità del fattore lavoro. E poiché, dominando ancora la grande sistematica pandettistica, si riteneva per certo che il diritto non è inventato dal giurista, ma trovato nelle fonti, il fondo inesauribile a cui si attinse, di fronte alla carenza dei codici borghesi, fu il diritto romano. In realtà, quel che oggi si intende come rapporto di lavoro vive, fino a che non si desta la coscienza sociale del problema, una vita di fatto più che di diritto, ed è a tutti gli effetti un rapporto di dominio da parte del contraente forte (A. Menger), occultato sotto lo schermo del contratto.
Nei sistemi giuridici di common law l'evoluzione segue un modulo diverso. Il rapporto di master and servant viene fissato nel tardo sec. XVIII nell'elaborazione di W. Blackstone, ma ancora con un'accentuazione degli elementi di status di origine feudale rispetto ai principi di libertà contrattuale. Questa elaborazione è parallela all'affermazione del factory system e al contenzioso che si sviluppa intorno ad alcune conseguenze indotte dall'accertamento di un rapporto di lavoro, quale l'applicabilità di benefici previsti dalla Poor law. La relazione master and servant viene poi gradualmente rigenerata per opera di leggi speciali e di contratti collettivi, o, ma con impatto meno sensibile, della giurisprudenza, fino a perdere l'impronta di rapporto di dominio e convertirsi nel contract of employment.
L'individuazione del moderno rapporto di lavoro richiede peraltro un ulteriore passo oltre l'individuazione di un tipo contrattuale distinto dalla locazione. Quest'ultima operazione era stata realizzata dal Codice civile entrato in vigore in Germania il 1° gennaio 1900, ma con uno schema sistematico non ancora coincidente con quello su cui si sarebbe sviluppato il moderno diritto del lavoro, in quanto orientato piuttosto a distinguere i contratti di lavoro secondo il criterio, anch'esso di impropria derivazione romanistica, dell'obbligo di svolgere un'opera, contrapposto a quello di rendere servizi.
La subordinazione alle direttive dell'imprenditore come criterio di individuazione del rapporto di lavoro costituisce l'ulteriore passo innanzi, il momento finale di questo processo, ed esso si generalizza rapidamente nei vari ordinamenti nel primo quarto di secolo.
L'evento nuovo, portato dall'industrialismo, è infatti la concentrazione del lavoro nell'ambito dell'organizzazione produttiva di forma manifatturiera, che sostituisce gradatamente la commessa esterna ai lavoranti a domicilio, propria delle prime fasi del capitalismo. Sovente tuttavia questa modalità di prestazione ha una fisionomia incerta, di difficile qualificazione: nei lavori di specializzazione artigiana, e così pure nel lavoro a cottimo, è ancora possibile intravvedere i segni del contratto per un'opera definita o comunque misurabile nella quantità, svolta, anche se all'interno della fabbrica, in condizioni di autonomia esecutiva rispetto all'altro contraente, e cioè al creditore di lavoro. Ma il cerchio si chiude mano mano che si consolida la forma produttiva della manifattura, e l'indice caratterizzante del contratto di lavoro è allora definito nella subordinazione. Lo stesso lavoro a cottimo, soprattutto a seguito della trasformazione che subisce per l'introduzione dell'organizzazione scientifica del lavoro o taylorismo, assume i caratteri di una variante retributiva del lavoro subordinato. Lavoro a tempo e lavoro a cottimo, che in origine, sempre nella prestazione operaia, sono ambedue fornitura di lavoro retribuita a misura, si congiungono, anche per effetto della pressione sindacale e del garantismo legislativo, in un rapporto tendenzialmente continuativo.
L'asse portante di questo rapporto è il concetto di subordinazione, che però è molto vago, se non rarefatto, e certamente di difficile applicazione pratica. Tale concetto comunque consente una costruzione unitaria del rapporto di lavoro nei termini più elementari di scambio tra prestazione e retribuzione, che ingloba via via tipi di attività con origine diversa da quella del lavoro industriale (lavoro impiegatizio, domestico, salariati agricoli, fino ai dirigenti aziendali). Per effetto di questa operazione concettuale, peraltro, il diritto del lavoro viene a perdere i caratteri dell'originario droit ouvrier, e finisce in sostanza per coprire un'area interclassista: la piccola borghesia impiegatizia dapprima (v. Pic, 19225, p. 4) e, gradatamente e in misura diversa nei vari ordinamenti, la nuova classe dei managers.
In effetti, il riferimento alla condizione sociale proletaria o, il che è lo stesso, alla condizione dell'operaio dell'industria, è frequente tra scrittori di derivazione marxista o appartenenti all'eterogenea area del socialismo giuridico (si rammenti in particolare l'opera di Menger, che eserciterà per altri aspetti una profonda influenza). Tuttavia, mentre la letteratura giuridica marxista appare impegnata piuttosto sul fronte del diritto sindacale, nella dottrina e nella pratica giudiziale si impone il criterio formale della ‛dipendenza' o ‛subordinazione', che non solo diviene l'elemento qualificante del rapporto ma anche, sebbene con tonalità diverse (e con particolare accentuazione in Italia), il presupposto per l'applicazione del diritto del lavoro in generale. Il tentativo di qualificare più corposamente l'elemento della subordinazione ricorre più volte con la valorizzazione dell'elemento impresa o organizzazione del lavoro. Questo orientamento, che persegue il superamento della concezione atomistica e individualistica del contratto, viene enunciato in Germania da giuristi di ispirazione socialista (H. Potthoff, H Sinzheimer), che pongono in speciale evidenza il rapporto di potere che discende dal contratto di lavoro. Esso si ripropone, tuttavia, e con maggiore anche se effimero successo, nel clima culturale delle dittature fasciste; il collegamento lavoro-impresa viene evocato per rinsaldare il principio di autorità (Führerprinzip e art. 2086 del Codice civile italiano) (W. Siebert) o quanto meno per dare fondamento a una concezione organicista del rapporto di lavoro, di ispirazione romantico-medievalista, impostata sulla fedeltà del lavoratore e sulla protezione dell'imprenditore (von Gierke, Nikisch). Nei paesi ad alto livello industriale, il rapporto di protezione si presenta tuttora in Giappone, al di là dello schema contrattuale, come la nota tipica della prestazione di lavoro, soprattutto nella grande impresa. La concezione opposta del rapporto di scambio, applicabile al lavoro nell'impresa come a quello fuori di essa, domina invece, pressoché incontrastata, nel mondo anglosassone (T. Ascarelli), e prevale anche nei paesi a economia statizzata (v. Weltner, 1970, p. 117).
Collaterale all'individuazione del rapporto di dipendenza è quella, più densa di contenuto politico-sociale, della posizione del lavoratore come contraente più debole (v. Menger, 1890, p. 23; v. Commons e Andrews, 19364, p. 502). Kahn-Freund (v., 19772, p. 6) potrà pertanto affermare che ‟l'oggetto principale del diritto del lavoro è sempre stato, e mi azzardo a dire che sempre sarà, di costituire una forza di bilanciamento atta a compensare la diseguaglianza di potere contrattuale che è inerente, e tale non può non essere, al rapporto di lavoro". Questa constatazione è all'origine delle limitazioni poste all'autonomia delle parti, in quanto comporta l'abbandono dell'ipotesi di eguaglianza tra i due soggetti e del rapporto contrattuale come effetto di un incontro tra volontà libere ed eguali. Lo stesso problema, in altri ambienti culturali, viene formulato accentuando gli aspetti di tutela della persona piuttosto che quelli inerenti al rapporto di mercato: posto che il lavoro non è assimilabile a un bene dato in locazione, e poiché la prestazione coinvolge la personalità del lavoratore, ne viene dedotta la necessità di limitare, nella determinazione dei termini di scambio, una libertà che finisce per volgersi a danno di una delle parti.
Sia che l'argomento venga fondato su basi socioeconomiche, sia che riveli le tracce di un'ispirazione personalistica, l'esito di diritto positivo è lo stesso, nel senso che il rilievo del momento volontario viene progressivamente ridotto, fin quasi ad annullarsi. I contenuti del contratto sono determinati da fonti sovrastanti alle parti - le leggi o gli accordi collettivi - mentre anche il momento della costituzione del rapporto viene sottoposto in taluni ordinamenti a vincoli intensi (si pensi alle assunzioni obbligatorie di soggetti a ridotta capacità lavorativa, o al collocamento obbligatorio, come vige in Italia, per vero con scarsa effettività).
Conseguentemente, numerose voci si sono levate in dottrina per sostenere la non contrattualità del rapporto di lavoro. Nei paesi di common law, tale problema è stato formulato (A. V. Dicey) come un processo inverso rispetto al passaggio dallo status al contratto, che aveva invece caratterizzato il sec. XIX. D'altra parte, vi è da rammentare che il diritto nordamericano, a differenza di quello inglese, rifiuta in genere la nozione di contract of employment, e privilegia il momento del rapporto (employment relationship); e ciò anche a seguito della diversa efficacia e funzione del contratto collettivo rispetto a quello del diritto britannico (v. Wedderburn, 19712, p. 79; v. sotto, cap. 7).
È pur vero, tuttavia, che un nucleo di rilevanza della volontà sussiste pur sempre, vuoi nella stipulazione di condizioni più favorevoli di quelle prestabilite in sede eteronoma - come è ammessa nella maggior parte degli ordinamenti - vuoi nella costituzione del rapporto che richiede la volontà delle parti, anche nei pur limitati casi in cui essa è oggetto di costrizione: per esempio, quando il lavoratore che non accetti un'offerta di lavoro adeguata perde determinati benefici oppure quando il datore di lavoro sia obbligato ad assumere i lavoratori di ridotta capacità lavorativa (obbligo a contrarre). La soluzione del problema dipende in ultima analisi dalla nozione di ‛contratto' che lo studioso premette all'argomentazione (v. Rodotà, 1970, p. 25); nozione che oggi è tutt'altro che univoca. Ove si accetti la concezione di impronta giusnaturalistica del contratto come strumento di libertà, arduo sarebbe infatti riferirvi la moderna disciplina del rapporto di lavoro.
La nozione di contraente più debole viene in genere data come coincidente con quella di dipendenza o subordinazione. Anche sotto questo aspetto è dato individuare la contraddizione, già posta in luce, tra la definizione del contratto e la funzione economico-sociale del diritto del lavoro. Infatti la condizione di contraente più debole copre un'area in taluni casi più ampia del rapporto di dipendenza (questo dicasi per esempio con riguardo a rapporti associativi in agricoltura o a certe forme di agenzia o di lavoro autonomo continuativo con gli stessi committenti); in taluni casi più circoscritta, dato che non tutti i lavoratori subordinati sono economicamente ‛deboli' (questo dicasi per tutte le alte posizioni direttive o tecniche). L'aver privilegiato il criterio formale (la subordinazione nell'esecuzione del rapporto) rispetto a quello reale (l'esistenza effettiva di uno squilibrio di forza contrattuale) ha probabilmente contribuito a distorsioni del sistema, poiché ha iperprotetto rapporti che già si svolgevano in condizioni di relativo equilibrio, e ha lasciato invece fuori rapporti sociali di intenso sfruttamento.
5. I limiti dell'autonomia individuale
Il diritto del lavoro, per l'aspetto che concerne il contratto di lavoro, è un sistema di limiti all'autonomia privata. Esso si realizza con le tecniche giuridiche dell'invalidità (per es. nullità del contratto stipulato dal minore non provvisto di capacità giuridica lavorativa o del patto di mutamento peggiorativo delle mansioni); delle clausole imposte (per es. nullità di clausole difformi dalla legge o dal contratto collettivo e sostituzione di diritto con quelle previste da tali fonti, tra cui principalmente quelle relative alla misura del salario); dell'obbligazione risarcitoria (frequente nei casi di licenziamenti illeciti, ma non qualificati come invalidi); e, non di rado, della sanzione penale.
Una tecnica ‛promozionale', articolata su incentivi o sanzioni positive (per es., la costituzione di un rapporto in caso di mancata assunzione per motivi illeciti), appare negli anni più recenti, soprattutto nelle leggi antidiscriminatorie (v. sotto, cap. 9).
La materia oggetto di queste norme restrittive dell'autonomia privata è amplissima e variamente distribuita tra leggi e contratti - né va sottaciuto l'influsso che per es. negli Stati Uniti o in Italia hanno avuto le Costituzioni. A un sommario esame, si possono indicare tra gli argomenti più ricorrenti nella fonte legislativa: capacità di lavoro, forma del contratto, durata massima del lavoro, ferie e festività, sicurezza e igiene del lavoro, invalidità del contratto, obbligazioni accessorie del datore di lavoro e del lavoratore, licenziamenti. Tra gli argomenti propri piuttosto dei contratti collettivi: minimi retributivi e classificazioni professionali, lavoro straordinario, indennità relative alle condizioni di lavoro, incentivi, cottimi e premi di produzione, trattamenti di risoluzione del rapporto e, più di recente, livelli di occupazione, controllo del decentramento industriale. Sovente, comunque, la legislazione fissa i principi e i contratti collettivi vi danno applicazione, ovvero questi ultimi introducono innovazioni che la legge consolida e generalizza. A tali materie si aggiungono ora le legislazioni contro la discriminazione, soprattutto razziale e per sesso, che hanno la prima realizzazione con il Civil rights act emanato negli Stati Uniti nel 1963. Inoltre, è recentissima una tendenza a estendere l'area normativa oltre la protezione degli interessi patrimoniali o del benessere fisico, per fornire una tutela della libertà e dignità del lavoratore nella vita di relazione in fabbrica (in Italia, Statuto dei lavoratori, 1970). Ciò può essere realizzato anche mediante l'attribuzione di specifiche competenze ai consigli di fabbrica (RFT, 1972) o ai sindacati (Svezia, 1976).
Il progresso della normativa del contratto di lavoro segue comunque due tracciati ideologicamente divergenti. Da una parte si ribadisce la natura ‛personale' del rapporto, per cui il sistema delle garanzie viene articolato sulla premessa, che è a un tempo descrittiva e ottativa, del pieno coinvolgimento del lavoratore nella vita dell'impresa e del dovere di fedeltà a quest'ultima. L'esito politico coerente di tale concezione, che presenta forti impronte organicistiche, è stato l'attribuzione ai lavoratori di poteri di cogestione, in una con l'attenuazione degli elementi di conflitto d'interessi con l'altra parte: e questo è apparso il caso della Repubblica Federale Tedesca. Dall'altra, soprattutto nei paesi anglosassoni, ma anche in Francia o in Italia, l'orientamento di principio è piuttosto nel senso di tutelare la persona, impedendo che venga coinvolta nella sfera di interessi dell'imprenditore a cui, a costanza di sistema politico e sociale, essa appare sostanzialmente estranea. La linea di tendenza in questo caso è verso il potenziamento delle garanzie giuridiche contro l'imprenditore, la riduzione dei doveri del lavoratore al puro ambito della prestazione convenuta, nonché verso il riconoscimento dei diritti di libertà nei luoghi di lavoro. Tuttavia, ad onta delle diverse premesse ideologiche, gli esiti sono sovente omogenei; così, a proposito di esercizio della libertà sindacale (ma assai meno in tema di sciopero) o di tutela della dignità del lavoratore, sia nel posto di lavoro sia, anche con l'affermarsi del principio dell'irrilevanza della vita privata nelle vicende del rapporto (v. cap. 10), fuori di esso. La stessa partecipazione agli organi dell'impresa, che ha celebrato i suoi fasti, come si ricordava, nella Repubblica Federale Tedesca, è ora oggetto, nel ben diverso ambiente culturale britannico, di una proposta ufficiale (Rapporto Bullock, 1976).
Infine, la prevalenza degli elementi di collaborazione su quelli conflittuali, nel nome della disciplina socialista del lavoro, è connaturata all'ideologia giuridica dei paesi comunisti dove, comunque, non è venuto meno l'apparato garantistico del lavoratore nei confronti della proprietà collettiva (v. Weltner, 1970, p. 172). Anche qui sono rilevabili tendenze non uniformi. Così il riferimento alla disciplina socialista (cfr. Codice del lavoro cecoslovacco, 1970 e il Codice del lavoro della Repubblica Federale Tedesca, 1961), cui è propria l'idea di una intensa fedeltà all'impresa, non compare nel recentissimo Codice del lavoro polacco (1976), che (art. 12) impone al lavoratore, in termini più cauti, il dovere di ‟impegnarsi a conseguire dal proprio lavoro i migliori risultati possibili e di manifestare a tal fine l'appropriato spirito di iniziativa nonché ad aver cura dell'interesse e dei beni dell'azienda".
6. La libertà e l'organizzazione sindacale
Come abbiamo ricordato, per diritto sindacale si intende il sistema di norme che si pone come cornice all'attività dei gruppi organizzati. Condizione di esistenza del diritto sindacale è pertanto che vi siano gruppi organizzati o coalizioni. I rapporti di diritto sindacale sono rapporti tra ‛po teri collettivi': le coalizioni dei lavoratori e le imprese, intese queste ultime come ‟accumulazioni di risorse materiali e umane che ne fanno un potere collettivo" (v. KahnFreund, 19772, p. 6). La formazione delle coalizioni operaie, in conflitto con il potere collettivo delle imprese, è fenomeno tipico del sec. XIX, ed è effetto indotto dall'industrialismo, anche se non sempre dalla concentrazione del lavoro nelle manifatture (o factory system) (v. Commons e altri, 1918, vol. I, p. 8, con riferimento alla storia americana, in cui le prime coalizioni si formano nello stadio del capitalismo mercantile).
La tipologia del diritto sindacale è variegata, e dipende a sua volta dalla tipologia delle relazioni industriali in ciascun determinato paese. Un quadro compiuto e analitico, al di là della comparazione tra le istituzioni legali, potrebbe oggi essere definito con l'ausilio della disciplina delle ‛relazioni industriali' approfondita soprattutto nei paesi anglosassoni (v. Sellier, 1976). Essa, secondo la definizione di Spyropoulos (v., 1976, p. 17), ‟si riferisce ai modi con cui vengono stabilite e applicate le norme di lavoro e ai modi con cui vengono adottate le decisioni per distribuire tra i produttori i frutti dell'attività produttiva". In questo ambito disciplinare sono state elaborate tipologie differenziali, che tengono conto di variabili, tra cui le principali sono: regime politico; livello dell'industrializzazione; struttura del mercato del lavoro; motivazioni e comportamenti dei soggetti (imprese, sindacati, operatori pubblici). Ogni data combinazione delle variabili genera un sistema di relazioni industriali; che è comunque un sistema di norme di lavoro (v. Fox e Flanders, 1969).
Da un punto di vista rigorosamente giuridico, deve riconoscersi che il diritto sindacale appare in tutti gli ordinamenti in cui è ammessa l'esistenza del gruppo organizzato. Sotto questo aspetto, pertanto, è dato affermare l'universalità del diritto dei gruppi organizzati, apparendo ormai del tutto superate quelle strutture legali rigorosamente individualistiche che, in polemica con l'ancien régime, avevano improntato costituzioni e codici del secolo passato.
Questa ‛universalità' del diritto sindacale, testimoniata anche dalla quasi totale adesione delle nazioni all'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), non vale peraltro a sfumare la discriminante fondamentale, che è quella tra gli ordinamenti caratterizzati dal riconoscimento e dall'effettività della libertà sindacale, e quelli invece dove questa, di diritto o di fatto, non è operante: vuoi nei regimi autoritari, qualificati o no da ordinamenti corporativi della produzione, vuoi nei regimi di modello sovietico, per la particolare posizione che ivi assume il sindacato. In tali sistemi, comunque, è dato sovente constatare una discrepanza clamorosa tra la normativa, che consacra il principio di libertà, e la realtà di fatto. Tali contraddizioni hanno formato oggetto in alcuni casi di denunce o di interventi nel seno di varie organizzazioni internazionali (Comitato per la libertà sindacale dell'OIL, Comitato di esperti per l'attuazione della Carta sociale europea presso il Consiglio d'Europa).
In una trattazione che, come la presente, non si propone direttamente obiettivi di comparazione giuridica, ma intende piuttosto porre in luce i tratti più originali di questo ramo del diritto, attingendo i dati significanti dei vari ordinamenti, appare opportuno concentrare l'attenzione sulle strutture che traggono origine dall'antagonismo tra capitale e lavoro, e che sono perciò costruite sul rapporto ‛conflittuale' tra i poteri collettivi dianzi rammentati. I sistemi conflittuali presuppongono: a) un'identità dell'organizzazione sindacale del tutto distinta da quella dello Stato e libera da ingerenze di quest'ultimo; b) la disponibilità di strumenti di autotutela, e perciò, principalmente, dello sciopero. L'antagonismo conflittuale può avere o no connotazioni riconducibili alla lotta di classe; quest'ultima appare pressoché irrilevante, per esempio, in un sistema di relazioni industriali pur accesamente conflittuale come quello degli Stati Uniti. Tale antagonismo non viene a priori escluso, almeno sul piano teorico, in regimi che si definiscono di dittatura del proletariato (cfr. per esempio, la Costituzione cinese del 1975, che ammette la libertà di sciopero).
Nel diritto sindacale così inteso acquistano rilevanza centrale tre istituti o gruppi di istituti giuridici: la libertà sindacale e il sindacato; il contratto collettivo di lavoro e le procedure per la stipulazione di esso; le forme di autotutela.
Prima di esaminare, sia pure in forma sintetica, tali istituti, è peraltro necessario porre in rilievo una peculiarità ulteriore di questo ramo del diritto, propria soprattutto dei sistemi di antagonismo conflittuale; e cioè che la materia di esso non si identifica sempre con quella dell'ordinamento giuridico dello Stato, potendosi avere in taluni e non infrequenti casi una produzione normativa ‛non azionabile' in sede di giurisdizione statuale e rimessa a meccanismi sanzionatori interni allo stesso sistema delle relazioni industriali. Tale fenomeno è visibile nel sistema britannico dove, come si accennerà più oltre, il contratto collettivo è una realtà viva e operante, ma normalmente priva di enforceability diretta; e lo stesso è stato riscontrato (v. Giugni, 1960) in alcuni momenti e aspetti dei rapporti collettivi di lavoro in Italia.
Il tema della libertà sindacale, principio elevato a valore costituzionale solo nelle costituzioni di questo secolo (Messico, 1917; Germania, 1919; Francia, 1946; Italia, 1948; RFT, 1949; Carta delle Nazioni Unite, 1945) si pone in primo luogo con riferimento agli individui, e acquista valore problematico soprattutto nel profilo della cosiddetta libertà sindacale negativa, e cioè della libertà di non aderire a una determinata o a nessuna organizzazione sindacale. Tale problema è particolarmente sentito nei paesi (soprattutto anglosassoni) in cui è diffusa nelle sue numerose varianti la pratica dell'union shop, in forza della quale l'iscrizione al sindacato diviene condizione per l'occupazione. Qualora non si ritenga che la libertà sindacale sia riferibile anche all'aspetto negativo di essa, sorge un conflitto, che può tingersi di forti cariche polemiche, con riguardo al principio, anch'esso a volte costituzionalmente garantito, del diritto al lavoro. In questo contrasto tra interesse collettivo e individuale, di non rara ricorrenza nel diritto sindacale, l'obiettivo di rafforzare l'organizzazione e rendere effettiva la libertà collide con la costruzione della libertà stessa in termini rigorosamente individualistici. La stessa consistenza del problema varia a seconda che sia operante un sindacalismo unitario e non ideologico, oppure un sindacalismo pluralistico fondato su differenze di credo politico, che rendono più essenziale la garanzia del diritto di non appartenenza, e cioè della libertà sindacale negativa. Si può comunque rilevare, nel complesso, un atteggiamento restrittivo da parte dei vari ordinamenti nei confronti delle clausole di appartenenza obbligatoria: limitate negli Stati Uniti, soprattutto dalle leggi statali (le leggi sul right to work, vivacemente contrastate dal movimento sindacale), esse sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte federale del lavoro della Repubblica Federale Tedesca.
Un ulteriore importante sviluppo viene dall'applicazione della garanzia di libertà anche nei rapporti interprivati (l'effetto di Drittwirkung, v. sotto, cap. 9), laddove la concezione dei diritti di libertà come diritti pubblici soggettivi vedeva come termine di essi solo lo Stato. Intesa in questo senso, la libertà sindacale diviene diritto alla non discriminazione da parte del datore di lavoro, e genera lo sviluppo di tecniche giuridiche appropriate. Già in tal modo essa acquisisce una dimensione collettiva come fattore di equilibrio rispetto al potere ‛collettivo' dell'imprenditore.
Tale valenza collettiva appare naturalmente più netta quando la normativa riguarda il sindacato in quanto tale. Si noti però che negli ultimi decenni il problema della qualificazione giuridica del sindacato inteso come associazione è stato ridimensionato e condotto nei suoi giusti termini; l'attribuzione della personalità giuridica è apparsa di per sé come uno strumento valido soprattutto ai fini patrimoniali, peraltro non tipici né di primaria importanza nell'esperienza sindacale, ma non come presupposto necessario per altri effetti di maggior rilievo.
L'associazione sindacale appare pertanto oscillare tra la figura della persona giuridica vera e propria, forme di soggettività attenuata (Francia) o di certificazione (Gran Bretagna, 1975) e la qualificazione di associazione di fatto, ma pur sempre idonea a costituire un centro di imputazione unitario per alcuni rapporti giuridici (Italia, Repubblica Federale Tedesca). Una menzione a parte meritano invece le rappresentanze aziendali, perché sovente esse appaiono fondate sulla rappresentanza elettorale anziché su quella associativa. Nell'ordinamento tedesco, e fin dal tempo di Weimar, il consiglio di fabbrica non è organo associativo né sindacale. Nell'esperienza italiana di questi ultimi anni, il consiglio di fabbrica si è invece sviluppato secondo un modulo riconducibile sul piano funzionale all'organizzazione sindacale, mentre sul piano strutturale permane una dicotomia tra l'associazione fondata sul principio di adesione e l'istituzione aziendale alla cui formazione possono partecipare tutti i lavoratori.
Nonostante la variabile qualificazione giuridica, l'associazione sindacale presenta, in vario grado, ricorrenti forme di capacità, come alcune legittimazioni processuali, la legittimazione a stipulare contratti collettivi, a proclamare lo sciopero o, sul piano pubblicistico, a designare rappresentanti in corpi o collegi pubblici. A tal fine può essere richiesto il requisito della rappresentatività, che è una valutazione di effettività dell'organizzazione: così, in Francia, dal 1971 la capacità contrattuale è riservata ai sindacati rappresentativi; l'Employment protection act emanato nel 1975 in Gran Bretagna impone invece il requisito della indipendenza.
Una linea di tendenza in espansione è quella della normativa di sostegno dell'attività sindacale, che è in realtà un conseguente sviluppo della garanzia di libertà sindacale, nelle forme di esercizio collettivo di essa. Anche qui l'attività del sindacato, in genere, viene presa in considerazione, per implicito o espressamente, in base alla rappresentatività e cioè in ragione della rilevanza sociale dell'attività dispiegata dal sindacato stesso. A vantaggio di questo l'ordinamento riconosce specifiche capacità o diritti, a cui corrisponde, generalmente, una restrizione della sfera giuridica dell'imprenditore. Permessi retribuiti per lo svolgimento dell'attività sindacale, facoltà di indire assemblee anche nel luogo di lavoro, diritto di affissione e di sede nei locali aziendali, diritto di prelievo dei contributi: l'una o l'altra di queste forme dell'attività sindacale trovano espliciti riconoscimenti nella legislazione francese (1968), nello Statuto dei lavoratori italiano (1970), nel Trade unions and labour relations act britannico (1974). Si possono menzionare inoltre le sovvenzioni da parte degli imprenditori previste da contratti collettivi nel Belgio. La legge può infine intervenire a sancire veri e propri diritti di informazione, di negoziazione o di codeterminazione: siamo allora peraltro in un campo che non attiene più all'attività sindacale in quanto tale ma ai rapporti tra i contrapposti poteri collettivi, ed è materia che può essere affrontata nell'ambito dei problemi connessi all'attività di contrattazione collettiva, soprattutto nei suoi più recenti sviluppi (v. sotto, cap. 10).
7. Il contratto collettivo di lavoro
Il contratto collettivo di lavoro è lo strumento che stabilisce la misura e la qualità del rapporto di equilibrio tra i due poteri collettivi antagonistici. Con il contratto collettivo viene posta in essere una composizione temporanea del conflitto, generato, il più delle volte, dalle ‛rivendicazioni' dei lavoratori: nulla impedisce peraltro che siano l'imprenditore o la coalizione degli imprenditori a proporre proprie rivendicazioni, e così avviene ad esempio quando il conflitto insorge a seguito di riduzioni del personale.
Il contratto assume pertanto una funzione sociale di ‛trattato di pace' (v. Scelle, 1922; v. Kahn-Freund, 19772, p. 122) e, riguardo al suo contenuto, pur ribelle a ogni definizione ontologica, esso può essere individuato in: a) norme che regolano in via diretta i contenuti dei rapporti di lavoro; b) norme che regolano le procedure per la determinazione delle prime, ponendo vincoli ‟ai comportamenti e alle modalità d'azione delle diverse organizzazioni formali e informali che fanno parte del sistema di relazioni industriali" (v. Fox e Flanders, 1969). Questa tipologia funzionale di contenuti corrisponde a quella tra norme di condotta e norme sulla produzione giuridica, ben nota nella giuspubblicistica, ma è stata resa nel diritto del lavoro, coltivato soprattutto da scrittori di cultura civilistica, in base alle differenze degli effetti discendenti da esse. Si è così consolidata una distinzione, la quale trae origine dalla dottrina tedesca (v. Sinzheimer, 1908, pp. 92 ss.) e appare ampiamente diffusa (in Italia per opera di Messina, in Francia di Durand), tra la parte normativa (ricollegabile a sua volta alla specie del contratto normativo) e la parte obbligatoria del contratto. La distinzione è importante e tuttora attualissima; tuttavia essa, per la ragione anzidetta, può risultare deviante rispetto a una cognizione funzionale dell'istituto, ed è mal adattabile alle clausole o parti procedurali e istituzionali (per es., commissioni miste, procedure arbitrali e di conciliazione, fondi previdenziali) tutt'altro che infrequenti nell'esperienza contrattuale.
La funzione primaria di composizione del conflitto è comune a tutti i contratti che sono, per l'appunto, atti di composizione di interessi. La tipicità del contratto qui in esame è data dalla natura collettiva dei soggetti coinvolti, per cui gli interessi in gioco divengono interessi collettivi. La funzione ‛di pace' assume peraltro caratteri specifici dove e quando si prolunga in un impegno di non modificare l'assetto di interessi per un tempo determinato. In Germania fu acquisito fin dalle origini (v. Sinzheimer, 1908, pp. 171 ss.) che ogni contratto collettivo comprendesse come effetto naturale il dovere di tregua o di pace sociale, nel senso che ne derivasse un obbligo per i sindacati stipulanti di astenersi da scioperi inerenti alle materie regolate dal contratto stesso, fino alla sua scadenza.
Il dovere di pace ‛relativo' (da distinguersi dal dovere ‛assoluto', che è l'impegno, questa volta non implicito, a non ricorrere all'azione diretta neppure per materie non regolate nel contratto), è invece altrove ritenuto un effetto del contratto solo se abbia formato oggetto di un esplicito accordo (clausola di tregua o di no-strike). In paesi dove il diritto di sciopero ha un riconoscimento costituzionale, in particolare in Italia e in Francia, si è persino dubitato della validità di tali clausole, in quanto comportano una rinuncia, sia pure temporanea, all'esercizio di un diritto costituzionale. Al di là di tali dispute, è dato constatare che l'intensità del vincolo che deriva dal contratto è un riflesso, in sede di disciplina legale, del grado di vocazione conflittuale del sindacato e/o di accettazione del conflitto stesso da parte del sistema politico. Non è casuale il fatto che la dottrina dell'obbligo di pace come effetto naturale del contratto collettivo sia propria di un paese dove i conflitti di lavoro sono fortemente contenuti, mentre, sia pure in modo diverso, la vincolatività dei contratti nel senso qui esaminato è stata ed è oggetto di accesa controversia in Gran Bretagna, come in Italia e in Francia.
Sotto il profilo economico, il contratto collettivo, in quanto posto in essere da una coalizione di operatori nel mercato del lavoro, o (qualora anche gli imprenditori siano organizzati) da due coalizioni contrapposte, è uno strumento limitativo della concorrenza; tende cioè a creare un mercato monopolistico. Per tale ragione esso, in passato, fu colpito negli Stati Uniti mediante la legislazione anti-trust. Trattandosi di un mercato caratterizzato da spiccati aspetti di imperfezione e di squilibrio, la limitazione della concorrenza è tuttavia apparsa come un fattore di normalizzazione del mercato stesso.
Tale funzione normalizzatrice può svolgersi in due modi: con il controllo dell'accesso al lavoro e con l'imposizione della norma comune (Webb). Il primo metodo si attua con il collocamento sindacale, ed eventualmente con l'adesione obbligatoria (union shop; v. sopra, cap. 6), integrata sovente da condizioni restrittive di ammissione. Quest'ultima forma appare tipica del sindacalismo di mestiere (v. sindacalismo). Il secondo metodo è quello che si giova, soprattutto, del contratto collettivo. Esso può essere orientato alla determinazione dei minimi, derogabili dai soggetti individuali solo con trattamenti più favorevoli ai lavoratori, e questo è tipico della maggior parte dei paesi europei; oppure, come negli Stati Uniti, può fissare le condizioni effettive, e in tal caso il contratto collettivo vanifica praticamente quello individuale.
È in ragione di tale funzione normalizzatrice del mercato che si avverte la necessità di attribuire al contratto collettivo la più ampia sfera di efficacia. E poiché negli ordinamenti ispirati ai principî privatistici esso ha effetti circoscritti agli stipulanti (sindacati e loro iscritti), si pone il problema di generalizzarne l'area di applicazione.
Tale risultato può essere conseguito di fatto quando il tasso di sindacalizzazione è molto elevato, mentre nel caso diverso vengono in genere sperimentati vari meccanismi di estensione: da quello dell'union shop, che indirettamente estende il contratto a tutti i lavoratori dell'azienda, alla generalizzazione del contratto a un intero ramo produttivo mediante un atto normativo, fino all'efficacia direttamente erga omnes. Quest'ultima fu introdotta in Italia dal regime corporativo e, prevista dalla Costituzione, ma con norma rimasta inattuata (art. 39, comma 3), venne realizzata nel 1959 da una legge ‛transitoria', che diede forza normativa ai contratti collettivi allora esistenti. In questi ultimi anni il generale rafforzamento dei sindacati, congiunto a indirizzi giurisprudenziali equitativi, hanno comunque prodotto anche in Italia una situazione di quasi generalizzazione di fatto. Si noti che, quando è elevata la sindacalizzazione, anche dove è prevista la possibilità di estensione con atto normativo, raramente a essa vien fatto ricorso (così nella Repubblica Federale Tedesca).
Le due funzioni di regolamentazione dei rapporti di lavoro e di controllo sul mercato (v. Kahn-Freund, 19772) appaiono perciò strettamente connesse, fino a fondersi in una sola. La variabile da prendere in considerazione è invece quella relativa alla forza organizzativa del sindacato: dove questa è rilevante, la norma comune si impone senza l'apporto della forza statale, altrimenti questa viene evocata per consolidare i risultati contrattuali.
Il fatto che il contratto collettivo e la legge spesso riguardino le medesime materie e che sia frequente l'assunzione di norme contrattuali in norme di legge o in provvedimenti muniti di pari efficacia, sta a indicare che questo istituto, quanto ai contenuti, è il più delle volte assimilabile a un atto normativo generale e astratto. È però importante avvertire che la cognizione di questo complesso sistema di regolamentazione dei rapporti di lavoro sarebbe parziale ove, come accade di frequente nelle trattazioni giuridiche, l'attenzione fosse circoscritta al contratto collettivo in sé e per sé considerato e non fossero presi in esame i nessi che collegano un contratto all'altro, sia in senso temporale, sia con riguardo alle aree geografiche e professionali coinvolte: vale a dire, il processo o sistema di contrattazione. Nei cosiddetti sistemi ‛dinamici', come quello britannico, il flusso di accordi continuativi, sovente mediati da istituzioni paritarie, è di gran lunga più importante del testo formale, via via rinnovato con modifiche a scadenza, che segna piuttosto il ritmo della contrattazione nella tradizione europea continentale e in quella statunitense. Ma anche in queste ultime, a ben guardare, il momento dinamico esiste e si esprime nell'applicazione dei testi tra una scadenza e l'altra; un momento applicativo che, soprattutto quando è calato nella concretezza dei rapporti aziendali, si svolge con integrazioni e innovazioni che danno corpo, per l'appunto, a un modello dinamico. Come tutti i modelli, anche quello che distingue tra forme statiche e forme dinamiche è schematico, epperciò, se elevato a dogma, può anche essere deformante. È certo comunque che nell'esperienza sindacale dell'Europa continentale i contratti collettivi appaiono sovente nella forma di codici professionali, rispondenti a una funzione più spiccatamente normativa, laddove il modello dinamico esalta piuttosto gli aspetti procedimentali della contrattazione.
L'identità giuridica del contratto collettivo (natura contrattuale, regolamentare, mista; v. Despax, 1966) è notevolmente controversa, e si può dire che un dibattito durato più di cinquant'anni non sia giunto a una conclusione sicura. Che una produzione normativa possa avvenire anche con l'impiego dello strumento contrattuale è noto al diritto pubblico, e in particolare al diritto internazionale. I problemi che si pongono in ordine al contratto collettivo riguardano soprattutto la natura di esso in rapporto agli effetti giuridici. Così, la non enforceability, salvo espressa volontà delle parti, confermata dalla più recente legislazione britannica (1974), qualifica il contratto collettivo come un'espressione di autonomia sociale operante fuori della sfera dei rapporti assunti come rilevanti dall'ordinamento statuale. Al contrario, è abbastanza consolidata negli Stati Uniti l'opinione che il contratto collettivo sia un accordo a contenuto normativo (legislative), del tutto estraneo alle forme contrattuali tutelate dalla common law; a simili, anche se più elaborate, conclusioni si perviene dove, come in Germania o in Francia, è il diritto positivo stesso ad attribuire al contratto collettivo una forza imperativa diretta. Diverso è il caso in cui, in assenza di una tale statuizione positiva, l'istituto venga ricondotto nell'ambito del diritto comune delle obbligazioni, dove la deroga dei soggetti individuali alla norma comune può essere costruita solo in termini di inadempimento. Questa è stata la vicenda di tutti gli ordinamenti di civil law prima dell'emanazione di leggi ad hoc, e in particolare dell'Italia prima e dopo il sistema corporativo, anche se ormai una giurisprudenza consolidata, congiunta a indirette prescrizioni legislative, ha in sostanza sancito l'effetto inderogabile e configurato pertanto una funzione normativa imperativa, sia pure di diritto privato.
Vero è che il contratto collettivo è un istituto con tratti irriducibili sia alle fonti come categorizzate dal diritto pubblico moderno, sia al contratto come definito dalle codificazioni. La persistente difficoltà di costruzione giuridica può pertanto in parte essere imputata alla pervicace tendenza delle scuole giuridiche tradizionali a elevare le proprie definizioni dei meccanismi normativi a essenze, a cui debbono ricondursi per necessità logica tutte le forme dell'esperienza giuridica. Tale vizio di metodo rende ovviamente ardua più del necessario la definizione di un istituto che è stato generato da rapporti sociali del tutto specifici rispetto alla struttura statuale che produce la legge, così come ai rapporti prevalentemente mercantili su cui si fonda la vicenda storica del contratto; e che, in ultima analisi, si muove secondo regole interne che non è apparso azzardato definire come ‛esoteriche' (v. Kahn-Freund, 19772, p. 56).
8. Lo sciopero
Anche questo è un istituto tipico e inconfondibile del diritto del lavoro, di cui si è tentato di tracciare analogie più o meno plausibili con il diritto di resistenza o con i poteri di veto. In realtà il fenomeno dello sciopero è la diretta derivazione di due aspetti tipici dell'industrialismo e cioè: a) la sostituzione del contratto di lavoro ai rapporti servili o vincolati dell'età precedente: da questo punto di vista lo sciopero è null'altro che il ritiro collettivo e concertato della forza lavoro dal mercato; b) l'agglomerazione di masse di lavoratori nelle manifatture, e la conseguente formazione di condizioni favorevoli all'organizzazione di azioni collettive.
Lo sciopero risulta essere storicamente il primo modo di espressione della protesta collettiva, che dà forma a coalizioni più o meno temporanee, dalla cui graduale stabilizzazione ha origine il sindacato (v. Kahn-Freund, 1954).
La prima reazione degli ordinamenti, in omaggio a una concezione rigorosamente individualistica dei rapporti economici, è dovunque repressiva: la coalizione per provocare il rialzo del prezzo del lavoro è punita nei codici penali o dalla dottrina della conspiracy. Quest'ultima è fondata sul principio per cui ciò che è lecito al singolo (nel nostro caso: il rifiuto del lavoro) può non esserlo se attuato da più soggetti in forma concertata. All'inizio del secolo, peraltro, appare abbastanza generalmente consolidato il principio della non punibilità, ovvero dello sciopero-libertà; il rifiuto del lavoro è inadempimento, e come tale è perseguibile, ma solo in sede civile. Gli stessi valori fondamentali dello Stato liberale rendevano difficilmente sostenibile la negazione della libertà di disporre del proprio lavoro contenuta nel divieto delle coalizioni. Forme di repressione dello sciopero, anche se episodiche, permangono negli Stati Uniti fino agli anni trenta. La repressione è invece ripristinata e applicata con estremo rigore nei regimi fascisti e in quelli di modello sovietico.
Il diritto di sciopero forma oggetto di garanzia costituzionale per la prima volta nella Carta di Querétaro (Messico, 1917) e, dopo la seconda guerra mondiale, nelle Costituzioni francese, italiana e, più di recente, nella Costituzione portoghese del 1976. Interessa rilevare che tale riconoscimento si ha anche nella Costituzione cinese del 1975 e si può infine aggiungere che il diritto di sciopero è affermato da importanti Carte internazionali, sia pure di variabile efficacia (art. 6 della Carta sociale europea, 1965; art. 8 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali dell'ONU, 1966).
La novità del diritto di sciopero rispetto alla libertà di sciopero viene essenzialmente individuata nell'effetto che l'inadempimento all'obbligo di lavorare produce sul rapporto di lavoro. Dove è ammesso che lo sciopero ha per effetto la sospensione di quest'ultimo senza altra conseguenza che la perdita del salario, si può affermare che esiste un vero e proprio diritto di sciopero (v. Calamandrei, 1952). A parte i casi del riconoscimento costituzionale, per cui non sorge problema, l'effetto sospensione è ormai quasi generalmente acquisito nell'ambito degli ordinamenti a libertà sindacale. Un analogo risultato producono le norme che dispongono l'immunità dello sciopero dalle varie conseguenze di common law.
Il diritto di sciopero, tuttavia, non si esaurisce necessariamente nella sospensione, e anzi è improprio definire un diritto in base agli effetti giuridici prodotti dall'esercizio di esso. E infatti vanno riportati al contenuto del diritto anche alcuni comportamenti, tutelati dalla legge in misura e modo variabile, che costituiscono i vari elementi in cui si snoda l'azione dello sciopero nel suo complesso: vale a dire, oltre la sospensione del lavoro, la deliberazione, la diffusione e la propaganda, il picchettaggio pacifico ecc. Anch'esse riferibili al contenuto del diritto, perché dirette a garantirne l'effettività, sono le norme che impediscono comportamenti ostativi, quali: la sostituzione degli scioperanti, gli atti di discriminazione, la non riammissione al lavoro a sciopero terminato. La sospensione del lavoro è il fatto centrale, ma non è tutto, nello svolgimento di uno sciopero; eppertanto la garanzia della facoltà di astenersi dal lavoro, e cioè l'effetto sospensivo, non è sufficiente a esaurire il contenuto del diritto di sciopero.
Raramente lo sciopero si sottrae a una qualche forma di regolamentazione dettata dalla legge o elaborata dalla giurisprudenza o, infine, definita dai contratti collettivi o da norme interne dei sindacati stessi. La regolamentazione si snoda in genere in ragione di: a) i fini dello sciopero (economico, politico, ecc.); b) le modalità di attuazione (preavviso, limiti alle cosiddette forme anomale, salvaguardia degli impianti e servizi essenziali, ecc.); c) i soggetti (lavoratori del settore privato, dipendenti pubblici, funzionari, personale militare, ecc.); d) le procedure di conciliazione e mediazione, l'arbitrato. La serie dei problemi è vastissima e non è qui possibile darne conto, apparendo invece utile tentare di definire i tratti essenziali di un diritto comune, insieme con una indicazione degli argomenti più dibattuti nel momento attuale.
In linea di massima, è dato riscontrare che la titolarità dello sciopero è estesa ormai anche al settore pubblico, se pure non alla totalità di esso (vedi per es. l'eccezione dei funzionari o Beamte della Repubblica Federale Tedesca e altrove, e quella pressoché generale dei militari); lo sciopero politico è stato espressamente dichiarato ammissibile solo in Italia (con la sentenza n. 290 del 1974 della Corte costituzionale); la salvaguardia dei servizi essenziali è prevista da norme di legge o, come in Italia e nella Repubblica Federale Tedesca, da orientamenti giurisprudenziali o da forme di autodisciplina.
Raro è il ricorso a vere e proprie forme di arbitrato che, d'altronde, nella sua versione obbligatoria, sarebbe difficilmente compatibile con il diritto di sciopero, ma crescente appare l'intervento degli organi politici nella mediazione dei conflitti o nella preventiva determinazione dei limiti degli aumenti salariali (politica dei redditi, guidelines). In altre parole, mentre si è consolidato un ampio riconoscimento della legalità del conflitto (se pur con scarti notevoli, basti raffrontare la Repubblica Federale Tedesca all'Italia), crescenti sono le tendenze verso forme di gestione politica di esso. Ciò ha determinato anche la scarsa funzionalità degli organi di mediazione di tipo paragiurisdizionale (v. Lyon Caen, 1974, p. 242), che, soprattutto per la suggestione delle singolari esperienze dell'Australia e della Nuova Zelanda, avevano avuto una certa diffusione nei primi decenni del secolo.
Un altro dato da registrare è, in generale, la scarsa incisività della regolamentazione non sostenuta dal consenso dei lavoratori organizzati oppure da quello di una vasta parte dell'opinione pubblica. La vicenda dell'industrial relations act, emanato nel 1971 in Gran Bretagna e abrogato solo tre anni dopo, è stata la manifestazione più clamorosa di fallimento di una regolamentazione imposta in pieno contrasto con i principali destinatari; si può notare invece che le regolamentazioni restrittive introdotte negli Stati Uniti nel 1947 e gradualmente elaborate nella Repubblica Federale Tedesca dalla Corte federale del lavoro, soprattutto nel periodo di presidenza del prof. H. C. Nipperdey, abbiano sostanzialmente resistito alla più o meno compatta ostilità dei sindacati. Al contrario, in Italia e in Francia la resistenza di questi ultimi ha in pratica vanificato la forza repressiva di leggi o di indirizzi giurisprudenziali, concernenti peraltro soltanto conflitti o modalità di conflitto particolarmente gravi per la collettività (servizi pubblici) o per la controparte (gli scioperi cosiddetti articolati o a scacchiera o a intermittenza).
Un particolare rilievo ha manifestato il problema dell'attribuzione del diritto di sciopero ai singoli ovvero ai sindacati, epperciò quello del trattamento del cosiddetto sciopero selvaggio. La legittimità di quest'ultimo è ora ammessa (Italia, Francia), ora negata (Repubblica Federale Tedesca, Stati Uniti) e anche qui le scelte dell'ordinamento sono spie di concezioni diverse del sindacato e dell'azione sindacale, a seconda che venga privilegiato l'elemento di spontaneità e di movimento ovvero quello dell'organizzazione.
Mentre in tema di sciopero, al termine di un'elaborazione pluridecennale, alcuni punti fermi sono stati posti, più aperti sono i problemi concernenti le altre forme di tutela: dalla serrata degli imprenditori, che è illecita in Italia, pienamente ammessa altrove (Svezia, per esempio), allo sciopero bianco o alle varie forme di rallentamento concertato della produzione e infine all'occupazione dell'azienda che, sovente usata come mezzo di difesa da licenziamenti, è stata, in quest'ultimo decennio, al centro di clamorose vicende in vari paesi (più clamoroso di tutti, il caso Lip in Francia). L'autotutela, questo aspetto singolare e nel contempo essenziale del diritto sindacale, è apparsa restia a collocarsi in un ordine statico e, così come indeterminati appaiono tuttora in alcuni casi i limiti del diritto di sciopero, un cono d'ombra resta proiettato sulle altre forme di azione diretta.
È apparsa abbastanza chiara, d'altronde, l'ingovernabilità del fenomeno con i normali strumenti sanzionatori, sia di tipo civile sia di tipo penale, che, anzi, nei conflitti più generalizzati finiscono sovente per essere accantonati o sostituiti da mediazioni politiche. Ciò può indurre a importanti riflessioni sulla natura degli Stati a democrazia sociale, nei quali il principio di legalità può essere sottoposto a verifiche di consenso in conflitti che, trascendendo o sfiorando i limiti della legalità, pongono in essere soluzioni di continuità dell'ordine legale stesso. Diversamente dalla rivoluzione o dallo sciopero generale soreliano, tali vicende peraltro non sono state fattori di rovesciamento dell'ordine legale ma hanno al più prodotto la modificazione di equilibri politici nell'ambito della continuità del sistema.
9. Le innovazioni delle strutture e delle tecniche giuridiche
Il diritto del lavoro ha esercitato una profonda influenza sulla trasformazione delle strutture giuridiche in cui esso si evolve, e particolarmente di quelle riferibili al diritto costituzionale e al diritto civile.
Un vero e proprio impatto sulle strutture dello Stato rappresentativo si verifica invero soltanto nei regimi che sostituiscono o integrano le rappresentanze politiche con quelle sindacali: l'idea dello ‛Stato sindacale', abbastanza diffusa nei primi decenni del secolo e proposta come alternativa alla crisi dello Stato liberale, trova realizzazione nei regimi autoritari a partito unico e si confonde con la concezione corporativa dello Stato. Nelle costituzioni di modello sovietico, la partecipazione sindacale agli organi rappresentativi assume la forma indiretta del diritto di presentare candidati o di intervenire nella formazione delle liste elettorali unitarie; essa perciò non genera una sostanziale modificazione nella struttura rappresentativa, che rimane impostata su base elettiva.
Di maggiore interesse è l'esame delle modificazioni intervenute, presso i regimi di democrazia rappresentativa, nel rapporto tra i poteri dello Stato. Sotto questo aspetto, i due fenomeni di più spiccato rilievo sono: a) l'impulso alla centralizzazione verificatosi negli Stati federali o anche a struttura legislativa ‛composita' come il Regno Unito (v. Kahn-Freund, 1976, p. 245), determinato in primo luogo, specie negli Stati Uniti nella fase del New Deal, dall'esigenza politica di superare le resistenze locali, e, in secondo luogo, da quella di stabilire standard di condotta uniformi, vuoi per i lavoratori, vuoi per gli imprenditori; b) l'assunzione di un ruolo centrale da parte del Parlamento a seguito della diffusione di leggi speciali che sovrastano le tradizionali fonti del diritto tra privati (codici, common law) e parallelamente, soprattutto nell'area di common law, comprimono la discrezionalità del potere giudiziario. Tale effetto è solo in parte controbilanciato dall'importante ruolo assunto dalle Corti costituzionali, dove queste operano. L'intervento legislativo si è cospicuamente esteso, nell'ultimo periodo, anche in Gran Bretagna, dove l'‛astensione della legge' dal campo dei rapporti di lavoro era diretta non già ad ampliare l'area giurisdizionale, quanto invece, stante la natura ‛non azionabile' delle fonti collettive, a porre ad essa un argine (v. Wedderburn, 19712, p. 23).
Infine, è soprattutto attraverso il varco aperto dal diritto del lavoro che si è verificata la penetrazione dei diritti costituzionali nella sfera dei rapporti interprivati. Negato negli Stati Uniti, tale effetto (Drittwirkung) è stato riconosciuto nella Repubblica Federale Tedesca soprattutto da parte delle corti del lavoro (v. Ramm, 19742) e, con minori resistenze, in Italia.
Il campo di elezione delle capacità di trasformazione del diritto del lavoro è stato comunque il diritto privato. Le nuove tecniche giuridiche in esso generate e sperimentate si sono sovente rivelate capaci di effetti diffusivi su tutta l'area privatistica. L'antica discussione sull'affrancamento del diritto del lavoro dal diritto civile (v. Lyon Caen, 1974, p. 231) appare forse superabile dal momento che quest'ultimo, aprendosi a nuovi indirizzi metodologici, corre in un processo di trasformazione parallelo a quello del diritto del lavoro.
Tra le nuove tecniche giuridiche introdotte o diffuse con il diritto del lavoro, sembrano particolarmente meritevoli di elencazione le seguenti.
1. Le norme imperative che si impongono alla volontà delle parti e modificano direttamente il contenuto dei negozi da esse posti in essere. La sostituzione della legge (o del contratto collettivo) ai contenuti negoziali voluti effettivamente dalle parti - successivamente largamente praticata anche nei contratti di vendita, di somministrazione, di locazione ecc. - trasforma profondamente l'essenza stessa del contratto che, da strumento per produrre effetti giuridici voluti diviene un mezzo per realizzare effetti legali, talvolta ignoti, o neppure prevedibili dai contraenti (v. Rodotà, 1970).
L'imperatività - come si è rilevato (v. sopra, cap. 7) - si estende anche ai contratti collettivi ed esprime in tal modo un rapporto di prevalenza dell'interesse del gruppo sull'interesse individuale. Tale rapporto appare ancor più evidente a fronte del principio di irrinunciabilità da parte del lavoratore ai benefici del contratto (come pure a quelli della legge), che viene in genere derivato dal principio di inderogabilità.
2. L'obbligo a contrarre, quale viene stabilito ad esempio nelle assunzioni obbligatorie di persone con minore capacità lavorativa, colpisce l'autonomia contrattuale nel suo stesso momento genetico. Non destano sorpresa pertanto la forte resistenza che vi è ancora ad ammettere la costituzione coattiva del rapporto, e le inclinazioni della giurisprudenza, quando manchino esplicite norme positive, ad attestarsi sulla responsabilità risarcitoria. Nel diritto sindacale emerge, invece, la distinta figura dell'obbligo dell'imprenditore a negoziare, e cioè a condurre le trattative per il contratto collettivo, senza peraltro l'obbligo di venirne a termine. Ammesso dalle legislazioni svedese (del 1936 e ampliata nel 1976; v. Schmidt, 1977, p. 80) e nordamericana (1935), nonché dall'Industrial relations act britannico (1971-1974), l'obbligo a negoziare è in prevalenza negato dalla giurisprudenza italiana, nel quadro delle numerose pronuncie in materia di repressione della condotta antisindacale (art. 28 dello Statuto dei lavoratori). Si è infatti ritenuta estranea alla considerazione del legislatore, nell'atto in cui ha disposto una speciale tutela dell'attività del sindacato, la materia dei rapporti di quest'ultimo con la controparte, che oltretutto avrebbe affidato alla discrezione del giudice la soluzione di complessi problemi di rappresentatività e di legittimazione a negoziare.
L'Employment protection act (1975) britannico, infine, ha configurato un obbligo del datore di lavoro a consultare il sindacato e a fornirgli informazioni utili per la contrattazione; può parlarsi, in proposito, di un obbligo a negoziare attenuato.
3. L'incoercibilità delle obbligazioni di fare, principio fortemente radicato nel diritto civile, anche se non privo di eccezioni nella procedura civile francese e tedesca, è stata incrinata dalle leggi limitative del potere di licenziamento, quando esse hanno riconosciuto (il che non è di tutti gli ordinamenti) il diritto alla reintegrazione. Infatti, se ancora persiste l'impossibilità naturale di costringere l'imprenditore a dar lavoro al prestatore reintegrato per ordine del giudice, è stato chiarito che ciò non è sufficiente a sostenere il dogma dell'incoercibilità, perché appare pur sempre possibile la coazione indiretta mediante l'impiego di sanzioni afflittive. Questo ha condotto, almeno in taluni ordinamenti, a superare la soluzione dell'erogazione indennitaria, variamente sperimentata, e sempre risultata inidonea a garantire l'effettività della tutela dai licenziamenti arbitrari. In ragione di questi sviluppi normativi si è parlato di un ‛diritto al posto di lavoro' che, con enfasi eccessiva, è stato talvolta assimilato ai diritti reali (su tale argomento v. Meyers, 1964).
4. Non meno indebolito appare il concetto di corrispettività. Il riconoscimento della continuità del rapporto, a volte con retribuzione, nei casi di temporanea impossibilità della prestazione, o, in ipotesi individuate in ragione di esigenze politico-sociali (dalle ferie ai permessi retribuiti per attività sindacale) ha reso impraticabile il ricorso al principio dell'equilibrio tra le prestazioni nell'esecuzione del contratto, o, più probabilmente, lo ha ridotto a operare in un'area residuale che appare poi sempre più ristretta. È oggi controverso se si debba ritener ammissibile la sospensione della retribuzione per mancanza temporanea di lavoro, come veniva tranquillamente dedotto, in passato, dal principio della corrispettività, o se debba invece darsi per avvenuto il trasferimento del rischio al datore di lavoro, fatta salva naturalmente la possibilità di copertura assicurativa dello stesso (per l'Italia, la Cassa integrazione guadagni).
5. Notevoli sono poi gli effetti indotti nelle tecniche sanzionatorie. A parte l'introduzione della vigilanza amministrativa sull'esecuzione di contratti privati, che fu a suo tempo un innovazione cospicua, sempre più marcata appare oggi la tendenza ad attribuire al giudice poteri di intervento con fisionomia ingiuntiva, e a delineare forme di esecuzione non più soltanto patrimoniale in funzione risarcitoria. Esempi possono essere attinti dalla legislazione sindacale statunitense, imitata dall'effimero Industrial relations act britannico; dalla legislazione svedese (dove la condanna patrimoniale ai ‛danni generali' è in realtà una sanzione); dallo Statuto dei lavoratori italiano e dai nuovi comportamenti processuali da esso sollecitati; nonché, infine, dalle leggi antidiscriminatorie, compresa quella italiana (1977) sulla parità tra uomo e donna nel lavoro. La funzione giurisdizionale, una volta destinata non più soltanto a dirimere controversie tra possessori di beni, bensì a garantire le regole del gioco nei conflitti collettivi o la soddisfazione di interessi del lavoratore non immediatamente traducibili in valori economici né a realizzazione posponibile indefinitamente nel tempo, richiede rapidità di procedure e ampiezza di mezzi istruttori ed esecutivi che sono del tutto estranei al processo dispositivo proprio della tradizione eurocontinentale.
In sintonia con questa linea di evoluzione appare l'attribuzione di legittimazioni processuali al sindacato, per la tutela di interessi propri o di gruppo; si noti, peraltro, che parallela a questo rafforzamento dello strumento giurisdizionale opera la tendenza alla devoluzione della materia contenziosa a sedi conciliative e arbitrali, regolate nell'ambito della contrattazione collettiva. In tale sede di ‛giurisdizione privata', azione individuale e azione collettiva sfumano sovente le loro differenze, o, quanto meno, ha luogo la devoluzione della prima al pieno controllo sindacale. Tale è la caratteristica delle grievance procedures nordamericane, che hanno origine nel ricorso aziendale e terminano in vere e proprie decisioni arbitrali munite di piena efficacia giuridica.
6. Infine è emerso, soprattutto nell'ambito delle recenti legislazioni antidiscriminatorie, come neppure la sanzione afflittiva sia sufficiente per la realizzazione di alcuni obiettivi di politica legislativa. Si profila allora il ricorso all'affirmative action (v. Schmidt e altri, 1978), e cioè l'intervento giurisdizionale ovvero amministrativo, diretto a modificare le situazioni in atto, con mezzi quali: l'avviamento al lavoro (con tecniche compulsive - v. sopra, punto 2 - ma anche, e più frequentemente, persuasive) di soggetti appartenenti a gruppi discriminati; la determinazione di condizioni di lavoro conformi alle particolari esigenze di tali soggetti (quale l'obbligo fatto all'imprenditore, negli Stati Uniti, di far ogni sforzo ragionevole per adattare lo svolgimento del lavoro alle esigenze delle minoranze religiose). L'azione affermativa viene qui menzionata come tecnica giuridica: è evidente che essa può dilatarsi in un indirizzo di politica generale (piena occupazione, politica attiva della manodopera, qualificazione professionale di gruppi sottoprotetti) e acquisire anche maggiore efficacia, ponendosi però in una cornice estranea all'oggetto della presente trattazione per divenire un capitolo di politica sociale.
10. Le frontiere attuali del diritto del lavoro
Per tutta una serie di argomenti è particolarmente vivace il susseguirsi di innovazioni normative; in taluni ordinamenti esse già hanno avuto corso; in altri è intenso il dibattito preparatorio e fortemente probabile l'innovazione stessa.
L'istituto che ha subito i più profondi mutamenti è stato senza dubbio quello del licenziamento, che si è radicalmente trasformato dalla forma ad nutum in un atto motivato e sottoposto a controllo giudiziale. Con tale mutamento si è praticamente chiuso il ciclo evolutivo che ha origine dal contratto di fornitura di opere (v. sopra, cap. 4), misurabili nella quantità a seconda delle esigenze della produzione e del mercato, rimesse, a loro volta, alla libera valutazione dell'imprenditore. Restano tuttavia aperti i problemi inerenti alla reintegrazione effettiva nel posto di lavoro e quelli connessi ai licenziamenti per riduzione del personale, frequentemente sottoposti a controlli sindacali e amministrativi preventivi, ma in genere non ritenuti assoggettabili a un controllo di motivi, che si risolverebbe in un controllo sulla politica d'impresa.
Un altro settore in pieno sviluppo è quello della tutela del lavoratore dalla discriminazione. La discriminazione antisindacale è stata la prima a essere affrontata con le leggi di sostegno dell'attività sindacale e dispone quasi dovunque di un corredo ampio di difese giuridiche. Nel concetto di discriminazione in senso più lato si annoverano tutti i casi in cui lo squilibrio contrattuale tra le due parti è aggravato dall'appartenenza del lavoratore a gruppi sociali emarginati o minoritari. Vengono in rilievo primario, naturalmente, i gruppi razziali ed etnici, gli stranieri e le minoranze linguistiche. Ormai attualissimo è il problema dell'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna, al quale sono stati dedicati alcuni tra i più recenti e significativi testi legislativi (Stati Uniti, 1963 e 1972; Gran Bretagna, 1975; Italia, 1977). Giova ricordare che la politica legislativa antidiscriminatoria ha comportato l'adozione di tecniche giuridiche alquanto nuove e più efficaci che non le normali invalidità civilistiche. La stessa qualificazione del motivo discriminatorio come illecito non è apparsa sufficiente a coprire l'intera area del fenomeno: donde, nella normativa americana e britannica, il ricorso al criterio statistico, per cui può essere considerata discriminatoria la situazione in cui un gruppo risulti statisticamente emarginato, a prescindere dalla ragione di tale evenienza.
La discriminazione per motivi religiosi e politici è oggetto di diretta attenzione legislativa, mentre appare meritevole di menzione la tendenza, percepibile soprattutto nella giurisprudenza, ad affermare l'irrilevanza della condotta privata nel rapporto di lavoro (v. Schmidt e altri, 1978). Questi vari aspetti si muovono secondo linee non parallele. L'irrilevanza della vita privata segue dappresso i profondi mutamenti intervenuti nel costume e che riguardano la condotta morale così come l'abbigliamento e l'aspetto esterno, ecc. Essa è un aspetto del più generale problema della tutela della privacy (vedi, nello Statuto dei lavoratori italiano, il divieto di indagine in materia) e, nel nostro caso, concorre ad accentuare la spersonalizzazione legale del rapporto, in quanto assume il coinvolgimento della persona come un dato di fatto da limitare con lo strumento giuridico (v. anche, con riferimento alle dottrine più accentuatamente personalistiche, il precedente cap. 4). In tema di discriminazione religiosa, poi, val la pena di osservare che si è posto addirittura il problema di adattare per quanto possibile i metodi di lavoro alle esigenze di pratica di culto (così in particolare, negli Stati Uniti, ma anche nei paesi europei con forti aliquote di immigrati musulmani). La discriminazione politica, infine, è oggetto di generale esecrazione, ma in realtà si mantiene in forme attenuate o mascherate soprattutto nel pubblico impiego, fino a emergere in alcuni casi in tutta evidenza (vedi tra i regimi a pluralismo democratico, il caso del Berufsverbot nella Repubblica Federale Tedesca). Degna di rilievo, comunque, è l'affermazione, comune alla Corte suprema americana e a quella della Repubblica Federale Tedesca, che la semplice appartenenza a un partito ritenuto sovversivo non è sufficiente a giustificare la discriminazione.
Un vero e proprio campo di frontiera è costituito dal pubblico impiego. Escluso tradizionalmente dal campo del diritto del lavoro, anche in omaggio a una concezione acontrattuale e tutta pubblicistica del rapporto, il pubblico impiego si appropria gradualmente di tutti gli strumenti del diritto sindacale e, in tutto o in parte, viene estesa a esso la fonte contrattuale collettiva. In parallelo a tale processo viene messa in discussione la natura stessa del rapporto e ne viene contestata la acontrattualità: in effetti, la predeterminazione eteronoma dei contenuti è ormai propria anche del rapporto privato, mentre la ‛nomina' all'ufficio, che deve pur sempre essere accettata dal preposto, appare come una mera variante procedimentale nella formazione del contratto. Fatta eccezione per gli alti livelli amministrativi (i Beamte del diritto tedesco), è profezia avverabile quella che il pubblico impiego verrà gradualmente attratto nel diritto del lavoro.
Nel rapporto di lavoro privato si profila d'altronde una nuova marca di frontiera, che in parte appare invece già occupata nell'impiego pubblico, e si tratta del diritto allo svolgimento effettivo del lavoro. Dato per acquisito per le prestazioni di alto valore tecnico o artistico (il caso esemplificato più frequentemente è quello dell'interesse del cantante lirico all'esecuzione della scrittura) ma negato nelle altre ipotesi, tale restrizione appare sempre meno giustificata, a fronte di orientamenti tendenti alla salvaguardia dello sviluppo e dell'esperienza professionale. Mentre la realizzazione del diritto al lavoro, principio o utopia della rivoluzione del 1848, appare, nella sua pienezza, tema di politica sociale (v. Mancini, 1976, p. 67), il diritto allo svolgimento della prestazione sembra avviarsi, in particolare nella giurisprudenza tedesca (v. Hueck e Nipperdey, 19637, vol. I, pp. 380 ss.), verso prospettive sconosciute e irrealizzabili nella costruzione civilistica del contratto di lavoro come mero scambio tra prestazione e retribuzione.
Il rapporto lavoro-impresa resta infine il tema aperto alle prospettive più problematiche e, a un tempo, all'immaginazione creativa. Appare evidente che lo stesso concetto di impresa, come mutuato dal diritto commerciale, è insufficiente a inquadrare la normativa giuslavoristica (v. Lyon Caen, 1974, p. 235). L'impresa, infatti, è trattata dall'ordinamento giuridico nella specie di attività dell'imprenditore sul mercato, non sotto il profilo, che qui invece rileva, dell'organizzazione del lavoro. Più rispondente a quest'ultima esigenza è apparso pertanto il concetto di Betrieb, o di ‛unità produttiva', che esprime un fenomeno organizzativo. Lungi dall'essere risolto, tuttavia, appare il problema, pur antico come è antica la produzione in forma manifatturiera, del collegamento tra la pluralità di rapporti di lavoro che coesistono in una unità produttiva. La posizione dell'imprenditore come unico titolare vale ai fini del coordinamento a uno scopo comune; ma l'esecuzione dei molteplici rapporti può comportare momenti di collaborazione diretta, o anche di conflitto (per es. in caso di sciopero parziale), tra i prestatori di lavoro.
Le dottrine organicistiche, più diffuse nell'area germanica, sono state certamente in grado di affrontare il problema con strumenti più adeguati che non quelle rigorosamente contrattualistiche. Dalle premesse dottrinali, peraltro, emergono esiti di politica del diritto molto diversi, poiché l'affermazione di una solidarietà giuridica tra i lavoratori può far affiorare una responsabilità degli uni per comportamenti di altri (vedi ancora l'esempio dello sciopero parziale, e inoltre i rallentamenti produttivi, le assenze non giustificate, gli infortuni). Tale conclusione può apparire incompatibile con la natura di un rapporto la cui caratteristica è proprio l'assunzione da parte dell'imprenditore del rischio per il risultato della prestazione lavorativa.
La verità è che il consenso intorno a determinate premesse teoriche non trae radici dalla loro congruenza logica, quanto piuttosto da una valutazione politica, e da ciò discende che l'argomento non può essere disgiunto dal problema che a esso soggiace: e cioè da quello dei rapporti di potere nell'impresa. Quest'ultimo aspetto chiama direttamente in causa la definizione dell'area di intervento del ‛potere collettivo' dei lavoratori nel campo delle scelte economiche dell'imprenditore. Trattasi del problema dei managerial rights o, visto dall'altro lato, della partecipazione o codeterminazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa.
La linea di tendenza è molto marcata nel senso di una contrazione dell'area di libera valutazione dell'imprenditore, e di ciò vi sono indici o realizzazioni significative, occorse quasi contemporaneamente negli anni più recenti: la generalizzazione della cogestione nella RFT (1976), sia pur in forma non esaurientemente paritaria; la sostituzione del principio di joint regulation a quello di riserva delle managerial prerogatives in Svezia (1976); il rapporto della Commissione reale presieduta da lord Bullock in Gran Bretagna, contenente proposte di cogestione paritaria; la contrattazione sugli investimenti, iniziata in Italia a partire dal 1974. Senza dubbio, questo è uno dei campi più fecondi di evoluzione, che non potrà non sollecitare profonde revisioni nella stessa dottrina giuridica. Le linee del mutamento, peraltro, sono dipendenti da variabili di ordine politico, la cui valutazione critica sarà materia di altri articoli (v., tra l'altro, sindacalismo).
11. Le ideologie e i modelli normativi
Le indagini sulle ideologie sottostanti alle dottrine giuridiche hanno posto in rilievo come tra l'ideologia professata e l'operazione concettuale che viene di volta in volta compiuta si interpone un'opzione, a volte professa, a volte inconsapevole, per un ‛modello' normativo che interpreta il diritto pubblico in funzione di una scelta di politica del diritto espressa in un linguaggio tecnico-giuridico (G. Tarello). Da questo punto di vista si può affermare una relativa autonomia dei modelli normativi rispetto alle ideologie, cosicché mentre apparirebbe povera di risultati di rilievo una classificazione degli autori (o anche delle decisioni) in ragione dell'ideologia degli stessi (o degli estensori delle stesse), ben più feconda di risultati appare la ricostruzione di modelli di riferimento a cui possano essere accostati i protagonisti della vicenda del diritto del lavoro come scienza sociale. Al solo fine di fornire un'ulteriore chiave di lettura dell'argomento, è dato formulare, con larga approssimazione, una classificazione nei termini che seguono: essa viene elaborata con riferimento pressoché esclusivo agli ordinamenti giuridici fondati sull'antagonismo conflittuale (v. sopra, cap. 5).
1. Il modello del diritto di classe che, quando non è affermazione retorica come appare frequentemente nei primi autori di orientamento socialista, concepisce il diritto del lavoro (e quello sindacale in ispecie) come struttura giuridica alternativa al diritto borghese, immessa nell'ordinamento giuridico al fine di lievitarne la trasformazione in senso socialista.
2. Il modello personalista e organicista, acclimatato nelle dottrine di origine cattolica, ma non infrequente visitatore di quelle socialiste (specie in Germania), in cui vengono esaltati i valori di solidarietà professionale e/o anche interclassista. In tali modelli, il diritto sindacale ruota intorno alla autoresponsabilità delle categorie o delle professioni organizzate, e il contratto di lavoro si intinge di contenuti associativi o si collega a istituzioni collettive cogestionali. Il transito verso i modelli corporativi veri e propri talvolta appare agevole, e non richiede salti concettuali.
3. I diversi modelli d'impronta riformistica, che ripetono la loro origine dal ‛socialismo giuridico' o dai vari movimenti di riforma sociale, in cui viene in genere valorizzato il momento dell'azione collettiva, ma è privilegiato nettamente l'intervento legislativo a tutela del contraente più debole. Il nuovo diritto non è però inteso come premessa e momento di un processo di trasformazione, bensì piuttosto come un valore in se stesso, idoneo a realizzare risultati definitivi, anche se graduali, di giustizia sociale.
4. I modelli del conflitto industriale, elaborati soprattutto sulle esperienze e condizioni storico-politiche dei paesi a capitalismo avanzato, in cui confluiscono elementi di tradizione socialista, anche marxista, in una con le concezioni competitive e antagonistiche proprie del pensiero liberale. Coerente con questi modelli è la valorizzazione della contrattazione collettiva e della funzione del sindacato come ‛contropotere', di cui viene sovente affermata la permanente necessità storica anche in una prospettiva di trasformazione socialista compiuta.
Gli scrittori, le dottrine, le varie tendenze di politica del diritto (legislative e giudiziali) analizzate in questa sede possono essere ascritti all'una o all'altra voce della tipologia testé enunciata, sebbene l'operazione presenti considerevoli margini di incertezza e di rischio, dovuti al fatto che raramente le operazioni concettuali dei giuristi vengono compiute con coerenza a modelli di riferimento, atti a esplicitarne le valenze politiche. Le stesse ricerche in tal senso appaiono scarse, anche se è meritevole di segnalazione il fatto che contributi significativi si sono avuti proprio in tema di diritto del lavoro (Tarello, Däubler).
bibliografia
Adams, J. C., Relation of the State to industrial action, in ‟Publications of the American Economic Association", 1886-1887, I, pp. 445-459, ora in Relation of the State to industrial action and economy and jurisprudence (a cura di J. Dorfman), New York 1954.
Amirante, L., Ricerche in tema di locazione, Milano 1958.
Arijzumi, T., Legal framework, in Workers and employers in Japan, Tokyo 1973.
Ascarelli, T., Su un diritto comune del lavoro, in Studi di diritto comparato e in tema di interpretazione, Milano 1952, pp. 135-154.
Barassi, L., Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano 1901, 1915-19172.
Blackstone, W., Commentaires on the law of England, 4 voll., Oxford 1865-1768.
Calamandrei, P., Significato costituzionale del diritto di sciopero, in ‟Rivista giuridica del lavoro", 1952, I, pp. 221-244 e in Opere giuridiche, vol. III, Napoli 1968, pp. 443-469.
Chiarelli, G., Lo stato corporativo, Padova 1936.
Commons, J. R., Legal foundations of capitalism, New York 1924.
Commons, J. R. e altri, History of labor in the United States, 4 voll., New York 1918-1935.
Commons, J. R., Andrews, J. B., Principles of labor legislation, New York 19364.
Däubler, W., Gesellschaftliche Interessen und Arbeitsrecht. Zum Selbstverständnis der Arbeitsrechtswissenschaft, Köln 1974.
Däubler, W., Das Arbeitsrecht, Reinbek bei Hamburg 1976.
De La Cueva, M., El nuevo derecho mexicano del trabajo, Ciudad de México 19774.
Despax, M., Conventions collectives, in Traité de droit du travail (a cura di G. H. Camerlynck), t. VII, Paris 1966.
Dicey, A. V., Lectures on the relations between law and public opinion in England during nineteenth century, London-New York 1905.
Durand, P., Jaussand, R., Vitu, A., Traité de droit du travail, 3 voll., Paris 1947-1956.
Fox, A., Flanders, A., Reform of collective bargaining: from Donovan to Durkheim, in ‟British journal of industrial relations", 1969, VII, pp. 151-180 (tr. it.: La riforma della contrattazione collettiva: da Donovan a Durkheim, in ‟Economia e lavoro", 1969, pp. 507-569).
Gierke, O. von, Die Wurzeln des Dienstvertrages, in Berliner Festschrift für Brünner, München 1914, pp. 37 ss.
Giugni, G., Introduzione allo studio della autonomia collettiva, Milano 1960.
Giugni, G., Diritto sindacale, Bari 19773.
Gurvitch, G., Le temps present et l'idée du droit social, Paris 1931.
Hueck, A., Nipperdey, H. C., Lehrbuch des Arbeitsrechts, Berlin-Frankfurt a. M., vol. I, 19637, vol. II, t. 1, 19677, t. 2, 19707.
Jacobi, E., Grundlehren des Arbeitsrechts, Leipzig 1927.
Jaeger, N., Principî di diritto corporativo, Padova 1939.
Kahn-Freund, O., Der Funktionswandel des Arbeitsrechts, in ‟Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", 1932, LXVII, pp. 146-174; ora in Arbeitsrecht und Politik. Quellentexte 1918-1933 (a cura di Th. Ramm), Neuwied a. R.-Berlin-Spandau 1966, pp. 211-245.
Kahn-Freund, O., Intergroup conflicts and their settlement, in ‟The British journal of sociology", 1954, pp. 193-227 (tr. it.: I conflitti fra i gruppi e la loro composizione, in ‟Politica sindacale", 1960, pp. 9-42).
Kahn-Freund, O., The impact of Constitutions on labour law, in ‟The Cambridge law journal", 1976, XXXV, pp. 240-271.
Kahn-Freund, O., Labour and the law, London 19772.
Kaskel, W., Arbeitsrecht, Berlin 1924.
Leroy, M., La coutume ouvrière, 2 voll., Paris 1913.
Lotmar, Ph., Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des deutschen Reiches, vol. I, Leipzig 1902, vol. II, Leipzig 1908.
Lyon Caen, G., Du rôle des principes généraux du droit civil en droit du travail (première approche), in ‟Revue trimestrielle de droit civil", 1974, pp. 229-248.
Lyon Caen, G., Camerlynck, G. H., Précis du droit du travail, Paris 19767.
Mancini, F., Costituzione e movimento operaio, Bologna 1976.
Menger, A., Das bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen. Eine Kritik des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das deutsche Reich, Tübingen 1890 (tr. it.: Il diritto civile e il proletariato, Torino 1894).
Mengoni, L., La stabilità dell'impiego nel diritto italiano, in La stabilità dell'impiego nei paesi membri della CECA, Luxembourg 1958, pp. 231-279.
Mengoni, L., Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in Il contratto di lavoro nei paesi membri della CECA, Luxembourg 1965, pp. 407-504.
Messina, G., I concordati di tariffa nell'ordinamento giuridico del lavoro, in ‟Rivista di diritto commerciale", 1904, I, p. 458; ora in Scritti giuridici, vol. IV, Milano 1948, pp. 3-54.
Meyers, F., Ownership of jobs: a comparative study, Los Angeles 1964.
Nikisch, A., Die Grundformen des Arbeitsvertrags und des Austellungsvertrags, Berlin 1926.
Nikisch, A., Arbeitsrecht, vol. I, Tübingen 19613, vol. II, Tübingen 19592, vol. III, Tübingen 1966.
Persiani, M., Il sistema giuridico della previdenza sociale, Padova 1960.
Pic, P., Traité élémentaire de législation industrielle. Les lois ouvrières, Paris 1903, 19225.
Potthoff, H., Arbeitsrecht. Das Ringen um werdendes Recht, Berlin 1928.
Ramm, Th., Der Arbeitskampf und die Gesellschaftsordnung des Grundgesetzes. Beitrag zu einer Verfassungslehre, Stuttgart 1965.
Ramm, Th., Einführung in das Privatrecht, BGB allgemeiner Teil, vol. I, Stuttgart 19742.
Redenti, E., Massimario della giurisprudenza dei probiviri, Roma 1906.
Renner, K., Die Rechtsinstitute des Privatrechts und ihre soziale Funktion, Tübingen 1929.
Rodotà, S., Le fonti d'integrazione del contratto, Milano 1970.
Romagnoli, U., Lavoratori e sindacati tra nuovo e vecchio diritto, Bologna 1974.
Santoro Passarelli, Fr., Autonomia collettiva, giurisdizione diritto di sciopero, in ‟Rivista italiana di scienze giuridiche", 1949, pp. 138-162; ora in Saggi di diritto civile, Napoli 1961, vol. I, pp. 177-204.
Santoro Passarelli, Fr., Autonomia collettiva, in Enciclopedia del diritto, vol. IV, Milano 1959; ora in Saggi di diritto civile, Napoli 1961, vol. I, pp. 255-266.
Santoro Passarelli, Fr., Nozioni di diritto del lavoro, Napoli 197729.
Scelle, G., Le droit ouvrier, Paris 1922.
Schmidt, F., Law and industrial relations in Sweden, Stockholm 1977.
Schmidt, F. e altri, Discrimination in employment, Stockholm 1978.
Sellier, F., Ls relations industrielles. Choix de textes commentés, Paris 1976.
Siebert, W., Das Arbeitsverhältnis in der Ordnung der nationalen Arbeit, Hamburg 1935.
Sinzheimer, H., Der Korporative Arbeitsnormenvertrag, vol. I, Leipzig 1907, vol. II, Leipzig 1908.
Sinzheimer, H., Grundzüge des Arbeitsrechts, Jena 19272.
Spyropoulos, G., Relaciones laborales. Conceptos y tipología internacional, Ciudad de México 1976.
Tarello, G., Teorie e ideologie nel diritto sindacale, Milano 19722.
Webb, S., Webb, B., Industrial democracy, London 1902 (tr. it.: Democrazia industriale, Torino 1912).
Wedderburn, K. W., The worker and the law, Harmondsworth 19712.
Weltner, A., Foundamental traits of socialist labour law, Budapest 1970.