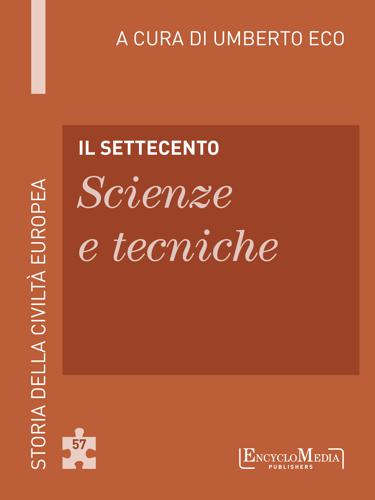Le teorie del calore
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Due teorie del calore sono in competizione nel Settecento: la prima, che risale al meccanicismo del secolo precedente, considera i fenomeni termici come effetti sensibili dei movimenti di particelle di fuoco o di materia, mentre la seconda ritiene il calore, al pari del fuoco, un tipo di materia.
Le due concezioni del calore
Il Settecento vede competere due teorie del calore. Alla prima, che risale al meccanicismo del secolo precedente e considera i fenomeni termici come effetti sensibili dei movimenti di particelle di fuoco o di materia, aderiscono fisici matematici come Euler e Daniel Bernoulli. E proprio nella sua Hydrodynamica del 1738, Bernoulli ne offre la prima formulazione matematica grazie a una versione secondo cui il calore dipende dai moti oscillatori che subiscono le molecole materiali per effetto della loro forza viva.
Da qualche anno, però, Hermann Boerhaave con gli Elementa chemiae (1724) considera il calore, al pari del fuoco, un tipo di materia. La chimica, forte della spiegazione unitaria che può dare di tutti i fenomeni della combustione grazie al principio materiale di infiammabilità cosiddetto “flogisto”, incita a vedere nel calore una sostanza in grado di fluire fra corpi a temperatura diversa, per quanto densi siano e senza che la bilancia ne registri la presenza: un “fluido calorico”, dunque, sottile e imponderabile al pari di quei fluidi che vengono allora postulati per spiegare anche i fenomeni elettrici e luminosi.
D’altra parte la moderna termometria di precisione, introdotta da Fahrenheit, Celsius e Réaumur, mette in evidenza come le sostanze abbiano diverse capacità di assorbire il calore e inoltre come esista un rapporto fra temperatura e pressione. La teoria del calorico permette per la prima volta di pensare che temperatura e calore siano non la stessa cosa, bensì due concetti differenti. Si possono quindi conseguire le prime moderne scoperte sperimentali sul calore: la “capacità termica specifica” necessaria per aumentare di un grado la temperatura di una sostanza, ossia il calore specifico scoperto dal chimico Joseph Black a cui si deve pure il concetto di un “calorico latente” assorbito o ceduto, spiega lo svolgersi delle trasformazioni a temperatura costante, come per esempio il fatto che il ghiaccio assorba calore pur mantenendo invariata la sua temperatura quando si fonde.
Affermazione della teoria del calorico
Nonostante nel 1784 Lavoisier e Laplace con Mémoire sur la chaleur dichiarino l’ammissibilità sia della teoria materiale che di quella corpuscolare del calore, saranno proprio loro che contribuiranno in misura maggiore a decretare il trionfo della teoria materiale nella scienza ufficiale di fine secolo. Da un lato, infatti, il Traité élémentaire de chimie di Lavoisier nel 1789 adotta l’ipotesi sostanzialista del calore, mentre la fisica di Laplace propone un modello meccanico di interazione fra la materia e il fluido calorico, basandosi sull’ipotesi che le particelle materiali, dotate di forze attrattive, siano circondate da atmosfere repulsive di calorico. Con questo modello Laplace riesce non solo a dominare matematicamente tutti i parametri termologici, dal calore totale di un corpo al rapporto fra pressione e temperatura, dal calore specifico al calore latente, ma anche a spiegare la differenza fra valore teorico e valore osservato della velocità del suono, causata dalle dilatazioni e rarefazioni adiabatiche prodotte nell’aria dalle onde sonore.
Al trionfo della materialità del calore si oppongono oltremanica critiche marginali, come quelle di Benjamin Thompson Rumford, basate sulle esperienze di produzione del calore per attrito – che Thomas Young incita a interpretare in favore di una spiegazione meccanico-ondulatoria unificata dei fenomeni termo-luminosi –, o come l’esperimento di fusione del ghiaccio per attrito presentato contro la teoria del calorico da Humphry Davy nell’ Essay on heat, light and the combinations of light del 1799. Ma obiezioni del genere non possono minacciare una teoria dominante che ha ormai al suo attivo sofisticate formulazioni matematiche, misure sperimentali e una efficace presentazione didattica nei manuali. In una fisica che è diventata adesso una disciplina professionale, il prestigio scientifico del calorico è destinato a mantenersi ben oltre l’inizio del XIX secolo.