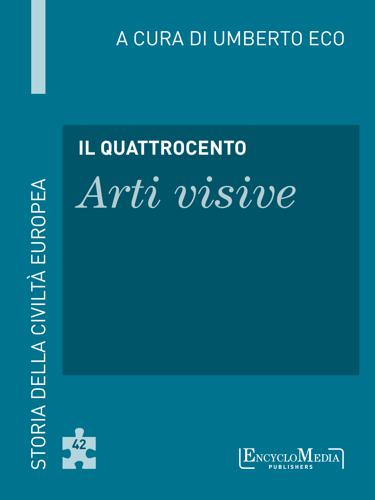Les Très Riches Heures de Jean de Berry
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Le Très Riches Heures di Jean di Berry, ovvero il libro della devozione privata, è specchio nella ricchezza dell’illustrazione, affidata inizialmente ai fratelli Limbourg, della passione bibliofila del duca e allo stesso tempo paradigma di uno stile che si fa interprete della vita stessa della corte.
La collezione di Jean de Berry
Arazzi, oreficerie, dipinti e manoscritti splendidamente illustrati da alcuni fra i maggior artisti della corte erano il vanto di una delle collezioni più ricche dei Valois, quella di Jean, duca di Berry. L’inventario più antico della raccolta, redatto tra il 1401 e il 1403, elenca ben 1317 oggetti. Si tratta di una collezione nata con acquisizioni, vendite e permute, che viene periodicamente aggiornata come registrano sia gli inventari a cura di Robinet d’Estampes nel 1413, sia l’ultimo, redatto nel 1416 da Jean Lebourne all’indomani della morte del duca. La parte più cospicua della collezione era conservata a Mehun-sur-Yèvre.
Nei primi anni il duca raccoglie una collezione che non si distingue molto da quella di Carlo V di Francia, ma già verso il 1380 vanno precisandosi i suoi gusti e interessi. Jean de Berry privilegia manoscritti liturgici, soprattutto libri d’ore, e mostra una spiccata attenzione per artisti come Jean Pucelle, di cui colleziona alcuni manoscritti. Si avvarrà anche dei servigi del suo allievo più dotato, Jean le Noir, per le sue Petites Heures (Parigi, Bibliothèque Nationale de France, ms. Lat. 18014). Il maestro lavora al manoscritto a partire dagli anni 1375-1380, ma completa il solo ciclo della Passione. Il lavoro, interrotto alla sua morte, viene ripreso dopo il 1385 da più artisti; tra questi spicca Jacquemart d’Hesdin, al servizio di Jean de Berry dal 1384. Il duca vi fa aggiungere verso il 1412 una miniatura dei fratelli Limbourg, forse Jean (f. 288v).
Tra i codici della sua ricca biblioteca meritano una seppur breve segnalazione il Salterio (Parigi, Bibliothèque Nationale de France, ms. Fr. 13091), miniato verso il 1386 da André Beauneveu, chiamato a dirigere i lavori nel castello di Mehun, le Les Très Belles Heures de Notre-Dame (Parigi, Bibliothèque Nationale de France, ms. N.A. Lat. 3093 e Torino, Museo Civico di Arte Antica, inv. 47) e Belles Heures (New York, The Cloisters, The Metropolitan Museum of Art, ms. 54.1.1.) dei fratelli Limbourg.
Les Très Riches Heures del duca di Berry
Il manoscritto al quale è più strettamente legata la fama di bibliofilo del duca è certamente le Les Très Riches Heures, oggi conservato nella Biblioteca del Musée Condé a Chantilly (ms. 65).
Il codice, che ha perso la legatura originaria e si presenta oggi con una legatura italiana in marocchino rosso del XVIII secolo, è stato miniato tra il 1411/1412 – poiché vi compare nelle litanie il nome di Alberto di Sicilia, carmelitano canonizzato solo nel 1476 ma la cui festa era stata introdotta nel calendario liturgico proprio a partire al 1411 – e il 1416 a Bourges e forse anche a Parigi dai fratelli Limbourg, coadiuvati, soprattutto per le iniziali e i fregi, dal Maestro del Breviario di Jean sans Peur e da altri artisti della bottega. Non è questo il primo incarico del duca per i fratelli Limbourg, che avevano già completato per Jean de Berry Belles Heures. La morte di Jean de Berry nel 1416, seguita a brevissima distanza da quella dei tre miniatori, probabilmente a causa della peste, provoca l’interruzione dei lavori. Dobbiamo aspettare gli anni Quaranta del Quattrocento perché si prenda la decisione di riprendere la decorazione del manoscritto. È a questa data che deve collocarsi l’intervento di Barthélemy d’Eyck, pittore di origine fiamminga al servizio di René d’Anjou, che dipinge i fogli del calendario con i mesi di Ottobre e Dicembre, intervenendo in parte anche nei fogli con i mesi di Marzo, Giugno e Settembre. Il pittore si distingue dal racconto, sempre fiabesco dei Limbourg, per un più accentuato realismo, a volte quasi ruvido nella caratterizzazione dei personaggi, e nell’impiego di ombre portate, notturni e inediti effetti di luce, punto di approdo di un’indagine analitica condotta sempre con grande lucidità. Solo tra il 1485 e il 1489 il manoscritto sarà portato a termine da Jean Colombe alla corte di Savoia.
Raffinatissimo nelle immagini, questo offiziolo con più di 35 miniature a piena pagina, alcune eseguite su fogli aggiunti come composizioni autonome indipendenti dal testo, rappresenta il vertice dell’illustrazione libraria di corte. L’arte dei fratelli Limbourg, Pol, Jean e Herman, vi si dispiega in tutta la sua ricchezza di notazioni minute e quasi di genere, soprattutto nella descrizione dei mesi, ai quali si accompagnano le occupazioni dell’aristocrazia e il lavoro dei contadini e degli artigiani. Giustamente celebre il mese di Aprile (f. 4v) che, sullo sfondo del castello di Dourdan e di una campagna ordinata e quieta, vede protagonista l’incontro di una giovane coppia ed è tutto uno sfoggio di copricapi stravaganti alla moda e stoffe intessute in oro, mentre due ancelle si chinano a terra a raccogliere alcuni fiori. La storia di questo fidanzamento prosegue poi in altri fogli del calendario. Nel mese di Maggio (f. 5v) è infatti una cavalcata festosa sullo sfondo del Palais de la Cité, che si indovina al di là del boschetto che incornicia la scena. E, per finire, nel mese di Agosto (f. 8v) la coppia si diverte nella caccia al falcone. È stata suggerita l’ipotesi che questi fogli possano rinviare a un matrimonio da poco celebrato a corte, e precisamente alle nozze tra Maria e Jean de Bourbon, figlio di Luigi II, che si svolse a Parigi il 24 giugno 1400. Nell’illustrazione del calendario, nelle ampie aperture del paesaggio, l’attenzione è anche al variare continuo delle stagioni e del tempo atmosferico, dalla nevicata che copre ogni cosa nel mese di Febbraio (f. 2v) fino al cielo primaverile del mese di Aprile (f. 4v). Persino gli episodi della vita di Cristo – si pensi alla Presentazione di Gesù al tempio (f. 54v) – o il ciclo della Passione sono risolti in chiave di un’attualizzazione cortese e aristocratica, con la città di Parigi come sfondo (f. 143r) o, come nella Tentazione di Cristo (f. 161v), con il castello di Mehun-sur-Yèvre, residenza del duca di Berry, a dominare la scena.