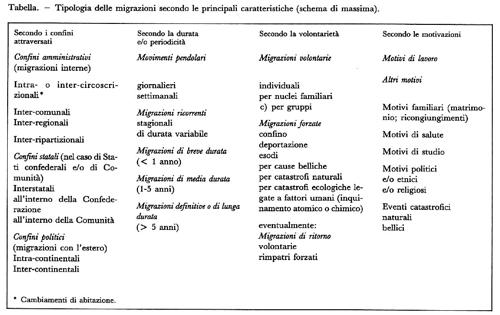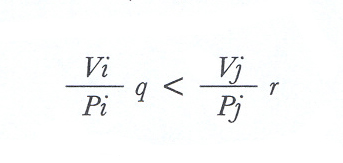Migratori, movimenti
MIGRATORI, MOVIMENTI
Aspetti generali
di Nora Federici
Spostamenti territoriali di popolazione e migrazioni
Il termine 'movimenti migratori' - o 'migrazioni' - indica uno spostamento individuale o collettivo da un luogo d'origine (emigrazione) a un luogo di destinazione (immigrazione). Considerando solo la migrazione umana, e intendendo gli spostamenti come spostamenti territoriali, questo concetto assai ampio di migrazione fa riferimento a qualsiasi cambiamento dello 'spazio di vita', inteso come porzione dello spazio, nelle sue varie articolazioni, in cui l'individuo esplica tutte le sue attività (v. Courgeau, 1980, p. 14).
Tenendo presente che i due poli essenziali della vita di ogni individuo sono il luogo di abitazione e il luogo di lavoro, si possono considerare come migrazioni tutti gli spostamenti di residenza, intesa come dimora abituale - abitativa o lavorativa - e quindi anche gli spostamenti dal luogo di abitazione a quello di lavoro quando i due spazi di vita non siano compresi entro uno stesso territorio definito da confini politici o amministrativi.
Al fine di individuare più chiaramente il fenomeno e di effettuarne una precisa e articolata registrazione statistica, è necessario considerare alcuni elementi quali la natura dei confini che il migrante attraversa spostandosi dal luogo di provenienza a quello di destinazione, la durata o periodicità dello spostamento - che oggi vengono valutate in parallelo anche se alla periodicità viene attribuito maggior rilievo (v. Golini, 1987, p. 269) -, le motivazioni e le modalità dello spostamento.
Particolarmente importante è la motivazione che può anzi essere considerata l'elemento di discrimine tra la migrazione e altri tipi di spostamento territoriale. Nella sua accezione più diffusa, in effetti, il termine migrazione è oggi riservato quasi esclusivamente agli spostamenti per motivi di lavoro, quale che sia la loro durata, la distanza coperta e la natura del confine attraversato (politico o amministrativo).
Ai motivi di lavoro vanno affiancati inoltre i motivi familiari (quando questi abbiano come scopo il matrimonio con un emigrato o il ricongiungimento della famiglia con uno o più membri emigrati per motivi di lavoro) e i motivi di forza maggiore, che possono essere di natura politica, etnica o religiosa, oppure legati a eventi catastrofici (terremoti, inondazioni, carestie, guerre, ecc.).
Dovrebbero invece venire esclusi dalla categoria della migrazione gli ormai frequentissimi spostamenti per motivi di diporto e fruizione del tempo libero, mentre è più discutibile l'esclusione degli spostamenti determinati da motivi di salute e soprattutto da motivi di studio, anche perché in molti casi le motivazioni studio-lavoro sono collegate tra loro e spesso coesistono.
Cenni storici sulle grandi migrazioni del passato
Il fenomeno delle migrazioni è antico quanto l'uomo. I recenti e sempre più frequenti ritrovamenti archeologici indicano che probabilmente sin dalle epoche preistoriche le migrazioni sono state all'origine del popolamento dei continenti.
Già i popoli di cacciatori e raccoglitori migravano alla ricerca di zone più ricche di vegetali commestibili e di cacciagione, e in genere più idonee alla sopravvivenza.
Col progredire della civiltà, alle motivazioni di tipo economico se ne sono aggiunte altre. Il consolidamento di grandi aggregati politici ha stimolato il desiderio di espansione e di conquista di nuovi territori al fine di sfruttare le loro risorse naturali e il lavoro servile delle popolazioni assoggettate. Le conquiste politico-militari dell'antichità e del Medioevo hanno provocato ingenti spostamenti di popolazione tanto dalla madrepatria verso i territori conquistati, quanto da questi verso il paese dei conquistatori: spostamenti spontanei e determinati da motivazioni politico-militari ed economiche nel primo caso, più o meno forzati e determinati da motivi di lavoro, perlopiù in condizione di schiavitù, nel secondo.
Le grandi esplorazioni geografiche dell'età moderna aprono nuove prospettive sia politiche che economiche. Sorgono i grandi imperi coloniali e viene favorito e stimolato il popolamento delle terre di conquista. Ma le prime esperienze di sfruttamento agricolo dei nuovi, sterminati territori danno luogo anche a forme di migrazione forzata: da un lato le deportazioni, dall'altro il trasferimento coatto di schiavi dall'Africa nel Nuovo Mondo.
La dominazione coloniale provoca inoltre un particolare flusso migratorio dalla madrepatria alle colonie - un flusso costituito da quadri politici, militari e tecnici, il cui spostamento è in genere (ma non sempre) volontario e comunque legato non tanto alle esigenze dei singoli, quanto alle necessità organizzative del paese colonizzatore.
Le migrazioni moderne e la loro tipologia
Per poter quantificare un fenomeno che ha implicazioni demografiche, economiche, sociali, antropologiche e politiche così significative, e che può essere considerato un elemento fondamentale dell'evoluzione delle popolazioni, si rende necessario definire una tipologia delle migrazioni.
Una prima, importante distinzione tipologica è quella tra migrazione interna ed esterna. Se il contesto demografico-territoriale al quale ci si riferisce è costituito da uno Stato, la distinzione sarà tra migrazione interna e migrazione internazionale (o con l'estero). Se lo spostamento non comporta il passaggio di confini politici, ma solo di confini amministrativi, la migrazione interna può essere definita interregionale, intercomunale oppure ancora intercircoscrizionale (nel caso dei grandi centri urbani infatti la circoscrizione va considerata un territorio più o meno autonomo sul piano amministrativo, o comunque chiaramente delimitato).
Nel caso di unità politiche multistatali, come le confederazioni di Stati (Stati Uniti, Brasile, CSI), o con stretti legami giuridico-economici (come si avvia a diventare la CEE) si ha un tipo di migrazione che rispetto al passaggio di confini va collocata in una categoria intermedia tra la migrazione interna e l'emigrazione con l'estero, perché in questo caso il passaggio di frontiera e la permanenza sono regolati da norme diverse.
Quando si fa riferimento a confini geografici anziché politici o amministrativi, le migrazioni esterne possono essere intercontinentali o intracontinentali. Qualora i continenti siano separati da un oceano si parlerà di migrazioni transoceaniche.
Un elemento essenziale della migrazione è la sua durata. Da questo punto di vista, una distinzione tradizionale è quella tra migrazioni temporanee e migrazioni definitive, e, nell'ambito delle migrazioni temporanee, tra quelle a lungo termine (con durata superiore a un periodo prefissato, ma non necessariamente uniforme) e quelle a breve termine. Oggi, però, si va facendo sempre più frequente un tipo di migrazione che sotto un certo punto di vista si può considerare intermedio tra le migrazioni temporanee e quelle definitive: le migrazioni ricorrenti, caratterizzate da uno spostamento ripetuto, perlopiù a breve termine, molto spesso con periodicità regolare o di durata più o meno uniforme. Al criterio della durata si affianca quindi sempre più spesso quello della periodicità.
La crescente diffusione delle migrazioni ricorrenti e in particolare di quelle periodiche è certo conseguenza delle sempre maggiori facilità di spostamento anche a distanze notevoli.
Le migrazioni periodiche a carattere stagionale erano legate in passato allo svolgimento di lavori agricoli ricorrenti (semina, raccolto, mondatura del riso, ecc.). Oggi le migrazioni stagionali si ritrovano soprattutto nel settore delle attività lavorative del terziario legate al turismo (settore alberghiero e della ristorazione), mentre sono pressoché scomparse quelle legate alle attività agricole che, ormai largamente meccanizzate, richiedono solo eccezionalmente manodopera stagionale.
Si sono invece largamente diffusi gli spostamenti periodici di durata più breve, noti come pendolarismo, che includono spostamenti settimanali o giornalieri a scopo sia di lavoro che di studio. Tutt'altro che infrequenti sono i casi in cui i pendolari passano, più o meno quotidianamente, confini politici: in questo caso vengono detti frontalieri.
Le migrazioni si possono poi distinguere in base alle motivazioni, che come abbiamo già accennato costituiscono un elemento essenziale per delimitare le migrazioni rispetto ad altri tipi di spostamento.
Un'altra distinzione riguarda le modalità del trasferimento. Da questo punto di vista le migrazioni possono essere individuali o per gruppi. I gruppi a loro volta possono essere costituiti da singoli individui oppure da nuclei familiari. Le migrazioni per nuclei familiari del resto possono anche essere considerate una categoria intermedia tra le migrazioni individuali e le migrazioni per gruppi.
Una speciale forma di migrazione per gruppi è costituita dagli esodi, migrazioni di massa che hanno motivazioni diverse rispetto alle migrazioni individuali.
Le migrazioni possono poi essere spontanee (o volontarie, cioè derivate da una scelta autonoma del migrante, sia pure indotta da ragioni pressanti come la ricerca del lavoro) oppure forzate (come nel caso degli esodi) oppure ancora coatte (come le deportazioni e il confino). Evidentemente nel caso delle migrazioni forzate le motivazioni sono di natura politica, religiosa o etnica, oppure sono legate a eventi catastrofici (eventi bellici, terremoti e altre catastrofi naturali o provocate dall'uomo) e la ricerca di un lavoro in un luogo diverso da quello di origine è una conseguenza piuttosto che una causa dello spostamento.
Per quanto riguarda la composizione dei flussi, si può osservare che le migrazioni temporanee (e in particolare quelle pendolari) sono perlopiù individuali, mentre quelle definitive coinvolgono l'intero gruppo familiare, anche se spesso i componenti della famiglia migrano in tempi successivi (ricongiungimento familiare). Le migrazioni forzate coinvolgono assai spesso interi gruppi di popolazioni (ad esempio negli esodi determinati da eventi bellici o catastrofici, o da ragioni politiche, religiose e razziali). Per quanto riguarda la struttura demografica dei flussi migratori, si può osservare - fatta eccezione per gli esodi di massa e le migrazioni per nuclei familiari - una netta prevalenza di individui di sesso maschile e di età giovanile. L'accresciuta presenza delle donne nel mondo del lavoro ha tuttavia modificato notevolmente il rapporto dei sessi nelle migrazioni, che in molti casi tende a divenire pressoché paritario. Resta invece accentuata la prevalenza dei giovani nella massa migrante; gli anziani costituiscono una presenza rilevante solo nelle migrazioni di ritorno, ossia nei flussi di rientro dalle migrazioni di lunga durata, soprattutto estere.
Per quanto riguarda la composizione socioprofessionale, si può parlare di una tradizionale prevalenza di migranti scarsamente qualificati sul piano professionale e con un livello di istruzione medio-basso. Negli ultimi decenni, tuttavia, la situazione si è andata modificando. Da un lato, infatti, per la diffusione dell'alfabetizzazione anche in molte zone economicamente poco sviluppate, è andato crescendo il livello medio di istruzione dei migranti, che non di rado è in contrasto con il livello del loro impiego nel luogo d'immigrazione. D'altro lato, si sono andate sviluppando correnti migratorie con direzione inversa a quella tradizionale e tuttora prevalente; gruppi di tecnici di medio e alto livello si spostano dalle zone economicamente e tecnologicamente progredite verso le zone più arretrate a seguito di commesse di lavori, soprattutto infrastrutturali, in cui viene impiegata manodopera locale per le mansioni meno qualificate.
Gli squilibri esistenti nei vari paesi tra il progresso economico-sociale e quello più propriamente legato all'evoluzione tecnologica da un lato, e dall'altro all'organizzazione e allo sviluppo della ricerca scientifica, hanno provocato e continuano a provocare particolari correnti migratorie formate da elementi con notevoli capacità potenziali e/o con aspirazioni a una più elevata qualificazione che non riescono a trovare nel loro paese sbocchi professionali adeguati e/o possibilità di ulteriore specializzazione. Questa corrente, nota come brain drain, negli ultimi decenni ha avuto per destinazione soprattutto gli Stati Uniti, e provenienze diverse: asiatiche, europee e, negli ultimi anni, africane, mentre alcuni paesi europei, come ad esempio l'Italia e la Spagna, cominciano a divenire poli di attrazione anziché zone di deflusso. Dopo il crollo dei regimi comunisti si osserva un deflusso continuo dai paesi dell'Est europeo.
Un'altra distinzione di primaria importanza è quella tra un tipo di immigrazione che può essere definita fisiologica, in quanto caratterizzata da intercambi di popolazione e pertanto non legata a particolari squilibri territoriali, preesistenti al fenomeno migratorio o da esso derivanti, e un tipo di migrazione unidirezionale che si può definire patologica, in quanto determinata dall'esistenza di squilibri oggettivi nello sviluppo demografico-economico tra aree di espulsione e aree di attrazione dei migranti (v. Federici e Golini, 1972, pp. 34-35). Questo tipo di migrazione caratterizza i flussi che oggi si dirigono dai paesi economicamente e tecnologicamente arretrati a quelli con avanzato grado di sviluppo industriale e tecnologico, designati rispettivamente, in base alla loro approssimativa collocazione geografica, come 'Sud' e 'Nord' del mondo. Esso ha caratterizzato anche i flussi transoceanici e intraeuropei nel corso della prima metà di questo secolo, come anche le massicce migrazioni interne italiane Sud-Nord nel corso degli anni sessanta. Nella tabella è riportata una possibile tipologia delle migrazioni, distintamente articolata in base ai loro caratteri fondamentali.
Le grandi correnti migratorie mondiali degli ultimi due secoli
Il forte accrescimento demografico che ha caratterizzato le popolazioni europee nella seconda metà del XVIII secolo e nel XIX secolo ha dato luogo a imponenti flussi migratori che dai vari paesi d'Europa si sono diretti verso il Nuovo Mondo attratti dalla disponibilità di immense ricchezze nei nuovi territori ancora pressoché completamente spopolati. Parallelamente, lo sviluppo industriale temporalmente sfasato dei singoli paesi europei ha alimentato correnti migratorie all'interno del continente.
Migrazioni transoceaniche e intercontinentali
L'enorme portata di questo fenomeno si può apprezzare tenendo presente che, nel corso di un secolo, le correnti migratorie europee hanno popolato interi continenti. Le due Americhe, l'Australia, la Nuova Zelanda e, in misura minore, alcuni territori dell'Africa debbono infatti una parte, talora consistente, del loro popolamento all'afflusso di ingenti masse demografiche provenienti dall'Europa che, nello stesso tempo, hanno provocato - direttamente o indirettamente - la progressiva eliminazione o perlomeno la segregazione della popolazione autoctona.
Nella prima metà del XIX secolo le correnti di maggior consistenza partono dai paesi dell'Europa nordoccidentale e si dirigono quasi esclusivamente verso gli Stati Uniti. Dal 1819 (data a partire dalla quale iniziano le statistiche statunitensi) al 1855 entrano negli Stati Uniti 4,5 milioni di immigrati, di cui 3,9 milioni di Europei, prevalentemente provenienti dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda e, in misura minore, dalla Germania e da altri paesi (in questo periodo gli Italiani sono solo 7.000).
Nella seconda metà del secolo, per effetto dello sviluppo delle vie di comunicazione e dell'incombente disoccupazione della manodopera non qualificata provocata dallo sviluppo industriale e tecnologico, l'emigrazione europea assume dimensioni imponenti. A ciò concorre anche la fase espansiva di transizione demografica provocata dalla progressiva riduzione della mortalità. In questo periodo ai flussi provenienti dall'Europa nordoccidentale si aggiungono quelli che provengono dall'Europa meridionale e orientale. Si intensifica così il popolamento degli Stati Uniti, mentre acquistano progressivamente importanza anche altri sbocchi: Canada, Argentina, Brasile, Australia e Nuova Zelanda.
Parallelamente, diviene consistente anche una corrente di migrazione asiatica proveniente soprattutto dall'India, dalla Cina e dal Giappone, che si dirige prevalentemente verso gli Stati Uniti, il Brasile, le Antille e, in Oceania, verso le isole Hawaii.
Il periodo che ha segnato i massimi assoluti negli spostamenti intercontinentali di popolazione è stato il decennio 1880-1890. Nella seconda metà del secolo i soli Stati Uniti accolgono complessivamente circa 17 milioni di immigrati (di cui circa 15 milioni di Europei). L'Italia partecipa a questo flusso con oltre 1 milione, i paesi dell'Europa orientale con circa 2 milioni. Nello stesso periodo il Canada accoglie oltre 2 milioni di Europei, mentre in Argentina e in Brasile si dirigono rispettivamente circa 3 milioni e 2-2,5 milioni (prevalentemente Spagnoli e Italiani e in minor misura Portoghesi, Russi e Polacchi).
Più contenuta e più omogenea è stata l'immigrazione in Australia e Nuova Zelanda (1 milione circa di Britannici).
All'inizio del XX secolo si è registrato un nuovo, ancor più cospicuo, flusso di immigrati verso i nuovi continenti, che ha provocato l'adozione di politiche restrittive, specie da parte degli Stati Uniti, che con il Quota act del 1921 e con leggi successive hanno imposto rigidi limiti, differenziati per le singole etnie, all'ingresso di nuovi immigrati. Di conseguenza, i flussi provenienti dall'Europa e soprattutto dall'Europa meridionale e orientale si sono ridotti, ma principalmente si sono diretti verso altre destinazioni dove era ancora relativamente facile l'ingresso: il Canada (dove tra il 1900 e il 1950 sono affluiti in totale 4,5 milioni), Argentina e Brasile (che nello stesso periodo hanno accolto oltre 5 milioni di Europei, di cui circa 1/3 Italiani).
Dopo le punte massime di emigrazione transoceanica, verificatesi nel primo quindicennio del secolo, l'Europa ha visto ridurre drasticamente i flussi di uscita. Sebbene sia molto difficile stimare il complesso di popolazione europea emigrata nelle due Americhe e in Australia e Nuova Zelanda, è stato calcolato che dall'inizio del XIX secolo alla metà del XX l'Europa abbia ceduto ai nuovi continenti oltre 60 milioni di persone, di cui 40 costituirebbero la perdita netta, in quanto rimasti definitivamente nelle nuove residenze. Dei 60 milioni di emigrati, circa 34 si sarebbero recati negli Stati Uniti, 12 in Argentina e Brasile (rispettivamente 4 e 5) e circa mezzo milione in Nuova Zelanda, mentre quote minori avrebbero scelto altri paesi delle Americhe (Messico, paesi dell'America centrale, Uruguay).
Flussi emigratori europei, più difficilmente quantificabili, hanno anche raggiunto alcuni paesi dell'Africa all'epoca soggetti al dominio coloniale europeo (Algeria, Tunisia, Marocco, Libia sulla costa mediterranea, e Unione Sudafricana). Viceversa, nell'ultimo mezzo secolo flussi migratori notevoli si sono diretti dall'Africa mediterranea verso l'Europa, che ha accolto e accoglie tuttora anche contingenti non trascurabili provenienti dal Medio Oriente e da alcuni paesi asiatici (v. Federici, 1979, pp. 559-564).
Negli ultimi decenni il crescente divario economico e il parallelo divario demografico tra il Nord e il Sud del mondo hanno determinato una sempre maggiore pressione demografica intercontinentale: popolazioni africane e asiatiche premono in misura crescente sui paesi europei e sull'America del Nord alimentando flussi consistenti di migrazione a scopo di lavoro, mentre estesi conflitti religiosi ed etnici concorrono a ingrossare i flussi, particolarmente quelli diretti verso l'Europa.
Migrazioni intracontinentali europee
Anche se meno importanti delle correnti transoceaniche e intercontinentali, di notevole portata sono state durante gli ultimi due secoli anche le migrazioni intracontinentali europee.
Anche in questo caso, le più consistenti sono state le correnti che dai paesi a economia prevalentemente preindustriale si sono dirette verso i paesi industrializzati. Il deflusso è stato particolarmente forte dall'Italia, ma anche dalla Spagna, dall'Austria, dall'Ungheria e dalla Polonia; mete prevalenti sono state la Francia, la Germania, il Belgio e la Svizzera. In epoca più recente ai paesi di emigrazione tradizionale si sono aggiunti - e in buona parte sostituiti - anche la ex Iugoslavia, la Grecia e soprattutto la Turchia.
Un'altra corrente, per converso euroasiatica, ha consentito il progressivo popolamento della Siberia da parte delle popolazioni della Russia europea.
Dopo la seconda guerra mondiale la situazione si è profondamente modificata. Da un lato la costituzione della Comunità Europea e la conseguente libera circolazione dei lavoratori al suo interno, dall'altro la progressiva e rapida industrializzazione dell'Europa mediterranea hanno profondamente mutato le caratteristiche delle correnti intracontinentali europee. Così, ad esempio, i flussi intracomunitari hanno assunto il carattere di migrazioni ricorrenti e si sono comunque ridotti come consistenza, mentre alcuni paesi con maggiore necessità di utilizzare manodopera straniera, come la Germania, hanno visto aumentare progressivamente i flussi di immigrati più periferici (soprattutto i Turchi). Nello stesso tempo, i paesi che hanno sperimentato con ritardo il processo di industrializzazione e di terziarizzazione (come l'Italia e, più di recente, la Spagna) sono divenuti paesi di immigrazione e accolgono ormai da decenni flussi non trascurabili di immigrazione intercontinentale provenienti dall'Africa e dall'Asia (v. Federici, 1979, pp. 564-566).
Particolarmente intense sono divenute le migrazioni intracontinentali Est-Ovest dopo il crollo dei regimi comunisti dell'Europa orientale. In effetti, la caduta del Muro di Berlino ha determinato una forte pressione demografica soprattutto verso la Germania, e la fine delle dittature nei paesi del Patto di Varsavia ha innescato un flusso più che consistente verso tutti i paesi dell'Europa occidentale. L'Italia si è trovata direttamente coinvolta nell'afflusso conseguente al crollo del regime comunista albanese, e ha costituito una delle mete dei profughi dell'ex Iugoslavia, che si sono diretti e continuano a premere verso Trieste.
I movimenti Est-Ovest nel continente europeo sono probabilmente destinati a continuare se non addirittura ad accrescersi, aggiungendosi così alle notevoli correnti intercontinentali che hanno come meta l'Europa.
Migrazioni intracontinentali in Africa, America Latina e Asia
Anche nei continenti che presentano larghe aree tuttora arretrate, come l'Asia, l'America Latina e soprattutto l'Africa, non mancano correnti migratorie, talora anche di notevole consistenza, a carattere internazionale. E ciò a prescindere dalle migrazioni interne, che assumono talora entità imponente.
Purtroppo è difficile, nel caso di questi continenti, seguire la natura e la direzione dei flussi migratori che, al pari e forse più di altri fattori demografici, raramente sono oggetto di rilevazione statistica. Si può dire, in generale, che la tipologia migratoria è spesso diversa da quella indicata in precedenza, e vede con frequenza assai maggiore che non nel Nord del mondo flussi migratori mutevoli, legati a fattori etnici, politici e/o religiosi.
Qui, inoltre, le migrazioni interne non sempre sono facilmente distinguibili da quelle internazionali, specie per quanto riguarda l'Africa, giacché i confini sono spesso incerti e talora sono stati disegnati, dopo il secondo conflitto mondiale e a seguito dell'indipendenza acquisita dai vari territori, senza tener conto delle dislocazioni territoriali tradizionali delle varie etnie, il che comporta scambi demografici consistenti legati anche a conflitti tribali sempre più frequenti. In linea di massima, si può dire che - anche a prescindere dal processo di urbanizzazione - i flussi da uno Stato all'altro sono tutt'altro che irrilevanti.
Caratteristiche e direzioni delle correnti migratorie attuali
Per ragioni politiche, economiche e demografiche il fenomeno migratorio va assumendo verso la fine del millennio un carattere di globalità, sia dal punto di vista delle masse migranti, sia dal punto di vista dei territori interessati.
La tendenza alla globalizzazione delle correnti migratorie non esclude però la loro polarizzazione geografica, legata sia a circostanze demografiche ed economiche che a circostanze politiche, interne e internazionali.
In effetti, nel corso degli ultimi decenni del XX secolo, il crescente divario di accrescimento demografico e sviluppo economico tra continenti, più che tra popolazioni dello stesso continente, ha dato impulso a correnti migratorie imponenti che si sono spostate e continuano a spostarsi da un continente all'altro (e segnatamente dall'Africa e dall'Asia verso l'Europa, l'America del Nord e l'Australia), favorite anche da mezzi di trasporto sempre più numerosi e rapidi.
Peraltro l'intensificarsi dei flussi intercontinentali è stato accompagnato negli ultimi decenni da un intensificarsi dei flussi intracontinentali, gli uni e gli altri favoriti dal sorgere di nuove aggregazioni economiche (Comunità Economica Europea, European Free Trade Association, North American Free Trade Agreement, Andean Pact, Association of South-East Asia Nations) (v. OCDE-SOPEMI, 1992, pp. 13-15).
Le migrazioni interne e l'urbanesimo
All'interno dei singoli Stati esistono differenze, talora rilevanti, nello sviluppo economico di zone diverse: per ragioni ambientali, storiche e sociali. E molto spesso queste differenze si accompagnano anche a diversità nell'evoluzione demografica. Ne conseguono squilibri che favoriscono spostamenti di popolazione a volte di notevole consistenza. D'altra parte, ovunque si verifica una differenziazione nelle fasi di sviluppo di aree diverse (in particolare, zone montuose e zone pianeggianti, zone prevalentemente rurali e zone urbane) che determina correnti di deflusso dalle zone più arretrate verso i territori più favoriti e/o economicamente più progrediti. A parte le migrazioni interregionali, si osservano quindi sistematicamente correnti migratorie dalla montagna alla pianura e dalle zone rurali alle zone urbane. Soltanto in una fase molto avanzata dello sviluppo, quando si passa dall'economia industriale all'economia postindustriale, si possono avere flussi invertiti, sia per effetto del decentramento produttivo, sia come conseguenza dello sviluppo di servizi legati alla valorizzazione del territorio e al turismo. Tale inversione dei flussi è ormai più o meno statisticamente evidente nel mondo industrializzato.
Tra le diverse forme di migrazioni interne una particolare attenzione va rivolta al fenomeno dell'urbanesimo, ossia ai flussi migratori che si dirigono dalle zone rurali a quelle urbane. Tali flussi provocano una duplice e opposta trasformazione nella distribuzione territoriale della popolazione all'interno di un paese: una crescente concentrazione urbana e un progressivo spopolamento delle zone rurali. Si tratta di un fenomeno ricorrente nella storia del popolamento, che assume peraltro connotazioni diverse nelle diverse fasi evolutive degli aggregati statali e del loro assetto giuridico.
Nell'antichità il flusso migratorio in ciascuna area territoriale era perlopiù circoscritto all'attrazione esercitata da pochi centri urbani, o addirittura da una sola grande città, sul resto di un vasto territorio caratterizzato da un popolamento assai limitato e prevalentemente a carattere sparso. L'attrazione esercitata dalle città era in genere originata dal loro carattere di centri religiosi e politici, oltre che economici, ma solo raramente ciò dava luogo a una concentrazione demografica particolarmente forte.
I moderni flussi rurali-urbani hanno invece motivazioni complesse, che affondano le loro radici nella trasformazione produttiva e nell'evoluzione sociale che l'accompagna. Alla loro base ci sono difatti il processo di industrializzazione in un primo tempo e quello di terziarizzazione in un secondo tempo, processi che coincidono con due fasi successive e via via diverse dell'urbanizzazione.
Nella prima fase le popolazioni rurali sono attratte verso i centri urbani dalle prospettive di impiego più remunerativo e meno gravoso offerte dallo sviluppo industriale, e nello stesso tempo dal desiderio di fruire di un maggior numero di servizi e più in generale di migliorare il tenore e la qualità della vita. Il trasferimento dalle campagne alle città è anche favorito dall'introduzione in agricoltura di nuovi metodi di coltivazione, che riducono drasticamente la necessità di lavoro umano.
Il flusso demografico rurale-urbano che deriva da questa trasformazione porta a una progressiva concentrazione demografica nei centri urbani, soprattutto quelli più importanti, e allo spopolamento dei piccoli agglomerati rurali, cui è venuta meno anche la funzione di fornire beni e servizi artigianali specifici. Il loro spopolamento è tanto più rapido e intenso quanto più essi sono situati lontani dai centri urbani e dalle vie di comunicazione che ne facilitano l'accesso.
Tuttavia, dopo questa prima fase, si verifica in genere un fenomeno di crescente diffusione territoriale dell'urbanizzazione, che vede i flussi migratori diretti non più soprattutto verso le città maggiori, ma anche verso quelle di media ampiezza e persino verso quelle minori. Si crea così progressivamente un'area di insediamenti economici e demografici che gravitano intorno al centro principale, dal quale si irradiano anche flussi centrifughi: si creano, cioè, le aree metropolitane.
Questo processo spontaneo è la conseguenza di due fattori: il decentramento produttivo e il degrado ambientale delle grandi città, che rende sempre meno desiderabile la vita nei centri urbani più congestionati.
L'eccessiva concentrazione della popolazione, infatti, tende a limitare nelle città più affollate le possibilità di occupazione o, quantomeno, di occupazioni desiderabili, e nello stesso tempo determina un peggioramento delle condizioni di vita per effetto del degrado ambientale, sia fisico (inquinamento, traffico) che sociale (crescente diffusione della droga, della violenza e della criminalità).
Nei paesi che hanno raggiunto un avanzato grado di sviluppo industriale è ormai in atto la seconda fase dell'urbanizzazione: aumenta il numero delle città di modesta e media ampiezza mentre i grandi e grandissimi centri urbani si trasformano progressivamente in aree metropolitane sempre più estese, caratterizzate da cospicui flussi bidirezionali di tipo prevalentemente pendolare.
Tra questi processi distributivi della popolazione all'interno del territorio nazionale va menzionato anche il decentramento di alcune funzioni politico-amministrative verso città diverse dalla capitale (delocalizzazione), e cioè lo sviluppo di quella che è stata denominata 'capitale reticolare' (v. "XX secolo", 1994, pp. 1-20).
Il processo per stadi dell'urbanizzazione riguarda, ovviamente, i paesi che hanno raggiunto un elevato grado di sviluppo. Tra l'altro, per essi va tenuto presente che l'urbanizzazione non è fenomeno che rientra esclusivamente nel quadro delle migrazioni interne, ma riguarda anche i flussi di immigrazione provenienti dall'estero. Infatti gli immigrati provenienti dai paesi economicamente arretrati si riversano prevalentemente nelle aree più urbanizzate, dove maggiori sono - o si pensa che siano - le possibilità di lavoro. Non si tratta, però, di una regola assolutamente generale. Infatti ancora oggi (e non soltanto nelle fasi del popolamento dei continenti nuovi) una certa quota, anche se minoritaria, dei flussi di immigrazione verso i paesi industrializzati copre anche posti di lavoro nel settore primario (agricoltura e pesca) ormai disertato dai nativi.
Nei paesi sottosviluppati, per contro, è in atto un'urbanizzazione che - almeno per alcuni di essi - potrebbe definirsi selvaggia, in quanto vede riversarsi nelle pochissime città (e talora nella sola capitale), già affollate da una popolazione in rapida crescita naturale, ingenti e continui flussi di immigrati. In alcuni casi questo afflusso è accresciuto da emergenze di carattere naturale o politico; ad esempio in Africa la progressiva desertificazione del Sahel e le conseguenti carestie danno luogo a veri e propri esodi di interi gruppi, e lo stesso accade sia in Africa che in Asia in conseguenza di conflitti armati.
La rilevazione statistica delle migrazioni
Una rilevazione diretta, completa e sistematica di tutte le migrazioni non esiste in nessun paese, né sarebbe possibile effettuarla perché la maggior parte degli spostamenti territoriali non sono soggetti ad alcun vincolo amministrativo. Tuttavia, nei paesi dove esiste l'anagrafe della popolazione, si dispone di dati sugli spostamenti di residenza che danno luogo alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche a livello di minima unità amministrativa autonoma (in Italia, il comune). Ogni trasferimento di residenza comporta pertanto la cancellazione dall'anagrafe della residenza precedente e l'iscrizione in quella nuova. Si hanno così dati continui sui flussi di entrata e di uscita da ogni unità amministrativa autonoma, con indicazione della provenienza e destinazione dei migranti; ciò rende possibile distinguere le migrazioni interne dalle migrazioni con l'estero, e in entrambe le diverse provenienze e destinazioni. Poiché però non tutti i trasferimenti di residenza vengono regolarmente denunziati, tale fonte di rilevazione non è completamente attendibile, soprattutto sotto il profilo temporale: spesso infatti la denunzia dello spostamento avviene a distanza più o meno lunga dal momento in cui questo si è effettivamente verificato.
L'anagrafe della popolazione è sostituita in alcuni paesi dai registri della popolazione, che hanno funzioni analoghe. In assenza di un'anagrafe o di un registro della popolazione si può far ricorso ad altre fonti amministrative indirette (liste elettorali, elenchi dei contribuenti, ecc.). Nei casi in cui manchi qualsiasi forma di registrazione degli spostamenti territoriali della popolazione, come avviene in molte zone dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania, è necessario ricorrere a indagini indirette, perlopiù su campioni della popolazione. Le notizie così ricavate, però, sono assai incerte e sicuramente incomplete.
Sia la fonte anagrafica che quella censuaria non consentono di tener conto del legame temporale tra lo spostamento e la vita del migrante, il quale nel corso della sua esistenza effettua talora una pluralità di spostamenti territoriali.Le indagini campionarie relative alle migrazioni possono essere di due tipi: indagini retrospettive e indagini seguite. Nel primo caso, si può ricostruire la successione degli spostamenti degli intervistati, classificati in base al sesso e ad altre caratteristiche, dalla nascita alla data della rilevazione. Nel caso delle indagini seguite (o a 'passaggi ripetuti') la conoscenza che si ricava è prospettiva, e consente di seguire le variazioni direzionali dei flussi, a partire dal momento iniziale dell'inchiesta, nel corso dei successivi passaggi (v. Courgeau, 1988, pp. 93-99).
Una recente proposta è quella di utilizzare per lo studio della mobilità migratoria indagini che raccolgono 'storie di vita', metodo molto usato nelle ricerche sociologiche (v. Courgeau e Lelièvre, 1989, p. 268).
Le teorie delle migrazioni
Sebbene non esistano vere e proprie teorie delle migrazioni che spieghino il fenomeno nella sua globalità, sono state avanzate parecchie ipotesi esplicative. Ne prenderemo in considerazione solo alcune, limitatamente al periodo del secondo dopoguerra.
In Italia, negli anni cinquanta, Corrado Gini (v., 1954) avanzò l'ipotesi delle migrazioni adattative, secondo la quale gli individui che si spostano presentano caratteristiche più simili a quelle proprie degli abitanti dei paesi di destinazione che non a quelle più diffuse nei paesi d'origine. Una variante di questa teoria fu formulata dal sociologo Francesco Alberoni (v., 1962) che parlava (riferendosi in particolare all'urbanesimo e alle migrazioni interne italiane) di "socializzazione anticipatoria", ossia della tendenza dei migranti ad assumere taluni modelli di comportamento propri del luogo di destinazione ancor prima di lasciare il loro luogo d'origine.
Più nota a livello internazionale è l'ipotesi formulata da Everett Lee (v., 1966), secondo la quale vi sarebbe una selettività delle migrazioni: la selezione sarebbe positiva (il livello socioculturale dei migranti è superiore a quello medio della popolazione d'origine) nel caso di spostamenti non determinati da assolute necessità economiche, mentre si avrebbe una selezione negativa nel caso in cui la spinta a migrare fosse determinata da tali necessità. Comunque, anche secondo Lee i migranti tenderebbero ad assumere alcune delle caratteristiche della popolazione di destinazione, pur senza perdere quelle della popolazione d'origine.
Qualche anno più tardi Wilbur Zelinsky (v., 1971) elaborò un quadro di sintesi molto esauriente, che colloca le migrazioni in una visione evolutiva storico-antropologica della transizione migratoria, collegando in qualche misura le fasi migratorie con le fasi della transizione demografica. Egli distingue cinque fasi successive: società tradizionale premoderna, società transizionale primitiva, società transizionale avanzata, società avanzata, società futura superavanzata.
Ciascuna di queste fasi è caratterizzata da diverse forme di mobilità, che evolverebbero sostanzialmente nel modo seguente. 1ª fase: scarsi spostamenti residenziali, legati alla coltivazione della terra, agli scambi di visite, al commercio e ai doveri militari e religiosi; 2ª fase: movimenti massicci dalle campagne alle città e per la coltivazione di terre all'interno delle frontiere, crescenti flussi migratori verso destinazioni estere con caratteristiche di attrazione, possibile immigrazione di lavoratori specializzati provenienti da zone più sviluppate, aumento di varie forme di circolazione; 3ª fase: riduzione dell'urbanesimo, riduzione o cessazione dell'emigrazione all'estero, accresciuta circolazione di sempre maggiore complessità strutturale; 4ª fase: oscillazione della mobilità residenziale, ormai livellata, urbanesimo in progressiva riduzione sia assoluta che relativa, intensi scambi demografici interurbani e intraurbani, nessun avanzamento di eventuali frontiere di insediamento e possibile retrocessione di queste, immigrazione netta significativa di manodopera non qualificata o scarsamente qualificata proveniente da aree arretrate, rilevante circolazione internazionale di persone altamente qualificate, circolazione notevolmente accelerata di spostamenti con motivazioni varie, specie economiche e di diporto; 5ª fase: possibile riduzione degli spostamenti residenziali e di alcune forme di circolazione derivanti da mezzi di trasporto migliori e più rapidi, migrazione residenziale legata quasi esclusivamente a spostamenti inter- e intraurbani, ulteriore possibile immigrazione di lavoratori non qualificati da aree sottosviluppate, possibilità di accelerazione di alcune forme di circolazione e nuove forme di questa, possibilità di stretto controllo politico dei movimenti sia internazionali che interni.
A prescindere dal fatto che nello schema di Zelinsky non è stato previsto il flusso centrifugo urbano-rurale attualmente in atto nelle aree sviluppate, tale schema forse non è applicabile ai paesi sottosviluppati, dove sia il processo di industrializzazione che quello di urbanizzazione presentano caratteristiche e ritmi assai diversi (v. Brown e Sanders, in De Jong e Gardner, 1981, pp. 149-184) e dove gli spostamenti territoriali di popolazione sembrano accentuare, anziché ridurre, gli squilibri demografico-economici (v. Todaro, 1976).
Le teorie non riguardano solo le cause, ma anche gli effetti delle migrazioni. Tra le teorie più recenti ricordiamo: l'approccio macroeconomico, che sottolinea la funzione svolta dalle migrazioni nel commercio internazionale e nel processo di crescita globale; l'approccio microeconomico, che si occupa delle motivazioni individuali dello spostamento; l'approccio gravitazionale, che analizza in particolare il ruolo della distanza tra i paesi e le caratteristiche di questi ultimi.
Un nuovo orientamento dell'analisi delle correnti migratorie, affermatosi negli ultimi anni, è il cosiddetto approccio sistemico, che tiene conto delle profonde trasformazioni in atto nel mondo, che investono l'ambiente naturale, l'economia, i rapporti sociali a livello sia individuale che nazionale. In questa fase già in atto, e destinata probabilmente a protrarsi nel tempo, è inevitabile che anche il fenomeno migratorio subisca una progressiva trasformazione, non da ultimo a seguito della sempre più profonda frattura economico-demografica tra i paesi economicamente avanzati e quelli sottosviluppati.Queste nuove linee di ricerca sono state promosse dall'Unione Internazionale per lo Studio Scientifico della Popolazione (IUSSP) e mirano a studiare i flussi migratori in relazione agli altri flussi di capitali e di merci (v. Kritz e altri, 1992).
Le cause oggettive e le motivazioni individuali delle migrazioni
La distinzione tra cause oggettive e motivazioni soggettive è assai importante per comprendere il fenomeno delle migrazioni, anche se alcuni studi recenti hanno cercato di collegare l'analisi dei due aspetti (v. Stark, 1991, pp. 3-6).
Le cause oggettive (aspetto macro)
Le cause oggettive degli spostamenti di popolazione sono molteplici e di varia natura. Se però si fa riferimento alla situazione attuale e si escludono le migrazioni forzate, emerge una circostanza ricorrente che può essere considerata la causa di fondo, sulla quale si innestano eventualmente altre circostanze concomitanti. Tale causa di fondo può essere definita 'pressione demografica differenziale' tra il luogo di provenienza e il luogo di destinazione dei migranti (v. Federici, 1979, pp. 591-597), intendendo con ciò l'esistenza nelle due aree di uno squilibrio di segno opposto nel rapporto fra tasso di incremento demografico (incremento naturale della popolazione) e tasso di sviluppo del reddito, rapporto che esprime appunto la 'pressione demografica'.
Nell'ipotesi teorica di un territorio nel quale il rapporto che esprime la pressione demografica denotasse una situazione di equilibrio (ossia risultasse pari all'unità) non si dovrebbero avere migrazioni, o meglio, il saldo migratorio dovrebbe essere nullo: in tal caso, infatti, le eventuali migrazioni assumerebbero il carattere di interscambi di popolazione e non di corrente unidirezionale. Nel caso di rapporto superiore all'unità si dovrebbe avere una quota di emigrazione netta tendenzialmente crescente al crescere del valore del rapporto; nel caso di rapporto inferiore all'unità, viceversa, una quota di immigrazione netta crescente al diminuire del valore del rapporto.
Questo schema, in realtà, risponde solo approssimativamente alle situazioni effettive, perché le correnti migratorie sono determinate dalla pressione demografica 'differenziale' tra le due aree e pertanto possono verificarsi, entro certi limiti, anche indipendentemente dal valore del rapporto che le caratterizza, per il solo fatto che tale valore differisce dall'una all'altra.
Secondo una più puntuale impostazione (v. Tapinos, 1974, pp. 60-66), la decisione di emigrare sarebbe determinata da una condizione necessaria (anche se non sufficiente) espressa dalla seguente relazione:
dove - essendo rispettivamente i e j il luogo di emigrazione e quello di immigrazione - con V viene indicato il reddito totale, con P la popolazione, con q e con r la probabilità individuale di percepire un dato reddito, rispettivamente nella zona di origine e in quella di destinazione.
Fatto per ipotesi q = 1, r può variare tra 0 e 1; la decisione di emigrare dipende dunque sia dalla differenza tra i due rapporti che dal valore di r, che riflette in qualche modo gli effetti delle caratteristiche distributive del reddito nella zona di immigrazione.
Al concetto di pressione demografica differenziale viene così aggiunto anche un fattore distributivo di notevole importanza.
In realtà, la forte pressione demografica che caratterizza le aree di emigrazione determina la forza di espulsione dalla zona di origine, mentre sulla forza di attrazione delle varie zone di destinazione, oltre al rapporto tra incremento demografico e sviluppo economico, influiscono altre circostanze, tra le quali notevole peso assumono - nel caso delle migrazioni internazionali - la diversa legislazione e, nel caso di tutte le migrazioni, il diverso atteggiamento politico dei vari paesi di immigrazione, nonché la diversa disponibilità della popolazione ospite ad accettare e a favorire l'integrazione sociale, oltre che economica, degli immigrati.
Oggi, in relazione a questa causa di fondo, si tende a distinguere le migrazioni da 'domanda' dalle migrazioni da 'offerta' di lavoro. Le prime hanno caratterizzato, ad esempio, il periodo di popolamento dei continenti nuovi, mentre attualmente l'eccezionale pressione demografica dei paesi sottosviluppati e le ricorrenti crisi etniche e politiche di vaste aree territoriali danno luogo a continue e massicce correnti migratorie che sono un caratteristico esempio di migrazioni da 'offerta'.
Naturalmente vanno tenute in conto altre cause oggettive, che hanno determinato in passato e ancor oggi determinano importanti correnti migratorie. Tra queste vanno ricordate, per il passato, le cause di ordine militare e politico.
Attualmente sono frequenti, specie nel Terzo Mondo, correnti migratorie provocate da catastrofi naturali o da conflitti politici, religiosi o etnici. Particolarmente rilevanti sono i flussi migratori determinati dal crollo dei regimi comunisti e dai conflitti etnico-politici che ne sono derivati (ex URSS, ex Iugoslavia, ex Cecoslovacchia, Polonia, Albania).
Nell'attuale fase postindustriale dei paesi ad avanzato sviluppo economico si verifica un diffuso rifiuto da parte dei lavoratori locali di occupazioni considerate 'socialmente non desiderabili' per livelli salariali o per condizioni di lavoro, che vengono pertanto rese disponibili per la manodopera immigrata. Questo fenomeno è presente anche là dove esiste una quota notevole di disoccupazione, come ad esempio in Italia. Per quanto non possa essere considerato una vera e propria causa delle migrazioni, tale fenomeno costituisce tuttavia un fattore importante nel determinare la consistenza e la continuità dei flussi migratori motivati dalla ricerca di lavoro. Di ciò si è occupato l'International Labour Office (ILO), che nel quadro di una ricerca per il World employment programme ne ha valutato l'importanza quantitativa in relazione all'occupazione di nativi e immigrati nel settore del lavoro non qualificato, analizzando inoltre le possibilità di accedere a occupazioni 'socialmente accettabili' da parte dei lavoratori immigrati (v. Böhning, 1976, pp. 6-23).
Le analisi dell'ILO riguardavano le migrazioni internazionali, ma è chiaro che il problema investe anche le migrazioni interne qualora sussistano forti differenziazioni nello sviluppo economico e sociale di diverse zone di uno stesso paese.
Un discorso a parte meritano le cause delle migrazioni di ritorno, che possono anch'esse venir considerate fenomeno di massa. Talora all'origine del rientro è la delusione per la difficoltà di trovare una collocazione soddisfacente sotto il profilo economico e/o di inserirsi nel nuovo ambiente sociale (in questo caso il ritorno segue a distanza relativamente breve - uno o due anni - l'emigrazione), o, più frequentemente, il desiderio di tornare nel proprio contesto sociale e familiare dopo aver raggiunto lo scopo di mettere insieme un capitale da investire a garanzia del futuro (in questo caso il ritorno avviene a scadenza più lunga e talora anche oltre i limiti dell'età lavorativa).
Talora il rientro è programmato sin dal momento dell'emigrazione (questo sembra essere il caso dei Filippini, oggi numerosi anche in Italia) e allora la durata di permanenza nel paese ospite non supera qualche anno.
Diverso è il caso delle migrazioni legate a lavori stagionali, e, più in generale, della migrazione individuale ricorrente. Lo stesso vale per le migrazioni per gruppi, attualmente organizzate da imprese di paesi industrializzati che appaltano lavori in aree sottosviluppate; in questo caso esiste addirittura un periodo prefissato di permanenza all'estero.
Le motivazioni soggettive (aspetto micro)
Il fenomeno migratorio è stato analizzato anche al microlivello, ossia dal punto di vista delle motivazioni individuali dello spostamento territoriale.
Nella decisione di emigrare si possono distinguere due momenti: la decisione di lasciare l'attuale residenza e la scelta del luogo di destinazione, determinate rispettivamente da vari fattori di repulsione e di attrazione.
È ovvio che le motivazioni possono essere di diverso tipo, e che con l'evoluzione sociale a quelle tradizionali se ne aggiungono altre, espressione di nuove concezioni di vita. Non a caso l'approccio micro si è sviluppato in risposta all'esigenza di tener conto di una realtà sempre più ricca e complessa.
Le diverse motivazioni soggettive si intrecciano sempre più alla spinta determinata dalle condizioni oggettive, talvolta accentuandola e talaltra agendo in contrasto con essa.
Le numerose elaborazioni teoriche sull'argomento sono state ben sintetizzate in un modello proposto negli anni ottanta da De Jong e Fawcett (v. De Jong e Gardner, 1981, pp. 13-58). Tale modello, secondo gli autori, è valido per le migrazioni sia interne che internazionali e per i paesi sia avanzati che in via di sviluppo, in quanto prende in considerazione la decisione di migrare indipendentemente da condizioni oggettive relative al luogo d'origine e a quello di destinazione.
La costruzione del modello parte dalla considerazione delle aspettative potenziali che possono essere sintetizzate nei seguenti valori-obiettivo: ricchezza, status, comfort, stimolo, autonomia, affiliazione, moralità, per ciascuno dei quali vengono proposti vari indicatori.
Un modello dinamico globale interdisciplinare
È stato anche elaborato un modello statistico molto complesso inteso a configurare la dinamica migratoria di una popolazione di n membri migranti tra l regioni (intese in senso lato come ampie aree, province o Stati di una confederazione). Il modello, mutuato dalla fisica statistica, collega il livello micro delle decisioni individuali con il livello macro del processo migratorio; esso si propone anche di descrivere quantitativamente e di stimare la migrazione interregionale di paesi diversi in termini di 'utilità dinamiche' e di 'mobilità', e di correlare la migrazione interregionale con la situazione socioeconomica di tali paesi (v. Weidlich e Haag, 1988, p. V).
Gli effetti delle migrazioni e il problema dell'integrazione degli immigrati
Le migrazioni provocano effetti di varia natura sia nella collettività d'origine che nella collettività di destinazione. Tali effetti sono rilevabili anche nel caso delle migrazioni temporanee e valgono in linea di massima sia per le migrazioni internazionali sia per quelle interne.
È molto difficile individuare e soprattutto valutare tutte le conseguenze dei flussi migratori di una certa entità, giacché tali conseguenze dipendono non solo dalla consistenza numerica dei flussi, ma anche dalla loro struttura demografica e sociale. In linea di massima, si può operare una distinzione tra: a) effetti demografici; b) effetti economici; c) effetti sociali; d) effetti politici; e) effetti antropologici.
Effetti demografici
Innanzitutto, va premesso che gli effetti demografici riguardano tutti gli spostamenti di popolazione, anche quelli che non vengono compresi usualmente nel novero delle migrazioni.
Una prima distinzione fondamentale è quella tra effetti diretti ed effetti indiretti. Tra i primi, il più importante è ovviamente quello di alterare la consistenza numerica della popolazione di origine e di quella di destinazione. Altrettanto importante è la modificazione della struttura demografica delle due popolazioni, in quanto i flussi migratori presentano sistematicamente (eccettuati gli esodi di intere popolazioni) una struttura per sesso, per età e per stato civile ben diversa, sia rispetto alla collettività di origine sia rispetto a quelle verso cui sono diretti. Nel passato tra i migranti prevalevano largamente il sesso maschile, le classi di età giovanili e centrali e i non coniugati. Negli ultimi decenni, tuttavia, il generalizzato ingresso delle donne nel mercato del lavoro ha attenuato le diversità nella presenza dei due sessi fra i migranti, e la tendenza al ricongiungimento familiare ha ridotto anche le altre tradizionali anomalie strutturali dei flussi, senza peraltro eliminarle.
Forse ancora più importanti degli effetti diretti delle migrazioni sono quelli indiretti, che nel caso di flussi continuativi e di una certa consistenza possono modificare radicalmente le caratteristiche demografiche delle zone interessate. Tali effetti indiretti sono una conseguenza sia della struttura per età che caratterizza le masse migranti, sia dei loro comportamenti demografici, che risentono dei comportamenti propri della zona di origine e sono pertanto diversi da quelli della popolazione ospite.
Il fatto che la struttura per età dei migranti sia caratterizzata da una larga prevalenza di età giovanili, ossia delle età a più bassa mortalità e a più elevata fecondità, fa sì che i flussi migratori contribuiscano a modificare la dinamica naturale delle due popolazioni, nel senso di abbassare la natalità in quella di origine elevandone la mortalità (per effetto dell'invecchiamento della popolazione) e di provocare effetti opposti nella popolazione ospite, come effetto dell'afflusso prevalente di individui in età feconda e a basso rischio di morte.
A titolo esemplificativo si può ricordare che la massiccia migrazione interna Sud-Nord verificatasi in Italia negli anni sessanta ha portato una modificazione nella graduatoria regionale della natalità, particolarmente evidente nel caso del Piemonte, che aveva accolto flussi consistenti di immigrazione meridionale.
Va ricordato inoltre che questo effetto demografico indiretto è di regola accentuato dal fatto che gli immigrati provengono da zone nelle quali il comportamento procreativo è caratterizzato da fecondità assai più elevata di quella propria della zona di nuovo insediamento. Tuttavia gli effetti indiretti sulla dinamica naturale delle zone di immigrazione tendono a smorzarsi nel tempo. Infatti, per quanto riguarda gli effetti sulla mortalità, è evidente che i giovani immigrati andranno man mano a ingrossare le classi di età anziane e poi senili, mentre il loro maggior apporto alle nascite si andrà riducendo per effetto dell'acquisizione, più o meno rapida ma inevitabile, dei comportamenti procreativi della zona di nuovo insediamento, in conseguenza dell'integrazione socioeconomica e culturale nel nuovo contesto.
Se sugli effetti demografici diretti delle migrazioni non vi sono interpretazioni e pareri discordi, sugli effetti indiretti non si riscontra uguale consenso.Sin dalla fine del secolo scorso è stata sviluppata negli Stati Uniti un'ipotesi interpretativa relativa agli effetti esercitati dall'immigrazione sull'evoluzione della popolazione locale. Secondo tale ipotesi, risalente a Benjamin Franklin e nota come 'teoria americana' (in quanto adottata successivamente, sia pure con diverse argomentazioni, da autori statunitensi a seguito delle grandi migrazioni dall'Europa verso gli Stati Uniti), l'emigrazione, allentando la pressione demografica del luogo d'origine e favorendone così lo sviluppo, vi provocherebbe una riduzione della mortalità e un incremento della natalità. Per converso, nella popolazione ospite l'afflusso dei migranti abbasserebbe il tenore di vita, e ne risulterebbero un'aumentata mortalità e una ridotta natalità.
Effetti economici
Gli effetti economici delle migrazioni possono essere considerati in buona parte un riflesso di quelli demografici, in quanto il trasferimento di forza lavoro prevalentemente giovanile da un'area a forte pressione demografica a un'area a più debole pressione demografica modifica il rapporto produttori/consumatori e costituisce perciò un fattore positivo per l'assetto produttivo della zona di immigrazione, mentre il luogo d'origine può beneficiare economicamente delle rimesse degli emigranti che, probabilmente, non avrebbero potuto trovare localmente un'adeguata funzione produttiva. Anche se è difficile valutare questi effetti in termini quantitativi, una scuola di pensiero europea che ha avuto largo seguito nella prima metà di questo secolo, e che si è soprattutto basata sull'esperienza delle grandi ondate migratorie Europa-Americhe, e in particolare di quelle Italia-Americhe, ha tentato di affrontare il problema in termini di costi-benefici, sostenendo che le zone di immigrazione hanno beneficiato della ricchezza prodotta da generazioni di individui i cui costi di allevamento sono stati sostenuti dai paesi d'origine (v. Beneduce, 1904; v. Coletti, 1905). Questo tipo di analisi, insieme al tentativo di giungere a una stima quantitativa del trasferimento di ricchezza determinato dalle migrazioni, è stato riproposto in epoca più recente e riferito non soltanto alle migrazioni intercontinentali, ma anche a quelle intraeuropee e persino a quelle interne (v. Sauvy, 1952, pp. 302-330, e 1977; v. Alvaro, 1974; v. Mastrodonato, 1981-1984). Non mancano però ipotesi più sfumate che, pur confermando il vantaggio economico per il paese ospite, tengono conto di possibilità differenziate a seconda delle condizioni di maggiore o minore flessibilità del mercato del lavoro (v. Böhning, 1976, pp. 13-21).
Un cenno a parte merita l'emigrazione qualificata (skill drain), e in particolare quella altamente qualificata (brain drain) che trasferisce nel paese ospite energie produttive di particolare valore. In questo caso, tuttavia, non bisogna dimenticare che tali energie probabilmente non avrebbero potuto trovare modo di esplicarsi nel paese d'origine per mancanza di condizioni strutturali adeguate.
Quando si vogliano valutare gli effetti economici delle migrazioni seguendo i criteri dell'analisi costi-benefici, va tuttavia ricordato che oltre alle poste del bilancio valutabili in termini monetari - i costi di allevamento, di formazione, di trasferimento e di insediamento, nonché i benefici di cui fruiscono il paese ospite (produzione di beni e servizi), i migranti (guadagni) e il paese d'origine (rimesse, capitali investiti dai migranti di ritorno) - ne esistono altre non esprimibili in termini monetari: costi di natura psicologica per i migranti che devono inserirsi nel nuovo contesto, di natura politica e sociale per la collettività ospite, e benefici in termini di interscambi culturali.
Sotto l'aspetto distributivo si può senz'altro affermare che per le poste valutabili in termini monetari il vantaggio è certamente per il paese ospite, mentre più dubbia è tale conclusione per le poste non suscettibili di contabilizzazione.
Effetti sociali
Gli effetti sociali delle migrazioni sono di natura e portata diversa. Sempre facendo riferimento ai flussi migratori più frequenti, ossia quelli dai paesi meno sviluppati verso aree economicamente e socialmente più progredite, si può parlare di una maggiore facilità di accesso da parte dei migranti alla formazione culturale e alla qualificazione professionale: in ragione di una maggiore organizzazione sociale nelle aree di immigrazione rispetto a quella d'origine e di migliori possibilità economiche nelle nuove sedi. Le possibilità di qualificazione facilitano, a loro volta, l'ascesa sociale, soprattutto nel caso di migrazioni definitive e in particolare per le generazioni successive.
Assai importante è l'effetto che le migrazioni esercitano sia sui migranti sia sulla popolazione ospite ponendo a contatto culture diverse. In linea di massima si può parlare di effetti positivi. Se le culture che vengono a contatto non sono profondamente diverse, si determina una compenetrazione in cui prevalgono in genere gli elementi propri della cultura più evoluta, che accoglie però anche apporti a essa estranei. Il processo di compenetrazione è però meno rapido e completo quando la cultura degli immigrati non è omogenea a quella locale.
Se la cultura degli immigrati ha un grado avanzato di evoluzione, essi tenderanno a mantenere i propri caratteri culturali creando una comunità nella comunità, non necessariamente ostacolata dalla popolazione ospite; in caso contrario, si potranno determinare conflitti più o meno gravi, provocati dagli atteggiamenti razzistici di quest'ultima, mentre gli immigrati potranno reagire con comportamenti asociali.
Gli effetti sociali delle migrazioni poi si risentiranno anche nei luoghi d'origine qualora vi siano flussi di ritorno, giacché, dopo una permanenza più o meno lunga nell'area di immigrazione, stili di vita e consuetudini propri di questa vengono comunque acquisiti e, al ritorno, saranno in qualche misura introdotti nella popolazione d'origine. Questo processo di omogeneizzazione, anche se lento, è continuo e accelerato oggi dai mezzi di comunicazione sempre più efficaci.
Effetti politici
Le migrazioni influenzano in varia misura l'ambito politico in conseguenza dei loro effetti sociali. L'analisi storica del fenomeno delle grandi migrazioni insegna che di fronte a flussi immigratori massicci e alle tensioni sociali che ne derivano e che danno luogo ad atteggiamenti xenofobi e razzistici, l'orientamento politico tende a farsi sempre meno permissivo.Conseguenze politiche di maggior gravità derivano poi da migrazioni di massa il cui carattere sia già di natura politica, che possono dar luogo anche a conflitti cruenti e di lunga durata, come nel caso del conflitto arabo-israeliano.
Non sempre, però, le migrazioni determinate da motivi politici provocano tensioni. In certi casi esse possono modificare nel lungo periodo gli atteggiamenti e gli orientamenti politici della zona di nuovo insediamento, come accade non di rado nelle migrazioni dell'epoca attuale in cui spesso, nel determinare la direzione dei flussi, si intrecciano motivazioni sia politiche che economiche.
Effetti antropologici
Nel caso di migrazioni massicce e di una relativamente facile integrazione economica e sociale degli immigrati nella collettività ospite, si verificano con frequenza unioni miste (matrimoni e/o unioni libere) tra immigrati e popolazione locale o tra immigrati di diversa provenienza. Le unioni miste danno luogo a una progressiva modificazione dei caratteri fisici delle nuove generazioni e, nel lungo periodo, tendono a modificare anche le caratteristiche antropologiche della popolazione, come è avvenuto nel corso dei millenni in tutti i continenti.
Tale trasformazione è anche effetto del nuovo ambiente, giacché molti caratteri antropologici sono influenzati, oltre che da fattori genetici, anche da fattori ambientali: la statura ad esempio è influenzata dall'alimentazione, il peso dall'alimentazione e dal genere di vita, e persino la pigmentazione si modifica per effetto di fattori climatici, né si esclude che effetti provocati da fattori ambientali (agenti fisici o chimici) possano incidere nel lungo periodo sul patrimonio genetico - soprattutto attraverso la selezione - e risultare quindi trasmissibili, sì da determinare variazioni antropologiche nelle generazioni successive anche indipendentemente da incroci.
Il problema dell'integrazione degli immigrati
Quando i flussi migratori sono consistenti e continuativi, si pone il problema dell'integrazione degli immigrati nella società ospite. Si tratta di un problema complesso, che presenta diversi aspetti - economici, sociali e politici - i quali possono considerarsi anelli successivi di una catena.
L'integrazione economica, intesa come possibilità per l'immigrato di raggiungere l'autonomia economica attraverso la collocazione nelle strutture produttive della società ospite, può essere considerata la base di partenza per la sua integrazione sociale. Quest'ultima, peraltro, è condizionata anche da altri fattori socioculturali, quali la conoscenza della lingua (che può condizionare la stessa integrazione economica) e in misura minore l'affinità di altri elementi culturali, in particolare la religione.
In conseguenza di una raggiunta integrazione economica e socioculturale si determina anche un'integrazione politica. I matrimoni misti, come abbiamo già accennato, danno luogo poi a un'integrazione fisico-antropologica.
Il processo di integrazione degli immigrati non è sempre indolore, e provoca non di rado tensioni politiche e sociali più o meno gravi. Come abbiamo visto, tale processo è ostacolato da forti difformità di carattere etnico e culturale (in particolare difformità di religione) tra masse immigrate e popolazione ospite. Non sempre però esse creano tensioni tali da compromettere la convivenza pacifica.
Un caso tipico è quello della società statunitense, in cui convivono larghissime comunità fortemente differenziate dal punto di vista etnico e religioso: il processo di integrazione si è svolto qui con ritmo differenziato a seconda della minore o maggiore difformità originaria dei vari gruppi, ma può considerarsi ormai avviata una coesistenza sempre meno conflittuale. E ciò nonostante continuino a verificarsi episodi di intolleranza più o meno gravi, soprattutto nelle zone in cui la popolazione con caratteristiche etniche e culturali molto diverse raggiunge la parità o addirittura la prevalenza numerica.
È assai probabile che l'avvenire vedrà un processo evolutivo analogo anche nelle società europee, dove l'integrazione intracontinentale è già avanzata e dove avrà probabilmente luogo nel prossimo secolo un processo forse più lento e meno indolore di inserimento di consistenti masse di popolazioni africane e asiatiche.
Fenomeni emergenti
Le migrazioni clandestine
Con il termine 'migrazioni clandestine' ci si riferisce ai casi di ingresso o permanenza illegale in un determinato paese. Il fenomeno delle migrazioni illegali è assai diffuso ovunque, e in taluni paesi o in taluni periodi assume proporzioni notevoli, anche se è difficile valutarlo in termini quantitativi poiché sfugge a ogni registrazione statistica.
Si tratta evidentemente di un fenomeno che è tanto più diffuso quanto più sono restrittive le norme di ingresso nel paese, e che l'accresciuta pressione demografica delle zone sottosviluppate e la maggiore facilità di spostamenti anche a lungo raggio hanno reso e tendono a rendere sempre più consistente.
Sebbene le migrazioni illegali siano costituite soprattutto da migranti che si spostano per ragioni di lavoro, non mancano casi di flussi costituiti da migranti che lasciano il loro paese d'origine per ragioni politiche o religiose, perlopiù legate ai sempre più numerosi conflitti interetnici.
L'esempio più macroscopico di migrazione clandestina a scopo di lavoro è il flusso continuo proveniente dal Messico e diretto negli Stati Uniti, favorito dalla contiguità territoriale: secondo stime internazionali circa la metà degli immigrati illegali negli Stati Uniti (da 2,5 a 4 milioni, escluse le famiglie) sarebbe costituita da Messicani (v. ONU, 1989, p. 70).
La tipologia dei flussi clandestini è peraltro molto varia e complessa nelle sue motivazioni, in quanto risente di una pluralità di circostanze. Quando i controlli sono praticamente inesistenti o sono previste sanzioni di lieve entità, la tipologia dei flussi clandestini è assimilabile a quella dei flussi legali. Lo stesso vale per i casi, piuttosto frequenti, di clandestinità derivante da permanenza illegale nel paese ospite una volta scaduto il permesso di soggiorno. In altre circostanze l'emigrazione clandestina assume un carattere di azione assai rischiosa, soprattutto quando è legata a motivazioni politiche.
Nel tentativo di valutare l'entità delle presenze illegali, i paesi di immigrazione cercano di favorire la regolarizzazione dei clandestini attraverso leggi speciali: queste sono state emanate nel corso degli anni 1985-1993 sia negli Stati Uniti, sia in molti Stati europei (Francia, Spagna, Italia), ma con scarso successo.
Il problema dei rifugiati
Nell'ambito delle migrazioni un problema che ha assunto importanza crescente nel corso degli ultimi cinquant'anni è quello dei rifugiati.
Nel primo ventennio dopo la conclusione della seconda guerra mondiale la maggior parte dei rifugiati era di origine europea e si è inserita nei paesi industrializzati. Più recentemente però il fenomeno ha assunto dimensioni mondiali: è stato calcolato che nel 1985 vi erano nel mondo circa 14 milioni di rifugiati e che nel periodo 1980-1985 il numero dei rifugiati nei paesi in via di sviluppo era passato da 6,5 milioni a 8,2 milioni, di cui circa il 50% in Asia e il 30% in Africa, mentre nei paesi sviluppati la cifra si era stabilizzata intorno ai 2 milioni, di cui circa il 32% in Europa, il 63% nell'America del Nord e il 5% in Oceania (v. ONU, 1988, pp. 241-245). Alla fine degli anni ottanta il numero complessivo dei rifugiati è stato stimato pari a 20 milioni (v. AIDELF, 1988, p. 123). Una valutazione statistica esatta è tuttavia difficile, anche perché manca una definizione universalmente accettata del 'rifugiato'; l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) considera tali solo le persone che lasciano il loro paese d'origine, escludendo coloro che si spostano all'interno di esso, mentre gli organismi assistenziali adottano definizioni molto late.Gli orientamenti seguiti dall'UNHCR nei confronti dei rifugiati sono: la promozione, ove possibile, del rimpatrio volontario e il tentativo, ove questo non sia possibile, di integrazione nel paese di primo asilo o di asilo in paesi terzi.
Attualmente i rifugiati sono particolarmente numerosi in Africa e in Asia come conseguenza dei gravi conflitti politici, etnici e religiosi che affliggono tali continenti. Molti di essi peraltro emigrano in altri continenti. Flussi prevalentemente intercontinentali caratterizzano l'America Latina, i cui esuli si dirigono soprattutto verso l'America settentrionale, e abbastanza consistenti sono tuttora i flussi provenienti dall'Europa orientale: soprattutto Ebrei provenienti dall'ex Unione Sovietica, esuli dall'ex Iugoslavia e Polacchi, i quali hanno perlopiù come destinazione finale l'America del Nord e l'Australia, ma in attesa dei permessi di soggiorno in tali paesi vengono accolti nei paesi europei, tra cui l'Italia.
Le politiche migratorie
Le politiche migratorie riguardano sia le norme di ingresso che le norme di uscita dei migranti.Le norme di ingresso possono essere estremamente liberali, o addirittura incoraggiare l'immigrazione (è questo il caso di Israele nei confronti degli Ebrei di ogni provenienza); possono seguire criteri selettivi (ad esempio favorire gli ingressi a scopo di lavoro o i ricongiungimenti familiari), oppure accettare senza restrizione alcuna i rifugiati. Non mancano peraltro paesi che vietano ogni forma di immigrazione a lungo termine (ad esempio il Giappone).
Anche le norme di uscita sono diversificate. In linea di massima i cittadini sono liberi di lasciare il proprio paese, come sancito dalla Dichiarazione di Helsinki sui diritti umani. Solo in qualche caso vi possono essere norme che vietano l'uscita di cittadini con particolari competenze (ad esempio l'Egitto aveva proibito in un certo periodo l'uscita di fisici) o appartenenti a determinati gruppi etnici. In alcuni casi, infine, l'uscita dei cittadini viene favorita per alleggerire il mercato del lavoro interno e per accrescere le rimesse (lo Sri Lanka, il Pakistan, il Bangladesh e l'India, ad esempio, incoraggiano l'emigrazione in Medio Oriente; in passato la Turchia favoriva l'emigrazione in Germania e l'Algeria l'emigrazione in Francia).
Sono abbastanza frequenti i casi di norme di espulsione: la classe media fu espulsa da Cuba dopo la rivoluzione di Fidel Castro, talune minoranze etniche sono state espulse da alcuni paesi: Cinesi dal Vietnam, Indiani dall'Africa orientale.Le politiche migratorie possono essere suggerite da considerazioni demografiche o economiche e da preoccupazioni di natura sociale. Sebbene gli effetti demografici delle migrazioni possano essere notevoli, non sembra però che vi siano considerazioni demografiche all'origine delle politiche migratorie, né nei paesi d'origine né in quelli di destinazione. Un'eccezione è forse costituita dalla Francia, in cui il problema della denatalità è stato sempre particolarmente sentito, sin dal Settecento. Tale paese ha infatti favorito l'integrazione degli immigrati per ragioni demografiche oltreché economiche, e ha sempre adottato nei loro confronti una politica di naturalizzazione.
Considerazioni di carattere economico sono invece prevalenti nelle politiche migratorie della maggior parte dei paesi, sia quelli ospiti che quelli d'origine. In genere i paesi di immigrazione caratterizzati da una deficienza di manodopera non pongono praticamente limiti all'ingresso di lavoratori stranieri, né esercitano controlli rigorosi (è quanto è accaduto, ad esempio, nello sviluppo dei continenti nuovi). Quando però la consistenza e la continuità dei flussi cominciano a creare problemi di assorbimento economico e/o di integrazione sociale, vengono stabilite quote di ingresso di nuovi immigrati, spesso discriminanti dal punto di vista della provenienza. Attualmente la maggior parte dei paesi di immigrazione fissa quote di ingresso ritenute compatibili con le possibilità di assorbimento nel mercato del lavoro: è questo il caso dell'Australia, del Canada e degli Stati Uniti. Questi ultimi peraltro hanno seguito sino al 1986 le linee dell'Immigration act del 1952, che stabiliva quote etnicamente differenziate tenendo conto dei "legami culturali e storici" degli Stati Uniti con i diversi paesi d'origine. Nel 1990 è stato approvato il nuovo Immigration act, che risponde alla necessità di conciliare le esigenze dei lavoratori stranieri e quelle delle imprese, evitando i possibili effetti negativi per i lavoratori statunitensi (v. OCDE-SOPEMI, 1992, pp. 85-88).
Un orientamento molto diffuso è quello di favorire le riunificazioni familiari (Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda), mentre alcuni paesi mirano anche a facilitare l'ingresso a persone qualificate (Argentina, Australia, Sudafrica, Canada).In appoggio alle politiche perseguite, molti paesi mirano alla stipulazione di accordi bilaterali per favorire un'immigrazione permanente selezionata (Australia, Nuova Zelanda, Venezuela, Portogallo, Repubblica di Corea e alcuni paesi dell'America Latina). Gli accordi vengono generalmente conclusi attraverso i canali del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni, ICM (v. ONU, 1982, pp. 5-8).
La crescente pressione dei migranti verso i paesi dell'OCDE ne ha influenzato le politiche, che all'inizio degli anni novanta sono caratterizzate da tre obiettivi: più attento monitoraggio e regolazione dei flussi; accresciuto sforzo per combattere l'immigrazione illegale e il suo impiego; facilitazione dei processi di integrazione dei gruppi immigrati.
Nel caso di immigrazioni temporanee a scopo di lavoro, l'iniziativa viene lasciata in genere alle imprese, salvo interventi politici quando il verificarsi di catene migratorie pone l'alternativa tra il rimpatrio e l'integrazione. Il rimpatrio è stato favorito dalla maggior parte dei paesi europei di tradizionale immigrazione (Repubblica Federale Tedesca, Francia, Svizzera) a partire dal 1973-1974, nel tentativo di ridurre la disoccupazione dei lavoratori locali, anche se i risultati in tal senso sembrano scarsi. Talora la politica di rimpatrio è stata sostenuta anche con misure economiche (Francia). Parallelamente si è cercato di favorire l'integrazione attraverso le riunificazioni familiari e la sempre più ampia concessione di diritti sociali, mentre tuttora poco diffusa è la concessione di diritti politici.
La sensibilità per i problemi dei migranti è cresciuta da parte di organismi sia nazionali (commissioni governative e nazionali) che internazionali (CEE, Consiglio d'Europa, OCDE, ICM, ILO) con il fine di favorire l'integrazione economica dei migranti e di assicurare loro sempre maggiori garanzie sociali.Nel Trattato di Maastricht del 1993 per la prima volta viene inclusa tra le materie di interesse e competenza comunitaria la questione della mobilità delle persone. In Italia, il decreto legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, fissa la quota annua di ammissione di immigrati.Il cosiddetto 'Accordo Shengen', al quale l'Italia ha aderito nel 1990, favorisce una più facile e rapida circolazione all'interno della Comunità Europea, ma esige requisiti assai più omogenei e controlli più severi per entrare nella Comunità.
Anche sul piano scientifico, oltre che istituzionale, i problemi connessi all'emigrazione sono all'ordine del giorno. Il fenomeno è stato discusso nel 1993 a Santa Cruz, in Bolivia, da un gruppo di esperti sulla distribuzione della popolazione, di cui facevano parte i rappresentanti delle commissioni regionali dell'ONU e delle principali organizzazioni internazionali (v. ONU, 1993, n. 34-35, pp. 120-152).
Se nell'ultimo ventennio è notevolmente aumentata l'attenzione nei confronti dei migranti sia da parte dei paesi ospiti che da parte degli organismi internazionali, una trasformazione è osservabile anche nei paesi di emigrazione. A parte la situazione dei paesi petroliferi del Medio Oriente, che improvvisamente sono divenuti aree di immigrazione e non sembrano seguire una precisa politica migratoria, la maggior parte delle aree di emigrazione del Terzo Mondo ha incentrato la propria politica sullo sforzo di utilizzare al meglio le rimesse degli emigranti, in qualche caso rendendole obbligatorie (Filippine) o incentivandole con concessioni valutarie (Algeria e Marocco), anche se rari sono i tentativi riusciti di una loro utilizzazione produttiva (v. ONU, 1982, pp. 42-44).
(V. anche Demografia; Demografia storica; Industrializzazione; Integrazione sociale; Popolazione; Sottosviluppo; Urbanizzazione).
Bibliografia
AIDELF (Association Internationale Demographes de Langue Française), Les migrations internationales. Séminaire de Calabre (8-10 septembre 1986), Paris 1988.
Alberoni, F., Un modello interpretativo dell'integrazione sociale dell'immigrato nel milanese, in "Rivista italiana di sociologia", 1962, n. 3.
Alvaro, G., Una valutazione del capitale umano emigrato dal Mezzogiorno nel periodo 1951-1971, Roma 1974.
Beneduce, A., Capitali sottratti all'Italia dall'emigrazione con l'estero, in "Giornale degli economisti", 1904, XXIX, pp. 506-518.
Böhning, W.R., Basic aspects of migration from poor to rich countries: facts, problems, policies, International Labour Office, New York 1976.
Boyce, A.J. (a cura di), Migration and mobility. Biosocial aspects of human movements, London-Philadelphia 1984.
Coletti, F., Il costo di produzione dell'uomo e il valore economico degli emigranti, in "Giornale degli economisti", 1905, XXX, pp. 260-291.
Coletti, F., L'emigrazione italiana, in Cinquant'anni di storia italiana, vol. III, Milano 1911, pp. 1-284.
Courgeau, D., Analyse quantitative des migrations humaines, Paris 1980.
Courgeau, D., Méthodes de mesure de la mobilité spatiale, Paris 1988.
Courgeau, D., Lelièvre, E., Analyse démographique des biographies, Paris 1989.
De Jong, G.F., Gardner, R.W. (a cura di), Migration decision making, New York 1981.
Eisenstadt, J.N., Analysis of patterns of immigration and absorption of immigrants, in "Population studies", 1953, n. 7, pp. 167-180.
Federici, N., Istituzioni di demografia, Roma 1979.
Federici, N., Le migrazioni: che cosa interessa conoscere, in "Genus", 1991, XLVII, 1-2, pp. 153-162.
Federici, N., Golini, A., Les migrations entre les grandes régions des Six Pays, in "Genus", 1972, XXVIII, pp. 27-68.
Georges, P., Les migrations internationales, Paris 1976 (tr. it.: Le migrazioni internazionali, Roma 1978).
Gini, C., La teoria delle migrazioni adattative, in "Statistica", luglio-settembre 1954, pp. 325-349.
Golini, A., Distribuzione della popolazione, migrazioni interne e urbanizzazione in Italia, Roma 1974.
Golini, A., Population movements: typology and data collection, trends and policies, in "European population conference", 1987, pp. 263-328.
Golini, A., Bonifazi, C., Demographic trends and international migration, in "The future of migration", Paris 1987, pp. 110-136.
Gonnard, R., L'émigration européenne au XIXème siècle, Paris 1906.
Gonnard, R., Essai sur l'histoire de l'émigration, Paris 1928.
Kritz, M.M., Leanlim, L., Zlotnik, H., Migration systems. A global approach, Oxford 1992.
Lee, E., A theory of migration, in "Demography", 1966, III, 1, pp. 47-57.
Livi Bacci, M., La trasformazione demografica delle società europee, Torino 1977.
Mastrodonato, A., Il capitale umano emigrato dal Mezzogiorno al Centro-Nord d'Italia nel trentennio 1952-1981, in "Annali dell'Istituto di Statistica di Bari", 1981-1984, pp. 17-81.
Melotti, U., Migrazioni internazionali e integrazione sociale, il caso italiano e le esperienze europee, in Analisi dei bisogni e offerta dei servizi per gli stranieri extra-comunitari, Milano 1992, pp. 1-38.
Natale, M., Analisi delle fonti statistiche per la misura dell'immigrazione straniera in Italia: esame e proposte, ISTAT, Note e relazioni, n. 6, Roma 1989, pp. 19-40.
OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique), Migration. The demographic aspects, Paris 1991.
OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économique) - SOPEMI (Continuous Reporting System on Migration), Trends in international migration, Paris 1992.
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), The determinants and consequences of population trends, I, 50, New York 1973.
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), Statistiques des migrations, New York 1976.
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), Statistiques des migrations internes: rapport technique, New York 1978.
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), International migration policies and programmes, New York 1982.
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), World population trends and policies, New York 1988.
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), World population monitoring, New York 1989.
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), Population studies, New York 1990.
ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), Population bulletin, New York 1993.
Sauvy, A., Théorie générale de la population, vol. I, Économie et population, Paris 1952.
Sauvy, A., Coût et valeur de la vie humaine, Paris 1977.
Stark, O., The migration of labor, Padstow 1991.
Tapinos, G., L'économie des migrations internationales, Paris 1974.
Todaro, M.P., International migration in developing countries, International Labour Office, Geneve 1976, pp. 106 ss.
Weidlich, W., Haag, G. (a cura di), Interregional migration. Dynamics theory and comparative analysis, Berlin 1988.
Withol de Wenden, C., National policies and practices of entry control in OECD countries, Paris 1986.
"XX secolo", 1994, VI, 1.
Zelinsky, W., The hypothesis of the mobility transition, in "Geographical review", 1971, LXI, 2, pp. 219-249.
Zlotnik, H., Measuring international migration: theory and practice, in "International migration review", 1987, XXI, 4, pp. 925-1550.
Aspetti storici
di Egmont Lee
1. Quadro storico delle migrazioni umane
Il primo popolamento del globo
Il processo di diffusione dell'uomo sulla Terra è stato ricostruito sulla base di vari modelli - tutti, inevitabilmente, in qualche misura provvisori, date le radicali revisioni cui sono soggette le conoscenze attuali alla luce di nuove acquisizioni. A quanto sembra la diffusione dei primi Ominidi, avvenuta da 5 milioni a 1 milione di anni fa, fu limitata all'Africa subsahariana. Da allora sino a circa 200.000 anni a.C. apparve in Nordafrica Homo erectus, o una forma arcaica di Homo sapiens, per poi diffondersi, più o meno verso il 50.000 a.C., alle medie latitudini dell'Asia e dell'Europa, nonché in altre parti dell'Eurasia continentale. Da allora sino a circa 8.000 anni a.C. gruppi di Ominidi con caratteri anatomici ormai moderni fecero la loro comparsa in Australia, nella Siberia orientale, lungo le coste del Pacifico, in Giappone, nelle Americhe e sulle catene montuose non coperte dalla glaciazione. Approssimativamente 1.500 anni a.C. l'uomo occupò anche alcune zone dell'Artico, le regioni dell'Oceano Indiano e del Pacifico, nonché le foreste tropicali e i grandi deserti di sabbia. Nel più recente passato sono state abitate anche le regioni dell'Atlantico centrale e meridionale, lasciando l'Antartico quale unico continente privo di insediamenti umani stabili. La progressione dell'insediamento umano fu tutt'altro che continua; essa venne profondamente influenzata da fattori ambientali (in particolare dalle glaciazioni), e fu accompagnata da un adattamento evoluzionistico. Lo schema cronologico che viene oggi accettato come il più attendibile è stato ricostruito in larga misura sulla base delle distanze genetiche e delle loro implicazioni per la diffusione dell'umanità geneticamente 'moderna'; un contributo fondamentale in questo senso è stato dato dal lavoro teorico di Luca Cavalli-Sforza e dei suoi collaboratori.
Per la maggior parte i movimenti di popolazione che furono all'origine della diffusione dell'uomo sulla Terra possono essere definiti migrazioni solo nel senso che implicano lo spostamento di gruppi di individui. Non si tratta di eventi separati, e sarebbe più appropriato parlare in proposito di diffusione e di colonizzazione, ossia di occupazione di habitat disponibili e della loro estensione a nuove aree. Analogamente, sembra che molti fenomeni - come ad esempio la diffusione delle tecnologie e delle lingue - che in passato venivano spiegati ipotizzando movimenti migratori non documentati altrimenti, siano da ricondurre a processi di imitazione e a prestiti piuttosto che alla mobilità delle popolazioni. Di conseguenza oggi si ritiene poco probabile che la diffusione delle lingue indoeuropee sia dovuta agli spostamenti di una popolazione indoeuropea originaria anche se, naturalmente, non sussistono dubbi sulle migrazioni di popoli che parlavano l'una o l'altra delle lingue indoeuropee.
L'Eurasia
I primi insediamenti umani in Eurasia sono notevolmente anteriori al periodo della glaciazione più recente, e potrebbero risalire a circa 200.000 anni fa. Alcuni siti nell'area delle pianure europee e lungo il fiume Don sono anteriori all'ultima glaciazione, che ebbe la sua massima espansione intorno al 16.000 a.C., ma per la maggior parte tale regione venne ripopolata solo dopo che la glaciazione si fu ritirata.
Permane una notevole incertezza relativamente alle origini dell'insediamento umano nella parte asiatica del continente. Mentre alcune testimonianze indicano la presenza di Homo erectus in Cina forse già 700.000-200.000 anni fa, sembra probabile che l'Asia sia stata ricolonizzata più tardi, poiché solo dal 38.000 al 36.000 a.C. compaiono siti di Homo sapiens migrante. Navigatori provenienti dalla Cina potrebbero aver colonizzato il Giappone approssimativamente nello stesso periodo. Il primo popolamento del Nordest asiatico e della Siberia risale a 12.000-10.000 anni fa.
I movimenti migratori successivi furono frequenti e intensi, e interessarono tutto il continente. Uno dei principali focolai di instabilità furono le steppe dell'Asia centrale, in particolare della Mongolia, abitate da popolazioni nomadi: grazie alla loro unione in efficaci alleanze, queste ultime riuscirono ripetutamente a oltrepassare i confini degli Stati esistenti e a effettuare importanti conquiste. Per esempio, i Hsiung-nu tra il I e il V secolo saccheggiarono la Cina settentrionale determinando migrazioni di popolazioni cinesi verso il Nordovest. Noti in Europa come Unni, questi gruppi nomadi innescarono una sequenza di migrazioni alle quali si deve in parte la nuova configurazione dell'Europa alla fine dell'antichità. Anche l'impero di Genghiz Khān al principio del XIII secolo e gli Stati che gli succedettero ebbero importanti ripercussioni sullo sviluppo dell'Iran e dell'antica Russia. La Mongolia fu inoltre il punto di partenza del successivo esodo turco, diretto inizialmente verso l'Anatolia e in seguito verso le coste del Mediterraneo orientale nonché, con i Turchi ottomani, verso l'Europa sudorientale, la Siria, Cipro, l'Egitto e il Nordafrica.
Nel caso del mondo antico è difficile e spesso poco utile operare una netta distinzione tra migrazioni e colonizzazioni. Elementi di entrambi i fenomeni si ritrovano nella fondazione delle colonie greche e fenicie sulle coste e nelle isole del Mediterraneo, e lo stesso vale per i movimenti delle popolazioni identificate come Celti. La successiva creazione degli imperi del Vicino Oriente e poi degli imperi macedone e romano comportò in un primo tempo spostamenti di popolazione di proporzioni relativamente modeste, ma a questi fecero seguito trasferimenti assai più massicci, inclusi esodi forzati di consistenti gruppi etnici per motivi politici, militari ed economici. I grandi imperi offrirono inoltre nuove opportunità di colonizzazione, favorirono la migrazione volontaria di individui e di gruppi, e organizzarono spostamenti di popolazione - a volte coatti - attraverso il servizio militare e la deportazione di schiavi.
La massiccia migrazione di popoli verificatasi tra il IV e il X secolo d.C., quando ondate successive di tribù germaniche e, in seguito, di Berberi e Magiari penetrarono nel subcontinente europeo, diede luogo a imponenti esodi e spostamenti di popolazione. Spesso questi movimenti innescarono migrazioni a catena, in cui la conquista determinava l'esodo delle popolazioni conquistate. L'insediamento dei nuovi popoli spesso diede luogo a scambi culturali e all'integrazione con la popolazione locale. Nel caso di molti dei gruppi più importanti, tuttavia, l'insediamento ebbe un carattere temporaneo e fu seguito da nuovi spostamenti. Le migrazioni slave tra il VII e il X secolo ebbero come luogo d'origine l'area a nord dei Carpazi e portarono gli Slavi meridionali nei Balcani, quelli occidentali in Boemia e Polonia e quelli orientali nella Russia centrale.
Lungi dall'essere l'era statica postulata dalle vecchie convenzioni storiografiche, il periodo compreso tra l'XI secolo e l'inizio dell'epoca delle grandi migrazioni, nel XVI secolo, fu caratterizzato da estesi movimenti di popolazione praticamente in tutte le aree del continente. La mobilità dei primi secoli fu alimentata in larga misura da un consistente incremento demografico. Sebbene le cifre attendibili a nostra disposizione siano scarse, si ritiene che dall'XI al XIV secolo, prima della comparsa delle malattie pandemiche, la popolazione europea sia aumentata da 30 a più di 70 milioni. Nella maggior parte dei casi gli spostamenti erano da zone rurali a zone rurali e su brevi distanze, secondo una tendenza destinata a durare sino al XVIII secolo. D'altro canto la progressiva urbanizzazione dell'Europa centrale e occidentale determinava significativi flussi rurali-urbani, e le frontiere coloniali dell'Europa orientale e sudoccidentale attraevano masse di migranti provenienti sia dalle regioni periferiche che dal cuore dell'Europa occidentale, con spostamenti che spesso coprivano distanze notevoli.
Nell'Asia centrale le più importanti correnti migratorie a noi note tra il XIII e il XVIII secolo furono legate alla formazione dei sultanati musulmani e successivamente alla nascita dell'impero moghūl nell'India settentrionale.Nell'Europa dell'epoca preindustriale le ricorrenti epidemie che fecero la loro prima comparsa nel XIV secolo, nonché una serie di conquiste e di guerre che iniziarono approssimativamente nello stesso periodo, furono all'origine di molti dei più importanti spostamenti di popolazione. La rinascita urbana dopo il declino demografico e le opportunità offerte dai territori di frontiera attrassero ingenti flussi di popolazione rurale dai paesi dell'Europa centrale e occidentale. Nello stesso tempo le conquiste dei Turchi ottomani nei Balcani e la crescente intolleranza religiosa generarono ampi movimenti di rifugiati, molti dei quali cercarono asilo in regioni assai distanti dai luoghi di residenza originari.
A partire dal XVI secolo la creazione delle prime colonie europee in altri continenti segnò l'inizio di un'era di grandi migrazioni transoceaniche, che raggiunsero il culmine tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Tra il principio del XVI secolo e la metà del XVII più di 400.000 Spagnoli emigrarono nei Caraibi, nell'America centrale e meridionale e in Messico; nello stesso periodo circa 70.000 Portoghesi migrarono in Brasile. Prima del periodo di massima espansione delle migrazioni, nel XIX secolo, l'America settentrionale accoglieva già circa 1 milione di immigrati provenienti dal Regno Unito (comprese Scozia e Irlanda) e i Caraibi ne assorbivano altri 100.000. I flussi migratori provenienti da altre regioni europee furono più modesti, anche se la Francia, gli Stati tedeschi, l'Olanda e la Scandinavia ebbero correnti di emigrazione di un certo rilievo.
Nello stesso tempo, con l'affermarsi dell'industrializzazione, si intensificarono gli spostamenti di popolazione all'interno del continente europeo, nonché all'interno dei vari Stati che andavano acquistando confini politici sempre più definiti. In alcune aree la domanda di manodopera nei centri urbani in via di espansione determinò un afflusso di popolazione rurale dalle regioni circostanti, ma anche di lavoratori provenienti da aree assai più lontane.
L'eccezionale transizione demografica della metà del XIX secolo creò i presupposti per gli ingenti movimenti migratori che caratterizzarono la seconda metà del secolo e l'inizio del successivo. Le stime relative alla migrazione europea transoceanica variano. Nel secolo della sua massima espansione, nello spazio di circa tre generazioni - dalla metà dell'Ottocento al 1932 - si calcola che gli immigrati europei ammontassero complessivamente a circa 50 milioni, di cui 18 provenienti dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda, 11,1 dall'Italia, 6,5 dalla Penisola iberica, 5,2 dall'Austria-Ungheria, 4,9 dalla Polonia e dalla Russia, e 2,1 dalla Scandinavia. Il gruppo più consistente - 34,2 milioni di immigrati - fu accolto dagli Stati Uniti. L'Argentina e l'Uruguay ne ricevettero 7,1 milioni, il Canada 5,2, il Brasile 4,4 e l'Australia e la Nuova Zelanda 3,5. Naturalmente furono rilevanti anche le migrazioni di ritorno. Secondo le stime di Massimo Livi Bacci circa il 50,2% degli italiani emigrati negli Stati Uniti fece ritorno al paese d'origine. L'alta incidenza delle migrazioni di ritorno non è un fenomeno eccezionale. Secondo stime relative al Canada francese per un periodo precedente, forse i due terzi degli immigrati alla fine tornarono in Francia.
Le migrazioni intracontinentali europee e nordasiatiche furono anch'esse cospicue, e furono determinate in larga misura dalla domanda di manodopera industriale. Ingenti flussi migratori si dovettero anche alle persecuzioni religiose e all'aprirsi di vasti territori alla colonizzazione. La Siberia venne colonizzata in misura massiccia dai Russi, specialmente nel periodo compreso tra il completamento della linea ferroviaria transiberiana e la prima guerra mondiale, in cui emigrarono circa 6 milioni di Russi. Altri 4 milioni si diressero verso il Caucaso e l'Asia centrale. Nell'Europa occidentale, negli anni precedenti il primo conflitto mondiale, circa 60.000 Polacchi emigrarono in Germania, in larga misura a seguito della domanda di manodopera nelle industrie. L'immigrazione in Francia fu particolarmente consistente, e continuò nel XX secolo, con 3,7 milioni di stranieri registrati nel 1926 e 2,2 milioni nel 1936, cui si aggiungevano circa 500.000 cittadini naturalizzati.
Nell'Asia sudorientale l'emigrazione su larga scala dalla Cina verso altri paesi cominciò nel XVI secolo, e in quello successivo ebbe inizio la colonizzazione di Taiwan. Nel secolo precedente la prima guerra mondiale gli immigrati cinesi a Taiwan arrivavano già a circa 1,3 milioni; complessivamente gli immigrati nel Sudest asiatico erano circa 12 milioni, e il Nordamerica ne accoglieva più di 500.000. Un flusso di manodopera a contratto si diresse anche verso il Perù, il Sudafrica e i Caraibi. A partire dalla metà del XVIII secolo aumentò considerevolmente l'emigrazione indiana verso la Malesia, che alla metà del XX secolo accoglieva oltre 4 milioni di immigrati, sebbene vi fosse anche una significativa migrazione di ritorno. Un altro flusso di 1,5 milioni circa si diresse verso il Sud dell'Asia e verso l'Africa orientale e meridionale. Un contingente di manodopera a contratto fu inviato inoltre nella Guiana, a Trinidad e nella Réunion. Tra il 1815 e il 1914 gli immigrati giapponesi nelle Hawaii e nel Nordamerica arrivavano a un totale di circa 150.000; flussi di più modesta entità si diressero in Sudamerica, mentre piuttosto cospicua fu l'emigrazione verso altre parti dell'Asia, in cui affluirono circa 6 milioni di immigrati.
L'Africa
Probabile luogo d'origine della specie umana, l'Africa conobbe le prime ondate preistoriche di migrazione, diffusione e colonizzazione umane. In epoca storica il Nordafrica, l'Egitto e il Sudan furono fortemente influenzati dai flussi migratori che interessarono anche l'Europa mediterranea. Tra il 1100 e il 1400 l'Africa subsahariana fu teatro di estesi movimenti migratori su grandi distanze, compreso quello degli Swahili: muovendosi dai territori degli odierni Oman, Baḥrein e Iran, sia per mare che per terra (dall'interno dell'Africa), questi fondarono una serie di porti commerciali sulla costa orientale dell'Africa, tra cui Mombasa, Malindi, Kilwa e Mogadiscio. Tra il 1300 e il 1800 gli Hausa islamici si trasferirono dal Sudan occidentale verso la Nigeria settentrionale e l'area del lago Ciad. Altri importanti flussi migratori provenienti dal Sudan si diressero verso la savana dell'Africa occidentale. Le popolazioni nilotiche dei Masai e dei Nuer migrarono dal Sudan orientale verso il Sudan meridionale, l'Uganda settentrionale e il Kenya: a partire dal XVI secolo i Lunda e i Luba di lingua bantu migrarono dal corso superiore dei fiumi Lulua e Kasai verso le regioni interne dell'Africa centrale. Nella seconda metà del XIX secolo la domanda di manodopera costituì una delle principali cause della mobilitazione di imponenti flussi migratori intracontinentali. A seguito della scoperta delle miniere d'oro e di diamanti in Sudafrica (rispettivamente nel 1869 e nel 1886) si ebbe una significativa migrazione di manodopera dalle regioni vicine. Successivamente l'immigrazione di lavoratori in Sudafrica venne organizzata attraverso un reclutamento controllato. I più massicci spostamenti di popolazione riguardanti l'Africa non ebbero il carattere di migrazioni spontanee.
Tra il 1500 e il 1900 probabilmente non meno di 15 milioni di schiavi vennero inviati da varie parti dell'Africa nel Nuovo Mondo, nonché nel Medio Oriente, nelle regioni del Golfo Persico e in Europa. La penisola arabica ricevette circa 3 milioni di schiavi dall'Africa nordorientale, orientale e centrale, 400.000 affluirono nell'area del Golfo Persico e altri 250.000 nel Medio Oriente. I contingenti più massicci, rispettivamente di 4 e di 3,5 milioni, furono inviati dall'Africa occidentale e centrale verso i Caraibi e il Brasile. Al confronto, di dimensioni più modeste appaiono i flussi diretti verso altre destinazioni del Nuovo Mondo: Nordamerica (500.000), Messico e America centrale (500.000), Sudamerica settentrionale (750.000), Sudamerica meridionale (250.000). Circa 300.000 schiavi provenienti dall'Africa occidentale affluirono nell'Europa occidentale e meridionale.
Per contro, il flusso di immigrati in Africa da altri continenti fu quantitativamente più modesto. In diversi territori dell'Africa subsahariana i colonizzatori europei trasformarono l'assetto politico e sociale del continente e il suo regime economico, ma rimasero in netta inferiorità numerica rispetto alla popolazione indigena. Anche in Nordafrica, dove il dominio europeo fu particolarmente forte, il numero dei bianchi era relativamente esiguo. Ancora all'epoca della seconda guerra mondiale, solo 1,5 milioni di europei, prevalentemente francesi, spagnoli e italiani, risiedevano in Nordafrica. In alcune regioni ebbe una certa consistenza l'immigrazione di manodopera asiatica.
I paesi di immigrazione
Sia pure con modalità diverse, alcuni paesi moderni hanno risentito in misura tale gli effetti di ondate migratorie relativamente recenti da poter essere definiti paesi di immigrazione.
Il continente nordamericano e quello sudamericano, i Caraibi, l'Australia e la Nuova Zelanda sono stati gli sbocchi di ingenti flussi di immigrati i quali, spesso anche a seguito del declino demografico della popolazione locale, sono diventati la quota preponderante della popolazione. La maggior parte degli immigrati proveniva dall'Europa, ma flussi di una certa consistenza arrivarono anche dall'Africa e dall'Asia.
Sembra certo che il popolamento del Nordamerica e del Sudamerica sia relativamente recente, sebbene restino ancora oggetto di controversia l'epoca dell'arrivo, gli spostamenti e i modelli di distribuzione geografica delle prime popolazioni. Gli studiosi indicano per il primo popolamento delle Americhe una data che oscilla tra i 50.000 e i 30.000 anni fa. I primi insediamenti umani in Australia e in Nuova Zelanda sembrano essere più recenti. La colonizzazione della Nuova Zelanda da parte dei Polinesiani e dei Melanesiani risale al 1000, quella delle Hawaii al 1400.I primi contatti con gli europei provocarono invariabilmente catastrofi demografiche nelle popolazioni indigene, causate principalmente dalle epidemie di malattie contagiose. Già nel XVI secolo nelle Americhe, e alla fine del XVIII secolo in Australia e in Nuova Zelanda, la decimazione delle popolazioni locali e l'espansione aggressiva dei colonizzatori, che arrivavano in contingenti sempre più massicci, crearono realtà sociali, economiche e culturali radicalmente nuove. La provenienza degli immigrati e la natura delle migrazioni variavano notevolmente nelle diverse regioni: dalle migrazioni relativamente aperte e senza restrizioni caratteristiche di certe aree del Nordamerica ai flussi assai più controllati ed etnicamente omogenei approdati in Nuova Zelanda e in Australia nel XIX secolo e agli inizi del XX. Le migrazioni forzate furono un elemento importante della prima fase della colonizzazione europea in Australia, dove verso il 1900 vennero inviati dal Regno Unito circa 150.000 deportati. Le migrazioni coatte di schiavi assunsero un'importanza fondamentale nei Caraibi e in alcune regioni dell'America centrale e settentrionale. Nel complesso, il XIX secolo fu caratterizzato da un significativo incremento della popolazione immigrata, da consistenti correnti migratorie interne e, nel caso delle Americhe, intracontinentali. Prima del 1914 circa 300.000 Messicani emigrarono negli Stati Uniti e in Canada, un flusso che negli ultimi decenni ha registrato un vistoso incremento: nel 1990 il numero degli immigrati messicani, in prevalenza illegali, è stato stimato pari a 1,2 milioni. L'immigrazione dai Caraibi verso gli Stati Uniti ha raggiunto anch'essa proporzioni imponenti.
2. Il XX secolo
A seguito delle notevoli instabilità causate dalle guerre, dai mutamenti climatici e da una crescita demografica senza precedenti - soprattutto in Africa, in Asia e in Sudamerica - nel XX secolo si è assistito a un vistoso incremento delle migrazioni internazionali. Perlopiù si è trattato di migrazioni forzate: gli immigrati erano spesso rifugiati costretti ad abbandonare il paese d'origine a causa di guerre o repressioni politiche, oppure vittime di esodi forzati per motivi politici, ideologici e religiosi. Il numero complessivo dei rifugiati dal 1900 a oggi probabilmente supera quello degli immigrati appartenenti a questa categoria di tutte le epoche passate. Solo per gli anni 1950-1990 il numero complessivo dei rifugiati è stato stimato pari a 70 milioni circa.
Le più recenti ondate di migrazioni forzate hanno riguardato pressoché tutti i continenti, ma a risentire maggiormente del fenomeno sono stati il Sud e il Sudest asiatico, il Vicino e il Medio Oriente, e soprattutto l'Africa. Qui gli Stati creati a partire dagli anni sessanta con l'acquisizione dell'indipendenza politica sono caratterizzati da società multietniche, mentre i confini politici separano gruppi etnici affini. Le guerre civili degli ultimi anni hanno causato imponenti flussi di rifugiati internazionali, ma ancora più numerosi sono gli immigrati interni, che sebbene non attraversino confini internazionali sono nondimeno da includere nella categoria dei rifugiati. Al confronto con la situazione africana, il problema dei rifugiati in Asia e nelle regioni del Pacifico appare più limitato sul piano quantitativo, sebbene anche qui le guerre in Vietnam, Cambogia e Afghanistan abbiano determinato esodi massicci. Analogamente, i conflitti politici nel Medio Oriente hanno dato luogo a un numero relativamente limitato di rifugiati, tra i quali nel 1990 i Palestinesi in Giordania, Libano e Siria costituivano il gruppo più consistente riconosciuto dalle Nazioni Unite.
La direzione delle migrazioni volontarie a scopo di lavoro che interessano gruppi imponenti di popolazione tende ad andare prevedibilmente da aree relativamente arretrate verso i paesi economicamente più sviluppati. Tra i migranti appartenenti a questa categoria prevalgono i lavoratori con scarse qualificazioni professionali. Con poche eccezioni, la corrente migratoria di elementi altamente qualificati, nota come brain drain, non ha una grossa incidenza, anche se può essere significativa dal punto di vista qualitativo sia per la regione di provenienza che per quella di destinazione.Su scala globale, alla fine del XX secolo, i flussi di migrazione volontaria su grandi distanze a scopo di lavoro sono prevalentemente asiatici. Secondo stime relative al 1990, gli emigrati cinesi all'estero (Hong Kong, Singapore, Taiwan, Stati Uniti e paesi del Golfo) ammontavano a più di 1 milione; l'India aveva inviato nei paesi del Golfo e negli Stati Uniti circa 1,5 milioni di lavoratori vincolati da contratti di lavoro di vario tipo, inclusi contratti temporanei; gli emigrati pakistani in Arabia Saudita, nei paesi del Golfo e negli Stati Uniti superavano il milione. A questi si aggiungevano forse 2,7 milioni di Filippini emigrati in Arabia Saudita e nei paesi del Golfo, oltre che in Malesia, nel Nordamerica, a Hong Kong, a Singapore e in Giappone. Assai consistenti erano anche i flussi provenienti dalla Corea del Sud, dallo Sri Lanka, dall'Indonesia e dal Vietnam; i contingenti più rilevanti di ciascun paese si erano diretti rispettivamente verso gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e i paesi del Golfo, la Malesia e l'Europa orientale.Tra le due guerre circa 3 milioni di Cinesi emigrarono in Indocina, in particolare in Vietnam, e altri 3 milioni in Thailandia, 2,3 milioni in Malesia e 1,4 milioni in Indonesia. Nel ventennio successivo al primo conflitto mondiale, circa 1,5 milioni di Indiani, tra cui anche persone nate all'estero, affluirono nello Sri Lanka, nella Birmania, in Malesia, nelle isole Fiji e Mauritius, nell'Africa orientale e in quella meridionale. Nello stesso periodo si ebbe anche un consistente flusso migratorio giapponese; i gruppi più cospicui si diressero verso la Cina (200.000), la Manciuria (820.000) e il Brasile (200.000).
Nell'Africa subsahariana la maggioranza dei migranti è rimasta all'interno del continente, dove i principali paesi di sbocco sono stati la Costa d'Avorio (2 milioni), la Nigeria (1 milione), lo Zaire (600.000) e il Sudafrica (500.000). Un flusso sudanese e somalo relativamente ridotto si è diretto verso la regione del Golfo e l'Arabia Saudita, mentre una corrente senegalese ha avuto come sbocchi l'Europa centrale e meridionale e contingenti ancora più modesti di lavoratori nigeriani altamente qualificati sono emigrati in vari paesi di lingua inglese. Per quanto riguarda il Nordafrica, flussi migratori algerini, marocchini e tunisini si sono diretti verso l'Europa centrale e meridionale e verso la Libia. Una percentuale significativa dell'immigrazione nordafricana in Europa è clandestina.I principali sbocchi dei flussi migratori mediorientali (Egitto, Giordania, Siria e Yemen) sono stati l'Arabia Saudita, l'Iraq e la regione del Golfo Persico, ma la situazione è cambiata a seguito della guerra del Golfo. In Libia, tuttavia, sono continuati ad affluire circa 500.000 immigrati dalla Tunisia, dall'Egitto, dal Pakistan e da vari paesi europei. Nel 1990 Israele accoglieva 185.000 immigrati provenienti dall'Unione Sovietica.
Nel Nordamerica, nell'America centrale e nei Caraibi il flusso migratorio più importante - 1,2 milioni secondo le stime del 1990 - è quello proveniente dal Messico e diretto verso gli Stati Uniti. Qui vi sono anche numerosi immigrati, legali o clandestini, provenienti dalla Repubblica Domenicana, da Haiti, dalla Giamaica e dalle Indie occidentali, nonché da vari paesi dell'America centrale e meridionale, tra cui la Colombia, l'Ecuador e il Perù. Nel Canada si contano circa 100.000 immigrati da Haiti e altrettanti dalla Giamaica e dalla Guiana, oltre che immigrati e rifugiati provenienti da altre aree. Nell'America meridionale l'Argentina è stato il principale paese di sbocco delle correnti migratorie, con 2 milioni circa di immigrati provenienti prevalentemente dalla Bolivia, dal Paraguay e dall'Uruguay; segue il Venezuela, in cui il gruppo più consistente è costituito da circa 800.000 immigrati legali o clandestini provenienti dalla Colombia. L'Argentina accoglie anche 800.000 immigrati dal Paraguay, che a sua volta è meta di circa 350.000 lavoratori e coltivatori provenienti dal Brasile.Tra il XVI secolo e la metà del XX l'Europa ha ceduto circa 60 milioni di emigrati alle Americhe, all'Australia, alla Nuova Zelanda, al Nordafrica e all'Africa meridionale, alla Siberia e ad altre aree ancora. Con una radicale inversione di tendenza, attualmente questa corrente si è considerevolmente ridotta e alcuni paesi europei sono diventati aree di attrazione anziché di deflusso. La domanda di manodopera negli anni successivi alla seconda guerra mondiale ha determinato un flusso migratorio dai paesi mediterranei (Turchia, Grecia, Iugoslavia, Italia, Spagna) verso la Germania, il Belgio, la Svizzera e l'Austria. Il Regno Unito e la Francia, per contro, a motivo dei loro legami coloniali hanno attirato correnti migratorie provenienti rispettivamente dalle Indie occidentali, dall'India e dal Pakistan, e dal Nordafrica e dalla regione subsahariana. Ad aumentare l'afflusso di migranti nel secondo dopoguerra hanno contribuito le obbligazioni giuridiche contratte dalle potenze coloniali europee, a seguito delle quali esse si sono trovate costrette a rimpatriare i propri cittadini residenti all'estero e ad accogliere quanti avevano acquisito un titolo legale a risiedere nella madrepatria. Anche il rimpatrio di cittadini tedeschi da varie parti dell'ex Unione Sovietica ha contribuito ad incrementare l'afflusso di nuovi residenti. Il risultato è stato l'affermarsi di società multiculturali a tutti gli effetti, caratterizzate da un grado di diversificazione religiosa e razziale sconosciuto in passato. A rafforzare questa tendenza ha contribuito il flusso in costante aumento di profughi e di immigrati clandestini (principalmente asiatici e africani).
A seguito della recessione economica che ha caratterizzato gli anni 1970-1990, vi sono stati vari tentativi di invertire il flusso delle migrazioni a scopo di lavoro favorendo il rimpatrio, perlopiù volontario, dei lavoratori stranieri. Questi sforzi hanno avuto un certo successo nel caso degli immigrati spagnoli, portoghesi e italiani, mentre maggiori problemi hanno creato gli immigrati iugoslavi, turchi e nordafricani.
3. Le politiche migratorie
I tentativi da parte dei governi di incoraggiare o di limitare i flussi migratori hanno avuto storicamente diversa riuscita. Alcune politiche, come quella di favorire il reinsediamento di gruppi relativamente omogenei nel contesto della colonizzazione, hanno avuto pieno successo, e lo stesso può dirsi per gli sforzi intrapresi da alcuni governi di fissare quote di ingresso di nuovi immigrati o di chiudere le frontiere a tutti gli immigrati o a gruppi selezionati.
Nell'ultimo decennio di questo secolo i paesi che negano l'ingresso agli immigrati o lo limitano drasticamente sono di gran lunga più numerosi di quelli che non pongono alcuna restrizione alle immigrazioni legali. Le eccezioni più rilevanti sono rappresentate tipicamente dai nuovi continenti (Australia, Canada e Stati Uniti), il cui popolamento è stato dovuto in larga misura all'immigrazione. Anche qui, tuttavia, i flussi di rifugiati provenienti da regioni dilaniate da guerre civili o internazionali assorbono la maggior parte delle quote generali di immigrazione. Nei confronti dei rifugiati, il cui numero è in costante aumento, vi è una forte tendenza a consentire la permanenza nel paese ospite solo per periodi di tempo limitati. Gli organismi internazionali hanno cercato di incoraggiare i governi ad adottare politiche umane, ma spesso non sono nemmeno riusciti a convincerli ad accettare standard comuni di definizioni e procedure. Così molti paesi non applicano gli standard procedurali e di controllo fissati dall'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), e ben pochi sono firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951.
In costante aumento è anche la pressione degli immigrati a scopo di lavoro. A seguito dei cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro, in cui domina la richiesta di qualificazioni professionali più elevate, e della sostituzione della manodopera non qualificata con processi meccanizzati, le opportunità di lavoro per gli immigrati si sono ridotte sempre più a nicchie relativamente limitate, spesso nel settore dei servizi. Le tendenze attuali, unite a un tasso di incremento demografico assai più elevato di quello della crescita economica nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo, rendono sempre più probabile la prospettiva di una crescente pressione verso una redistribuzione demografica, pressione che i paesi economicamente avanzati potrebbero avere difficoltà a contrastare attraverso l'istituzione di controlli legali sull'accesso ai loro territori.
(V. anche Demografia; Demografia storica; Popolazione).
Bibliografia
Adepoju, A., International migration in Africa south of the Sahara, in International migration today, vol. I, Trends and prospects (a cura di R. Appleyard), Paris 1988, pp. 17-88.
Bohning, W.R., Studies in international labour migration, London 1984.
Cavalli-Sforza, L.L., Genes, peoples, and languages, in "Scientific American", 1991, CCLXV, pp. 71-78.
Cavalli-Sforza, L.L., Bodmer, W.F., The genetics of human populations, San Francisco 1971.
Gamble, C., Timewalkers: the prehistory of global colonization, Cambridge, Mass., 1994.
Klein, H.S., African slavery in Latin America and the Caribbean, New York 1986.
Livi Bacci, M., A concise history of world population, Cambridge, Mass., 1992.
Martinet, A., Des steppes aux océans: l'indo-européen et les 'IndoEuropéens', Paris 1987.
Petras, E.M., The global labor market in the modern world economy, in Global trends in migration (a cura di M.M. Kritz e altri), New York 1981, pp. 44-63.
Rouse, I., Migration in prehistory. Inferring population movement from cultural remains, New Haven, Conn.-London 1986.
Segal, A., Atlas of international migration, London 1993.
Zolberg, A.R., International migrations in political perspective, in Global trends in migration (a cura di M.M. Kritz e altri), New York 1981, pp. 3-27.
Il caso italiano
di Ercole Sori
1. Origini, dimensioni e caratteristiche generali dell'emigrazione italiana
Le origini
Le origini della grande emigrazione italiana all'estero vanno ricercate per lo meno nella ripresa demografica ed economica (agricoltura) del secondo Settecento. L''inquietudine' territoriale che si registra da allora nella domanda e nell'offerta di forze di lavoro rinvia al carattere estensivo che presiede l'incremento della produzione agricola, tutto basato su un più intenso sfruttamento del fattore lavoro, con particolare riguardo a quello stagionale migrante. L'offerta di lavoro che proviene dai consolidati insediamenti umani alto-collinari e montani, ad esempio, si è progressivamente integrata, sotto forma di migrazioni agricole stagionali, con la domanda che proviene dalle zone di più recente sviluppo o messa a coltura (pianure, risaie, aree insalubri e/o bonificate), tanto nella penisola che nelle regioni europee a essa adiacenti, ove stanno prendendo corpo, tra l'età napoleonica e la metà del XIX secolo, ondate eccezionali di domanda di manodopera per 'grandi lavori' (fortificazioni, rinnovo urbano, canali, ferrovie). Prima dell'Unità i pionieri dell'emigrazione italiana si dirigono già verso quelle che saranno le future destinazioni classiche: dall'arco alpino verso i limitrofi territori francesi, tedeschi, svizzeri, austroungarici; dalla Liguria, lungo le rotte del commercio marittimo, verso i paesi della Plata; dalla Sicilia verso il Nordafrica; da varie regioni verso gli Stati Uniti.
Le dimensioni
La rilevanza economica, sociale, politica e culturale dell'emigrazione nella storia dell'Italia contemporanea, ma anche quella attuale degli 'italiani all'estero', deriva in gran parte dalla dimensione assunta dal fenomeno. Nel periodo 1861-1970 l'emigrazione netta verso l'estero si aggira intorno ai 9 milioni; gli atti di espatrio intorno ai 27 milioni. Alcune valutazioni 'nazionalistiche' dell'estensione delle odierne comunità 'italiane' all'estero le fanno equivalere alla popolazione entro i confini. Una comparazione internazionale dei valori relativi (per 1.000 abitanti) degli espatri intercontinentali durante il secondo Ottocento e il primo ventennio del Novecento mostra che l'Italia, tra il 1910 e il 1913, periodo di massima espansione del fenomeno, tocca livelli che non hanno eguali in altre esperienze europee, salvo il caso drammatico dell'Irlanda.
La provenienza regionale
Fino al 1900 e nella declinante e scarsa emigrazione del periodo tra le due guerre, i maggiori flussi di espatrio provengono dal Centro-Nord (Veneto, soprattutto, con i flussi temporanei per l'Europa). Nei restanti periodi fu il Mezzogiorno a inviare i massimi contingenti, specie oltreoceano e in Africa. La Basilicata, assieme alla Liguria, fu precocissima, mentre le regioni che tardarono di più ad aprirsi a un'emigrazione di massa furono la Sicilia e quasi tutta l'area mezzadrile dell'Italia centrale. Regioni con agricoltura mercantilizzata e robusto ceto o movimento contadino (Emilia Romagna, Puglie e Toscana, ma con l'eccezione delle province di Lucca e Massa) emigrarono sempre poco, così come quelle con agricoltura arcaica (Sardegna), salvo brevi e violente parentesi. Si emigrò sempre poco (Lazio) o sempre meno (Liguria, Piemonte, Lombardia) ove si crearono valide alternative all'esodo, come l'urbanizzazione a Roma e l'industrializzazione del 'triangolo'. Il grosso dell'emigrazione provenne dal Mezzogiorno rurale, interno e montuoso (l''osso', e non solo meridionale), dalle sacche padane di arretratezza e sovrappopolazione agricole (Polesine, Vicentino, Trevigiano, Mantovano), dalla montagna alpina (province di Udine, Belluno, Cuneo).
La destinazione dei flussi emigratori
Una sorta di principio di equa ripartizione del flusso tra destinazioni transoceaniche e destinazioni europeo-mediterranee sembra essersi affermato fino al secondo dopoguerra, trascorso il quale prevalgono le destinazioni europee. Le deviazioni dalla norma sono dovute, da una parte, alla fase di gestazione dell'emigrazione italiana (1876-1886: prevalenza dell'Europa) e al massiccio assorbimento degli Stati Uniti tra 1901 e 1914, che fece salire la quota transoceanica a circa il 60%; dall'altra, alla chiusura cui vanno incontro Stati Uniti e America Latina durante gli anni venti con la conseguente crescita della quota di emigrazione diretta in Europa. In sostanza l'emigrazione italiana giocò la sua complessa partita di allocazione del massimo di espatri su uno scacchiere formato da quattro mercati del lavoro: due 'capitalistici' (Stati Uniti ed Europa, ma con congiunture significativamente sfasate e rese compatibili dai movimenti di capitali e di forze di lavoro dalla sponda europea a quella americana dell'Atlantico); uno 'semicapitalistico' (Argentina e Australia, con congiunture agrarie opposte a quella europea); uno 'protocapitalistico' (Brasile, che assorbe in ultima istanza, come negli anni novanta dell'Ottocento, ciò che crisi simultanee sugli altri tre mercati respingono).
Età, sesso, professione
La domanda di lavoro internazionale operò di fatto una drastica selezione della forza lavoro estraibile dall'Italia: si trattò di maschi delle classi di età centrali, professionalmente molto vicini alla figura del puro erogatore di forza muscolare, almeno secondo la denominazione ufficiale (braccianti), che fotografa un proletariato in regime di extraterritorialità e di extrasettorialità economica, sospeso tra Italia e qualche paese estero, tra agricoltura e qualche attività secondaria (sempre dequalificata e intercambiabile) difficilmente classificabile. Ciò spiega la tendenza a una costante diminuzione della quota di agricoltori a partire dalla fine degli anni ottanta, anche se a ogni massimo relativo di espatri corrisponde perfettamente una impennata di emigrazione di agricoltori. Da questa angolatura l'emigrazione italiana ci appare come un potente meccanismo di trasformazione degli 'agricoltori' in qualche cosa di professionalmente diverso: più che uno spaccato del complessivo processo di trasformazione della composizione di classe, un terreno specifico ove si dispiegò una parte importante del processo di proletarizzazione nel nostro paese. In assenza di perturbazioni, il 90% degli emigrati italiani aveva età maggiore di 15 anni, l'80-85% era maschio, il 60-80% partiva da solo anziché in gruppi familiari. Questi parametri si abbassano durante la prima guerra (ricomposizione all'estero di famiglie di renitenti definitivi; emigrazione di donne in alternativa ai maschi richiamati alle armi) e durante gli anni venti e trenta, quando le chiusure degli sbocchi tradizionali e il fascismo stimolano di nuovo la ricomposizione delle famiglie.
2. Le cause economiche dell'emigrazione
La storiografia italiana sull'emigrazione ha posto l'accento più sui fattori di espulsione (push factors) che su quelli di attrazione (pull factors), e ciò per l'evidente peso che il tema assunse in ogni epoca nel dibattito e nella polemica politici. Più equilibratamente l'andamento del fenomeno nel tempo può essere spiegato da una combinazione estremamente complessa di diversi fattori del primo e diversi fattori del secondo gruppo, ulteriormente complicata dalle diverse modulazioni temporali con le quali ciascun fattore può manifestarsi (fenomeni strutturali a lenta gestazione; fenomeni congiunturali; episodi ben localizzati nel tempo e nello spazio). Schematizzando i principali fattori economici di espulsione, otteniamo le seguenti cause che analizzeremo singolarmente.
Erosione degli ammortizzatori economico-sociali d'ancien régime
Questa causa è legata principalmente al mutamento politico-culturale connesso all'ascesa al potere della borghesia dopo l'Unità. Nei luoghi d'esodo, e particolarmente nel Mezzogiorno, si lamenta l'usurpazione dei demani e dei beni comunali, l'accaparramento dei beni ecclesiastici alienati e delle quotizzazioni, la gestione 'privatistica' dei patrimoni delle opere pie e dei monti frumentari. Ciò, assieme alle forti difficoltà della finanza pubblica postunitaria, costituisce la premessa per drastiche riduzioni della spesa pubblica per i trasferimenti 'improduttivi' di reddito (beneficenza e assistenza, che dovevano essere particolarmente ampie data la forte dominanza ecclesiastica e le pratiche 'sanfediste' di lotta per l'egemonia sulle masse popolari nell'età risorgimentale), o per la sua conversione in spese 'produttive' (infrastrutture per la modernizzazione e l'industrializzazione). Istruttivo era stato il dibattito sette-ottocentesco sull'onerosità delle istituzioni caritative, sul loro effetto distorsivo negli impieghi del surplus (consumi anziché investimenti) e nella stessa linearità e ampiezza di formazione di un mercato capitalistico del lavoro (ozio anziché lavoro produttivo). In tempo di emigrazione di massa, il fior fiore della cultura economica italiana si misurerà, invece, con un altro schema di ragionamento costo/opportunità - il 'costo di produzione dell'uomo' o 'valore economico della vita umana' - onde stabilire se l'eliminazione di un uomo per emigrazione fosse un guadagno o una perdita per l'economia nazionale.
Pressione demografica
La particolare importanza di questo fattore risiede nel fatto che in Italia la transizione demografica (diminuzione della mortalità e conseguenti forti eccedenze naturali delle nascite sulle morti) si estende dalla metà dell'Ottocento al periodo tra le due guerre. Essa si realizza, cioè, in un arco di tempo che precede, talvolta di molto, come nel caso del Mezzogiorno, il consolidarsi di un'economia urbano-industriale portatrice di forti incrementi nell'occupazione extragricola e di atteggiamenti verso la procreazione capaci di ridurre fortemente il tasso di natalità: fenomeni, questi, concentratisi in larga misura nel secondo dopoguerra. Sembra, così, che la 'liberazione' delle forze di lavoro (alterazione dei rapporti di produzione, soprattutto nelle campagne) e il loro accumulo da parte della crescita demografica siano processi tra loro intrecciati nel concreto progredire del capitalismo italiano, e che l'emigrazione all'estero abbia saldato lo scarto epocale tra la modernizzazione istituzionale e l'integrazione internazionale del paese dopo l'Unità, da una parte, e le ristrettezze, difficoltà e tortuosità del suo sviluppo economico dall'altra.
Dall'economia di sussistenza all'economia monetaria e di mercato
Un efficace veicolo di immissione dei rapporti capitalistici nelle campagne italiane, soprattutto in quelle sue zone sociali che si difendevano dietro la cedente barriera dell'autoconsumo, fu il crescente fabbisogno di denaro, attraverso il quale filtrava la legge del valore che imponeva di fare il conto del reddito contadino e della produttività del lavoro. Le ansie monetarie delle campagne italiane si chiamavano imposta fondiaria, di registro, di successione; debito ipotecario e colonico, usura, altri oneri di successione.
Zone agrarie e aziende 'marginali': montagna e piccola dimensione
Molti dei fattori negativi appena elencati, o che lo saranno, avevano un peso maggiore in particolari circostanze ambientali o istituzionali. Lo squilibrio stagionale (montagna) o strutturale (piccola azienda/proprietà) tra la disponibilità di forza lavoro familiare e la terra/risorse o una loro combinazione, rendeva spesso l'emigrazione una scelta obbligata. Rispetto ai modelli d'ancien régime consolidati (integrazione lavorativa stagionale o periodica di alcuni membri della famiglia, tra montagna e pianura; minuto mercato del lavoro avventizio sfruttato dalle grandi proprietà adiacenti; artigianato domestico invernale o manifattura protoindustriale a domicilio e non: ad esempio trattura della seta) l'emigrazione si presenta come un naturale allargamento geografico e adattamento settoriale rispetto al passato. Il tutto al fine di puntellare la precaria azienda agricola di riferimento adottando stabili modelli di emigrazione temporanea.
Il declino dei mestieri artigianali e della manifattura rurale
L'emigrazione fu anche un espediente con cui una o più generazioni di artigiani espansero una capacità professionale, che veniva domandata sempre meno sul mercato del lavoro, attraverso una o più di queste vie: a) ampliando, a volte a dismisura, il raggio geografico di azione, che, ancor prima dell'emigrazione all'estero, aveva prodotto la figura dell'artigiano girovago; b) dirigendosi verso economie più 'arretrate', come l'agricoltura di frontiera dei nuovi continenti, ove si riproduceva, anche transitoriamente, una struttura extragricola di tipo tradizionale e sostanzialmente autarchica; c) sfruttando alcune rigidità del mercato del lavoro dei paesi economicamente più avanzati e inventando una professionalità molto specifica, il che spesso comportava una dequalificazione e una pericolosa vicinanza con i mestieri 'vergognosi'. A partire dagli anni ottanta, quando crisi agraria e accentramento nelle fabbriche della produzione tessile (cotone, lana, lino, canapa) procedono parallelamente, viene alterato in molte zone del paese il delicato equilibrio nella distribuzione del tempo di lavoro contadino tra le varie occupazioni, a causa della caduta della manifattura domestica rurale.
Disoccupazione, salari e patti agrari
Sottoccupazione delle forze di lavoro, bassa retribuzione e rapporto generalmente sfavorevole tra capitale-proprietà e lavoro emergono, a questo punto, come cause più comprensive dell'emigrazione italiana. Nelle campagne la possibilità per il padronato di minimizzare il prodotto tra salario giornaliero e giornate lavorate si afferma con una tendenza di lungo periodo alla liquidazione del salariato fisso o obbligato e a un maggiore uso di quello avventizio, disobbligato, fino all'estremo limite di precarietà del rapporto di lavoro costituito dal salariato giornaliero, tipica figura del Mezzogiorno, ove le 'steppe a cereali' garantiscono trenta giornate lavorative in un anno. La situazione sostanzialmente non mutava al variare dei sistemi di conduzione: affitti elevati e di corta durata, colonìe parziarie con poderi sempre più esigui, mezzadrie degenerate nelle clausole contrattuali o trasferite su terreni montani o da colonizzare, a fianco delle quali crescevano inediti ceti rurali privi di terra (i casanolanti marchigiani, i casengoli umbri e i pigionali toscani). In molte aree del paese si osservò che l'emigrazione era cominciata al termine di grandi ondate di lavori pubblici, specie quelli ferroviari: sul nuovo mezzo di trasporto, dunque, salivano i disoccupati adattati al lavoro salariato dalle grandi opere pubbliche che, una volta esauritesi, finivano col rendere esplicita una disoccupazione nascosta. Fu ciò che accadde, per l'intera economia nazionale, quando la crisi economica e finanziaria apertasi alla fine degli anni ottanta determinò un severo ridimensionamento della spesa pubblica infrastrutturale, protrattosi fino al 1905.
La crisi agraria e il protezionismo
La crisi agraria internazionale, che, scaturita dal brusco confronto tra agricolture a così diversi livelli di produttività, diede un impulso decisivo alla prima ondata di emigrazione di massa delle classi agricole italiane, aveva in sé anche un meccanismo potenzialmente correttivo, i cui passaggi fondamentali erano i seguenti: pauperizzazione dei coltivatori europei 'marginali'; loro emigrazione verso i nuovi territori; aumento della popolazione oltreoceano; aumento del suo consumo interno di derrate e materie prime agricole; riequilibrio dei prezzi e comunque minori esportazioni verso l'Europa. Tuttavia anche il possibile significato riequilibratore che la crisi agraria conteneva, cioè l'imperativo di una razionalizzazione tecnico-colturale e di una crescita della produttività, venne inibito dalla tariffa protezionistica del 1887, e in particolare da quella sul grano, che riconfermava gli ordinamenti produttivi e le strutture agrarie, fondiarie e di potere tradizionali che dovevano alimentare, anche in futuro, ulteriore emigrazione soprattutto nel Mezzogiorno.
3. Emigrazione, crescita economica e integrazione internazionale
Emigrazione e crescita economica
Le variazioni di volume del lavoro migrante italiano sono legate, essenzialmente, a condizioni di offerta strutturali (arretratezza agricola, sottosviluppo regionale, ecc.) e a condizioni di domanda congiunturali. Fino al 1962 ciò ha determinato una relazione diretta tra crescita dell'economia italiana e livello dell'emigrazione, spiegata dalla dipendenza di entrambi i fenomeni dal ritmo di sviluppo dell'economia internazionale e dalle componenti 'permissive' che l'emigrazione introduce nel modello di sviluppo dell'economia italiana. Questa relazione cessa di operare nei periodi (1915-1918 e 1924-1940) nei quali mancano le condizioni essenziali per l'esistenza di un libero mercato internazionale del lavoro. La 'fortuna' dell'emigrazione italiana in America Latina (1876-1900) corrisponde invece alla fase di più marcato deterioramento dei terms of trade di quei paesi, il che spiega le difficoltà e le durezze che i lavoratori italiani vi incontrarono. In generale la grande stagione dell'emigrazione italiana va collegata alle esigenze della tormentata fase di ristrutturazione e sviluppo estensivo che l'economia mondiale attraversa tra la 'grande depressione' (1873-1896: processi di sostituzione della manodopera per abbassare il salario e diminuire la forza contrattuale del sindacato) e la fase di crescita 1896-1914.
Il ruolo delle rimesse nello sviluppo economico italiano
Vi è concordanza nel ritenere che le rimesse degli emigranti, a livello macroeconomico, hanno evitato che l'Italia in due periodi cruciali del suo sviluppo economico (1896-1914, 1946-1962) incappasse nel vincolo della bilancia dei pagamenti, stante l'elevata elasticità delle importazioni al ritmo di crescita. La circostanza spiega perché, dopo le iniziali perplessità e ostilità, si registri durante gli anni novanta un crescente favore dei governi e della classe dirigente più moderna verso l'emigrazione, favore sfociato nella 'permissiva' legge sull'emigrazione del 1901. Le rimesse contribuirono a triplicare le riserve auree tra 1896 e 1912, a realizzare un consistente apprezzamento del cambio della lira, fino a far aggio sull'oro, a ottenere, infine, una relativa abbondanza di risparmio. Quest'ultima fu la condizione per tonificare il gettito tributario; i depositi presso il sistema creditizio (banche locali, risparmio postale e, di qui, alle grandi banche d'investimento e alla Cassa depositi e prestiti) servirono a far rimpatriare debito pubblico collocato all'estero, a convertire con successo nel 1906 la rendita pubblica dal 5 al 3,5%, e ad avviare una non insignificante esportazione di capitale all'estero. L'importanza delle rimesse è testimoniata anche dal fatto che il loro venir meno, nel primissimo dopoguerra e verso la metà degli anni venti, sarà dapprima tenacemente contrastato dai governi postbellici e fascisti con un'azione (stimolo all'espatrio, particolarmente di persone con famiglia in Italia; fondazione di istituti per il rastrellamento del risparmio italiano all'estero) che poi sfocerà nella complessa manovra di stabilizzazione finanziaria interna e internazionale che va sotto il nome di 'quota 90' (1927).
Emigrazione e commercio estero
Se nel breve periodo fu notata una relazione diretta tra l'ampiezza di alcune comunità di italiani all'estero e l'avvio di consistenti flussi di esportazione verso i rispettivi paesi, soprattutto extraeuropei, nel medio periodo (20-25 anni) questo legame andò attenuandosi. Esso corrispondeva a uno stadio iniziale di segregazione culturale (anche nei consumi) dei neoimmigrati e dei loro discendenti, i quali venivano via via integrati negli schemi di consumo locali oppure avviavano all'estero, quando possibile, produzioni tradizionali (vino, formaggi, olio d'oliva, ecc.) alternative alle importazioni dall'Italia. Più concrete le facilitazioni all'importazione di materie prime d'oltreoceano rese possibili da compensazioni tra 'ricchi' noli di andata per emigranti e noli di ritorno per merci più bassi della norma, oppure quelle sperimentate durante la prima guerra mondiale quando si stipularono con gli alleati accordi per lo scambio di manodopera italiana per le miniere contro carbone. Negli anni sessanta e settanta del XIX secolo la sequenza emigrazione-navigazione-commercio estero venne teorizzata, soprattutto negli ambienti liguri, come via italiana al colonialismo commerciale, in forte contrasto, tuttavia, con il carattere 'proletario' che di lì a poco prenderà la grande emigrazione italiana.
Emigrazione e colonizzazione
L'emigrazione come alternativa, surrogato o via originale al colonialismo fu, per l'Italia, una suggestione comune a molte delle correnti del pensiero economico e politico fino alla seconda guerra mondiale. Quando gli Italiani entrarono nell'ampio e variegato mosaico della colonizzazione agricola estensiva del Sudamerica, del Nordafrica, dell'Australia, a essi fu quasi sempre assegnato il compito di coprire gli interstizi, le aree territoriali, produttive e sociali di risulta. Nell'America del Nord la 'frontiera' poteva considerarsi ferma dagli anni novanta, cioè prima che vi giungesse il grosso dell'emigrazione italiana, che comunque non andò mai oltre le grandi metropoli e i distretti minerari e industriali della fascia atlantica. Il proposito di corredare l'elemento forte dell'espansionismo italiano nel mondo, le braccia, con capitali italiani che finanziassero le imprese di colonizzazione agricola si mostrò inconsistente per pigrizia dei capitali italiani, poco propensi al rischio. I modelli ai quali si rifece l'ideologia della cosiddetta 'più grande Italia' furono molteplici: l'Argentina come luogo socio-politico-geografico ideale; il modello tedesco fondato su potenti compagnie di colonizzazione (Brasile meridionale); il modello religioso-comunitario delle organizzazioni cattoliche, con qualche esperimento di comunità venete trasferitesi in Brasile con il parroco alla testa; il modello nazionalista preoccupato della conservazione dell'italianità; quello della 'colonizzazione democratica' di Franchetti, che voleva coniugare le ricorrenti tentazioni coloniali africane con i sistemi di colonizzazione libera, di popolamento; quello delle cooperative emiliane che tentarono, senza successo, di esportare nel certao brasiliano la via emiliana al socialismo. A parte qualche esito concreto (latifondisti siciliani in Tunisia), gli emigranti italiani non furono colonizzatori e il loro impiego in agricoltura si giocò sul filo di una concorrenza-sostituzione con sezioni del mercato del lavoro e movimenti migratori 'sporchi': coolies e kanaki nelle Americhe e in Australia. Il nesso tra ambizioni espansionistiche del capitalismo italiano ed emigrazione si ritrova anche nella versione bellicista del colonialismo di conquista, prospettato come sfogo naturale dell'esuberanza demografica italiana. Il tema di un colonialismo popolare (per l'appoggio di massa che avrebbe dovuto ottenere) e di popolamento (per la sua insistenza sul fattore demografico e sulla colonizzazione agricola) percorre tutti i dibattiti sull'emigrazione e sulle colonie, dagli anni settanta alla prima guerra d'Africa (Eritrea: 1882-1896), alla guerra di Libia (1911), all'avventura di Etiopia (1935) e alla costituzione dell'impero.
4. Le conseguenze economiche
Microeconomia delle rimesse
Le rimesse, sul piano microeconomico, interagirono con complesse strategie elaborate dall'emigrante e dai segmenti di famiglia, di varie dimensioni, restati in Italia. Innanzitutto esse furono l'argomento più convincente per indurre altri paesani a espatriare e su esse si svolse un razionale calcolo nel quale entravano i costi relativi di trasporto dalle varie regioni per i differenti paesi (ad esempio, gli italiani del Nord preferirono l'Europa, quelli del Sud l'America del Nord), il costo della vita in essi vigente, i mesi lavorabili, il livello dei salari esteri, il corso e la stabilità dei cambi. La logica degli impieghi del risparmio da emigrazione prevedeva, innanzitutto, quelli necessari ad 'arrestare la caduta', specie in alcuni settori del mondo contadino: pagare i debiti, primo tra tutti quello contratto per espatriare, poi quello verso i proprietari della terra, i concedenti, gli usurai; pagare i debiti di imposta e gli eventuali debiti ipotecari. Vi erano poi gli impieghi per stabilizzare la posizione sulla quale ci si era attestati: pagare puntualmente le imposte; costruirsi una casa, specie là dove, come nelle grosse città contadine del Mezzogiorno, gli affitti salivano rapidamente; mantenere un certo grado di liquidità familiare, sviluppando anche reti solidaristiche di prestito per battere l'usura e l'indebitamento colonico. Infine si trattava di espandere e differenziare i consumi familiari, a partire da quelli alimentari, e soprattutto investire per una più durevole emancipazione dallo stato di precarietà economica (acquisto di terra, spesso a prezzi d'affezione, o di un esercizio commerciale, o di bestiame e scorte, che consentivano di salire qualche gradino lungo la piramide sociale contadina). Queste strategie furono in larga misura frustrate, soprattutto nel Mezzogiorno, da inflazione, scarsa offerta di terre (marginali e a prezzo elevato), pressione fiscale, pressione demografica, instabilità dei redditi e della produzione agricola, scarsità di alternative - tecniche in agricoltura e generali in altri settori - per investimenti che accrescessero la produttività del lavoro. A ciò si aggiunga l'ossificazione degli istituti contrattuali e gli scarsi apporti esterni all'esercizio della piccola azienda agricola (credito, assistenza tecnica e commerciale, istruzione agraria, cooperazione). Per queste e altre ragioni le rimesse tesero ad alimentare gli impieghi di riposo (depositi, buoni fruttiferi, debito pubblico, cartelle fondiarie) e con la loro liquidità finirono per rappresentare il capitale di esercizio di un'azienda familiare emigratoria nella quale gli espatri erano genealogicamente scaglionati e ripetuti, un capitale necessario anche a coprire finanziariamente i più che probabili periodi di disoccupazione all'estero o la vecchiaia.
Il Mezzogiorno e la 'nuova democrazia rurale'
Una parte della cultura liberale e meridionalistica pose l'accento sulle rimesse come strumento autonomo di riscatto delle masse contadine a partire dalla grande inchiesta sulle regioni meridionali dell'età giolittiana, proprio in concomitanza, e in palese contrapposizione, con la prima legislazione speciale in favore del Mezzogiorno (1904-1905). Lo stereotipo della 'nuova democrazia rurale' nel Sud, con l'anello emigrazione-rimesse, consentiva di trasformare, nella catena di rielaborazioni che spiegano il sottosviluppo, un sintomo di disagio economico e sociale in un fattore positivo di sviluppo. Esso infatti pretendeva di agire simultaneamente sul mercato del lavoro salariato (aumento delle retribuzioni), sui patti agrari (miglioramento), sul mercato della terra (diminuzione dei valori fondiari e formazione di una nuova proprietà coltivatrice), sul mercato dei capitali (diminuzione del saggio di interesse e dell'usura), sulla produttività totale (innovazioni labour saving dettate dalla rarefazione della manodopera), sui livelli di vita (consumi quantitativamente e qualitativamente migliori), sulla struttura basilare dei rapporti sociali e di classe (eclisse dei 'galantuomini' - piccoli proprietari non coltivatori - e formazione di nuovi ceti produttivi autonomi e moderni). Nella realtà questo stereotipo, nelle sue varie parti, ebbe riscontri esili, saltuari e soprattutto riassorbibili nel tempo, a causa dei fortissimi vincoli 'istituzionali', in presenza dei quali il paradigma marginalistico faceva cilecca.
5. Le conseguenze sociali nei luoghi d'esodo
Gli effetti demografici
L'estrema selettività della domanda internazionale nei confronti dell'offerta italiana di lavoro migrante finì per determinare nelle aree d'esodo e soprattutto in alcune regioni meridionali (Basilicata, Calabria, Abruzzi e Molise) squilibri nella proporzione tra i sessi, nella composizione per classi di età, nella struttura della famiglia (assenza del capo). In queste regioni i comportamenti demografici (natalità, nuzialità, mortalità) non uscirono altrettanto modificati da una fase di forte esodo, nel senso che il sistema socio-demografico reagiva ai 'vuoti' seguendo uno schema tipicamente preindustriale, cioè occupandoli rapidamente (dispiegamento della nuzialità frustrata a seguito del miglioramento della posizione economica causato dall'espatrio o dalla minore pressione sulle risorse locali) o recuperandoli nel tempo (recupero della fertilità perduta in occasione del rimpatrio del coniuge). Diverso il comportamento di aree con emigrazione temporanea di antica tradizione, come l'arco alpino, ove questa è entrata in un ben definito modello antropologico-demografico volto a deprimere stabilmente la fertilità. La maggiore indipendenza economica della famiglia dell'emigrante, inoltre, stava conducendo, soprattutto nel Mezzogiorno, a una famiglia meno numerosa e composita, più nucleare-coniugale.
Le forze di lavoro
Unanime è il riconoscimento che nelle aree di emigrazione, e segnatamente nel Mezzogiorno, si è registrata una più ampia partecipazione di donne, fanciulli e anziani al mercato del lavoro. Queste quote 'marginali' dell'offerta di lavoro furono coinvolte in un meccanismo di risposta economico-sociale sostanzialmente conservatrice agli squilibri indotti da una emigrazione di massa (reggenza dell'azienda agricola di riferimento, con una sorta di matriarcato a termine; partecipazione a un mercato minuto del lavoro avventizio con salari sensibilmente inferiori, come nell'industria armentizia o nel bracciantato generico). Attraverso queste forzature si creano le premesse per una più ampia partecipazione di donne e giovanissimi agli stessi flussi di espatrio e per più progressivi sviluppi nel mercato del lavoro e nei ruoli sociali.
Famiglia, comunità, classi
Numerose conseguenze sociali vengono ascritte alla forte incidenza dell'emigrazione in alcuni settori della società italiana, specie quelli più tradizionali. Ruoli, classi, forme di convivenza rimescolarono il vecchio e il nuovo in assetti ambigui quanto a livello di modernizzazione. La disgregazione sociale, commentata con forti pregiudizi moralistici nelle aree d'esodo dagli osservatori del tempo, trova un primo piano di verifica 'micro' in quella familiare: fenomeno dei 'due focolari'; scomparsa di mariti lungo le strade del mondo; aumento delle separazioni legali; crescita dell''ozio' e dell'infedeltà delle 'vedove bianche'; diffusione della sifilide importata dagli emigranti rimpatriati; precoce emancipazione, fino al limite dell'insubordinazione, dei figli. Il matriarcato che si affermava, ad esempio, in alcune aree venete era tuttavia temperato dal potere che il maschio capofamiglia conservava in virtù del fatto che 'portava lui i soldi'. Spesso il ciclo familiare veniva piegato al ciclo emigratorio: emigrazione del padre, poi del figlio maggiore (come accompagnatore), poi del minore (e rimpatrio del padre). Un matrimonio contratto alla vigilia del primo espatrio (e magari non consumato) poteva significare varie cose: una sposa in 'ostaggio' per assicurarsi il ritorno del giovane emigrante; il finanziamento dell'espatrio attraverso la dote; il distacco finanziario dell'economia delle rimesse dalla famiglia di origine.
'Corruzione' della donna ed emigrazione spesso si autoalimentavano, come accadeva nei non esigui flussi di espatrio femminile per prostituzione e baliatico. Ma con l'emigrazione spesso diminuivano nei luoghi d'origine le nascite illegittime e crescevano le legittimazioni, segno questo che la 'Merica' portava con sé anche l'emancipazione economica e culturale e una famiglia più cosciente e matura. Normalmente nelle aree e nei periodi di forte esodo diminuiva la criminalità (furti, soprattutto quelli campestri; omicidi; 'ribellismo'), ma la relazione poteva anche essere inversa: le pratiche di polizia in tema di governo dell'ordine pubblico mostrano come chi entrava nella zona grigia della devianza sociale (ammonimento, sorveglianza) presto non avesse altra soluzione che andarsene. Sul piano dei rapporti ideologici e politico-sociali, all'emigrazione è connessa una diminuita presa del clero nelle campagne. Forme di aggregazione moderna delle masse popolari rurali, anche se investite da massicci fenomeni emigratori, stentano a manifestarsi: i partiti locali (normalmente due), regolati dalla grande possidenza, restano gli stessi, affiancati tutt'al più da neonate società operaie animate da ex emigrati, le quali assomigliano più a gruppi di pressione collaterali che a reali istanze di organizzazione di un contropotere. Si manifesta, invece, un associazionismo di difesa che cerca di consolidare i benefici che l'emigrazione sta riversando sulla comunità locale: cooperative e leghe di credito, cooperative di acquisto della terra o affittanze collettive, cooperative di consumo, latterie sociali, mentre le 'camere del lavoro' furono una denominazione volta a volta confessata e soppressa. In pochi casi si avrà un maggiore radicamento dei partiti popolari (radicali, repubblicani e socialisti), ma è probabilmente eccessivo legare ogni tipo di trasformazione in questi settori della vita sociale alla sola azione del fenomeno emigrazione.
Il controllo sociale dell'emigrazione in Italia
Il fatto che l'emigrazione finisse per collegare le aree più appartate della società italiana, e specialmente le campagne, con esperienze ideali e pratiche tra le più avanzate nel movimento operaio e popolare o, semplicemente, nelle società urbano-industriali del mondo, impose nuovi compiti alle principali forze politico-sociali che si contendevano l'egemonia sulle classi popolari: Chiesa, Stato e socialismo. La Chiesa passò gradualmente da un iniziale non expedit (che poteva significare contemporaneamente non ostacolare l'emigrazione, interpretata come rivolta 'antiborghese', oppure combatterla come veicolo di scristianizzazione) a una presenza più attiva. Lo Stato sperimentò, con la legge del 1901, i 'comitati comunali per l'emigrazione', comprendenti notabilato e clero del posto, che però non funzionarono. I governi postunitari, comunque, mirarono a controllare questo grandioso fenomeno sociale con gli strumenti nei quali confidavano di più: centralmente con il Ministero dell'Interno, localmente con prefetti e organi di polizia. I socialisti stentarono a seguire nei luoghi d'esodo figure sociali e occupazionali ancora molto spurie, le quali, al ritorno al paese, tendevano a riacquistare i quadri ideali e i comportamenti più tradizionali del mondo contadino preindustriale.
Emigrazione, analfabetismo, scolarizzazione
L'elevata percentuale di analfabeti tra gli emigranti italiani, ancora durante il primo decennio del Novecento (50% circa per gli immigrati negli Stati Uniti, media tra l'11% per gli italiani del Nord e il 52% per quelli del Sud), è un indicatore sintetico della natura sociale di questa massa migrante e dei gravissimi problemi di integrazione culturale e politica che essa dovette affrontare nei paesi ospitanti. Uno dei cavalli di battaglia della polemica statunitense contro la new immigration fu la ricorrente minaccia di introdurre il literacy test e vietare, così, l'immigrazione agli analfabeti (come ai criminali, ai malati, ai pazzi) al fine di evitare la cosiddetta 'degradazione' della società americana. Contro questo rischio, e resi edotti circa i gravi inconvenienti che un emigrante analfabeta incontrava nella quotidiana esperienza sociale e di lavoro all'estero, i luoghi d'esodo manifestarono una forte propensione di 'base' all'aumento del livello di scolarizzazione e di alfabetizzazione, soprattutto nel Mezzogiorno e tra le donne.
Lo stato di salute
Lo stato di salute tra i rimpatriati e nei luoghi d'esodo misurava, con un bilancio spesso contraddittorio, gli esiti finali, 'corporali', di un'esperienza di vita materiale e culturale spesa all'insegna del lavoro in terra straniera. In alcune aree di forte esodo (Veneto) le rimesse e le migliorate condizioni di alimentazione contribuirono a debellare, durante i primi decenni del secolo, malattie sociali 'da miseria' come la pellagra. Inoltre l'emigrazione, mettendo in comunicazione 'fisica', tramite il pendolarismo migratorio, mondi e organismi sociali spesso diversissimi, pose seri problemi epidemiologici, tanto che il Mezzogiorno contadino finì per sperimentare patologie tipiche delle società urbano-industriali: tubercolosi, sifilide, blenorragia. Più in generale i rimpatriati posero gravi problemi di contagio e degradazione del corpo sociale, portando spesso impresse sul corpo le risultanti di drammatiche esperienze lavorative, umane ed 'ecologiche' all'estero: malaria, tracoma e anchilostomiasi per chi proveniva dall'America del Sud; demenza, anemia, nefrite e bronchite per i provenienti dall'America del Nord. Il tema della salute e dell'igiene tra gli emigranti si faceva drammatico sulle navi adibite al trasporto di questi carichi umani, le quali evidenziavano in maniera sistematica ai medici di bordo le risultanti sanitarie della miseria e dello sfruttamento patiti in Italia e oltreoceano.
6. Emigrazione e lotta politica
La valvola di sicurezza
L'adagio che assimilò l'emigrazione italiana a una valvola di sicurezza, che aveva impedito alle masse popolari e contadine 'compresse' di esplodere, fu coniato dalle componenti più avvedute del liberalismo italiano (Sidney Sonnino) e ha goduto di una serie di verifiche puntuali, nel tempo e nello spazio. In alternativa all'organizzazione di classe e alla lotta, o dopo un ciclo di lotte perdenti (ad esempio, in Sicilia, dopo la sconfitta dei 'fasci' del 1894-1895 o nel Mantovano dopo il 1873), l'emigrazione si presentò come un grande e silenzioso sciopero, un atto di insubordinazione, estraniazione e autonomia popolare, ma soprattutto contadina, nei confronti delle classi dirigenti ben installate alla guida dello Stato liberale. Fu presto chiaro che, sotto questo riguardo, esistevano tre Italie: una che lottava; l'altra, sempre più coincidente con il Mezzogiorno, che emigrava; e infine una che si rassegnava o quasi (poca emigrazione, poco movimento operaio e contadino).
Emigrazione e composizione di classe
L'emigrazione italiana, massiccia, precaria, dequalificata, finì per alterare profondamente la composizione e la cultura delle classi sociali sia in Italia che nei paesi stranieri ove si diresse. Per questi ultimi essa fu una sorta di pietra filosofale per ottenere una classe operaia (ovvero per evitare di averne troppa e troppo stabile nel tempo a causa di particolari congiunture con punte di domanda di lavoro) senza avere un movimento operaio o, quantomeno, per averne uno ragionevole, diffidente verso i gruppi operai immigrati, incapace di alleanze con un semiproletariato lanciato sulle vie dell'America o dell'Europa. Il risultato implicito di immigrazioni massive era anche quello di determinare una forte mobilità socio-professionale verso l'alto dei lavoratori nazionali, come accadde, ad esempio, in Francia, Svizzera e Belgio nel corso del XX secolo e per merito di immigrati italiani, polacchi, spagnoli. Visto dall'Italia, il meccanismo regolatore della composizione di classe consisteva nel disfarsi, con l'emigrazione, di 'pregiudicati, facinorosi e irrequieti', mantenendoli in una sorta di regime di extraterritorialità sociale e politica. L'immigrazione italiana servì anche per sporadiche e limitate - nel numero, nel tempo e nello spazio - ricuciture del tessuto sociale e produttivo tradizionale di alcuni paesi, lacerato in qualche punto debole (agricoltura, commercio, artigianato, servizi personali domestici e non) dal procedere squilibrato dello sviluppo capitalistico.
Emigrazione e socialismo
L'emigrazione italiana, e in generale la new immigration posteriore agli anni ottanta dell'Ottocento, fu una spina nel cuore del socialismo italiano e internazionale. Nei suoi confronti il socialismo nostrano mostrò impacci nella teoria (verso il fattore demografico, prima disconosciuto e poi recepito, da personaggi come Antonio Labriola, nell'infida accezione di 'nazione proletaria' e in chiave espansionistica, colonialista e antiplutocratica) e nella pratica politica. Le difficoltà erano assimilabili a quelle generali che esso incontrava nell'affrontare la questione contadina, al di là della questione bracciantile delle zone agrarie capitalistiche, e la questione meridionale. Corporativismo e provincialismo, misurati su concreti terreni di intesa con il riformismo giolittiano, furono le accuse che pervennero al PSI da opposte direzioni politiche (liberisti ortodossi, ma anche Gaetano Salvemini) proprio in considerazione della grande questione nazionale rappresentata dal binomio Mezzogiorno/emigrazione. Il socialismo italiano si caricò, piuttosto, del compito di sostenere diplomaticamente le ragioni dei partiti dei paesi di emigrazione, guardati con sospetto dai confratelli dei paesi di immigrazione, nelle assise della I e II Internazionale. In queste occasioni si registrava lo scontro tra le ragioni di difesa della classe operaia straniera e l'uso antioperaio, di strike-breaking, degli immigrati italiani. Più concretamente in sede partitica e sindacale si operò per facilitare la confluenza dei lavoratori italiani all'estero nei partiti e nelle organizzazioni professionali estere. I socialisti ebbero particolare successo nelle operazioni di 'scalata' e di trasformazione in senso classista del vecchio associazionismo e mutualismo italiano all'estero, borghese, patriottardo e ben controllato e foraggiato dal Ministero degli Esteri.
I cattolici
Non era difficile prevedere che la Chiesa cattolica italiana, pur partendo dalla posizione istituzionalmente e politicamente appartata in cui il laicismo anticlericale della borghesia liberale l'aveva costretta dopo l'Unità, era destinata a giocare un ruolo di primo piano rispetto a un fenomeno come l'emigrazione di massa tra Ottocento e Novecento. Un fenomeno che metteva in moto le zone e i ceti più segregati della società italiana (le campagne in primo luogo) toccava alla radice la base sociale dell'istituzione ecclesiastica costringendola a prendere posizione, prima, e a intervenire attivamente poi. Il cattolicesimo transigente italiano trovò, anzi, nell'emigrazione uno dei primi e più ampi terreni di incontro con lo Stato, di scontro ideale attivo con le idee socialiste, di 'bagno' nel sociale, rifunzionalizzando e mescolando, tra l'altro, ai destini delle comunità italiane all'estero una rinnovata tensione missionaria e di espansione della cattolicità, ad esempio entro le agguerrite isole protestanti europee e nordamericane. L'impegno cattolico nell'emigrazione nasce con l'azione di monsignor Angelo Scalabrini, l'apostolo degli emigranti e vescovo di Piacenza, tra la fine degli anni settanta e il 1890, e si dirige in prima istanza verso l'emigrazione transoceanica, entro la quale intende svolgere opera di patronato, assistenza religiosa e istruzione, soprattutto nei punti delicati della catena emigratoria, che sono il porto di imbarco e quello di sbarco. Dal 1900 in poi degli emigrati italiani in Europa, e con accenti più nazionalistici, di concorrenza politica nei confronti del socialismo, si occuperà l'Opera per gli emigranti nell'Europa e nel Levante, di monsignor Geremia Bonomelli.
La politica emigratoria
La politica emigratoria del governo e delle classi dirigenti italiane dopo l'Unità oscillò tra posizioni e gruppi che andavano dalla netta opposizione (il settore agrario fu generalmente ostile, così come chi osservava i crescenti fenomeni di renitenza alla leva dovuti agli espatri) all'incondizionato favore (società di navigazione, agenti di emigrazione), con un'ampia e manovrabile serie di posizioni intermedie, di distinguo, per lo meno fino alla fine del secolo, quando prevalsero le posizioni di incondizionato favore. La politica emigratoria italiana, se 'politica' si può chiamare, si venne definendo come oggetto di comportamenti politici trasformistici, inclini a privilegiare la via amministrativa (circolari) piuttosto che quella legislativa, e tutto sommato ad assumere posizioni attendiste. I capisaldi legislativi sono la legge cautamente permissiva del 1888, non a caso varata a ridosso della tariffa protezionistica del 1887 che aveva tranquillizzato la grande proprietà agraria meridionale, e la legge organica del 1901, apertamente filoemigratoria e istitutrice del Commissariato generale dell'emigrazione, del Fondo emigrazione (a spese degli emigranti) e di altre attività di patronato che ebbero vita breve o solo sulla carta. Restò a lungo insoluto uno spinoso e rilevantissimo problema sociale e finanziario: a chi spettasse l'onere di far rimpatriare sfortunate spedizioni di emigranti italiani. Le strutture diplomatiche e consolari italiane all'estero si mostrarono costantemente incapaci di gestire la nuova realtà dell'emigrazione italiana, oltre che soggettivamente ostili agli emigrati, che procuravano loro solo fastidi e lavoro aggiuntivo. L'attenzione dei pubblici poteri non si applicò mai al più delicato e carente degli anelli della 'catena' emigratoria, il collocamento, mentre grande cura fu riservata al rastrellamento delle rimesse, delegato dalla legge del 1901 al Banco di Napoli. A Novecento inoltrato il governo si avviò sulla strada dei trattati di lavoro ed emigrazione, ma per pochi paesi e con criteri che curavano più gli aspetti diplomatici che quelli di tutela dell'emigrante. Qualche sforzo maggiore, invece, fu fatto per ossequiare i principî di conservazione dell'italianità: le scuole all'estero ottennero un certo appoggio, così come le forme associative, mutualistiche e di aggregazione culturale a base nazionalistica.
7. Le 'catene' emigratorie
Per rendere effettiva un'offerta di lavoro di dimensioni tanto ampie e su scala intercontinentale, l'emigrazione italiana dovette avvalersi di una complessa 'organizzazione', di articolate catene che collegassero i luoghi d'esodo a quelli di destinazione. Caratteristica di queste catene fu la loro informalità, la loro capacità di funzionare tanto meglio quanto meno vi si ingerivano controlli e regolamentazioni statali, attività ordinatrici di associazioni, enti di tutela, ecc. Soprattutto per l'emigrazione transoceanica, il sistema funzionò come intersezione tra una microcatena (rapporti interpersonali di parentela, amicizia, compaesanità) e una macrocatena di processi e soggetti economico-sociali.
Il 'finanziamento' dell'espatrio
Particolarmente nella fase iniziale e per le destinazioni transoceaniche, la grande emigrazione italiana dovette affrontare spinosi problemi di finanziamento del viaggio. Questi furono risolti o con l'autofinanziamento (liquidazione di piccole proprietà immobiliari) e con concessioni di credito nei luoghi di origine (prestiti, spesso molto onerosi, oppure reti solidaristiche di prestito attivate dalle rimesse) o, sempre più spesso e ampiamente con il consolidarsi dei volumi e delle correnti di espatrio, con i biglietti 'prepagati' (prepaids) acquistati all'estero e offerti a familiari, amici oppure a terzi in qualche modo obbligati a controprestazioni verso il finanziatore ('padrone' o 'banchiere': un sistema che riecheggia le vecchie pratiche del lavoro indentured con i capitani dei vascelli transoceanici).
L'emigrazione sovvenzionata e gratuita
L'emigrazione sovvenzionata fu lo strumento attraverso il quale alcuni paesi dell'America Latina (Brasile) raschiarono il fondo delle potenzialità emigratorie del nostro paese (ad esempio, gli improvvisi e isolati esodi dalla Sardegna o dal basso Polesine negli anni novanta), raggiungendo le aree più povere e appartate delle campagne italiane. Questo tipo di emigrazione tendeva a dirottare i flussi dal mercato del lavoro nordamericano, più ambito, a quello sudamericano. Il sistema si concretizzava in 'contratti di introduzione' che il governo centrale o gli Stati regionali stipulavano con società di colonizzazione e queste, a loro volta, con quelle di navigazione.
Alle origini della grande emigrazione italiana vi è, tra l'altro, l'abbattimento dei costi di trasporto (maggiore velocità e minore prezzo) sia via terra (per ferrovia, particolarmente dopo che il governo italiano concesse agevolazioni tariffarie al lavoro migrante) che, soprattutto, via mare. Ciò consentì volumi e modelli di espatrio (pendolarità transoceanica, ad esempio) senza precedenti. I soggetti 'ordinatori' di maggiore efficacia nel regolare e indirizzare l'emigrazione italiana furono senza dubbio le compagnie di navigazione, che dal trasporto di emigranti ricavarono cospicui guadagni. Si deve anche a loro il graduale aumento del favore governativo verso l'emigrazione, onde far fronte al fenomeno dell'emigrazione italiana clandestina, che avveniva in porti e con marinerie concorrenti di altri paesi europei. Gli agenti di emigrazione - uno strato sociale intermedio e caratteristico, legato alle compagnie di navigazione, che si venne formando soprattutto nel Mezzogiorno - furono i terminali locali di una rete capillare che convogliava gli aspiranti all'espatrio verso i grandi porti di imbarco (Genova, Napoli, Palermo), ove fioriva un ampio sottobosco di affarismo più o meno lecito che girava attorno al mondo dei partenti. Gli agenti vennero additati dai censori dell'emigrazione di massa come i sobillatori di un'emigrazione 'artificiosa', ma nel fatto ottennero importanti protezioni da parte degli organi statali.
Padroni, bosses, banchieri
Alcuni dei caratteri dominanti dell'emigrazione italiana (individualismo, deprofessionalizzazione, analfabetismo, temporaneità) richiesero particolari 'istituzioni' per la regolazione dei flussi, soprattutto nella delicata fase del collocamento, un anello mancante come istituzione pubblica, sia italiana che straniera, nella complessa catena dell'espatrio. Negli Stati Uniti la massima espressione di questo fenomeno fu il padrone system (che poteva anche essere un 'banchiere', cioè un factotum le cui funzioni andavano dall'importazione di alimenti italiani all'effettuazione di rimesse). Questi intermediari di manodopera gestivano il reclutamento dell'emigrazione in Italia, talvolta con propri corrispondenti che non tardarono a trasmettere all'estero collegamenti mafiosi o camorristici, soprattutto con lo strumento dei biglietti prepagati. A New York 'stabulavano' i lavoratori italiani nelle tenement houses di loro proprietà, curavano l'avviamento al lavoro presso le imprese con le quali erano in contatto e gestivano persino spacci aziendali. Il boss giunse a svolgere più complesse funzioni di mediazione sociale e politica tra la massa immigrata da poco e la società statunitense (machines elettorali). Nell'emigrazione europea mediatori e incettatori di manodopera furono, per ovvi motivi, più rari e con funzioni più semplificate (capisquadra nell'emigrazione stagionale veneta per lavori edilizi).
8. L'emigrazione italiana nel periodo tra le due guerre
Nel 1914 inizia una sequenza di avvenimenti che porterà, nel volgere di un decennio, al tramonto di un'intera epoca storico-migratoria: quella della libera, o quasi, circolazione internazionale della manodopera. Questi eventi non potevano non incidere profondamente su dimensioni e contenuti dell'immigrazione italiana. In sede storiografica si è discusso, ad esempio, se i massicci rimpatri dall'estero (prima dalle aree europee di lingua tedesca e poi dalle altre aree mondiali) e il conseguente aggravarsi della già latente disoccupazione non siano stati una delle più forti spinte all'intervento in guerra del nostro paese. Durante gli anni di guerra l'economia statunitense imparò a fare a meno del massiccio e continuativo rifornimento della new immigration e ad approvvigionarsi presso i nuovi serbatoi di forze di lavoro interni (aree rurali, Stati del Sud, popolazione nera). Ciò costituisce la premessa affinché lo sviluppo economico del periodo bellico e la ripresa degli anni venti avvengano all'insegna di una progressiva chiusura dell'immigrazione negli Stati Uniti, culminata nei due provvedimenti di contingentamento (Quota acts) del 1921 e del 1924, che portano il tetto dell'immigrazione italiana al massimale di 42.057 unità annue, contro le 400.000 richieste che si erano andate affollando in uno degli anni tra il 1921 e il 1924. Ciò significa che il modello di sviluppo economico con emigrazione era diventato un dato stabile nella realtà italiana, soprattutto durante una crisi profonda come quella dell'immediato dopoguerra, e che il modello era pronto a rimettersi in moto con la stessa intensità degli anni prebellici. A questo obiettivo mirava una serie di discussioni, aspettative e preparativi dei governi italiani fin dal 1918. Si profilavano, infatti, i problemi sociali e occupazionali della smobilitazione, delle risposte da dare a una società (soprattutto quella contadina) colpita e 'svegliata' dai traumi della grande guerra e della riconversione industriale. Insomma si trattava, ancora una volta, di riaprire la 'valvola di sicurezza' per far sfogare la pressione sociale e politica, mentre entravano le rimesse che avrebbero contribuito a sanare il pesante indebitamento estero che la grande guerra aveva lasciato in eredità alla situazione finanziaria del paese. Governi prefascisti e primi governi fascisti premono, perciò, uniformemente fino al 1927 affinché si riaprano al più presto e il più ampiamente possibile le vie già percorse in passato dagli emigranti italiani.
Culmine di questi tentativi sono le Conferenze di Roma del 1921 e del 1924, con le quali il governo italiano e poi il fascismo cercano di organizzare un cartello dei paesi di emigrazione che contratti con più forza con i paesi di immigrazione, già avviati sulla via delle restrizioni. Vengono intanto affinati gli strumenti per 'valorizzare' al massimo la presenza degli italiani all'estero, soprattutto garantendo un ampio e agevole inoltro delle rimesse e incentivando, con appositi istituti di credito, la ricerca da parte delle imprese italiane di appalti all'estero (emigrazione imprenditorialmente organizzata). La diminuzione e la ristrutturazione dei flussi emigratori italiani durante gli anni venti avvengono, dunque, nelle seguenti direzioni: marcato riorientamento verso le destinazioni europee (soprattutto verso la Francia) e, all'interno della cedente emigrazione transoceanica, verso l'Argentina; più elevata caratterizzazione operaia, da un punto di vista sociale e professionale, destinata soprattutto alle industrie di base e insalubri (in particolare, le miniere francesi e belghe); consolidarsi di particolari flussi, come l'emigrazione di agricoltori (arricchitisi durante il conflitto e/o esacerbati dalla 'restaurazione contrattuale' fascista in agricoltura) verso le colonie agricole del sudovest della Francia, oppure come il piccolo boom di espatri verso l'Australia; peso decrescente della provenienza dalle regioni meridionali. Le restrizioni all'immigrazione, pendant del processo di progressiva non integrazione dell'economia internazionale che culminerà nella grande crisi del 1929-1930, si estendono progressivamente a tutto il Nord- e Sudamerica e all'Australia, tanto che la cosiddetta 'svolta antiemigratoria' del fascismo, nel 1927, sanziona quanto nel fatto è già accaduto non per autonoma scelta dell'Italia, ma per imposizione dall'esterno. A partire dalla grande crisi l'emigrazione italiana non avrà più storia e tenderà a confondersi con il movimento di forze di lavoro verso la Germania dell''Asse', in bilico tra emigrazione e deportazione. Resta l'isolata e drammatica punta di espatri del 1930, quando Mussolini permette improvvisamente, a seguito delle tensioni e dei turbamenti dell'ordine pubblico che la crisi sta scaricando sulla società italiana, che molti aspiranti emigranti vadano a vedere con i propri occhi che "non esistevano paesi facili in nessuna parte del mondo", come ebbe a dire in Senato. Ma è probabile che, con le istruzioni ai prefetti per un più largo ma selettivo (Liguria, Piemonte, Lombardia, Venezie, Emilia Romagna e alcune province dell'Italia centrale) rilascio dei passaporti, nel 1930 il regime abbia anche voluto disfarsi di oppositori e irrequieti, che andarono ad alimentare le file dei fuoriusciti antifascisti: fenomeno che segna un inasprimento della dialettica politica all'interno delle comunità italiane all'estero, entro le quali il regime cerca di penetrare propagandisticamente con il movimento dei fasci italiani all'estero.
9. L'emigrazione italiana nel secondo dopoguerra
Molti dei temi e problemi che avevano caratterizzato i due precedenti cicli emigratori si ripropongono dopo la fine della seconda guerra mondiale, con alcune accentuazioni o varianti. Costante è la pressione dei governi centristi per far riprendere il meccanismo di sviluppo economico associato all'emigrazione, mentre rapida e definitiva risulta, negli anni cinquanta, la destrutturazione del mondo agricolo-contadino, entro i cui confini il fascismo era sostanzialmente riuscito a contenere le forze di lavoro rurali. Riemerge con drammaticità e urgenza la questione meridionale, nella quale si concentravano insofferenze secolari, aspirazioni emigratorie penalizzate nel periodo tra le due guerre, gli insuccessi delle lotte contadine e la contraddittorietà degli esperimenti di riforma agraria. La forte ripresa economica europea, d'altra parte, stimolava di nuovo l'espansione dei movimenti migratori tra il sud e il nord del continente, ristabilendo una consistente libertà di movimento internazionale dei lavoratori, soprattutto entro quel blocco di paesi che daranno vita al processo di integrazione politico-economica della Comunità Europea (più la Svizzera). Il 'miracolo economico' italiano, che si dipana tra la ricostruzione e la forte congiuntura espansiva degli anni 1957-1962, avviene all'insegna di due tendenze che si incrociano: una contrazione dell'emigrazione extraeuropea, che era esplosa nell'immediato dopoguerra verso destinazioni tradizionali (Stati Uniti, Argentina) e nuove (talvolta solo per la dimensione: Canada, Venezuela, Colombia, Australia), e una oscillante ma massiccia espansione dei già elevati livelli di emigrazione verso l'Europa. Dall'inizio degli anni sessanta l'emigrazione italiana tenderà a diminuire con continuità, fino a giungere al suo momento di svolta che è anche l'epilogo di oltre un secolo di storia dell'emigrazione italiana all'estero.
La crisi internazionale da shock petrolifero del 1973 fa precipitare fenomeni come l'annullamento dei saldi annuali tra espatriati e rimpatriati, diventati positivi verso la fine degli anni settanta, ovvero come la trasformazione dell'Italia in paese di immigrazione, avvenuta molto in sordina e alimentata dai consistenti flussi provenienti dall'Africa e dall'Asia. Negli anni settanta risulta dunque ormai eroso il 'gradiente' di sviluppo economico e civile tra paesi a più antica o impetuosa industrializzazione e l'Italia: gli emigrati temporanei in Europa vedono incalzare una concorrenza che si è già manifestata in precedenza ma che ora prende vigore (nordafricani, turchi, iugoslavi), mentre nei nuovi territori l'assorbimento di europei langue, incalzato da nuove correnti (asiatici in Australia, centroamericani in Nordamerica). Questa coda finale della secolare storia emigratoria italiana ha visto rafforzarsi alcune delle tendenze in atto nel periodo tra le due guerre: lo sviluppo dei rapporti intergovernativi sotto la veste dei trattati di emigrazione e lavoro, in grado di avviare politiche di tutela dell'emigrante un po' più efficaci che in passato; il consolidarsi di alcune professioni standard (minatori, operai edili, operai delle grandi fabbriche meccanizzate). Le provenienze regionali, al contrario, tornano a essere quelle della fase culminante della grande emigrazione tra Ottocento e Novecento: Mezzogiorno, Veneto e Venezia Giulia, Marche.
10. Migrazioni interne e urbanizzazione fino alla seconda guerra mondiale
Un'impostazione metodologica molto consolidata negli studi sui movimenti migratori fa una distinzione abbastanza netta tra movimenti a breve e ad ampio raggio, tra una mobilità interregionale e una mobilità infraregionale (ma che cos'è una 'regione'?), tra una urbanizzazione ove la crescita demografica di una città si alimenta della popolazione della 'sua' campagna e le migrazioni interne in senso stretto. Analoghe 'drammatizzazioni' nelle differenze sono rintracciabili nella distinzione tra emigrazione all'estero 'definitiva' (fatta coincidere con quella transoceanica) ed emigrazione 'temporanea' (europea) e tra entrambe e le migrazioni interne. Come si vede, si tratta di categorie molto insoddisfacenti (ampiezza dello spostamento, mezzo di trasporto usato, regione, rapporto città-campagna, esistenza di un confine nazionale da attraversare, ecc.), che la realtà del continuum di flussi territoriali di forze di lavoro, messi in moto dalle discontinuità dello sviluppo capitalistico, sembra non aver mai rispettato, soprattutto nella peculiare esperienza italiana. Estremizzando, si potrebbe sostenere che i contadini meridionali a New York hanno sperimentato un processo economico-sociale di urbanizzazione, come chiaramente aveva intuito Antonio Gramsci che parlava del rapporto tra un Nord d'Italia sviluppato e industrializzato e un Mezzogiorno arretrato, agricolo, emigratorio, come del rapporto tra una grande città e una grande campagna.
Per quanto riguarda l'urbanizzazione, si può ben affermare che questo processo non è stato particolarmente veloce e vistoso nel nostro paese. A metà Ottocento l'Italia si presenta, nel contesto territoriale europeo, come l'area con il maggiore e storicamente più consolidato tessuto di città di media e grande dimensione. Da questo assetto iniziale parte, certo, una spinta alla concentrazione urbana della popolazione che è parallela alla modernizzazione complessiva e alla prima e regionalmente delimitata industrializzazione. Il fenomeno, tuttavia, non è travolgente, proprio in ragione del complesso rapporto che queste novità strutturali mantengono con un vasto e stabile retroterra agricolo tradizionale e, in larga misura, preindustriale, non mercantile, come ben si addice a un modello di sviluppo economico 'dualistico'. Una urbanizzazione vivace e 'classica', nella sua anima industrialista, si ha in poche aree del paese (Milano, Torino, Genova) e viene accompagnata, semmai, da una urbanizzazione terziaria, 'direzionale'. Questa tendenza sembra rimanere costante tra l'Unità e il secondo dopoguerra, in cui si verifica il più intenso ciclo di urbanizzazione che la società italiana abbia mai conosciuto. Questo ritmo medio secolare sembra, invece, leggermente rallentato nel periodo tra le due guerre, quando prende corpo un sottociclo di urbanizzazione dei centri di media dimensione, le 'capitali di provincia', che lo strutturarsi dei servizi e della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale rivitalizza, dopo il primo ciclo di urbanizzazione 'metropolitana' dell'età giolittiana.
È anche evidente che le migrazioni interregionali furono largamente inibite, fino alla fine degli anni venti, dal 'salto' che la mobilizzazione e l'offerta delle forze di lavoro italiane, tra Ottocento e Novecento, fecero direttamente sul mercato internazionale. Fino a questa epoca i movimenti interregionali più o meno definitivi sono esili, atipici (l'attrazione esercitata da Roma capitale su tutta l'Italia centrale e, in parte, meridionale), oppure permane la mobilità tradizionale interna al settore agricolo e stagionale (lavori nelle risaie lombardo-piemontesi; nell'Agro romano; mietiture nel Tavoliere delle Puglie; ecc.). Restano sulla carta i propositi degli inizi del secolo, e talvolta anche più remoti, di attivare movimenti migratori interni da nord a sud, al fine di ripopolare sedicenti aree incolte o depauperate demograficamente del Mezzogiorno (ad esempio Sardegna e Basilicata). Questo spunto di politica migratoria e agraria, basato sulla cosiddetta colonizzazione interna, sarà ripreso dal fascismo con la stagione delle bonifiche al centro-sud, della 'sbracciantizzazione' e dell'alleggerimento delle province con sovrappopolazione contadina (Emilia e Romagna, Veneto). Ma il vero legame osmotico tra emigrazione all'estero e migrazioni interne può essere collocato proprio nel periodo tra le due guerre, quando si manifestano i primi consistenti spostamenti di popolazione dal Mezzogiorno, compresso dalla persistente crisi strutturale e dall'assenza degli sbocchi verso l'estero. Inizia dunque a manifestarsi il fenomeno della progressiva 'meridionalizzazione' della popolazione italiana a partire dai grandi poli di attrazione: le regioni del 'triangolo' (Piemonte, Lombardia, Liguria, e questa precocemente, a causa della fase di 'stanchezza' demografica e delle esigenze di ristrutturazione del suo tessuto economico-industriale); le aree metropolitane (Roma, Milano, Torino, Genova), che cominciano a selezionare l'offerta di lavoro sulle grandi distanze in relazione a occupazioni precarie (edilizia) o dequalificate (servizi domestici); alcune industrie nuove a rapido sviluppo (ad esempio le fibre tessili artificiali). Anche l'Italia orientale veneta, 'Mezzogiorno' del Nord, risponde a questo ordine di sollecitazioni. Nelle aree metropolitane si manifestano i primi segni di una immigrazione definitiva e diseredata, ai margini del mercato ufficiale del lavoro (le 'baraccopoli' nelle periferie delle città). Tutto ciò avviene, si può dire, 'clandestinamente', mentre il fascismo, come spesso era solito fare, proclamava di percorrere una via esattamente opposta: quella della ruralizzazione, della politica 'antiurbana' che ostacolava, con disposizioni contraddittorie sulle variazioni anagrafiche di residenza e sul libretto di lavoro, i movimenti migratori interregionali e l'urbanizzazione. Nel fatto entrambi i fenomeni sono in crescita, particolarmente tra 1922 e 1927 e tra 1935 e 1939, anche se non è da escludere un effetto deterrente e ricattatorio di queste disposizioni (restate in vigore fino agli inizi degli anni sessanta) sulle condizioni di occupazione e sul potere contrattuale di fasce marginali di lavoratori clandestini di recente immigrazione.
11. Le migrazioni interne e l'urbanizzazione nel secondo dopoguerra
I rivoli di migrazioni interne che si andavano delineando con sempre maggiore chiarezza nel periodo tra le due guerre offrono uno schema già pronto sul quale troverà modo di espandersi a dismisura la massiccia mobilitazione della popolazione italiana nel secondo dopoguerra. Il fenomeno nuovo, per dimensione e qualità, del dopoguerra non sarà, dunque, la ripresa dell'emigrazione all'estero, quanto quella delle grandi migrazioni interregionali, che partono dal Mezzogiorno e dalle regioni del centro e vanno verso il nordovest d'Italia, con una diversione verso Roma. La riapertura del grande serbatoio di forza lavoro rurale in generale, e meridionale in particolare, andrà questa volta a beneficio degli equilibri salariali, di composizione di classe, di elasticità dell'offerta di lavoro, sui quali saranno costruite le fortune del modello di sviluppo e industrializzazione che l'Italia sperimenta come 'miracolo economico': un modello basato su una dinamica molto forte della domanda internazionale, delle esportazioni italiane che la soddisfecero, dei livelli di competitività che sostennero queste esportazioni, basati sul basso costo del lavoro oltre che su altri elementi più duraturi (aggiornamento tecnologico). Anche questo fenomeno declina durante la seconda metà degli anni sessanta e i primi anni settanta, in parallelo ai livelli di espatrio e ai movimenti di urbanizzazione, soprattutto quella 'metropolitana'.
La società italiana si sta dunque avviando a una prima e complessiva stabilizzazione demografica, sia sul terreno del movimento naturale ('crescita zero'), sia su quello delle strutture insediative e della distribuzione territoriale della popolazione, una stabilizzazione adeguata ormai al livello di sviluppo raggiunto, anche in termini di più diffuso benessere e/o di maggiori rigidità socioculturali relative all'offerta territoriale di lavoro. Anche quando questo livello di benessere non si realizza, come in molte aree del Mezzogiorno, la stabilizzazione insediativa della popolazione italiana mostra che una società urbano-industriale avanzata, anche se profondamente dualistica, non può più sopportare lacerazioni e costi sociali come quelli accumulati progressivamente durante i grandi movimenti migratori interregionali e la massiccia urbanizzazione degli anni cinquanta e sessanta. Il mercato del lavoro, grazie anche a una più attiva e diffusa presenza sindacale, non appare più, durante gli anni settanta, come un mercato perfettamente concorrenziale. D'altronde le diseconomie di accentramento urbano-regionale della forza lavoro e di scala nelle imprese (costi dell'urbanizzazione edilizia e della fornitura dei servizi collettivi; disagio socioculturale; devianza; insubordinazione operaia) cominciano a superare di gran lunga le possibili e ormai erose economie di agglomerazione urbana e di scala produttiva (minori salari; maggiore flessibilità nel rapporto, soprattutto congiunturale, tra domanda e offerta di lavoro; indivisibilità tecniche; economie esterne). Sono elementi, questi, che reimmettono nel circuito dello sviluppo e dell'industrializzazione intere aree e regioni un tempo obsolete ed emarginate (la cosiddetta 'terza Italia', ad esempio). Lo sviluppo degli anni settanta e dei primi anni ottanta avviene, come è noto, all'insegna di modelli di organizzazione economico-territoriale nuovi: piccola impresa, lavoro autonomo e a domicilio; decentramento produttivo in genere; valorizzazione delle risorse e delle economie esterne locali; elusione delle aree a forte concentrazione del movimento operaio organizzato; part time con altre attività di supporto, come l'agricoltura; ecc.
L'Italia, con quest'ultimo fenomeno, sembra dunque aver raggiunto una sorta di stato stazionario, entro il quale si va perdendo la nozione stessa dei termini che abbiamo fin qui impiegato (emigrazione all'estero, migrazioni interne, urbanizzazione), per lo meno nell'accezione che essi hanno avuto in passato. Parallelamente si profila un fenomeno più generale di circolazione delle persone e dei lavoratori, indistinguibile nelle sue componenti e motivazioni e dotato di un universalismo che lo rende più un salto antropologico che una evoluzione delle tendenze passate.
(V. anche Meridionale, questione; Urbanizzazione).
Bibliografia
AA.VV., Gli italiani negli Stati Uniti, Firenze 1972.
AA.VV., Un secolo di emigrazione: 1876-1976, Roma 1978.
AA.VV., Euroamericani. La popolazione di origine italiana negli Stati Uniti, in Argentina, in Brasile, 3 voll., Torino 1987.
Ascoli, U., Movimenti migratori in Italia, Bologna 1975.
Assante, F. (a cura di), Il movimento migratorio italiano dall'Unità ai giorni nostri, 2 voll., Genève 1978.
Barbagallo, F., Lavoro ed esodo nel Sud: 1861-1971, Napoli 1973.
Bezza, B. (a cura di), Gli italiani fuori d'Italia. Gli emigrati italiani nei movimenti operai dei paesi d'adozione (1880-1940), Milano 1983.
Blumer, G., L'emigrazione italiana in Europa, Milano 1970.
Borzomati, P. (a cura di), L'emigrazione calabrese dall'Unità ad oggi, Roma 1982.
Boyd Caroli, B., Harney, R.F., Tomasi, L.F., The Italian immigrant woman in North America, Toronto 1978.
Bruti Liberati, L., Il Canada, l'Italia e il fascismo, 1919-1945, Roma 1984.
Caliaro, M., Francesconi, M., L'apostolo degli emigranti. Giovanni Battista Scalabrini, Milano 1968.
Castelnuovo Frigessi, D., Elvezia, il tuo governo. Operai italiani emigrati in Svizzera, Torino 1977.
Cerase, F.P., Sotto il dominio dei borghesi. Sottosviluppo ed emigrazione nell'Italia meridionale, 1860-1910, Assisi-Roma 1975.
Cinanni, P., Emigrazione e imperialismo, Roma 1968.
Cinanni, P., Emigrazione ed unità operaia. Un problema rivoluzionario, Milano 1974.
Ciuffoletti, Z., Degl'Innocenti, M. (a cura di), L'emigrazione nella storia d'Italia, 1868-1975. Storia e documenti, 2 voll., Firenze 1978.
Coletti, F., Dell'emigrazione italiana, in AA.VV., Cinquanta anni di storia italiana, vol. III, Milano 1911.
Cresciani, G., Fascismo, antifascismo e gli italiani in Australia, 1922-1945, Roma 1979.
Cresciani, G. (a cura di), L'Australia, gli australiani e la migrazione italiana, Milano 1984².
Dall'Italia alle Americhe. Storie di emigranti e immagini dell'immigrazione, in "Movimento operaio e socialista", 1981, IV, n. speciale 1-2.
De Felice, R., L'emigrazione e gli emigranti nell'ultimo secolo, in "Terzo programma", 1964, n. 3.
De Felice, R. (a cura di), Emigrazione italiana nelle Americhe e in Australia, Milano 1979.
Dell'Orefice, A. (a cura di), Tendenze dell'emigrazione italiana: ieri, oggi, Genève 1978.
Devoto, F.J., Rosoli, G. (a cura di), L'Italia nella società argentina, Roma 1988.
Di Caporiacco, G., Storia e statistica dell'emigrazione dal Friuli e dalla Carnia, 2 voll., Udine 1969.
Dore, G., La democrazia italiana e l'emigrazione in America, Brescia 1964.
Duroselle, J.B., Serra, E. (a cura di), L'emigrazione italiana in Francia prima del 1914, Milano 1978.
Emigrazione, cento anni, 26 milioni, in "Il Ponte", 1974, XXX, nn. speciali 11 e 12.
Ferrari, M.E., Emigrazione e colonie: il giornale genovese "La borsa" (1865-1894), Genova 1983.
Filipuzzi, A., Il dibattito sull'emigrazione. Polemiche nazionali e stampa veneta (1861-1914), Firenze 1976.
Foerster, R.S., The Italian emigration of our times, Cambridge 1919².
Fontani, A., Gli emigrati, Roma 1962.
Fontani, A., La grande migrazione, Roma 1966.
Franzina, E., La grande migrazione. L'esodo dei rurali dal Veneto durante il secolo XIX, Venezia 1976.
Franzina, E., Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei contadini veneti in America Latina, 1876-1902, Milano 1979.
Franzina, E. (a cura di), Un altro Veneto. Saggi e studi di storia dell'emigrazione nei secoli XIX e XX, Abano Terme 1983.
Gallo, P. (a cura di), The urban experience of Italian-Americans, New York 1977.
Golini, A., Distribuzione della popolazione, migrazioni interne e urbanizzazione in Italia, Roma 1974.
Grassi, C., Le migrazioni interne italiane nel secolo unitario. Cause e conseguenze, Torino 1967.
Harney, R.F., Dalla frontiera alle Little Italies. Gli italiani in Canada, 1800-1945, Roma 1984.
Harney, R. F., Scarpaci, J.F. (a cura di), Little Italies in North America, Toronto 1981.
Istituto di Demografia dell'Università di Roma, L'emigrazione dal bacino mediterraneo verso l'Europa industrializzata, Milano 1976.
La società italiana di fronte alle prime migrazioni di massa. Il contributo di mons. Scalabrini e dei suoi primi collaboratori alla tutela degli emigranti, in "Studi emigrazione", 1968, V, n. speciale 11-12.
Lazzarini, A., Campagne venete ed emigrazione di massa (1866-1900), Vicenza 1981.
Livi Bacci, M., L'immigrazione e l'assimilazione degli italiani negli Stati Uniti secondo le statistiche demografiche americane, Milano 1961.
Manzotti, F., La polemica sull'emigrazione nell'Italia unita, Città di Castello 1969².
Martellone, A.M., Una Little Italy nell'Atene d'America. La comunità italiana di Boston dal 1880 al 1920, Napoli 1973.
Martellone, A.M. (a cura di), La 'questione' dell'immigrazione negli Stati Uniti, Bologna 1980.
Molinari, A., Le navi di Lazzaro. Aspetti sanitari dell'emigrazione transoceanica italiana: il viaggio per mare, Milano 1988.
Paris, R., L'Italia fuori d'Italia, in Storia d'Italia Einaudi, vol. IV, t. 1, Torino 1975.
Piselli, F., Parentela ed emigrazione. Mutamenti e continuità in una comunità calabrese, Torino 1981.
Prato, L., Sviluppo del capitale ed emigrazione in Europa: la Francia, Milano 1976.
Rosada, A., Serrati nell'emigrazione, 1899-1911, Roma 1972.
Rosoli, G. (a cura di), Emigrazioni europee e popolo brasiliano, Roma 1987.
Rosoli, G., Cannistraro, P.V., Emigrazione, chiesa e fascismo. Lo scioglimento dell'Opera Bonomelli (1922-1928), Roma 1979.
Sapere la strada. Percorsi e mestieri dei biellesi nel mondo, catalogo-mostra a cura della Banca Sella, Milano 1986.
Signorelli, A., Tiriticco, M.C., Rossi, S., Scelte senza potere. Il ritorno degli emigranti nelle zone d'esodo, Roma 1977.
Sori, E., L'emigrazione italiana dall'Unità alla seconda guerra mondiale, Bologna 1979.
Tomasi, S.M. (a cura di), Perspectives in Italian immigration and ethnicity, New York 1977.
Tosi, L., L'emigrazione italiana all'estero in età giolittiana. Il caso umbro, Firenze 1983.
Trento, A., Là dov'è la raccolta del caffè. L'emigrazione italiana in Brasile, 1875-1940, Padova 1984.
Treves, A., Le migrazioni interne nell'Italia fascista, Torino 1976.
Treves, A., Ripopolare il Sud. Il meridionalismo fascista allo specchio della colonizzazione (1926-1927), in "Storia urbana", 1988, XII, 43.
Vitali, O., Le migrazioni interne: una sintesi storico-statistica, in "Affari sociali internazionali", 1974, nn. 1 e 2.