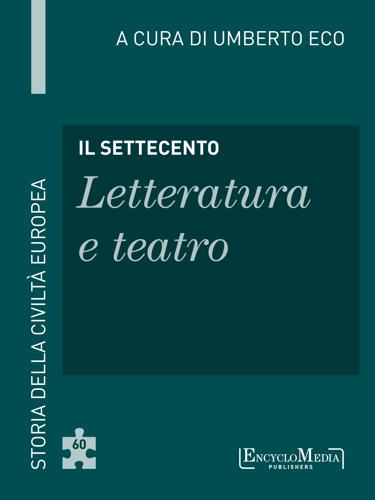Pietro Metastasio
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Tale è l’influenza di Metastasio nel teatro che molti storici della musica hanno definito il Settecento come “l’età di Metastasio”. Raffinatissimo poeta, i suoi testi si distinguono per l’attenzione prestata tanto al concetto musicale quanto a quello letterario. Nel Settecento l’opera seria è ritenuta l’espressione teatrale più alta dei valori della nobiltà e Metastasio ne è l’incontrastato maestro: i suoi drammi verranno posti in musica più di 800 volte.
Premessa
Il mondo artistico dei drammi in musica a cui approda Pietro Metastasio agli inizi della carriera è caratterizzato – e tale rimarrà durante tutto l’arco della sua vita attiva e oltre – dalla salda preminenza dell’opera seria italiana (a volte definita “opera napoletana”, anche se nessuna città può essere indicata con precisione come luogo natale del genere). Il contesto sociale di questo mondo è formato quasi esclusivamente di spettacoli sovvenzionati dalla classe patrizia e quindi a lei indirizzati; i testi drammatici dunque riflettono ed esaltano i valori cari alla classe dirigente. L’opera seria viene eseguita in grossi e fastosi teatri che si continuano a costruire per tutto il corso del secolo.
La crisi artistica che alla fine del Seicento investe l’opera italiana – tipizzata ormai da trame contorte fino all’incomprensibilità, che si affidano a situazioni o pretesti mirati solo a produrre effetti visivi spettacolari, e intrisa nelle commedie di scene farsesche di bassa lega – diviene oggetto di preoccupazione e dibattito tra gli intellettuali nelle accademie romane.
Tentativi di riforma letteraria del genere partono quindi dalla generazione di librettisti del primo Settecento capeggiati dall’intellettuale aristocratico veneto Apostolo Zeno, che trae i suoi soggetti non più dalla mitologia bensì dalla storia antica, adotta una linea di svolgimento più lineare, sfrondandola da situazioni esagerate e forzate per enfatizzare invece una gamma di sentimenti più razionali e, sempre con l’intento di rendere meno contorte le trame, riduce il numero di personaggi di primo e di secondo piano.
Tuttavia questa generazione di librettisti difetta nell’attenzione prestata alle possibilità d’espressione musicale dei loro scritti: Zeno stesso non è musicista e mostra scarso interesse nel risultato “operistico” dei libretti, incoraggiando perfino esecuzioni dei suoi drammi recitate in prosa (nel qual caso i testi delle “arie” – che rappresentano momenti di riflessione interiore e dunque di stasi drammatica – vengono semplicemente omessi). Metastasio ha una concezione dell’azione drammatico-musicale che si stacca radicalmente dalla prassi precedente. Pur privilegiando il concetto letterario non sottovaluta l’aspetto musicale, tenendo presente al contrario l’importanza di entrambi. Competente musicista, durante tutta la sua carriera Metastasio è solito mantenere contatti non solo con i letterati patrizi ma anche con cantanti e compositori e, nello stilare i suoi versi teatrali, tiene sempre ben presente non solo l’intrinseca “musicalità” di parola e metrica ma anche il modo in cui i versi si prestano ad essere “posti in musica”.
La carriera
Nato nel 1698 a Roma, Pietro Trapasso – questo è il suo vero nome – comincia gli studi sotto la protezione del cardinale Ottoboni. Il classicista Gian Vincenzo Gravina, sentendo il ragazzo decenne cantare e improvvisare, si prende cura della sua istruzione e grecizza il suo cognome in Metastasio. Nel 1712 Gravina avvia il giovane agli studi di filosofia – grande su di lui è l’influenza del pensiero cartesiano – e successivamente di giurisprudenza. Il giovane Metastasio mostra uno spiccato talento nello scrivere e improvvisare versi, e nel 1717 pubblica un volume di Poesie, tra cui la tragedia Giustino.
Pietro Metastasio
Sogni e favole io fingo; e pure in carte
Sonetti
Sogni e favole io fingo; e pure in carte
mentre favole e sogni orno e disegno,
in lor, folle ch’io son, prendo tal parte,
che del mal che inventai piango e mi sdegno.
Ma forse, allor che non m’inganna l’arte,
più saggio io sono? È l’agitato ingegno
forse allor più tranquillo? O forse parte
da più salda cagion, l’amor, lo sdegno?
Ah che non sol quelle, ch’io canto o scrivo
favole son: ma quanto temo o spero,
tutto è menzogna, e delirando io vivo!
Sogno della mia vita è il corso intero.
Deh tu, Signor, quando a destarmi arrivo,
fa’ ch’io trovi riposo in sen del Vero.
in La lirica d’Occidente, a cura di G. Conte, Parma, Guanda, 1990
Gravina muore nel 1718 e il suo testamento libera Metastasio da pensieri finanziari; poco dopo il giovane, trasferitosi a Napoli, abbandona la carriera giuridica per dedicarsi alla poesia. È incoraggiato in tale scelta dalla cantante Marianna Benti-Bulgarelli, detta La Romanina, che canta in molte delle opere per le quali Metastasio scrive i testi negli anni Venti e che lo porta a conoscere i più importanti compositori e cantanti operanti a Napoli.
Dopo una serie di testi per serenate, cantate e “drammi pastorali” assai ben accolti, Metastasio scrive nel 1724 il suo primo libretto d’opera, Didone abbandonata che viene musicata da Domenico Sarro. Il successo è enorme e immediato: l’opera viene richiesta nei maggiori teatri d’Italia e gli impresari fanno a gara per avere una “prima” metastasiana. Dal 1724 al 1729 il poeta si trasferisce in varie città ma soggiorna principalmente a Roma e a Venezia; più di una volta in queste due città, si hanno “prime” quasi simultanee di testi metastasiani musicati da due diversi compositori. In questi anni scrive sei libretti d’opera che avranno una grande influenza in tutta Europa: ormai Metastasio viene considerato il rinnovatore del teatro musicale italiano.
Nel 1730 si trasferisce a Vienna, indicato dallo Zeno come suo degno successore a poeta di corte, e da allora vivrà sempre nella capitale austriaca. È suo compito fornire i testi per qualsiasi evento, spettacolo o celebrazione richiestogli dalla corte, per cui la sua libertà di scelta viene notevolmente ridotta. I primi dieci anni a Vienna sono i più fecondi della sua carriera – scrive drammi per musica, feste teatrali, oratori, serenate – seguiti da oltre quarant’anni di relativo silenzio. Tale è tuttavia la fama internazionale conquistata nella prima metà della vita che la sua stella non si appanna mai nei successivi decenni di relativa aridità creativa; anzi col passare degli anni Metastasio rimane non solo un punto di riferimento ma assiste per così dire alla sua stessa apoteosi, divenendo quasi un monumento vivente e la sua arte un riassunto dell’estetica dell’epoca. Si spegne nel 1782.
Se nella seconda metà della sua vita Metastasio diminuisce sensibilmente l’attività artistica e si ritira, sempre più, dalla vita di corte, mantiene tuttavia una fitta corrispondenza con artisti, generosa di osservazioni sull’arte drammatica e sull’interpretazione. Rimane un convinto sostenitore della monarchia assoluta, refrattario ai nuovi concetti sociali e politici dell’Illuminismo, visione che viene sottolineata con eleganza e grande decoro stilistico in tutti i suoi testi.
Innovazioni e influenza sull’arte melodrammatica
Con Metastasio l’opera seria italiana consolida una sua struttura ideale. La divisione in tre atti (e non più nei cinque della generazione precedente) diventa pressoché fissa, la forma interna è costituita quasi sempre da un’alternanza di recitativi e arie.
Come già era d’uso nei recitativi si sviluppa l’azione, mentre le arie rappresentano momenti di sospensione in cui un protagonista esprime le proprie emozioni oppure riflette su quanto è appena successo. Sono pochi i brani d’assieme: dominano le “arie”, tant’è che l’opera seria settecentesca è stata anche definita “l’opera di arie”.
Diversamente dalla prassi di Zeno, Metastasio tende a porre le arie alla fine di ogni scena, per meglio fungere da momento culminante dell’azione che si è sviluppata nel recitativo precedente ma anche, dal punto di vista della logica dei movimenti scenici, per meglio preparare l’uscita del cantante a fine scena. I testi delle arie sono strutturati invariabilmente in due stanze che esprimono emozioni complementari o contrastanti, e sono dunque predisposti alla struttura musicale dell’aria con il “da capo” che rimane in voga fin oltre la metà del secolo.
Sebbene la forma dell’aria con il “da capo” presenti una struttura vincolante (con le due strofe poetiche cantate nell’ordine: prima strofa – seconda – ripetizione della prima; ciascuna strofa preceduta da un ritornello strumentale), proprio questa prevedibilità strutturale dà a Metastasio il modo di generare in maniera magistrale effetti di tensione o sorpresa, mediante anticipi, troncamenti o tagli di parti della forma consueta.
Pietro Metastasio
Il tormento di Megacle
Olimpiade
Scena 9 - MEGACLE solo
MEGACLE: Che intesi, eterni dèi! Quale improvviso
fulmine mi colpì! L’anima mia
dunque fia d’altri! E ho da condurla io stesso
in braccio al mio rival! Ma quel rivale
è il caro amico. Ah quali nomi unisce
per mio strazio la sorte! Eh che non sono
rigide a questo segno
le leggi d’amistà. Perdoni il prence:
ancor io sono amante. Il domandarmi
ch’io gli ceda Aristea non è diverso
dal chiedermi la vita. E questa vita
di Licida non è? Non fu suo dono?
Non respiro per lui? Megacle ingrato,
e dubitar potresti? Ah! se ti vede
con questa in volto infame macchia e rea,
ha ragion d’aborrirti anche Aristea.
No, tal non mi vedrà. Voi soli ascolto,
obblighi d’amistà, pegni di fede,
gratitudine, onore. Altro non temo
che ’l volto del mio ben. Questo s’evìti
formidabile incontro. In faccia a lei,
misero, che farei! Palpito e sudo
solo in pensarlo, e parmi
istupidir, gelarmi,
confondermi, tremar... No, non potrei...
Scena 10 - ARISTEA e detto; poi ALCANDRO.
ARISTEA: Stranier [senza vederlo in viso].
MEGACLE: Chi mi sorprende? [rivoltandosi]
ARISTEA: [riconoscendosi reciprocamente] (Oh stelle!)
MEGACLE: (Oh dèi!)
ARISTEA: Megacle! mia speranza!
Ah sei pur tu? Pur ti riveggio? Oh Dio!
Di gioia io moro; ed il mio petto appena
può alternare i respiri. Oh caro! Oh tanto
e sospirato e pianto
e richiamato in vano! Udisti al fine
la povera Aristea. Tornasti, e come
opportuno tornasti! Oh Amor pietoso!
Oh felici martìri!
Oh ben sparsi fin or pianti e sospiri!
MEGACLE: (Che fiero caso è il mio!)
ARISTEA: Megacle amato,
e tu nulla rispondi?
E taci ancor? Che mai vuol dir quel tanto
cambiarti di color? quel non mirarmi
che timido e confuso? e quelle a forza
lagrime trattenute? Ah! più non sono
forse la fiamma tua? Forse...
MEGACLE: Che dici!
Sempre... Sappi... Son io...
Parlar non so. (Che fiero caso è il mio!)
ARISTEA: Ma tu mi fai gelar. Dimmi: non sai
che per me qui si pugna?
MEGACLE: Il so.
ARISTEA: Non vieni
ad esporti per me?
MEGACLE: Sì.
ARISTEA: Perché mai
dunque sei così mesto?
MEGACLE: Perché... (Barbari dèi, che inferno è questo!)
ARISTEA: Intendo: alcun ti fece
dubitar di mia fé. Se ciò t’affanna,
ingiusto sei. Da che partisti, o caro,
non son rea d’un pensier. Sempre m’intesi
la tua voce nell’alma: ho sempre avuto
il tuo nome fra’ labbri.
il tuo volto nel cor. Mai d’altri accesa
non fui, non sono e non sarò. Vorrei...
MEGACLE: Basta: lo so.
ARISTEA: Vorrei morir più tosto
che mancarti di fede un sol momento.
MEGACLE: (Oh tormento maggior d’ogni tormento!)
ARISTEA: Ma guardami, ma parla,
ma di’...
MEGACLE: Che posso dir?
ALCANDRO: [uscendo frettoloso] Signor, t’affretta,
se a combatter venisti. Il segno è dato,
che al gran cimento i concorrenti invita [parte].
MEGACLE: Assistetemi o numi. Addio, mia vita.
ARISTEA: E mi lasci così? Va’: ti perdono,
pur che torni mio sposo.
MEGACLE: Ah sì gran sorte
non è per me! [in atto di partire].
ARISTEA: Senti. Tu m’ami ancora?
MEGACLE Quanto l’anima mia.
ARISTEA: Fedel mi credi?
MEGACLE: Sì, come bella.
ARISTEA: A conquistar mi vai?
MEGACLE: Lo bramo almeno.
ARISTEA: Il tuo valor primiero
hai pur?
MEGACLE: Lo credo.
ARISTEA: E vincerai?
MEGACLE: Lo spero.
ARISTEA: Dunque, allor non son io,
caro, la sposa tua?
MEGACLE: Mia vita... Addio.
Ne’ giorni tuoi felici
ricordati di me.
ARISTEA: Perché così mi dici,
anima mia, perché?
MEGACLE: Taci, bell’idol mio.
ARISTEA: Parla, mio dolce amor.
MEGACLE: Ah che parlando, oh Dio!
ARISTEA: Ah che tacendo, oh Dio!
A DUE: Tu mi trafiggi il cor.
ARISTEA: (Veggio languir chi adoro,
né intendo il suo languir).
MEGACLE: (Di gelosia mi moro,
e non lo posso dir).
A DUE: Chi mai provò di questo
affanno più funesto,
più barbaro dolor!
in S. Guglielmino, H. Grosser, Il sistema letterario. Dal Cinquecento al Seicento, Milano, Principato, 1988
Di norma i drammi di Metastasio presentano un conflitto di passioni che coinvolge due coppie di amanti, sullo sfondo di una storia derivata da un autore classico greco o latino; fanno da contorno e da “spalla” nello svolgimento alcuni ruoli secondari e, sovente, un personaggio caro al teatro settecentesco, il “tiranno magnanimo”. I drammi d’emozione si dipanano con decoro e aristocratico contegno. I personaggi nei drammi di Metastasio sono inevitabilmente figure nobili e grandiose motivate da generosi sentimenti. La trama offre numerosi spunti per introdurre una varietà di cambiamenti scenici, come ad esempio episodi pastorali, momenti bellici o cerimonie in alta pompa.
Infine, la risoluzione del dramma dipende quasi sempre da qualche altruistica rinuncia o da qualche atto eroico di uno dei protagonisti.
La preparazione musicale di Metastasio si fa evidente nella sublime costruzione di versi già da sé “musicali” per la loro fluidità e per l’accortezza di porre parole drammaticamente d’effetto in una posizione del verso dove, in una tipica frase musicale, naturalmente verrebbero a trovarsi in risalto. Tra gli accorgimenti di Metastasio vi è la cura con cui evita parole con vocali scomode nei punti chiave dei versi dove, in una “cadenza” musicale, un cantante solitamente aggiungerebbe una fioritura alla linea melodica.
In tutto, Metastasio scrive libretti per 27 opere serie in tre atti, che vengono poste in musica innumerevoli volte da molteplici compositori, inclusi i maggiori operisti del Settecento: Galuppi, Gluck, Händel, Jommelli, Mozart, Paisiello, Pergolesi, Salieri, Vivaldi. Non si contano poi le versioni musicali delle cantate, oratori, serenate e arie basate sui suoi testi. Per ancora quattro decenni dopo la sua morte, fino alla soglia dell’epoca romantica nell’opera italiana, compositori come Cherubini, Cimarosa, Mayr, Mercadante e Meyerbeer trarranno ispirazione dai suoi libretti.
Metastasio viene considerato dai suoi contemporanei il più illustre scrittore di melodramma, da alcuni addirittura il più grande poeta di tutto il Settecento, considerazione tanto più rilevante alla luce del fatto che i suoi più importanti componimenti portano una data anteriore al 1740.
È nell’altissimo livello stilistico che lascia il segno più profondo sui musicisti coevi e offre un modello ideale ai librettisti contemporanei e ai successori.