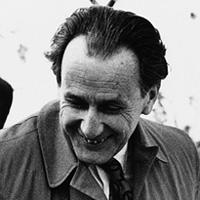LOPEZ, Roberto Sabatino
LOPEZ, Roberto Sabatino
Dalla formazione all’emigrazione
Roberto Lopez nacque l’8 ottobre 1910 a Genova, primogenito di Sabatino e di Sisa Tabet, appartenenti a famiglie ebraiche toscane di origine sefardita. A Genova il padre, drammaturgo e critico letterario, fu docente di italiano all’Istituto tecnico prima di trasferirsi a Milano, dove dal 1911 diresse la Società autori e dal 1915 insegnò all’Accademia di Brera e dove nacque l’altro figlio, Guido, giornalista e scrittore con forti propensioni verso la storiografia (1924-2010).
Lopez respirò un’atmosfera poco partecipe dell’esperienza fascista sia nella sua famiglia, bene inserita nel mondo culturale, sia soprattutto al ginnasio-liceo Berchet: qui si rivelò uno studente abbastanza turbolento, benché fosse straordinariamente ricco di interessi – tra cui l’amore per la montagna – e manifestasse una grande comunicativa, con il desiderio di diventare giornalista politico. Nella città ligure, dove era nato nella via dedicata all’annalista del secolo XII, Caffaro, in felice coincidenza con i suoi interessi futuri, Lopez continuò a soggiornare spesso grazie al forte legame con lo zio materno, che vi risiedeva.
A Milano, Lopez condusse gli studi universitari, laureandosi con Romolo Caggese, docente di storia medievale e moderna ed esponente di quella 'scuola economico-giuridica' che rappresentava un superamento dell’approccio positivistico: a lui dovette probabilmente la sensibilità per i documenti. Suggestionato da una recente ricerca del romeno Gheorghe Bratianu sul commercio dei genovesi nel Mar Nero che nel secolo XIII avrebbe inaugurato una nuova era, Lopez si orientò autonomamente verso l’argomento della tesi, che dedicò a Benedetto Zaccaria, un poliedrico personaggio – mercante, ma anche ammiraglio, guerriero, industriale, diplomatico – della Genova tardo duecentesca. Chiese conferma della praticabilità di quella scelta a Vito Vitale, grande conoscitore degli archivi genovesi che affrontò aspetti molteplici della storia cittadina inaugurando una stagione «prammatico-retorica» (Grendi, 1996, p. 21), in cui pesavano gli intenti istruttivi e dalle finalità formative, toccando durevolmente qualche corda della sensibilità storica di Lopez: ne nacque un duraturo rapporto. La tesi dedicata a Benedetto Zaccaria, che contribuì a costruire il prototipo e ad alimentare l’epopea del grande mercante, fu frutto di uno scavo documentario ben mirato innanzitutto nell’archivio notarile, che a Genova consente come per nessun altra città affondi ricchissimi. La vicenda individuale – ben calata in un articolato contesto familiare, ovvero una dimensione di indagine che in seguito non suscitò interesse in Lopez – fu usata per ripercorrere in chiave prevalentemente economica dinamiche che attraversavano il Mediterraneo. Completa di una consistente appendice documentaria e discussa nel 1932, la tesi di questo giovanissimo autore fu pubblicata già l’anno successivo e fu oggetto di positive recensioni, che premiarono la novità di impostazione e la limpidezza della narrazione, rimasta poi come un suo tratto distintivo. In breve tempo questi giudizi gli dischiusero o gli consentirono di rinsaldare relazioni con quanti seppe scegliersi quali punti di riferimento se non quali maestri, a partire da Gino Luzzatto, tra i precursori in Italia della storiografia economica (e di cui Lopez in un ricordo valorizzò soprattutto e significativamente la prudenza interpretativa), da André E. Sayous e Fernand Braudel, della cerchia di studiosi attiva attorno alle neonate Annales d’histoire économique et sociale ed entrambi forse conosciuti in quel fertile luogo di incontri che era la sala di studio dell’Archivio di Stato di Genova.
Lopez prese inizialmente la strada dell’insegnamento nelle scuole superiori, a Cagliari e poi a Pavia (1933-35), tornando a Genova nel 1935-36, dapprima all’Istituto magistrale.
Furono anni fecondi anche per la sua ricerca, in cui affrontò tematiche innovative – per l’epoca e rispetto alle fonti che privilegiava – e saldamente anticipatrici di alcune delle proprie direzioni future di indagine. Animato com’era dalla consapevolezza che l’osservazione dei fatti economici consentisse di costruire una prospettiva storiografica nuova, operò (anche in seguito) un setacciamento sistematico di quello straordinario giacimento che è costituito dai registri notarili genovesi, con tutta la loro varietà di contratti e di problemi che spalancano, anche oltre lo spazio urbano: queste fonti illuminano eccezionalmente taluni aspetti della vita della maggior città ligure tanto da occultarne in pratica altri. Quasi di conseguenza, per Lopez rimasero larghi angoli morti tematici – come tutto l’ambito religioso-ecclesiastico, le relazioni che si articolano sul territorio, le questioni istituzionali – che rimasero durevolmente estranei ai suoi interessi; in definitiva Lopez optò per l’inserimento in quella corrente di studi economici che stava assumendo un profilo disciplinare autonomo rispetto alla storiografia italiana: pesarono anche le sue relazioni con Luzzatto e con Armando Sapori.
Anche rispetto agli studiosi statunitensi che si stavano cimentando con le medesime fonti notarili, appiattiti su un ingenuo descrittivismo, spiccò il vigore interpretativo di Lopez, capace di gestire una più cospicua mole di dati con soluzioni originali. Lo si constata soprattutto nel saggio del 1934 dedicato all’attività economica di Genova nel marzo del 1253, anno tranquillo sotto tanti punti di vista. Qui Lopez sperimentò la scelta – molto originale rispetto alle correnti mode storiografiche, e indicativa di una sua attenzione 'sistemica' e non solo biograficistica – di circoscrivere quanto possibile l’arco cronologico e dilatare al massimo la raccolta documentaria (400 atti), senza selezione delle tipologie contrattuali, con il proposito, che poi non poté realizzare, di ripetere l’operazione di decennio in decennio. Fu un tentativo efficace e creativo di dare soluzione, avanzando valutazioni globali, alla questione della significatività delle testimonianze reperibili – quando ne siano disponibili in tal massa – che Lopez non reputò affrontabile in termini meramente statistici. È una prospettiva che evitò anche nei lavori successivi, in pratica liquidando subito, lui che fu prevalentemente uno storico economico, l’approccio quantitativo e il sussidio fornito dalle statistiche, cui raramente ricorse affidandosi invece alla qualità dei dati.
Tra un buon numero di indagini di varia taglia risalenti a questi anni vanno citate almeno quelle, molto mirate, raccolte nel 1936 in Studi sull’economia genovese nel medio evo, dedicate all’operato di genovesi fuori patria, in Africa orientale, oppure attivi solo in città, nell’arte della lana, e agli inventari patrimoniali duecenteschi. Proprio gli inventari furono valorizzati per il loro potenziale informativo e una loro selezione fu data in trascrizione, come sarà scelta frequente di Lopez, sempre attento a fornire non edizioni vere e proprie bensì documentazione interpretabile in chiave economica, anche con finalità divulgative.
A Genova, nel 1935 (dunque a soli 25 anni), Lopez acquisì la libera docenza e ricevette l’incarico dell’insegnamento di storia economica e poi di storia delle esplorazioni geografiche all’Ateneo. Ma alla fine del 1936 non superò il concorso a professore straordinario per la cattedra di storia economica presso l’Università ligure «nel quale» – come ricordò – «i voti favorevoli di Filippo Carli e Armando Sapori mi consolarono dell’avversa decisione della maggioranza, composta dal ministro [delle Finanze] Acerbo e i professori Arias e Franchini». Questo non isolato episodio di selezione universitaria per mano governativa è stato più volte rievocato, anche sottolineando come nel corso della lunga vicenda il ministero dell’Educazione nazionale fosse passato a Giuseppe Bottai. Fu premiata una terna di non uniforme valore (Amintore Fanfani, Santi Floridia e Luigi Dal Pane) e il prezzo per Sapori fu la stasi accademica, mentre Carli, che era fascista convinto, morì nel 1938. Maturò tuttavia un’amicizia che sarebbe durata tutta la vita tra Lopez e Sapori, lo storico economico definito nel primissimo dopoguerra il miglior medievista d’Italia, se non del mondo, da Fernand Braudel (Franceschi, 2014, pp. 367, 371). Nel rapporto con Sapori, testimoniato da un cospicuo epistolario, pesò anche il fatto che il percorso scientifico di entrambi non era connotato dall’appartenenza a una 'scuola' e che condivisero uno specifico oggetto di appassionato studio, i mercanti e la mercatura, benché poi il solo Lopez allargasse le proprie scelte tematiche.
Nonostante il freno alla carriera accademica, due successivi lavori in particolare consolidarono nello scenario della medievistica europea la posizione di Lopez. Aux origines du capitalisme génois fu pubblicato infatti nel 1937 sulle Annales (che ospitarono parallelamente un lavoro di Luzzatto, Les activités économiques du patriciat vénitien, Xe-XIVe siècle), grazie anche all’interesse che la produzione di Lopez aveva suscitato in Marc Bloch. Qui riconobbe il nesso tra la scarsità di risorse di una regione e la scelta dei suoi abitanti di dedicarsi, diffusamente e in maniera crescente nel tempo, al commercio, spesso dopo aver ceduto proprietà fondiarie ormai frazionate: qui, tra l’altro, impostò il problema del confronto con le altre città marinare italiane. Il secondo, dell’anno successivo e tutto condizionato dal ricorso massiccio alle fonti notarili, è una grande panoramica, Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo (un orizzonte cui resterà fedele in tanti studi) costruita su un ampio arco cronologico (i secoli X-XVI) e articolata in una pluralità di tematiche (ma senza un apparato di note, come era frequente per l’epoca). Pur se recante alcune scorie – come le allusioni frequenti alla vitalità collettiva o al genio etnico dei Liguri – che sono state intese come quasi inevitabili concessioni al clima del tempo per rendere possibile la pubblicazione, nelle sue linee di fondo e nelle scelte tematiche fu questo libro a influenzare durevolmente la storiografia genovese successiva (Balard, nella ristampa del 1996, pp. XVI-XVII).
L’arrivo negli Stati Uniti e la militanza antifascista
Già dal 1937 Lopez aveva considerato l’ipotesi dell’emigrazione, a causa del greve clima politico in Italia, ma si convinse a compiere questo passo dopo i provvedimenti governativi del novembre 1938 che proibivano la presenza di appartenenti alla «razza ebraica» nelle amministrazioni dello Stato e inibivano loro l’insegnamento. Lopez contava sull’aiuto dello studioso statunitense Robert Reynolds, che aveva conosciuto a Genova grazie alle comuni ricerche sui registri notarili e che avrebbe potuto offrirgli un lavoro presso l’Università di Madison, nel Wisconsin. Rispetto a un trasferimento diretto negli Stati Uniti vi furono intoppi burocratici (legati a pretestuosi motivi di salute), forse volti a scoraggiare l’emigrazione e non superati nemmeno da autorevoli interventi, tra cui quelli di Benedetto Croce e – proprio dagli Stati Uniti – di Arturo Toscanini, il direttore di orchestra esponente di punta dell’emigrazione politica. Così, tra la primavera e l’estate del 1939 Lopez si recò a Londra: qui ebbe anche modo di frequentare gli archivi del Public Record Office, per un’indagine sui rapporti anglo-genovesi fra Due e Trecento, prima di risolvere gli ostacoli all’emigrazione oltreoceano giungendo, non ancora trentenne, a Madison nel settembre. Mentre in Europa scoppiava la guerra, e con tutte le complicazioni dovute alla scarsità di notizie sui suoi familiari, Lopez dovette ricominciare da capo il percorso universitario per acquisire un titolo di studio riconosciuto, ricoprendo però il ruolo di research assistant. Si laureò nel 1942, con Reynolds, grazie a una tesi per sua stessa ammissione illeggibile, e non solo perché scritta in un inglese inadeguato: diventò comunque in seguito, pienamente, un poliglotta.
In questo lasso di tempo, tuttavia, Lopez non si astenne dalla ricerca storica e la distanza anche fisica dalle fonti fino ad allora più frequentate servì a orientarlo soprattutto in due direzioni, entrambe con riferimento a grandi ambiti di civiltà e con arretramento cronologico rispetto alla sua esperienza di indagine: una sorta di esplicita dichiarazione della sua intenzione di muoversi su cronologie molto distese. Da un lato, attuò una considerazione del diritto bizantino nella sua elaborazione del secolo VII e del suo recepimento da parte di Arabi e Germani. Dall’altro, pubblicando sulla prima rivista medievistica statunitense, Speculum, che più tardi lo vide nel proprio comitato scientifico, sollecitò una ripresa del dibattito attorno alla tesi di Henri Pirenne, ovvero sostanzialmente sui processi di natura periodizzante per l’alto medioevo: piuttosto che sull’espansione dell’Islam, pose l’accento sul progressivo distanziamento dell’Europa occidentale da Costantinopoli (su questo dibattito cfr. Capitani, 1979).
Nel periodo di guerra si aprì un altro breve capitolo della vita di Lopez. Coerente con le sue istanze giovanili e con la sua netta posizione antifascista, nel 1942 e nel 1943 collaborò intensamente all’Office of War Information – l’organismo con sede a New York preposto alla propaganda di guerra – nelle trasmissioni radio destinate all’Italia, entrata nel conflitto mondiale nel 1940. Grazie alla capacità organizzativa e all’efficacia dei suoi testi, divenne in breve capo-redattore della nutrita sezione italiana di The Voice of America, caratterizzando i propri messaggi in senso prevalentemente patriottico contro il regime fascista e tutti i suoi sostenitori; nella fase più tarda accolse alcuni motivi ispiratori del programma mirante a creare alleanze progressiste elaborato da Gaetano Salvemini, il grande storico meridionalista di posizioni socialiste emigrato negli anni Venti e cattedratico ad Harvard. Con l’armistizio dell’8 settembre 1943 il rapporto di reciproca fiducia con l’amministrazione statunitense, già incrinato per qualche apertura americana verso il governo Badoglio, si spezzò senza rimedio e Lopez si dimise bruscamente. La divergenza di opinioni rispetto alla militanza politica e all’orientamento in tale impegno si solidificò nel 1944 in un contrasto anche tra Lopez, più patriota che partigiano, e Salvemini, più radicale e politicamente coinvolto (che a ridosso di questo incidente definì Lopez «puramente conservatore, timido, tradizionalista – sebbene ottimo come storico»: G. Salvemini, Lettere americane, a cura di R. Camurri, 2015, p. 410).
Nel 1942 Lopez incontrò Claude-Anne Kirschen, giovane ebrea belga emigrata con la famiglia negli Usa per sfuggire all’occupazione nazista del suo Paese: era allora segretaria del bizantinista Henri Grégoire (anch’egli un ebreo emigrato), collaborò in seguito alla sezione francese dell’Office of War Information e diventò una grande studiosa di Benjamin Franklin. Il matrimonio avvenne quattro anni più tardi, dopo che nel 1945 Lopez ottenne la cittadinanza americana, facendo aggiungere in questa occasione il nome del padre, Sabatino, al proprio. La coppia ebbe due figli, Michele e Lawrence.
L’attività scientifica ed accademica negli Stati Uniti
Il Brooklyn College e la Columbia University diedero una breve accoglienza accademica a Lopez prima del suo passaggio nel 1946, quale assistant professor, a Yale: in questa prestigiosa Università compì tutta la carriera raggiungendo negli anni Settanta la posizione più alta (Sterling Professor); tra le iniziative che lì promosse vi fu innanzitutto il Dipartimento di studi medievali nel 1962, mentre presiedette la Society of Italian History Studies nel 1966-67. Nella sua vita professionale ebbe occasione di impartire il proprio insegnamento in altre sedi di gran prestigio e di partecipare a una molteplicità di iniziative, tra cui è indispensabile ricordare almeno quelle promosse nel suo Paese d’origine, anche con un diretto apporto nei comitati scientifici, dal Centro italiano di studi sull’alto medioevo di Spoleto, istituito nel 1952, e dall’Istituto internazionale di storia economica F. Datini di Prato, fondato nel 1967 con primo presidente proprio Braudel. Il pensionamento avvenne nel 1981. Lungo questi operosi anni avviarono la propria carriera di storici i suoi allievi John Paul Bischoff, Eric Cochrane, Sidney Cohen, Patrick Geary, David Herlihy, Diane Owen Hughes, Stuart Jenks, Benjamin Z. Kedar, Harry A. Miskimin, John Munro, Edward Peters, Katherine Reyerson, Abraham L. Udovitch e altri ancora, orientati su cronologie di ricerca disposte tra medioevo ed età moderna, e spesso con attenzione all’Italia, oppure liberi di scegliersi approcci loro congeniali. Una buona parte della medievistica statunitense ha tuttora una radice nel magistero di Lopez. Nel 1953 Lopez fu sollecitato dall’Università di Genova a chiarire la propria posizione di libero docente, dopo la decadenza avvenuta nel 1938: un episodio di ottusità burocratica cui non fu estraneo il ministero per l’Istruzione e che si risolse, come dimostra un discreto carteggio, con una delibera confermativa della facoltà di lettere del 1958.
L’enorme capacità di lavoro di Lopez, agevolata da un’eccellente memoria che gli consentiva di assimilare rapidamente una cospicua bibliografia e accompagnata da una sorta di rinuncia ascetica verso quanto potesse rallentare i suoi studi è immediatamente constatabile scorrendo la sua ricchissima produzione scientifica, in parte destinata all’alta divulgazione. Alcune durature direttrici di indagine di un percorso molto coerente sono riconoscibili con facilità, anche grazie alle raccolte di articoli successivamente montate dall’autore stesso, frequentate e riprese, anche a distanza di tempo, soprattutto dalla cerchia degli specialisti, spesso su questioni classiche come le persistenze e le rotture e i cicli della storia: un filone di studi ancora dedicato a Genova, dal momento che Lopez tornò con regolarità in Italia e nei suoi archivi fin dall’immediato dopoguerra; una sequenza di indagini rivolte al mondo bizantino, con attenzione prevalente alle relazioni economiche e istituzionali; una serie di ricerche di storia monetaria medievale; un filone di storia del commercio, variamente declinato (con un’importante pubblicazione relativa all’Europa meridionale nella Cambridge Economic History, 1952), in cui va incluso un discreto numero di affondi specifici sui commerci dei genovesi con le Indie e l’Estremo Oriente; solo dalla metà degli anni Cinquanta Lopez maturò uno specifico interesse proprio per l’idea di città.
Questi e altri lavori, come Settecento anni fa: il ritorno all’oro nell’occidente duecentesco (1955), contributo a un dibattito che già aveva coinvolto Henri Pirenne e Marc Bloch, oppure come l’innovativo studio dedicato a La prima crisi della banca in Genova (1250-1259) (1956), che colorano la larga palette di temi economici su cui si cimentò Lopez, costituirono una sorta di fitto tessuto sottostante o anticipatore di importanti sintesi e proposte, mai 'neutre', per cui Lopez è più noto, con varietà di recepimento e discussione – ragionando per grandi schemi – a seconda dei diversi contesti scientifici nazionali. Per esempio, non ebbe comprensibilmente quasi accoglienza in Europa il poderoso lavoro sviluppato con Irving W. Raymond, Medieval trade in the Mediterranean World. Illustrative documents (New York 1955), che forniva la traduzione inglese di circa duecento documenti, adeguatamente commentati. Se vi fu grande continuità con molti interessi coltivati nell’anteguerra, altrettante furono le aperture – non scontate – delle prospettive che la nuova e definitiva residenza americana sollecitava: viveva in un Paese che aveva vinto il conflitto mondiale e che aveva superato anche la grave crisi del 1929 (un risultato che lo aveva molto colpito), studiava in un contesto di relazioni accademiche differentemente plasmate ed era impegnato in una didattica con forti priorità se la sua preoccupazione, riscontrabile comunque in tutto il suo lavoro, fu «above all, do not bore». Furono peculiari di Lopez testi costruiti con accorto dosaggio di eclettiche citazioni e di sollecitazioni all’attenzione grazie a un calibrato uso della retorica e il ricorso a slogan atti a rimanere impressi (uno per tutti: la moneta bizantina quale «dollaro del medioevo»).
Dai primissimi anni Cinquanta Lopez si rivolse, in pochi ma fondativi interventi, a quanto poteva ricadere sotto l’etichetta di 'rinascimento', agendo in due opposte direzioni cronologiche. Dapprima, in Still Another Renaissance?, del 1951, affrontò un tema contiguo a quello già trattato nel contribuire al dibattito sulla 'tesi Pirenne', sottolineando con precocità – rispetto a quanti poi affrontarono il tema della 'ripresa dopo il Mille' – tutti gli aspetti positivi o che denotano un progresso già del secolo X: dall’irrobustirsi della natalità all’evoluzione della tecnica, all’arricchimento dei mercanti, fino al fatto che vi si potessero cogliere i primissimi germi delle future nazioni. La rivalutazione di questo secolo, sviluppata con la necessaria prudenza, generò poi, oltre a un’interessante riflessione sul rapporto tra economia e architettura medievale con attenzione in particolare alle cattedrali (1952), un Symposium sul Rinascimento (1952, con atti pubblicati l’anno dopo), anche grazie all’impegno di un gruppo di lavoro coordinato da Lopez. Nell’intervento dedicato ad Hard Times and Investment in Culture egli mise in originale relazione la fase di crisi prolungata avviata a metà Trecento in Europa con i concomitanti e ricchi investimenti in arte e cultura dei mecenati: il ceto più facoltoso aveva consentito la fioritura rinascimentale dal momento che le opportunità nei commerci si erano prosciugate. In tal modo, Lopez andava contro l’interpretazione data poco meno di un secolo prima (1860) in Die Kultur der Renaissance in Italien da Jacob Burckhardt, il quale intese il Rinascimento come un’età eccezionalmente creativa e un superamento del medioevo, con un’implicita fiducia che si fondasse su una crescita ininterrotta, come fu peraltro lunga convinzione degli economisti.
Al di là della discussione che la proposta generò, si poteva davvero cogliere cosa avesse comportato per Lopez il trasferimento negli Stati Uniti e la sua ormai sostanziale appartenenza anche a un ambito culturale prettamente anglossassone. Al pari di altri studiosi di origine europea, la scelta di porre nuovamente attenzione al Rinascimento in senso proprio andava infatti letta anche in chiave di risposta di impronta liberal dopo l’esperienza delle tirannie europee: fascismo, nazismo, comunismo. E del resto Lopez si mantenne nell’ambito ideologico-politico sempre su posizioni liberal, in materia di diritti civili, pacifismo antiatomico, appoggio alla democrazia laica in Usa e in Israele (cfr. Il medioevo degli orizzonti aperti, p. 10). Ad Hard Times and Investment in Culture seguì, per quanto riguarda il rinascimento precedente il Mille, una raccolta di documenti tradotti in inglese e commentati nel 1959 sotto un titolo accattivante, The Tenth Century. How Dark the Dark Ages?; mentre per quanto riguarda quello dei secoli XV-XVI Lopez perfezionò la propria impostazione in tre lezioni pubblicate nel 1970, distinguendo appunto tre diverse età (giovinezza, maturità e declino), scandite canonicamente da grandi eventi, ma precedute da una fase di 'ancestry', una categoria che ha una certa ricorrenza nel suo approccio.
Il lavoro più ambizioso di Lopez, quello che considerava il proprio capolavoro, è la brillante sintesi, anzi una storia comparata della società medievale, per cui firmò un contratto nel 1953 e che dopo una lunga gestazione fu pubblicata in francese, grazie alla revisione linguistica attuata dalla moglie, nel 1962. La Naissance de l’Europe rientrava in un largo progetto editoriale sviluppato da Braudel, che costrinse l’autore ad amputare dall’impianto generale le trattazioni relative al mondo arabo, slavo e bizantino e che vennero (re)introdotte nella più ampia traduzione italiana, del 1967: in ogni caso, l’opera costituì occasione per Lopez di esprimere la propria interpretazione del medioevo e il titolo, che fu una sua scelta, la chiariva immediatamente, anche mettendo in discussione le tradizionali periodizzazioni (un aspetto su cui tornò a più riprese). Il saggio abbraccia i secoli che vanno dal secolo V (ma con arretramenti significativi anche nel III) al XIV e individua nel X la ripresa, con una connotazione in termini negativi, di 'vecchiaia', della fase altomedievale: la fase carolingia, infatti, era intesa come una falsa partenza.
Nella versione italiana, quattro tendenze di fondo animano la rinascita che si interrompe con la crisi di metà Trecento. Schematizzando all’estremo, si tratta di migliore distribuzione della popolazione nelle campagne; accumulo di capitale e di energie grazie alla rinnovata attività mercantile; progressi tecnologici; frazionamento politico che incentiva le iniziative private (cfr. O. Capitani in Il Medioevo degli orizzonti aperti, 1989, in particolare p. 51; l’articolo è utile per la rassegna delle recensioni che il libro ricevette) che rientrano perfettamente nel suo percorso conoscitivo di storico innanzitutto dell’economia. La nascita dell’Europa ebbe un successo notevole fra i lettori e anche quale testo per gli esami universitari, se si pensa che l’editore Einaudi lo ristampò ancora nel 1999 (giungendo a vendere un totale di circa 25.000 copie) e conobbe traduzioni in molte altre lingue. Non convinse appieno i colleghi storici italiani, non solo medievisti, benché la discussione che sollecitò risultasse salutare e si riconoscesse la completezza dei temi trattati. Colpirono non favorevolmente, per esempio, il tentativo di trovare spiegazioni in termini di esperienze storiche «emisferiche» (innanzitutto la peste, per la sua diffusione asiatica e circummediterranea), una bassa sensibilità di fondo rispetto a temi come l’incontro cristiano-germanico, un premio quasi eccessivo dato alla categoria dell’intraprendenza. Ma tutto ciò, in definitiva, conferma la resistenza di Lopez a elaborare una filosofia della storia pur avvertendo fortemente l’esigenza di una storia totale, come ebbe a dichiarare in seguito, con significative puntualizzazioni e con evidente richiamo a Marc Bloch: «Ai miei studenti raccomando di fare macrostoria con microstoria per materia prima: cioè, idee larghe e suggestive, esempi e modelli stretti e precisi. Credo soltanto alla storia totale» (Sul medioevo e i medievisti, 1977, p. 126; Romagnoli, 1994, pp. 41-48).
L’altra sintesi per cui Lopez è più conosciuto, The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950-1350, venne pubblicata in inglese nel 1971 e costituì il coronamento di tanti precedenti affondi, mostrando una chiara influenza della sua opera maggiore e una grande capacità di fare convergere informazioni relative ai più vari ambiti nel quadro complessivo. Senza avere di necessità contorni troppo netti, la vigorosa accelerazione degli scambi si verificò nei secoli XII e XIII, benché con cronologie differenziate a seconda dei paesi, e si attenuò drasticamente con la pestilenza di metà del Trecento, ma quando ormai l’Europa aveva maturato una capacità di recupero ignota al mondo antico, bloccato da un ideale di aurea mediocritas. Forse più che in Italia, dove venne tradotto nel 1975 (con ristampe almeno fino al 1989), nel mondo anglosassone questo libro è stato a lungo considerato molto formativo per gli studenti.
Quello della città medievale costituisce per il genovese Lopez un tema 'originario', saltuariamente ripreso: per esempio, in omaggio a Marc Bloch per la lezione di metodo rispetto al mondo rurale, volle intitolare un breve intervento del 1973 I caratteri originali della città medievale. Tuttavia, la questione della natura della città lo appassionò particolarmente negli ultimi anni e l’intervento più articolato nasce da un denso colloquio, pubblicato nel 1984, con un altro grande storico, ma dell’età moderna, Marino Berengo. L’intervista-libro ebbe un cuore cronologico nei secoli XI-XIV, con aperture notevoli anche all’ambito extraeuropeo e riusciti sconfinamenti disciplinari. Qui Lopez ripropose la felice formula, cui già era ricorso con efficacia nella Settimana di Spoleto del 1955, della «città come prima di tutto uno stato d’animo» (La città dell’Europa post-carolingia, 1955, pp. 551 s.). A dimostrazione della sua sensibilità per le altre scienze sociali, si trattava di un «concetto integralmente ripreso» da due esponenti della scuola di Chicago degli anni Venti, i sociologi fondatori dell’ecologia urbana Robert E. Park e Ernest W. Burgess (Bordone, 1984, p. 13), approfondendolo però in senso culturale, come si ricava dal noto seguito della sua definizione: «Sono cittadini coloro che si sentono tali, che sono orgogliosi di appartenere a una comunità superiore a un villaggio». La nozione di città sviluppata da Lopez, in ogni caso, era un riconoscimento della sua complessità, superando senz’altro quella già tratteggiata da Henri Pirenne, e restava sostanzialmente legata all’impronta lasciata dei mercanti (e non dagli artigiani e nemmeno dai signori rurali che con lei variamente si rapportano): a parametro delle attività cittadine Lopez scelse nei differenti contesti urbani, per esempio, precocità e ritardo della presenza mercantile, l’equilibrio del rapporto instaurato con la circostante campagna, la capacità politica e la tenuta di un buongoverno animato dai mercanti (cfr. M. Berengo, in Il Medioevo degli orizzonti aperti, 1989, pp. 69-74).
Morì il 6 luglio 1986 a New Haven.
Opere
Si indicano qui i lavori di Lopez con attenzione a quelli richiamati nel testo e utili per reperire una bibliografia completa: Genova marinara nel Duecento. Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante, Milano 1933 (riedizione priva dell'appendice: Benedetto Zaccaria. Ammiraglio e mercante nella Genova del Duecento, Firenze 1996, con un testo introduttivo di G. Airaldi e un elenco di tutti gli interventi su Lopez e le sue commemorazioni); L’attività economica di Genova nel marzo 1253 secondo gli atti notarili del tempo, in Atti della Società ligure di storia patria, LXIV (1935), pp. 163-267 (con un estratto anticipato del 1934); Studi sull’economia genovese nel medio evo, Torino 1936; Aux origines du capitalisme génois, in Annales d’histoire économique et sociale, IX (1937), pp. 429-454, trad. in Storia dell’economia italiana. Saggi di storia economica, a cura di C.M. Cipolla, I, Secoli settimo-diciassettesimo, Milano 1959, pp. 285-312; Storia delle colonie genovesi nel Mediterraneo, Bologna 1938, Genova 1996 (ristampa con prefazione e aggiornamento bibliografico di M. Balard); Byzantine Law in the Seventh Century and its Reception by the German and the Arabs, in Byzantion, XVI (1942-43), pp. 445-461; Mohammed and Charlemagne: A Revision, in Speculum, XX (1945), pp. 1-42; Still Another Renaissance?, in American Historical Review, (1951), vol. 57, pp. 1-21; Économie et architecture médiévales, in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, VII (1952), pp. 433-438; Hard Times and in Investments in Culture, in The Renaissance: A Symposium, 8-10 febbraio 1952, New York 1953, pp. 19-34; La città dell’Europa post-carolingia: il commercio dell’Europa post-carolingia, in I problemi comuni dell’Europa post-carolingia, II, Spoleto 1955, pp. 547-599; Medieval trade in the Mediterranean World. Illustrative documents, New York 1955 (con I.W. Raymond); Settecento anni fa: il ritorno all’oro nell’occidente duecentesco, Napoli 1955; La prima crisi della banca in Genova (1250-1259), Milano 1956; The Tenth Century: How Dark the Dark Ages?, New York 1959; Naissance de l’Europe, Paris 1962 (trad. portoghese, Lisboa 1965; trad. inglese London 1966 e New York 1967; trad. italiana riveduta e ampliata Torino 1966 e Milano 2004; trad. spagnola Barcelona 1966; trad. slovena Ljubljana 1969); The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950-1350, Saddle River (New Jersey) 1971 (trad. italiana Torino 1974; trad. francese Paris 1974); I caratteri originali della città medievale, in Concetto, storia, miti e immagini del Medioevo, a cura di V. Branca, Firenze 1973, pp. 19-24; Su e giù per la storia di Genova, Genova 1975 (collezione di 23 lavori pubblicati tra il 1933 e il 1972, in varia misura rivisti e con inediti, con una bibliografia degli scritti e un elenco delle recensioni prevalentemente in Rivista storica italiana e Speculum, in Journal of Economic History, aggiornati al 1972; Sul medioevo e i medievisti, in Quaderni medievali, II (1977), 4, pp. 124-130 (risposte a otto domande poste dalla redazione della rivista, R. Licinio); Byzantium and the World around it: Economic and Institutional Relations, London 1978 (ristampa di 14 saggi pubblicati tra il 1944 e il 1976); The Three Ages of the Italian Renaissance, Charlottesville (Virginia) 1979; Intervista sulla città medievale, a cura di M. Berengo, Bari 1984; The Shape of Medieval Monetary History, London 1986 (ristampa di 10 saggi pubblicati tra il 1947 e il 1974); I monetieri del primo medioevo: la piu antica aristocrazia professionale laica che la storia ricordi, in Rassegna di studi del Civico museo archeologico e del Civico gabinetto numismatico di Milano: notizie dal Chiostro del Monastero Maggiore, 1991, 48, pp. 1-64 (in appendice una bibliografia degli scritti completa). Su un progetto non realizzato di libro dedicato ai commerci dei genovesi nelle Indie e in Estremo Oriente, che avrebbe dovuto raccogliere sette articoli e l’edizione di documenti, cfr. In quibuscumque mondi partibus, in Miscellanea di storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia, Genova 1978, pp. 345-354 (in partic. p. 348 nota 2).
Fonti e Bibliografia
Gran parte della corrispondenza di Lopez (comprese la puntuale testimonianza dei suoi riconoscimenti scientifici ed accademici) è custodita dalla Yale University a New Haven nel fondo Manuscripts & Archives, mentre biblioteca e archivio sono depositati presso l’Arizona State University, con un inventario accessibile on line, http://www.azarchivesonline.org/xtf/view?docld=ead/asu/lopezr.xml&doc.view=print;chunk.id=0; vedi inoltre G. Salvemini, Lettere americane. 1927-1949, a cura di R. Camurri, Roma 2015.
L’attività di Lopez è stata considerata, oltre che nelle introduzioni alle ristampe dei suoi lavori, in: O. Capitani, Medioevo passato prossimo, Bologna 1979, pp. 75-144, passim; R. Bordone, La società urbana nell’Italia comunale (secoli XI-XIV), Torino 1984; Il Medioevo degli orizzonti aperti. Atti della Giornata di studio per Roberto S. Lopez. Genova 9 luglio 1987, Genova 1989 (alle pp. 7-22 un nota biografica e una bibliografia degli scritti curate dal fratello Guido); A. Varsori, R. L.: l’impegno politico e civile (1938-1945), con contributi di S. Gerbi - C.A. Kirschen Lopez - G. Cherubini, Firenze 1990; D. Romagnoli, Il medioevo: uno stato d’animo? Riflessioni sull’opera di Roberto Sabatino Lopez, in Il mestiere di storico del medioevo, a cura di F. Lepori - F. Santi, Spoleto 1994, pp. 39-71; E. Grendi, Storia di una storia locale. L’esperienza ligure 1792-1992, Venezia 1996; The Renaissance. Italy and Abroad, a cura di J.J. Martin, London - New York 2003 (introduzione); P. Guglielmotti, La scoperta dei notai liguri negli studi medievistici tra Otto e Novecento, in Agli inizi della storiografia medievistica in Italia, a cura di R. Delle Donne (Reti Medievali E-Book, in corso di pubblicazione).
Fotografia: Centro italiano di studi sull'alto medioevo.