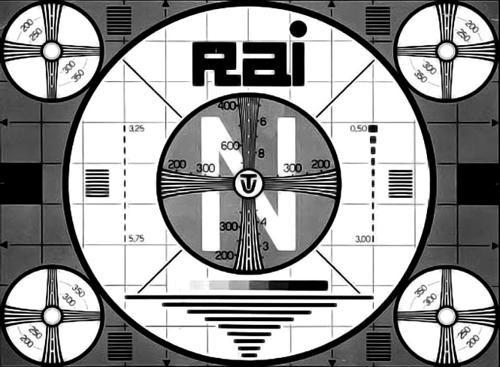Sessant'anni davanti alla tivù
Sessant’anni davanti alla tivù
Era il 1954 quando la televisione italiana iniziò le sue trasmissioni regolari: programmi pedagogici, dal professor Cutolo a padre Mariano, teatro in diretta e informazione essenziale. Solo nel 1961 nascerà il secondo canale ed Ettore Bernabei imporrà un modello più vicino al cinema.
Preceduta nel giorno di Capodanno da un discorso papale che metteva in guardia gli italiani dalle minacce alla morale derivanti dalla possibile penetrazione nelle case delle turpitudini di cui si stava macchiando il cinema, la televisione cominciò le sue trasmissioni regolari in Italia il 3 gennaio 1954. Le sperimentazioni, in verità, erano cominciate parecchio tempo prima: già nel 1938 da Roma Monte Mario, per poi riprendere nel 1952-53 in particolare a Torino e Milano.
Comunque, più che del cinema, la televisione italiana era figlia della radio: perché nasceva nell’ambito dell’azienda monopolista, la RAI, che da Radio italiana diventava Radiotelevisione italiana; perché a tenerla lontana dall’influenza del grande schermo vegliava una classe dirigente in prevalenza cattolica; e perché del medium era in effetti la prosecuzione con le immagini. Dalla radio derivava l’organizzazione dei programmi (il famoso ‘palinsesto’) e anche alcuni generi-guida: il giornale che fu a lungo soprattutto parlato, gli sceneggiati, le commedie, i quiz, le trasmissioni di ‘dialogo’ con gli ascoltatori, che erano in realtà conversazioni a una voce sola, dal professor Cutolo a padre Mariano, in risposta a quesiti arrivati per posta. Il telefono sarebbe arrivato alla radio solo nel 1969, e ancora dopo alla televisione.
Ma nonostante la continuità con la radio e il conservatorismo dei suoi primi dirigenti, la televisione venne subito percepita come una delle maggiori novità di un paese che proprio in quegli anni conosceva (anche con il passaggio in pochi anni dalla prevalenza dell’agricoltura a quella dell’industria in termini di occupazione, e con le connesse migrazioni interne) una trasformazione profonda. Non a caso venne riconosciuta a lungo come il medium ‘americano’ per eccellenza: dagli Stati Uniti arrivavano molti di quelli che allora non si chiamavano ancora format, i telefilm per bambini e adulti, e perfino il primo vero divo televisivo, un italoamericano dal cognome italiano e dal nome in un inglese confidenziale, Mike. Lo stesso che avrebbe poi tenuto a battesimo, un quarto di secolo dopo, la nuova avventura della tv, per la quale si sarebbe di nuovo parlato di ‘modello americano’: le reti private nazionali.
La memoria, tanto più quella che si fa senso comune, ha spesso un effetto non solo selettivo ma anche deformante. L’immagine diffusa oggi dei primi anni della televisione italiana ci racconta di una comunicazione sobria e nella sua povertà di mezzi piuttosto elegante, di un medium che aveva come primo scopo l’educazione degli italiani. In questa rappresentazione confluiscono insieme le trasmissioni pomeridiane di alfabetizzazione e gli sceneggiati della domenica sera tratti da romanzi ottocenteschi, la presunta funzione pedagogica dei quiz, che venivano invece liquidati allora da molti intellettuali come ‘cultura da settimana enigmistica’, e la presenza (in trasmissioni quasi mai molto seguite) di poeti e pittori. Questa immagine selettiva e idealizzata dimentica le tante banalità e improvvisazioni sparse lungo una programmazione pur limitata dapprima a poche ore. La televisione dei primi anni, se non era il ‘frigorifero del cervello’ deprecato dalla propaganda comunista, neppure era quella sorta di grande, e perduta, educatrice popolare che viene spesso evocata.
Del resto della televisione di quei tempi è facile distorcere il ricordo: ben poco ne è rimasto. Solo all’inizio degli anni Sessanta, con l’arrivo in Italia dei primi e costosi apparecchi per la videoregistrazione, sarebbe diventato normale archiviare e conservare i programmi più rilevanti (ma tanti, nonostante l’eccellente lavoro del sistema archivistico RAI che è parte delle Teche, sono andati comunque perduti). Prima si andava quasi sempre in diretta, e pochissimo veniva conservato per mezzo di una complessa apparecchiatura di archiviazione su pellicola chiamata vidigrafo.
Nel 1961-62 sarebbe cominciata la seconda tappa della storia della televisione nel nostro paese: con la nascita di un secondo canale arrivava una possibilità di scelta che prima non esisteva (ma non una concorrenza, il palinsesto di entrambi i programmi era pensato da un’unica direzione), e il numero delle famiglie in possesso di un televisore superò la metà del totale.
E arrivò alla direzione della RAI Ettore Bernabei, che modificò in profondità l’azienda, anche avvalendosi della pellicola e del videoregistratore, e stabilendo così un modello produttivo che si allontanava dal teatro e dalla diretta radiofonica e si avvicinava al cinema.
La fase bernabeiana sarebbe durata fino, di fatto, alla sconfitta del suo partito nel referendum sul divorzio (1974). Negli anni seguenti scomparivano il monopolio e il bianco e nero; la televisione rimaneva sempre lo stesso mezzo di comunicazione, abitudinario e domestico, eppure cambiava pelle, con la sua offerta smisurata 24 ore su 24, con l’apertura a un dialogo diretto (a volte sguaiato) con il pubblico, con la caduta di alcune barriere linguistiche e con il luccichio dei suoi nuovi colori.
Oggi resta di gran lunga il mezzo di comunicazione più seguito dagli italiani, quello che i più continuano a identificare con la casa, quello a cui i leader politici maggiormente si affidano per raccogliere consensi, anche quando a parole la dichiarano morta o moribonda.
Maestra RAI
di Giovanni Riva Berni
La vocazione culturale e pedagogica della neonata RAI tv si evince già dal palinsesto della prima giornata di trasmissioni: alle ore 21,45 l’unico canale trasmise la commedia di Carlo Goldoni L’osteria della posta. Un’emissione che si rivolgeva a un paese in cui l’apparecchio televisivo era ancora retaggio di pochi, in cui il 13% della popolazione era ancora analfabeta e solo un quinto parlava un italiano corretto. La televisione intesa come strumento di educazione e formazione di una unica lingua nazionale, oltre che con il teatro e la proposizione dei grandi classici della letteratura sotto forma di sceneggiati a puntate, trovò la sua massima espressione in Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per il recupero dell’adulto analfabeta: un programma organizzato con il contributo del Ministero della Pubblica istruzione, condotto dal maestro e pedagogo Alberto Manzi (1924-1997) che per 484 puntate dal 1960 al 1968 insegnò agli adulti analfabeti a leggere e a scrivere. Si stima che quasi un milione e mezzo di adulti ottenne la licenza elementare grazie a questo maestro che con l’uso di filmati e disegni a carboncino da lui stesso realizzati, divenne una delle figure più amate della nascente televisione. Un altro progetto simile, Telescuola, andò in onda dal 1958 al 1966 e si rivolgeva a scolari residenti in zone prive delle scuole secondarie per permettere loro di terminare il ciclo di istruzione. L’ultima trasmissione di Manzi fu Impariamo insieme. L’italiano per gli extracomunitari nel 1992. Proprio nel febbraio 2014 la RAI ha reso omaggio al maestro Manzi con una fiction sulla sua vita interpretata da Claudio Santamaria, dal titolo, scontato, Non è mai troppo tardi.
Sigle storiche
- Apertura: Finale del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini (1792-1868)
- Chiusura dal 1954 al 1985: Armonie del pianeta Saturno di Roberto Lupi (1908-1971)
- Intervallo: Toccata da Le sonate di gravicembalo di Pietro Domenico Paradisi (1707-1791)
- Eurovisione dal 1965 al 2007: Rielaborazione del preludio del Te Deum di Marc-Antoine Charpentier (1634 ca.-1704)
- Carosello: I menestrelli di Raffaele Gervasio (1910-1994); fu riadattata nel 1962 e arrangiata nel 1974 da Marcello De Martino
- Almanacco del giorno dopo: Chanson Baladée di Antonino Riccardo Luciani (n. 1931), ispirato a una melodia di Guillaume de Machaut (1300 ca.-1377)
Il palinsesto del 3 gennaio 1954
- ore 11: telecronaca diretta della cerimonia di inaugurazione degli studi televisivi, a cura di Fulvia Colombo da Milano e Nicoletta Orsomando da Roma;
- 14,30: Arrivi e partenze. Prima trasmissione regolare della televisione italiana a cadenza settimanale: Armando Pizzo e Mike Bongiorno hanno il compito di fermare i personaggi noti tra un volo e l’altro e di far loro qualche domanda; la regia è di Antonello Falqui;
- 14,45: cortometraggio;
- 15: Orchestra delle quindici (musica leggera);
- 15,45: Pomeriggio sportivo (ripresa in diretta di un avvenimento);
- 17,30: Le miserie del signor Travet (film con la regia di Mario Soldati);
- 19: Le avventure dell’arte: Giambattista Tiepolo, a cura di Antonio Morassi. È il primo programma culturale della storia della tv italiana;
- 20,45: Telegiornale, cura di Riccardo Paladini;
- 21,15: Teleclub (curiosità culturali presentate da note personalità);
- 21,45: L’osteria della posta di Carlo Goldoni (regia di Franco Enriquez, in diretta);
- 22,45: Settenote (programma di musica leggera presentato da Virgilio Riento);
- 23,15: La domenica sportiva, a cura di Aldo De Martino. Risultati, cronache filmate e commenti sui principali avvenimenti della giornata.