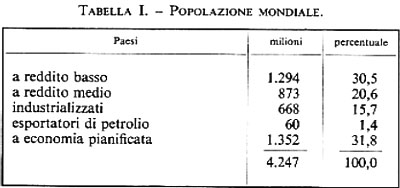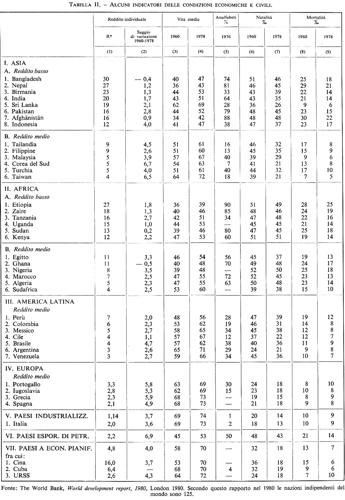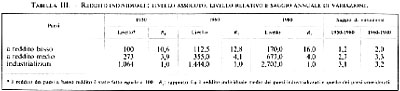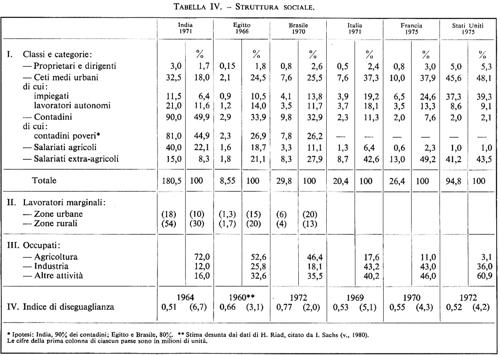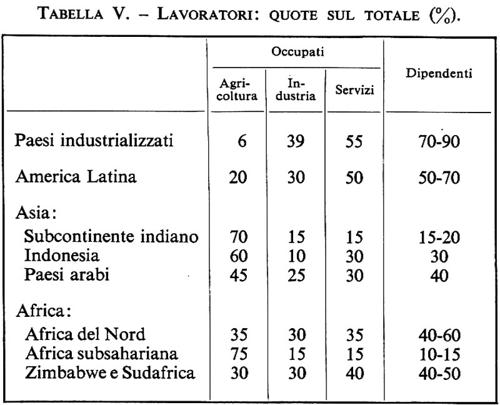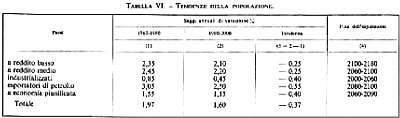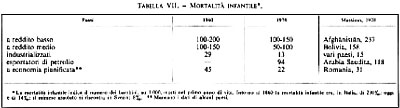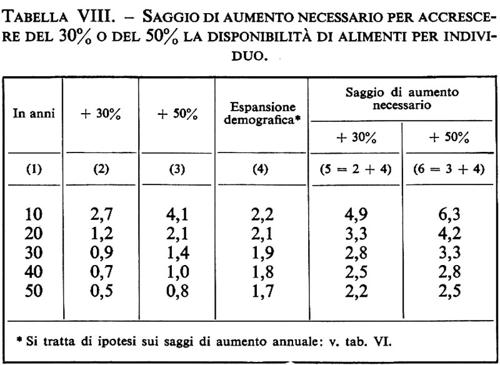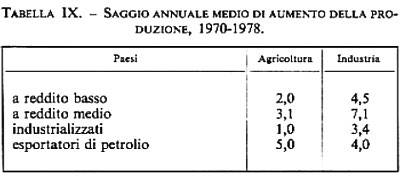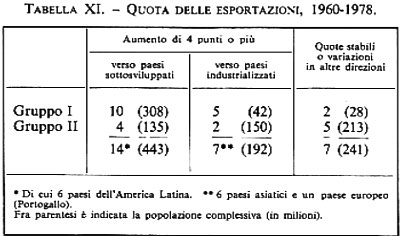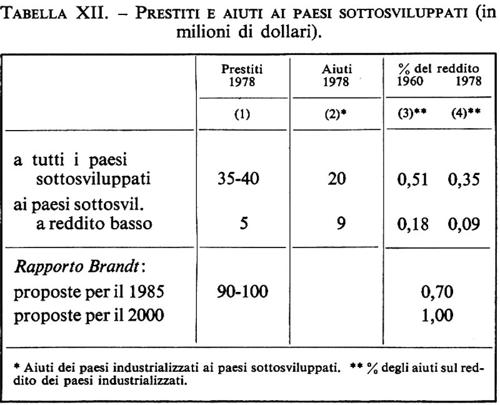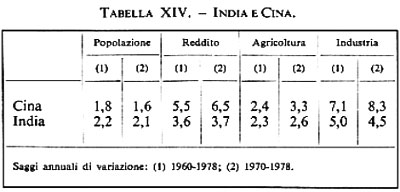Sottosviluppo
Sottosviluppo
di Paolo Sylos-Labini
Sottosviluppo
sommario: 1. Lo sviluppo economico: storia e teoria. 2. Il processo di colonizzazione. 3. Colonie di sfruttamento e colonie di popolamento. 4. Misure del sottosviluppo. 5. I paesi sottosviluppati nei diversi continenti. 6. Le strutture sociali. 7. Alcune ragioni della varietà nei saggi di sviluppo. 8. L'agricoltura. 9. Il problema della fame e la politica demografica. 10. Lo sviluppo industriale. 11. Le imprese multinazionali. 12. Commercio estero e progresso tecnico. 13. Le politiche di sviluppo. 14. Conflitti interni e conflitti internazionali. 15. Gli obiettivi dello sviluppo e le prospettive economiche. 16. Riforme e rivoluzione. □ Bibliografia.
Non s'intende svolgere un'esposizione sistematica, ma solo fornire qualche ragguaglio sul problema del sottosviluppo e prospettare, in modo ordinato, alcuni temi di riflessione. In particolare, il proposito è di mettere in chiaro l'ampiezza e la complessità del problema, che a rigore richiederebbe il lavoro congiunto di studiosi appartenenti a differenti discipline: non solo l'economia, ma anche la storia (specialmente la storia economica), l'antropologia, la demografia, la sociologia, la politologia, il diritto. Un'analisi elaborata da chi coltiva una sola di queste discipline non può che essere molto parziale.
1. Lo sviluppo economico: storia e teoria
I processi di sviluppo sono molteplici e hanno carattere storico. Pertanto, le possibilità di teorizzare, ossia di generalizzare, alcuni aspetti essenziali di siffatti processi sono inevitabilmente limitate. Ciononostante, conviene compiere tentativi in questa direzione, poiché le alternative si presentano come meno efficaci e più costose dal punto di vista interpretativo. In via preliminare, conviene distinguere diversi ‛stadi' nell'evoluzione economica delle società. Accogliendo i suggerimenti di Adam Smith, possiamo distinguere tre stadi primitivi, durante i quali non c'è ancora la proprietà privata della terra: caccia e pesca, pastorizia e agricoltura di sussistenza; a questi tre stadi occorre aggiungere, almeno nel caso dell'Europa (Grecia e Roma), lo stadio dell'economia fondata sul lavoro degli schiavi. Seguendo i suggerimenti dello stesso Smith e sulla scorta dell'analisi di Karl Marx, nell'epoca moderna distinguiamo tre stadi ulteriori: agricoltura feudale, capitalismo mercantile e capitalismo industriale. Naturalmente, fra i diversi stadi non vi sono mai confini netti e non di rado coesistono attività economiche e strutture sociali proprie di stadi diversi, anche se in una data epoca e in un dato paese tendono a prevalere un certo tipo di attività economica e un certo tipo di struttura sociale. Sebbene periodi di espansione produttiva abbiano avuto luogo presumibilmente in tutte le società anche negli stadi non recenti, sulla base di sporadiche innovazioni, è solo durante lo stadio del capitalismo industriale, là dove si afferma, che lo sviluppo diventa, pur tra fluttuazioni, un processo sistematico che ha assunto forme diverse nei diversi paesi capitalistici e forme particolarissime nei casi, recenti da un punto di vista storico, dei paesi a economia pianificata.
Ben poco si può comprendere dei paesi oggi ‛sottosviluppati' o ‛arretrati' senza una qualche nozione di storia economica con particolare riguardo alla colonizzazione che ebbe luogo durante gli ultimi due stadi sopra richiamati, e cioè lo stadio del capitalismo mercantile e quello del capitalismo industriale (v. colonialismo; imperialismo).
2. Il processo di colonizzazione
Il processo di colonizzazione è molto antico e ha assunto contenuti diversi nelle diverse epoche storiche.
Adam Smith osserva che la colonizzazione greca e quella romana differiscono fra loro e differiscono ancora più profondamente dalla colonizzazione dell'età moderna, che segue le grandi scoperte geografiche compiute da Vasco da Gama e da Cristoforo Colombo. Smith attribuisce un'importanza capitale alle scoperte geografiche e agli effetti che ne sono derivati. A questo proposito conviene riportare un passo dello stesso Smith, ove si trovano osservazioni quasi profetiche che indicano la straordinaria capacità di sintesi storica del padre della teoria economica moderna.
‟La scoperta dell'America e quella del passaggio del Capo di Buona Speranza per le Indie Orientali sono i due più grandi e importanti avvenimenti ricordati nella storia dell'umanità. Le loro conseguenze sono già state molto grandi; ma, nel breve periodo dei due o tre secoli che sono trascorsi da queste scoperte, e impossibile che si sia potuta vedere tutta l'importanza delle loro conseguenze. Nessuna sapienza umana può prevedere quali benefici, o quali sventure, possano in futuro derivare all'umanità da questi grandi avvenimenti. Unendo in qualche modo le parti più lontane del mondo, permettendo loro di soddisfare reciprocamente i loro bisogni reciproci, di aumentare reaprocamente le loro soddisfazioni e di incoraggiare reciprocamente le loro attività produttive, la loro tendenza generale sembrerebbe essere benefica. Tuttavia, per gli indigeni delle Indie Orientali e Occidentali, tutti i vantaggi commerciali che possono essere derivati da questi avvenimenti sono stati sommersi e perduti per le terribili sventure che essi hanno provocato. Sembra però che queste sventure siano derivate da cause accidentali piuttosto che da qualcosa che fosse nella natura di quegli stessi avvenimenti. Al tempo in cui vennero compiute queste scoperte, la superiorità di forze risultava essere così grande a vantaggio degli Europei, che essi poterono commettere impunemente ogni tipo di ingiustizia in quei paesi lontani. In futuro, forse, gli indigeni di quei paesi potranno diventare più forti, oppure gli Europei potranno diventare più deboli e gli abitanti di tutte le varie parti del mondo potranno forse pervenire a quell'uguaglianza di coraggio e di forze che, ispirando loro un timore reciproco, può sola trattenere l'ingiustizia delle nazioni indipendenti inducendole a rispettare in qualche misura i loro diritti reciproci" (v. Smith, 1776; tr. it., vol. II, p. 618).
Da un lato, dunque, Smith mette in rilievo i benefici, dall'altro, le ‟terribili sventure" provocate da quelle scoperte e le ‟ingiustizie" che gli Europei hanno potuto compiere nei paesi del Nuovo Mondo, grazie alla superiorità delle loro forze. Naturalmente, la sua analisi è centrata sulla colonizzazione nello stadio del capitalismo mercantile, dal momento che ai suoi tempi il capitalismo industriale era ancora di là da venire. In termini schematici si può dire che il primo processo, che si svolge dal Cinquecento al principio dell'Ottocento, è reso possibile da importanti innovazioni nel campo della navigazione ed è determinato da un triplice obiettivo: ricerca di oro e di altri metalli preziosi; costituzione di ‛empori', per la vendita di merci della madrepatria e per l'acquisto, in condizioni di monopolio assoluto, di merci esotiche da rivendere nel paese colonizzatore; costituzione di piantagioni per produrre (di solito per mezzo di schiavi) merci da vendere poi nella madrepatria: zucchero, caffè, tabacco, cacao. Per mantenere il controllo delle colonie di sfruttamento e delle città-emporio, vengono irrobustite le flotte da guerra e sono costituite colonie e roccheforti con fini essenzialmente strategico-militari.
Le specifiche e diverse motivazioni di questa fase corrispondono alle caratteristiche del sistema sociale delle più forti società organizzate del tempo (in un primo momento, fra il Cinquecento e il Seicento, Portogallo e Spagna; quindi anche Olanda, Francia e Inghilterra). Si tratta di sistemi con una struttura portante ancora di tipo feudale, ma nei quali si vanno rafforzando i ceti mercantili, che - in una con i più alti funzionari e amministratori dei principi o monarchi - trovano proprio fuori della patria d'origine i modi più rapidi per arricchirsi e quindi per salire socialmente. L'arricchimento, in quel periodo, avviene soprattutto attraverso il commercio, e specialmente attraverso il commercio di prodotti esotici e di pietre preziose. L'esigenza di sostenere lo sviluppo dei traffici con una crescente quantità di moneta - che in quel tempo era costituita prevalentemente da oro e da argento - spiega la grande attrazione esercitata sui mercanti, sugli avventurieri e sui monarchi dai nuovi giacimenti di metalli preziosi.
In questo primo periodo, gli strumenti che formalizzano giuridicamente la colonizzazione sono gli Atti di navigazione - particolari leggi che attribuiscono il monopolio assoluto dei traffici con determinati paesi dominati (colonie) a determinati paesi dominanti e, a questo fine, stabiliscono regole rigorose ed esclusive sui modi e sui mezzi di comunicazione marittima. Gli strumenti organizzativi e integrativi di tali norme sono le compagnie commerciali, composte da mercanti e da funzionari, alle quali il monarca attribuisce l'esercizio monopolistico dei traffici con le colonie. Certe nazioni, invece di dare il monopolio a una compagnia, concentrano tutto il commercio delle loro colonie in un determinato porto della madrepatria. Adam Smith, pur riconoscendo, a malincuore, una funzione storica agli Atti di navigazione e ai monopoli delle compagnie commerciali, li considera, per il suo tempo, sorpassati e deleteri; egli è favorevole, nell'interesse stesso dei paesi dominanti, al libero scambio tra le colonie e tutti i paesi.
Fra i paesi dominanti di questo periodo occorre distinguere, da un lato, i paesi iberici, Spagna e Portogallo, e dall'altro, Francia e Inghilterra; il sistema sociale in entrambi i casi è misto (feudale e mercantile nello stesso tempo), ma nel primo caso prevalgono le caratteristiche feudali, nel secondo quelle capitalistico-mercantili. Il Portogallo, quindi, e ancor di più la Spagna, ‛esportano' nelle colonie istituti tipicamente feudali, specialmente in quelle che diventano colonie di popolamento (così per l'assegnazione di terre in molti paesi dell'America Latina è usata l'encomienda, forma di concessione che conferisce al funzionario o al mercante che ne beneficia una giurisdizione completa, di tipo appunto feudale, su uomini e cose a lui assegnati). Gli istituti esportati dalla Francia e dall'Inghilterra nelle colonie hanno invece caratteristiche meno feudali e molto più capitalistiche. Inoltre, in Inghilterra le lotte religiose portano a un'emigrazione verso le colonie del Nuovo Mondo di persone che, per la maggior parte, all'atto della partenza non sono nè mercanti nè funzionari nè puri e semplici avventuneri e che tendono a costituire comunità libere, strutturate con istituti autonomi e non creati strumentalmente in funzione coloniale. Anche l'azione di questi coloni verso gli indigeni è spietata: essi vengono relegati in terre poco accessibili e poco fertili o addirittura sterminati. Tuttavia, gli sviluppi delle colonie di popolamento sono ben diversi da quelli delle colonie di puro sfruttamento o delle colonie di popolamento con forme organizzative di tipo feudale.
Nel periodo del capitalismo industriale moderno (dal principio dell'Ottocento in poi) le motivazioni specifiche delle colonizzazioni cambiano e cresce il loro numero: accanto alle motivazioni essenzialmente commerciali (fra cui diventa molto più rilevante la ricerca di sbocchi per i prodotti della madrepatria), compare o si rafforza la ricerca di materie prime per l'industria della madrepatria (minerali, cotone, prodotti alimentari). Con lo sviluppo dei moderni imperi - segnatamente quello inglese e quello francese - si fanno più numerosi e più importanti i casi di colonie o di zone coloniali conquistate e mantenute per ragioni strategico-militari, e in particolare per rafforzare il controllo della madrepatria sui grandi imperi coloniali.
Le più violente lotte coloniali del nostro tempo si svolgono dal 1870 in poi e culminano con la prima guerra mondiale che ha, fra le sue molteplici motivazioni, anche quella di procedere a una nuova spartizione delle colonie. Appartengono a questo periodo (1876-1918) una prima e poi una seconda spartizione dell'Africa. In questi anni si afferma anche il colonialismo della Germania, poi stroncato dall'esito della prima guerra mondiale. La Russia zarista (ove tuttavia il capitalismo industriale ha uno sviluppo tardivo e limitato) realizza le sue conquiste coloniali verso l'Oriente, e in Estremo Oriente si afferma il colonialismo del Giappone, ove, a partire dall'ultimo quarto del secolo scorso, comincia a delinearsi un rapido sviluppo di tipo industriale. Anche l'Italia tenta di inserirsi - con successi molto modesti - nella spartizione coloniale dell'Africa e nella conquista di punti coloniali in Cina, le cui coste sono però largamente dominate dai maggiori paesi imperialistici (Inghilterra, Francia, Giappone).
Fra le molteplici motivazioni della seconda guerra mondiale non mancano quelle connesse alla politica imperialistica e coloniale, ma il loro peso non è determinante nello scoppio del conflitto. Dalla fine di questa guerra si mette in moto un generale processo di decolonizzazione: molti paesi acquistano così, almeno formalmente, la loro indipendenza politica. Ciononostante, almeno in un primo periodo, il dominio delle potenze coloniali continua a farsi sentire e, malgrado i rapidi cambiamenti, la tremenda eredità del passato pesa sui paesi di recente indipendenza politica, come pesa tuttora sui paesi che questa indipendenza politica hanno ottenuto molto tempo fa: è questo il caso, per es., di molti paesi dell'America Latina.
Quelli che oggi vengono definiti paesi sottosviluppati o arretrati sono di regola paesi che in un tempo più o meno recente sono stati, in una forma o nell'altra, paesi coloniali: le eccezioni a questa regola, come la Turchia e l'Iran, sono più apparenti che reali. Alcuni paesi un tempo coloniali, come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda, hanno conquistato in epoca lontana la loro autonomia totale o parziale, e oggi sono anzi fra i paesi economicamente più progrediti. Si tratta però, come si è già accennato, di paesi che erano già in origine colonie di tipo speciale: colonie di popolamento, e inoltre con particolari caratteristiche e particolari istituti ‛importati' dai coloni.
3. Colonie di sfruttamento e colonie di popolamento
Le colonie di sfruttamento si affermarono particolarmente nelle zone equatoriali e tropicali: il clima rendeva difficile l'insediamento dei bianchi, i quali, dopo aver conquistato quelle terre, si limitavano a promuovere il commercio e la produzione agricola o mineraria con l'impiego di schiavi o di salariati.
Nelle colonie africane gli indigeni stessi furono trasformati in schiavi o costretti a lavorare come salariati; nelle colonie spagnole e portoghesi e, in seguito, nelle colonie inglesi delle zone tropicali del continente americano furono invece portati come schiavi milioni di uomini catturati in Africa, poiché gli indigeni di quelle zone si erano dimostrati inadatti al lavoro nelle piantagioni e nelle miniere. Per disporre delle terre possedute dagli indigeni e trasformarle in piantagioni o in miniere o anche (in certe regioni) in aziende agricole condotte dai coloni bianchi, sono stati perpetrati veri e propri genocidi, particolarmente in Brasile, in certe colonie spagnole e in due paesi che originariamente sono stati colonie di popolamento, Stati Uniti e Canada. Quanto al commercio degli schiavi, occorre osservare che, analogamente alla colonizzazione, anche la schiavitù dell'epoca moderna differisce in modo sostanziale da quella dell'epoca antica. Il commercio degli schiavi è stato attuato soprattutto da mussulmani, Portoghesi (nel Cinquecento Lisbona fu il maggior centro europeo di questo commercio), Spagnoli, Inglesi (Liverpool divenne un centro importante nel Settecento) e Olandesi.
Durante il periodo del capitalismo industriale nelle colonie di sfruttamento la situazione generale subisce profondi mutamenti: la schiavitù viene abolita e cambia il peso relativo delle diverse merci; tuttavia permangono, rispetto allo stadio precedente, alcune caratteristiche fondamentali. È bene tener presente che nel capitalismo mercantile la regola generale è ‛comprare a basso prezzo e vender caro'; in siffatte condizioni i mezzi di trasporto, per mare e per terra, e l'organizzazione di porti e di depositi hanno svolto una funzione essenziale. Nel capitalismo mercantile i profitti, nel medio e nel lungo periodo e nell'aggregato, sono relativamente stabili nel tempo, in quanto fondati su monopoli, garantiti dal potere politico, di determinati traffici, ovvero sul possesso di determinate terre e sul controllo pieno e diretto dei lavoratori che in esse lavorano. Il protagonista di questo sistema economico-sociale non entra nella produzione: al massimo la attua, con tecniche sostanzialmente invariate, attraverso lavoro coatto. Viceversa, nel capitalismo industriale i profitti non sono fondati su monopoli o su privilegi, ma debbono essere ottenuti in mercati aperti: tali sono, nel nuovo stadio, sia i mercati dei prodotti sia il mercato del lavoro; i profitti tendono a diminuire e possono essere via via ricostituiti, a condizione che il capitalista industriale rinnovi pressoché incessantemente i metodi produttivi per ridurre i costi, se i prezzi diminuiscono, o per neutralizzare i crescenti costi del lavoro se, a parità di prezzi, aumentano i salari.
Per quanto si è detto, nel capitalismo mercantile la produzione è, per sua natura, stazionaria: cresce solo se crescono, per fatti esterni, la domanda e i traffici. Forse perciò il capitalismo mercantile si afferma, in quanto sistema sociale, in simbiosi col feudalesimo, un sistema che per sua natura è stazionario dal punto di vista economico, dato che i signori feudali rifuggono dalle intraprese produttive. Spagna e Portogallo hanno appunto ‛esportato' nelle loro colonie un tale sistema misto. Nel capitalismo industriale, invece, la produzione tende a crescere per motivi interni allo stesso sistema. Pertanto, come aveva esattamente previsto Adam Smith, i privilegi commerciali, da un lato, e il lavoro coatto, dall'altro, mentre sono vantaggiosi per i privati che ne godono, non lo sono per la società nel suo complesso, poiché non promuovono l'espansione della ricchezza delle nazioni: profitti alti e relativamente sicuri non stimolano i cambiamenti creativi. Questo è un punto concettualmente di grande importanza per comprendere la logica dello sviluppo o del mancato sviluppo.
Alcune caratteristiche del capitalismo mercantile sopravvivono anche nell'epoca del capitalismo industriale, nelle piantagioni e nelle miniere dei paesi di tipo coloniale. Questo è vero anche nel Sud degli Stati Uniti, dove la schiavitù viene abolita molto tardi, dopo la guerra civile.
Nelle colonie di popolamento, diversamente da quanto accade nelle altre, in un primo tempo si afferma un sistema caratterizzato dalla prevalenza di numerosi piccoli produttori indipendenti: è un sistema a sé, che non è propriamente né feudale nè capitalistico. In un secondo tempo si afferma un capitalismo di tipo industriale, che anzi si sviluppa con un ritmo particolarmente rapido per ragioni connesse al mercato del lavoro, come si vedrà oltre (v. cap. 7), e per ragioni che si possono definire culturali in senso lato. In effetti nel Nordamerica i coloni sviluppano direttamente l'attività economica - senza schiavi e senza altri lavoratori coatti - e portano con sé la loro cultura: la conoscenza delle tecnologie agricole e artigianali (quelle propriamente industriali sono ancora di là da venire), la cultura istituzionale, legislativa e amministrativa. La cultura - un concetto che tende a coincidere con quello di civiltà - in ultima analisi è la causa profonda dello sviluppo economico e civile di una data collettività; uno sviluppo, tuttavia, che può essere portato avanti con mezzi aggressivi e non solo con mezzi pacifici. Infatti, intesa in senso ampio, la cultura include la conoscenza - e la capacità di far progredire la conoscenza - non solo delle arti e delle tecnologie per la produzione e per i trasporti, ma anche delle tecnologie militari.
Queste osservazioni sono da tener presenti anche quando si voglia spiegare l'evoluzione molto differenziata di zone un tempo colonie di uno stesso paese dominante: all'origine non troviamo solo diverse condizioni di clima e di risorse; troviamo anche - ciò che più conta - flussi migratori di persone fornite di culture più o meno evolute. Se da tali osservazioni si volessero ricavare illazioni di tipo razzista, si darebbe prova di grave superficialità. La diversità nei gradi di sviluppo culturale, oltre che economico e civile, delle diverse popolazioni, è innegabile: alcune culture sono incomparabilmente più complesse di altre. Ma un'interpretazione razzista di un tale stato di cose riferisce questi diversi gradi di sviluppo a differenze biologiche, innate e permanenti, mai dimostrate, mentre un'interpretazione non razzista li attribuisce a motivi storici: e ciò che la storia porta con sé, la storia stessa, nel tempo, tende a dissolvere o a cambiare.
Il problema storico per eccellenza diviene allora: perché alcune popolazioni si sono sviluppate prima di altre? E qual è la ragione ultima della superiorità tecnologica della cultura europea sulle altre per un lungo periodo storico? La caratteristica peculiare della cultura europea sembra consistere nel fatto che, insieme col pensiero speculativo e morale, essa abbraccia i sistemi generali dell'organizzazione sociale, fra cui, in primo luogo, il sistema giuridico; tali sistemi si sviluppano soprattutto nell'epoca romana, si rinnovano poi e si articolano nel periodo feudale e si rivelano talmente vitali da risultare utilizzabili nei tempi, nei sistemi sociali e nei paesi più diversi. Dallo sviluppo dei sistemi giuridici dell'organizzazione sociale si passa poi, attraverso un'evoluzione che vede il declino di certe classi e lo sviluppo di altre, allo sviluppo delle forme moderne dell'organizzazione economica e all'applicazione sistematica delle scoperte scientifiche alla produzione di merci e di armi e ai mezzi di trasporto.
Comunque sia, il problema del sottosviluppo economico non può quindi essere spiegato nell'ambito puramente economico: dev'essere posto sul piano più ampio dell'evoluzione culturale.
4. Misure del sottosviluppo
Nonostante l'insufficienza di attendibili dati statistici, gli storici economici e gli economisti sono concordi nel ritenere che nel passato le distanze economiche fra i diversi paesi del mondo fossero sensibilmente inferiori alle distanze osservabili oggi: cento anni fa il reddito individuale medio - è questo il termine di riferimento più usato per misurare la distanza economica fra i diversi paesi - poteva essere da un terzo a un sesto inferiore in Asia e in Africa rispetto a quello dei paesi più sviluppati dell'Europa e dell'America; oggi invece tale rapporto è assai più sfavorevole. In ogni caso tuttavia, come appare dalle cifre ora ricordate, i redditi individuali dei paesi oggi sviluppati erano nettamente maggiori di quelli degli altri già nella fase preindustriale: lo sviluppo dell'industria ha fortemente aggravato il divario precedente. Inoltre, la distanza che si può definire culturale - almeno della cultura idonea a promuovere un processo di sviluppo - era anche maggiore del divario fra i redditi. (Solo certi aspetti particolari della distanza culturale sono misurabili: il grado d'istruzione, l'organizzazione sanitaria e lo stato di salute).
Dunque, la distanza economica fra i paesi oggi sviluppati e i paesi sottosviluppati, già sensibile cento anni fa, è andata in seguito ulteriormente crescendo. Tuttavia, la misura generalmente usata per calcolare questa differenza (il reddito individuale), se non viene corretta, risulta ingannevole, poiché induce a credere che la distanza sia molto maggiore di quanto non è in realtà; questa osservazione risulta valida anche indipendentemente dalla produzione destinata all'autoconsumo, che nei paesi più poveri raggiunge dimensioni cospicue.
Per confrontare il reddito individuale di un paese sottosviluppato con quello di un paese sviluppato si procede di solito nel modo seguente: si assume come termine di confronto il reddito individuale degli Stati Uniti e si traduce in dollari il reddito del paese considerato, in modo da ottenere redditi monetari omogenei; per compiere questa traduzione, si usa il tasso di cambio. Ma il cambio esprime il rapporto dei poteri d'acquisto di due unità monetarie in termini delle merci che sono oggetto di commercio internazionale e proprio qui è l'origine dell'errore per il confronto che si intende compiere. Infatti, a noi interessa il confronto fra i poteri d'acquisto che vanno attribuiti ai redditi individuali medi di due o più paesi (salvo poi a considerare separatamente la distribuzione del reddito complessivo), e a questo scopo l'uso del tasso di cambio risulta ingannevole per due motivi: 1) perché al fine indicato sono rilevanti i prezzi al minuto e non quelli all'ingrosso; 2) perché nel reddito individuale medio non entrano solo le merci (tutte le merci consumabili) ma anche i servizi. La questione riveste grande importanza, non solo dal punto di vista dell'analisi economica, ma anche, come vedremo, sotto l'aspetto della politica economica e anzi della politica in generale (v. cap. 16): è quindi opportuno chiarire le ragioni di quanto si è detto.
Supponiamo che il salario per un giorno di lavoro comune sia in India pari a una rupia e, negli Stati Uniti, pari a un dollaro. Se ci fosse completa mobilità di lavoratori fra i due paesi, il cambio dovrebbe essere 1 : 1. Se invece possono spostarsi solo le merci e non i lavoratori (salvo casi sporadici) e se negli Stati Uniti la produttività, nel settore delle merci , è dieci volte maggiore che in India, la merce costa 1 giorno di lavoro nel primo paese e 10 giorni nel secondo, cosicché negli Stati Uniti il prezzo di una data merce è di 1 dollaro e in India di 10 rupie. Dunque, se sono trasferibili solo le merci, il cambio è 1 : 10. Il cambio effettivo tende appunto a livellarsi su questo valore, non sull'altro. Se però il reddito indiano, misurato in rupie, è composto per il 70% di merci e per il 30% di servizi, il cambio, che dipende solo dal rapporto fra i prezzi delle merci, tenderà a sottovalutare il potere d'acquisto interno del reddito monetario indiano rispetto all'incidenza dei servizi. Dal momento poi che le retribuzioni dei commercianti al minuto saranno, in India, simili alle retribuzioni del settore delle merci, quando non si considerano i prezzi all'ingrosso (quali sono quelli vigenti nel commercio internazionale), ma i prezzi al minuto, la sottovalutazione risulta ulteriormente aggravata, poiché i margini commerciali sono minori in India, pur tenendo conto che in questo paese l'efficienza del sistema commerciale è minore che negli Stati Uniti. Se, invece di seguire i criteri della moderna contabilità nazionale, si fosse seguito il criterio smithiano del ‟lavoro comandato" da una data merce (o delle quantità di merci ‟comandate", ossia acquistate, da una data quantità di lavoro comune), l'errore di cui parliamo sarebbe stato evitato.
Negli ultimi anni alcuni economisti, in particolare I. B. Kravis, hanno cercato di correggere il criterio di raffronto basato sul tasso di cambio. È possibile infatti individuare una norma nelle deviazioni del tasso di cambio effettivo rispetto al tasso di cambio che chiameremo ‛di conto', poiché tali deviazioni dipendono da fattori che variano in modo sistematico rispetto al grado di sviluppo (specialmente: produttività nel settore delle merci e quota dei servizi sul reddito nazionale). In effetti, Kravis e altri economisti hanno stabilito una relazione sistematica fra i due tassi di cambio.
Sempre su questa linea di ragionamento, ci è sembrato che si possa utilizzare una formula molto semplice per correggere nel senso ora chiarito il rapporto fra valore del reddito individuale degli Stati Uniti e quello di un determinato paese sottosviluppato. Se chiamiamo R questo rapporto e R* il rapporto corretto, il coefficiente di correzione è dato semplicemente da c = 4√-R, cosicché R* = R/c, dove c tende a 1 man mano che R diminuisce; in altri termini, per i paesi con un reddito vicino a quello degli Stati Uniti, il divario fra R e R* tende ad annullarsi. È bene tener presente che questa è una regola pratica e anche molto approssimativa. Ma non possono non essere approssimative anche le stime dei redditi dei diversi paesi, indipendentemente dai confronti: l'importante è che le approssimazioni non siano fuorvianti. Poiché il più alto R è quello che si riferisce al Bangladesh, il cui reddito individuale è, secondo il rapporto non corretto, 106,6 volte inferiore a quello degli Stati Uniti, il massimo R* è pari a 33,2; per illustrazione: un R pari a 10, 5 e 3 comporta un R* pari, rispettivamente, a 5,6, 3,3 e 2,3. Occorre tener presente che i redditi monetari posti a confronto comprendono quasi esclusivamente i beni e i servizi scambiati nei mercati, interni e internazionali; se si potessero includere anche i beni prodotti e consumati direttamente dalle unità familiari che operano in agricoltura, beni che nei paesi arretrati hanno una notevole rilevanza, quei rapporti diverrebbero ancora più bassi. Si deve anche avvertire che non solo il rapporto dei redditi, ma lo stesso saggio annuale di variazione deve essere corretto se, come spesso accade, le istituzioni internazionali calcolano tale saggio sui redditi monetari espressi in dollari; nel caso del saggio di variazione, tuttavia, le correzioni di norma sono di lieve entità.
Ciò premesso, conviene esaminare la tab. I, che indica il quadro della popolazione mondiale, suddivisa secondo alcune importanti categorie di paesi, e la tab. II, che indica i rapporti, corretti, fra il reddito individuale americano e quello di 41 paesi appartenenti alle categorie introdotte nella tabella precedente: paesi a reddito basso, medio e alto, paesi esportatori di petrolio e paesi a economia pianificata. Quelli considerati singolarmente nella tab. II sono i paesi a reddito basso e medio con oltre 9 milioni di abitanti; fra i paesi a reddito alto (cioè i paesi industrializzati) è stata isolata l'Italia; di quelli a economia pianificata sono stati considerati solo la Cina, l'Unione Sovietica e Cuba. Per reddito basso s'intende quello che è oltre 11 volte inferiore al reddito individuale americano; per reddito medio quello che è da 11 a 2 volte inferiore; per reddito alto quello fino a 2 volte inferiore (ma la Svezia e la Svizzera hanno un reddito individuale alquanto superiore al reddito americano). I paesi sottosviluppati in senso stretto sono quelli a reddito basso: è là che si trova la grande maggioranza delle persone che soffrono la fame. I paesi a reddito medio sono da considerare sottosviluppati in senso relativo; nei paesi a reddito medio-basso, sono rilevanti le quote di individui malnutriti e analfabeti.
Seguendo l'uso corrente, i paesi a reddito basso e medio, come anche i paesi esportatori di petrolio, verranno qui indicati anche come ‛paesi del Terzo Mondo', in contrapposizione ai paesi industrializzati e a quelli a economia pianificata. L'Italia, con un rapporto pari a 2, è al confine fra i paesi industrializzati e quelli a reddito medio: mentre l'Italia centro-settentrionale, con un rapporto di circa 1,6, rientra nettamente nella prima categoria, l'Italia meridionale, con un rapporto vicino a 3, appartiene in maniera altrettanto chiara alla fascia dei paesi a reddito medio.
Il reddito individuale è certo un utile indicatore sintetico delle condizioni economiche di un paese; ma, se preso isolatamente, è un indicatore del tutto insufficiente e, in certi casi, perfino ingannevole. È insufficiente sullo stesso piano economico in quanto - per fare solo due esempi - non dice nulla circa la distribuzione del reddito (v. cap. 6) e circa la struttura produttiva. Può essere inoltre ingannevole se lo si vuole usare anche come indicatore delle condizioni economiche di una data popolazione. Così, per esempio, il livello relativo del reddito individuale medio dei paesi esportatori di petrolio (la VI categoria include solo i grandi esportatori) e di quelli che producono comunque quantità relativamente elevate di petrolio, come la Nigeria e il Venezuela, potrebbe far pensare, considerato isolatamente, a condizioni economiche migliori della realtà. In altri casi, il reddito medio risulta ingannevole per l'esistenza di forti diseguaglianze nella distribuzione del reddito stesso, diseguaglianze dovute a fattori etnici e istituzionali, come nell'Unione Sudafricana, dove la minoranza bianca ottiene in media un reddito circa 6-7 volte maggiore di quello degli Africani, o dovute a un dualismo territoriale, come in Brasile, dove il Sud è notevolmente più sviluppato del Nord.
In generale, per ottenere un quadro relativamente attendibile delle condizioni economiche e civili di un paese il reddito individuale va integrato con altri indicatori, come ad esempio il saggio di variazione del reddito stesso, la durata media della vita, la percentuale degli analfabeti fra gli individui con più di 15 anni, i saggi di natalità e di mortalità.
Discuteremo poi, sia pure brevemente, le tendenze demografiche. Per ora osserviamo che la durata media della vita è cresciuta sensibilmente in tutti i paesi, anche se in certe parti del mondo permane a livelli molto bassi: 40-50 anni contro i 73-74 dei paesi industrializzati; si tenga presente che un secolo fa in Italia la durata media della vita era soltanto di 35 anni (oggi è di 73 anni). Anche la mortalità infantile è molto diminuita (v. tab. VII). Osserviamo inoltre che l'analfabetismo tocca ancora livelli molto alti nei paesi sottosviluppati, soprattutto in quelli a basso reddito.
Nella tab. III sono indicati i saggi medi di variazione del reddito individuale medio dal 1950 al 1980: il divario fra i paesi industrializzati e i paesi sottosviluppati, nel complesso, risulta accresciuto. Tuttavia, fra il 1960 e il 1980, il divario fra i paesi sottosviluppati a reddito medio e i paesi industrializzati è, sia pure di poco, diminuito (mentre era cresciuto nel decennio precedente); il divario fra i paesi a reddito basso e i paesi a reddito alto è invece cresciuto in entrambi i periodi. Il livello assoluto del reddito individuale dal 1950 al 1980 è però aumentato in misura sensibile (il 70%) anche nel caso dei paesi a reddito basso; inoltre nel secondo dei due periodi considerati (1960-1980) il saggio di aumento è cresciuto rispetto al decennio precedente. Su questi aspetti, strettamente economici, torneremo in seguito.
5. I paesi sottosviluppati nei diversi continenti
Il processo di sviluppo economico in senso moderno, quel processo che ha poi portato allo sviluppo industriale, è cominciato in Europa, ma non tutti i paesi europei si sono sviluppati contemporaneamente: Inghilterra, Francia e Olanda sono stati fra i primi; Italia, Irlanda, Spagna, Portogallo e Grecia fra gli ultimi. Le condizioni più favorevoli allo sviluppo del capitalismo industriale sembrano essersi determinate nei paesi in cui si erano affermati, da un lato, l'autogoverno di ampie fasce di cittadini (originariamente mercanti e borghesi) e, dall'altro, un forte e indipendente governo centrale. In ogni modo, le condizioni decisive per lo sviluppo sono sempre risultate quelle sociali e istituzionali; le condizioni di carattere economico (come, per es., alcune condizioni riscontrabili nel mercato del lavoro) e quelle di carattere naturale (come la disponibilità di determinate risorse) sono state rilevanti, ma non decisive.
Diversi storici economici, fra cui A. Gerschenkron e P. Bairoch, e diversi economisti fra cui S. Kuznets hanno posto a confronto l'evoluzione economica dei paesi sviluppatisi per primi con quella dei paesi ritardatari, pur mettendo in guardia contro affrettate analogie, e hanno ricavato da tali confronti alcuni insegnamenti. Conviene porre in rilievo due soli punti.
Anzitutto, la cosiddetta rivoluzione industriale inglese fu preceduta e poi accompagnata da una rivoluzione agraria che si svolse, in due ondate, nei secoli XVII e XVIII e si concluse nel secolo scorso; la stessa osservazione vale, con le differenze comprensibili, anche per gli altri grandi paesi europei. Diverse possono essere invece le considerazioni per i paesi più piccoli, che sono in grado di sopperire in gran parte con le importazioni ai bisogni alimentari della popolazione e, in particolare, ai bisogni delle persone che lasciano le campagne per diventare operai nelle fabbriche moderne. In altri termini: l'accrescimento sistematico della produttività in agricoltura e la crescente commercializzazione dei prodotti agricoli (in contrapposizione al precedente sistema dell'autoconsumo) rappresentano condizioni necessarie, anche se non sufficienti, dello sviluppo industriale.
Un altro punto importante riguarda una differenza essenziale fra i paesi che si sono sviluppati per primi e i paesi ritardatari: col passare del tempo si sono determinati ostacoli sempre maggiori a uno sviluppo industriale essenzialmente ‛privato', come quello che ebbe luogo in Inghilterra nel periodo a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo. In generale, le economie ritardatarie si trovano di fronte a vantaggi e svantaggi di tipo particolare nell'avviare un processo di espansione industriale. I vantaggi sono rappresentati dalla possibilità di accedere a certe tecnologie e a certi metodi organizzativi efficienti e moderni, ai quali le regioni e i paesi ora progrediti sono pervenuti attraverso una lunga evoluzione. Gli svantaggi sono rappresentati da tre ordini di ‛salti': il salto tecnologico, il salto del mercato e il salto che potremmo chiamare imprenditoriale.
Nei paesi che avviarono per primi uno sviluppo industriale moderno, come l'inghilterra, era possibile uno sviluppo graduale in tutte le industrie. Date le conoscenze tecniche del tempo, anche aziende relativamente piccole erano in grado di produrre in modo economico (a costi inferiori ai prezzi di mercato); ed era quindi possibile un passaggio graduale dalla piccola azienda artigianale all'azienda industriale basata sulle macchine, da principio piccola, poi sempre più ampia. In questo processo di espansione non s'incontrava la concorrenza di grandi aziende, che allora non esistevano nè in Inghilterra nè in altri paesi. Parallelamente, uno sviluppo graduale era possibile rispetto al mercato: all'inizio le nuove aziende avevano a disposizione il mercato locale, nel quale si ampliavano a spese delle unità artigianali (che entravano progressivamente in crisi); inoltre, per espandere le vendite sui mercati esteri, le nuove aziende dovevano battere nella concorrenza i prodotti delle aziende artigianali. Col perfezionamento dei metodi produttivi, questo obiettivo risultava relativamente facile: i metodi usati dagli artigiani non mutavano e questi, fino a un certo limite, potevano quindi difendersi soltanto vendendo a prezzi decrescenti e contentandosi di redditi decrescenti. Infine, sotto l'aspetto sociale, era possibile la formazione graduale di imprenditori nel senso moderno, con capacità, gradualmente acquisite, di dirigere grandi aziende.
In seguito, in molti rami della produzione, questo sviluppo graduale non è stato più possibile. Vi è infatti un ‛salto' imposto dalla tecnologia nei casi in cui, per produrre economicamente, le dimensioni delle unità produttive debbono essere grandi. Vi è poi un ‛salto' nella conquista del mercato, perché il mercato locale è spesso già stato conquistato da grandi imprese moderne ubicate altrove, per competere con le quali occorrono una vasta organizzazione commerciale e costose campagne pubblicitarie; per esportare, le difficoltà sono anche maggiori, perché si tratta di battere sui mercati esteri i prodotti di aziende moderne di altri paesi, che in quei mercati si sono già affermati. Vi è infine un ‛salto' nella formazione delle persone che potrebbero diventare imprenditori industriali. Al principio del secolo scorso questi ostacoli potevano essere superati dalle imprese private con un aiuto relativamente piccolo e comunque esterno, o indiretto, dell'autorità pubblica (infrastrutture e dazi protettivi). In seguito questi ostacoli sono divenuti così ardui da richiedere dei ‛salti' che le forze private, spontanee, non possono compiere. Lo svolgimento del processo nel senso del modello classico inglese - uno sviluppo graduale, uno sviluppo totalmente o in gran parte privato - non è quindi più possibile.
Tutto questo significa che, maggiore è il ritardo, più vasto tende a essere l'intervento dello Stato. Ma non sono sufficienti gli incentivi tradizionali, forniti dalle infrastrutture, e quelli escogitati di recente (agevolazioni creditizie e fiscali): tali stimoli presuppongono l'esistenza potenziale di imprenditori che nelle regioni sottosviluppate manca completamente. Lo Stato deve pertanto intervenire nella costitutuzione stessa delle imprese e delle attività produttive, che nel passato, nei paesi oggi progrediti, erano state promosse da forze private. Questo intervento è necessario in primo luogo nel campo delle attività d'interesse pubblico: ferrovie, fonti di energia, mezzi di comunicazione, organismi bancari e creditizi; poi anche nel campo manifatturiero, attraverso organizzazioni di varia natura e attraverso imprese miste ma create per iniziativa pubblica, e perfino nel campo commerciale. Ma lo Stato non è un'entità metafisica: esso è guidato dai rappresentanti di determinate classi, le quali possono indirizzare lo sviluppo verso fini particolari o egoistici, lasciando nella miseria ampie fasce di cittadini. Inoltre la pubblica amministrazione riflette il grado di sviluppo della società: se questa è arretrata, anche quella è arretrata e inefficiente. L'inefficienza può esser perpetuata e resa più grave dalle azioni e dalle omissioni di una classe politica che non intende usare la pubblica amministrazione come strumento per l'attuazione di riforme e come mezzo d'intervento diretto nell'economia, perché ciò urta contro gli interessi che essa rappresenta. Principalmente per questo, nelle odierne economie arretrate l'avvio di un processo di sviluppo industriale risulta così difficile. Tuttavia, difficile non significa impossibile: oltrepassata una certa soglia critica, dopo una prima fase, durante la quale la spinta proviene principalmente da imprese pubbliche e da imprese straniere, i salti di cui si è detto possono divenire via via meno ardui.
Queste contraddizioni, che tuttora in qualche misura pesano nei paesi ritardatari dell'Europa, pesano molto gravemente nei paesi sottosviluppati degli altri continenti, nei quali gli ostacoli da superare sono stati e sono ben più complessi. Per evitare i rischi analitici che si corrono se si concentra l'attenzione sugli aspetti puramente quantitativi, converrà fornire delle indicazioni sulla struttura sociale di alcuni importanti paesi arretrati dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina; dell'America settentrionale si prenderà in considerazione solo il Messico, mentre non si prenderà in considerazione l'Oceania i cui due unici paesi importanti in termini di popolazione - Australia e Nuova Zelanda - fanno parte, a tutti gli effetti, dei paesi sviluppati.
6. Le strutture sociali
I paesi asiatici, sotto l'aspetto economico e sociale, possono essere divisi in tre gruppi: i paesi del subcontinente indiano, quelli della penisola indocinese e l'Indonesia (si considerano qui solo i paesi sottosviluppati a economia di mercato e perciò non si esaminano né il Giappone - paese sviluppato - né la Cina - paese a economia pianificata). I paesi dell'Africa, invece, possono essere suddivisi in tre gruppi: quelli del Nord, quelli dell'Africa subsahariana e, infine, Zimbabwe (Rhodesia) e Repubblica Sudafricana. Quanto all'America Latina, fra i diversi paesi vi sono differenze notevoli ma anche notevoli affinità; tutto sommato, per questa parte del mondo conviene considerare i paesi maggiori e cioè il Brasile, l'Argentina e il Messico e poi, separatamente, gli altri. Occorre tener presente che, da un punto di vista economico, i paesi molto poveri (a reddito basso) di una certa consistenza demografica si trovano solo in Asia (in particolare i paesi del subcontinente indiano) e in Africa (in particolare nell'Africa subsahariana). Da un punto di vista europeo, vi sono diverse analogie fra la struttura sociale dei paesi latino-americani e quella dei nostri paesi (come anche dei paesi sviluppati del Nordamerica e dell'Oceania); le analogie sono molto minori con la struttura sociale dei paesi asiatici, ancora più limitate con i paesi africani e minime con i paesi dell'Africa subsahariana.
In Asia vi sono classi sociali sui generis, non generate dall'evoluzione economico-sociale ma prodotte, o almeno perpetuate, dalle leggi e dalla tradizione, e vi è un sistema di caste rigidamente definite, che già di per sè rappresenta un cospicuo ostacolo a un processo di sviluppo. Le differenze e le contrapposizioni etniche e religiose raggiungono un'intensità sconosciuta in Europa. Quanto alle attività economiche, sia in Asia che in Africa si osserva una complessa coesistenza di attività che caratterizzano tanto i tre stadi primitivi quanto i tre stadi moderni dell'evoluzione economica. L'ordinamento politico e istituzionale di queste società presenta ancora forti tracce del periodo coloniale e risulta quindi in gran parte sovrapposto - non ancora pienamente fuso - alla sottostante struttura economica e sociale. Tale struttura conserva al suo interno, oltre a nuclei di persone che svolgono ancora attività economiche proprie degli stadi primitivi (cacciatori e pescatori, pastori, contadini che consumano quel che producono), anche contadini che producono per il mercato e salariati agricoli. Salendo nella scala sociale (se così si può dire), troviamo gli artigiani, i salariati di piccole e piccolissime unità commerciali, artigianali e industriali, impiegati privati e pubblici, operai dell'industria moderna, fasce di borghesia rurale, commercianti medi e grandi, latifondisti (anche se quella che poteva essere considerata l'aristocrazia agraria, essendosi largamente compromessa con i dominatori bianchi, è stata poi almeno in parte espropriata nell'epoca della decolonizzazione).
In numerosi paesi dell'Asia e dell'Africa osserviamo che il commercio, all'ingrosso e al minuto, si trova nelle mani di gruppi etnici provenienti dall'esterno: i Cinesi in Indonesia e in diversi paesi del Sud-Est asiatico, gli Indiani nel Sudafrica e nel Kenya, gli Arabi in molti paesi dell'Africa subsahariana.
Nell'evoluzione che anche le economie relativamente stazionarie hanno subito nel corso dei secoli, a un certo punto si è determinata l'esigenza organica di sviluppare traffici non puramente locali. I gruppi sociali più adatti a rispondere a questa esigenza si sono rivelati i gruppi allogeni: in economie stazionarie, prevalentemente agricole, in cui le popolazioni locali erano in qualche modo legate alla terra, le persone più adatte a soddisfare l'esigenza di sviluppare traffici commerciali non locali erano, appunto, persone capaci di muoversi con facilità, persone senza radici, provenienti da altre regioni. Parecchie di queste persone poterono diventare relativamente ricche e non di rado all'attività di mercanti unirono quella di prestatori di danaro e quindi di usurai. Sia per questo motivo, sia per l'invidia che una relativa ricchezza suscita in popolazioni povere, sia per il fatto che erano estranee, certe volte perfino con la pelle di colore diverso, queste persone erano guardate con ostilità dalle masse di contadini. Dal canto loro, i ceti dominanti tendevano a sfruttare finanziariamente i gruppi allogeni e, in tempi di gravi tensioni sociali, a usarli come capri espiatori. In generale si può dire che, comunque originato, il trasferimento in paesi arretrati di persone provenienti da altri paesi ha contribuito in diversi casi a rompere il ristagno economico-sociale e a mettere in moto un processo di espansione non solo commerciale, ma anche produttivo.
Mentre la struttura sociale dei paesi sottosviluppati dell'Asia presenta alcuni punti di somiglianza con quella dei paesi sviluppati dell'Europa e del Nordamerica, la struttura sociale dei paesi africani presenta somiglianze molto più deboli. Più precisamente: si possono trovare aspetti in comune con i paesi dell'Africa settentrionale, ma i punti di contatto diventano quasi inesistenti quando si considerano i paesi dell'Africa subsahariana e i due paesi meridionali: Zimbabwe e Repubblica Sudafricana.
Sulla base delle precedenti considerazioni e sulla scorta dei dati ricavabili dall'Annuaire des statistiques du travail (1978) del Bureau International du Travail di Ginevra e dal World development report, 1980, della International Bank for Reconstruction and Development di Washington (la ‛Banca Mondiale'), è stata costruita la tab. IV, che presenta, a fini puramente indicativi, alcune stime sulla struttura sociale, da un lato, di tre importanti paesi sottosviluppati, uno asiatico (India), uno nordafricano (Egitto) e uno latinoamericano (Brasile) e, dall'altro, di tre paesi industrializzati: Italia, Francia e Stati Uniti. Gli studiosi marxisti hanno insistito più di tutti sulla necessità di fondare l'analisi delle diverse società sullo studio delle classi e dei gruppi sociali, ma, specialmente nel caso dei paesi sottosviluppati, questa indicazione è rimasta in gran parte nel limbo delle pie intenzioni: è per questo che i dati indicati nella tab. IV sono delle stime e, in certi casi, delle pure ipotesi. Di ipotesi, in particolare, si tratta nel caso dei contadini poveri, ossia dei contadini che posseggono appezzamenti minimi di terra, tanto che non di rado sono costretti a lavorare come braccianti (salariati giornalieri) nelle terre di contadini meno poveri o in quelle di veri e propri proprietari; di ipotesi, inoltre, si tratta nel caso dei lavoratori ‛marginali' o ‛precari' delle zone urbane e di alcune zone rurali (Marx parlava di ‟sottoproletariato", Marshall di ‟residuum"). Per le zone rurali si tratta delle fasce più basse dei contadini poveri e dei salariati agricoli; per quelle urbane si tratta di persone che vivono ai margini delle città (anche in senso topografico: popolano le cosiddette bidonvilles). In effetti, l'ingrandimento di alcune città asiatiche e latino-americane non è stato un fenomeno fisiologico, provocato cioè dallo sviluppo del settore industriale e del settore terziario moderno, ma patologico: uomini poverissimi sono affiuiti e affluiscono nelle città, non tanto perché il loro lavoro sia stato o sia richiesto da imprese o da uffici pubblici, ma per fuggire dalla miseria delle campagne: nelle città possono trovare qualche piccolo lavoro saltuario, svolgere piccoli traffici, leciti e illeciti, possono trovare una qualche, sia pur minima, assistenza pubblica, possono mendicare. Costoro perdono, se pure l'hanno mai avuta, l'abitudine al lavoro sistematico, alimentano (dal basso) la corruzione e perfino la criminalità. Qualsiasi sforzo di ricostruzione sociale e di riorganizzazione produttiva in quei paesi si troverà sempre di fronte il terribile problema del sottoproletariato cittadino.
Anche le persone che svolgono in modo precario e saltuario la loro attività in aziende minuscole vanno incluse nel sottoproletariato urbano. Viceversa, coloro che lavorano stabilmente e regolarmente in aziende minuscole, spesso a carattere familiare - botteghe commerciali, officine di riparazione, piccolissime aziende per la produzione di vestiti, scarpe, mobili e per i trasporti - non vanno inclusi nel sottoproletariato, anche se ottengono redditi molto bassi; queste aziende sono, sì, minuscole, ma sono suscettibili di trasformazione e di sviluppo e sono relativamente numerose non solo nelle grandi città, ma anche nei centri urbani di minori dimensioni. Oltre ai sottoproletari e ai lavoratori, dipendenti e autonomi, di cui si è detto, nei settori extra-agricoli vi sono coloro che lavorano stabilmente in aziende piccole e medie o nelle grandi imprese moderne. Questi salariati rientrano, insieme con coloro che lavorano come impiegati nelle stesse imprese, nella cosiddetta ‛aristocrazia del lavoro': le loro retribuzioni sono inferiori, ma non di molto, a quelle dei loro colleghi dei paesi industrializzati. Coloro che appartengono a questa aristocrazia del lavoro richiedono, oltre ai beni di prima necessità, anche i beni durevoli di consumo (automobili, elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi).
La struttura sociale dei paesi dell'Africa subsahariana è molto più elementare. Anche qui troviamo gruppi provenienti da altri paesi, anzi da altri continenti, trasformatisi col tempo in mercanti (con caratteristiche simili a quelle già indicate per alcuni paesi asiatici). Anche qui troviamo le aristocrazie del lavoro, molto più esigue di quelle dei paesi latino-americani e asiatici. Troviamo poi gruppi di salariati, agricoli e non, pagati con salari bassissimi, che spesso lavorano per una parte del tempo nei loro campi, presso le loro tribù, e, per un'altra parte del tempo, in aziende di tipo capitalistico. Al vertice troviamo invece i gruppi della burocrazia civile e militare, eredi degli amministratori bianchi, che spesso detengono il potere e che non di rado si sono attribuiti stipendi (relativamente elevati) simili a quelli dei loro predecessori bianchi.
Considerando l'alta percentuale di analfabeti, l'attrazione esercitata dai cosiddetti modelli di consumo occidentale e la spinta atavica a uscire dalla miseria, non c'è da stupirsi se nell'amministrazione pubblica di questi paesi anche di quelli, e sono numerosi, che si autodefiniscono socialisti - si trova, oltre all'inefficienza, anche la corruzione: la cosiddetta arretratezza non è un fatto puramente economico e la via dello sviluppo, una via che quelle collettività sono state, per così dire, costrette a imboccare, è lunga, faticosa e difficile. Le responsabilità storiche dei paesi colonizzatori bianchi sono senza dubbio enormi, specialmente in Africa, dove i Bianchi hanno razziato e deportato milioni di persone e hanno, per molto tempo, reso schiavi o quasi altri milioni di persone, spesso scacciandoli dalle loro terre. Introducendo l'economia monetaria, i coloni hanno anche minato, provocandone la decadenza e poi la distruzione, la vita patriarcale e i valori tradizionali dei diversi gruppi sociali; perfino quando hanno svolto una politica umanitaria, per es. allo scopo di migliorare le condizioni di salute, hanno provocato indirettamente, attraverso la riduzione della mortalità, gravissimi problemi, che oggi vanno sotto il nome di esplosione demografica.
Dopo aver ricordato tutto questo, però, bisogna aggiungere che sarebbe del tutto ingannevole pensare che prima della colonizzazione bianca la vita, in Africa, fosse idilliaca (e quel che vale per l'Africa può valere - si deve presumere - anche per gli altri continenti): fra i diversi gruppi etnici e le diverse tribù le guerre e le razzie di persone e di cose erano la regola; a volte, le razzie si concludevano con l'assoggettamento di certe tribù da parte di altre, che imponevano veri e propri tributi ai vinti. I Bianchi hanno crudelmente sfruttato gli Africani, ma hanno anche avviato mutamenti che trascendono il giudizio morale sul loro operato; come già si è accennato, Smith parla a questo proposito di ‟sventure" e ‟benefici" e al suo giudizio complessivo conviene tuttora rifarsi. Sarebbe molto ingiusto, per esempio, considerare in modo prevalentemente negativo l'azione sanitaria dei Bianchi che ha determinato una flessione della mortalità. Le popolazioni africane - organizzate nei confini di ‛nazioni' create quasi sempre da forze esterne e, quindi, originariamente artificiali - dopo la decolonizzazione hanno avviato dei processi volti a conquistare una propria identità collettiva e una piena autonomia, e l'autonomia è la condizione necessaria di uno sviluppo economico potenzialmente generalizzato. Si tratta di processi che i Bianchi - paesi e singoli, soprattutto intellettuali - devono cercare di comprendere e, per quanto possibile, favorire: molti Africani, a quanto pare, auspicano un tale aiuto; ma si deve essere ben consapevoli, a scanso di delusioni, che si tratta di processi lunghi, faticosi e dolorosi.
La tab. IV riporta dunque i dati, le stime e le ipotesi sulla struttura sociale dei sei paesi prima ricordati, tre sottosviluppati e tre industrializzati; riporta anche i dati sulle tre grandi categorie di lavoratori occupati: nell'agricoltura, nell'industria e nei servizi, privati e pubblici; riporta, infine, le stime di un indice di diseguaglianza nella distribuzione del reddito.
I dati relativi alle tre categorie di occupati della tab. IV (sez. III) vanno messi a confronto con quelli della tab. V, dove sono riportati dati analoghi relativi ad alcuni paesi o gruppi di paesi. Accanto a questi dati sono riportate le percentuali dei lavoratori dipendenti (operai e impiegati) sul totale: le percentuali sono alte o altissime nel caso dei paesi industrializzati, basse o bassissime nel caso dei paesi del subcontinente indiano e dell'Africa subsahanana: in questi due gruppi di paesi prevalgono tuttora in modo nettissitno i lavoratori indipendenti, nella massima parte occupati in agricoltura, in minime unità produttive familiari o tribali che di regola producono per l'autoconsumo e non per il mercato. La schiacciante maggioranza dei lavoratori indipendenti - alcuni dei quali in certi periodi lavorano come salariati in piantagioni - nei paesi dell'Africa subsahariana e la forte prevalenza di tali lavoratori nel subcontinente indiano mostrano, da un lato, il grado notevole di sottosviluppo di quei paesi e, dall'altro, le difficoltà estreme che si incontrano nello stabilire utili confronti fra la struttura sociale di quei paesi e quella dei paesi industrializzati.
L'ultima sezione (IV) della tab. IV riporta i valori di un indice di diseguaglianza nella distribuzione del reddito nazionale, ricavato dai dati sulla distribuzione per quintili; fra parentesi è indicata la percentuale di reddito che va al quintile più basso. I dati originari indicano quale quota del reddito ottiene ciascun 20% dei redditieri; i quintili sono in ordine crescente e la formula è D = (q5 − q1) + (q4 − q2). In teoria questo indice può variare da 0 a 1: il valore 0 esprime eguaglianza completa: ciascun quintile di redditieri ottiene il 20% del reddito; il valore 1 esprime la massima diseguaglianza: il quintile più alto ottiene l'intero reddito. (In pratica, per i 28 paesi di cui si hanno dati, il campo di variazione va da un minimo di 0,41 a un massimo di 0,77. Si può ritenere che valori intorno a 0,4-0,5 indichino una diseguaglianza minima, valori intorno a 0,5-0,6 una diseguaglianza media, intorno a 0,6-0,7 una diseguaglianza elevata, superiori a 0,7 una diseguaglianza massima. Anche la percentuale di reddito che va al quintile inferiore aiuta a comprendere l'intensità della diseguaglianza; in Brasile e in Egitto tale percentuale è solo del 2-3%: tenuto conto del basso livello del reddito medio, ciò denuncia una miseria gravissima degli strati più poveri della popolazione). Sull'importante questione della distribuzione del reddito torneremo più avanti, nel cap. 10.
7. Alcune ragioni della varietà nei saggi di sviluppo
La tab. II mette in luce la grande varietà di livelli di vita, ma anche di saggi di sviluppo, esistente nei diversi paesi e nei diversi gruppi di paesi; un divario anche piccolo fra i saggi di aumento può determinare nel giro di pochi decenni grandi differenze nei gradi di sviluppo. Si è già ricordato che 100 o 150 anni fa le distanze economiche fra i diversi gruppi di paesi erano, presumibilmente, molto minori di quanto siano oggi. E 100 o 150 anni fa paesi che oggi sono fra i più sviluppati del mondo erano colonie di paesi europei.
Di alcuni motivi generali di questo fenomeno si è già detto; ora si devono formulare alcune osservazioni di carattere più strettamente economico per cercare di chiarire perché in certi paesi l'espansione produttiva è stata rapida mentre in altri è stata lenta o molto lenta.
Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda erano divenuti colonie di popolamento a causa del clima. Si pensi per esempio, agli Stati Uniti e, in particolare, alle regioni centro-settentrionali di questo paese: considerazioni analoghe valgono anche per gli altri paesi che abbiamo ricordato.
Oltre alla questione del livello culturale dei coloni, di cui si è già detto, c'è un altro punto molto importante da considerare e cioè l'esistenza di terre libere. Col procedere dello sviluppo, un numero crescente di coloni cercava di assumere nelle proprie aziende lavoratori salariati; ma, a causa delle terre libere, i salariati si trasformavano essi stessi facilmente in coltivatori indipendenti. Per trattenere i salariati, i coloni più influenti fecero approvare delle leggi che rendevano oneroso l'acquisto delle terre libere, per le quali era necessario pagare un tributo che non aveva, come scopo principale, quello di procurare danaro allo Stato, ma, appunto, di rendere difficile l'accesso alla proprietà da parte dei lavoratori salariati. D'altra parte, si favorì, in tempi e in modi diversi, l'immigrazione, tanto più quanto più procedeva lo sviluppo. Ma nonostante i tributi e l'immigrazione, finché vi furono terre libere si poterono trattenere i lavoratori salariati per periodi non brevi solo offrendo loro salari elevati e crescenti e assicurando condizioni di lavoro - come si suol dire - umane. E l'aumento dei salari, mentre contribuì ad allargare il mercato interno, stimolò anche l'introduzione di innovazioni tecnologiche (di regola incorporate in impianti e macchine) le quali consentirono di produrre di più a parità di lavoratori salariati impiegati o con un aumento di lavoratori inferiore all'espansione della produzione. La produttività del lavoro crebbe pertanto rapidamente e furono sistematicamente incentivate le innovazioni tecnologiche: all'origine del rapido sviluppo degli Stati Uniti troviamo appunto questi processi.
Nelle colonie di popolamento si cercò dunque di attirare con l'immigrazione e poi di trattenere in tutti i modi una massa crescente di lavoratori salariati; ma tali sforzi ebbero successo nel lungo periodo solo perché i salari continuarono ad aumentare a un saggio assai sostenuto. (Si veda l'interpretazione, a mio giudizio parziale, di Marx, Il capitale, libro I, cap. XXV: La teoria moderna della colonizzazione; si veda anche Smith, Ricchezza delle nazioni, libro IV, cap. VII: Delle colonie).
Nelle colonie di sfruttamento, invece, di regola i coloni cercarono di far lavorare nelle miniere e nelle piantagioni, come schiavi, o gl'indigeni o le persone catturate in altri continenti (quasi sempre in Africa). In alcune colonie, soprattutto in Africa, i coloni cercarono invece di ‛produrre' artificialmente lavoratori salariati o attraverso incentivi (salari più alti del misero reddito di un'agricoltura di sussistenza) ovvero, in certi periodi, con metodi coercitivi: per es. spossessando gli indigeni delle loro terre o imponendo loro tributi da pagare obbligatoriamente in danaro. Ma sia la schiavitù sia il lavoro coatto non favoriscono lo sviluppo: non solo perché i capitalisti non hanno alcun incentivo a migliorare i metodi e a introdurre innovazioni, ma anche perché in quelle condizioni i lavoratori rendono il meno possibile.
Ricollegandosi agli economisti classici, W. A. Lewis ha elaborato un interessante schema teorico sugli spostamenti della forza lavoro, che si riferisce in particolare ai paesi tropicali e prende in considerazione due settori: un settore tradizionale, essenzialmente stazionario, e un settore capitalistico moderno, che tende allo sviluppo; il passaggio dei lavoratori dal primo al secondo settore non avviene con mezzi coattivi, ma attraverso incentivi salariali. L'ipotesi dell'autore è che le imprese possano indurre i lavoratori del primo settore a trasferirsi nel secondo offrendo loro un salario sia pure di poco più alto del reddito di sussistenza, che è quello ottenuto nel primo settore. Dal punto di vista economico l'offerta di lavoro è considerata come illimitata, sia perché si suppone che il settore capitalistico sia ancora ristretto rispetto al settore tradizionale, sia perché si ammette che le imprese capitalistiche possano attingere anche agli emarginati delle città o all'immigrazione o all'incremento della popolazione. I salari cominceranno ad aumentare solo quando il lavoro non sarà più disponibile in quantità illimitata, ma allora si sarà fuori dall'ipotesi adottata da Lewis.
Dunque, fino a quando in un paese sottosviluppato resta ampio il settore tradizionale, che rappresenta il principale serbatoio di manodopera, i salari si mantengono su livelli bassi: posto che i prezzi dei prodotti tropicali si formino sul mercato internazionale e siano largamente indipendenti dall'azione delle imprese capitalistiche, gli aumenti di produttività tenderanno in gran parte a tradursi in flessioni di costi e di prezzi. Ma una tale tendenza non avrà luogo nei paesi sviluppati, dove le imprese industriali sono in grado, entro certi limiti, di regolare i prezzi e dove l'offerta di lavoro non è illimitata ed esistono potenti sindacati: qui i salari aumenteranno in proporzione agli aumenti della produttività o in misura anche maggiore, cosicché i prezzi delle merci prodotte in questi paesi - in genere manufatti - tenderanno a crescere rispetto a quelli delle merci tropicali. In altri termini i rapporti di scambio fra manufatti e prodotti tropicali tendono - o meglio, per un lungo periodo hanno avuto tendenza - a modificarsi in modo sfavorevole ai prodotti della seconda specie. Questo è stato un ostacolo addizionale allo sviluppo di numerosi paesi sottosviluppati. All'origine troviamo una bassa produttività e, correlativamente, un reddito basso e stazionario nel settore tradizionale: è per questo motivo che salari stabilmente bassi, se pur di poco meno bassi di quel livello, costituiscono un incentivo sufficiente al trasferimento dei lavoratori.
Dall'analisi di Lewis si deduce che, in economie tropicali, fondate sulle piantagioni, le imprese capitalistiche hanno tutto l'interesse a far sì che la produttività nel settore dell'agricoltura di sussistenza non progredisca: progredendo, i salari necessari a incentivare il passaggio dei lavoratori dovrebbero aumentare. Non di rado le imprese capitalistiche sono straniere (possono essere grandi società multinazionali), ma possono anche essere imprese indigene: il contrasto d'interessi permane.
Quella di Lewis è una delle analisi più acute del cosiddetto ‛dualismo economico'. In verità, i casi di dualismo sono numerosi; e ancora più numerosi sono gli schemi teorici interpretativi. Come risulta dallo schema di Lewis (mentre non risulta in altri modelli) non c'è separazione fra i due settori - quello tradizionale e quello moderno; c'è piuttosto una simbiosi, ove però le imprese del settore moderno tendono a sfruttare il settore tradizionale in vari modi e non solo usandolo come serbatoio di lavoro. Si deve avvertire, tuttavia, che lo sviluppo stesso delle imprese capitalistiche tende, nei fatti, a rompere quella sorta di equilibrio che pure, per il loro vantaggio, esse avrebbero interesse a mantenere: a lungo andare il dualismo, con i caratteri sopra ricordati, non può sussistere.
8. L'agricoltura
In diversi paesi tropicali le imprese capitalistiche, sviluppando le piantagioni, hanno in vari modi ridotto l'area dell'agricoltura di sussistenza. Non sempre tale riduzione ha aggravato la situazione alimentare delle popolazioni di quei paesi: non l'ha aggravata, per esempio, se in quell'area è cresciuta la produttività per unità di superficie, o se i prodotti delle piantagioni sono serviti per pagare beni alimentari importati. Se invece quei prodotti vengono scambiati contro beni di lusso, acquistati dalla minoranza ricca del paese preso in considerazione, o se una parte almeno dei proventi delle vendite viene trasferita all'estero, a parità di altre condizioni la situazione alimentare peggiora.
Comunque sia, nei paesi sottosviluppati il problema alimentare è quello più grave per fasce rilevanti della popolazione; si stima che tale problema riguardi non meno di 800 milioni di persone (circa un quinto dell'umanità), concentrate soprattutto nel subcontinente indiano e nell'Africa subsahariana. Si tratta di un problema che non ha solo implicazioni umanitarie: se l'agricoltura non si sviluppa a un saggio sostenuto, l'intero processo di sviluppo viene, se non impedito, per lo meno frenato.
Queste difficoltà hanno diverse cause: in primo luogo, le carenze alimentari comportano bassa efficienza e alta morbilità dei lavoratori di tutti i settori; in secondo luogo, lo sviluppo delle attività extra-agricole, e in particolare dell'industria, richiede un trasferimento di lavoratori dalle zone rurali alle zone urbane, e questo trasferimento richiede una produzione agricola crescente e in eccesso rispetto ai bisogni dei produttori; in terzo luogo, una crescente disponibilità di prodotti agricoli alimentari crea un mercato per i prodotti non agricoli e ne favorisce in questo modo lo sviluppo.
Fra gli ostacoli allo sviluppo dell'agricoltura nei paesi arretrati è da annoverare anche l'elevata concentrazione nella proprietà della terra. Già gli economisti classici avevano messo in evidenza che i latifondisti sono interessati al reddito netto e non al reddito lordo (quello netto essendo depurato dalle spese di produzione, fra cui sono i salari): il reddito netto è importante ai fini della formazione del risparmio e della capacità contributiva, ma per l'occupazione e la soddisfazione delle esigenze alimentari della popolazione è il reddito lordo quello che conta. Pertanto, più la proprietà della terra è concentrata, più grave diviene tale contraddizione. Inoltre i grandi proprietari sono spesso assenteisti e talvolta non si preoccupano neppure di accrescere in modo sistematico il reddito netto. Tuttavia nei casi in cui i proprietari perseguono un tale accrescimento, la contraddizione, già presente in condizioni stazionarie, si ripresenta in termini dinamici, quando il proprietario decide di compiere investimenti che risparmiano lavoro. Così, quando il proprietario, in presenza di una rilevante disoccupazione agricola, manifesta o nascosta, decide d'introdurre macchine agricole che riducono ulteriormente il numero dei lavoratori impiegati, egli può certo accrescere il suo reddito netto, ma non promuove lo sviluppo agricolo complessivo. (In questi casi c'è spazio per opportuni interventi pubblici, come quelli di porre elevati tributi sull'acquisto di macchine che risparmiano lavoro, stimolando, anche attraverso incentivi, gli investimenti e gli impieghi che accrescono non tanto la produttività per lavoratore, quanto la produttività per unità di superficie - come gli investimenti per l'irrigazione e l'impiego di fertilizzanti).
Per lo sviluppo dell'agricoltura non è importante solo l'assetto della proprietà, ma anche il sistema dei contratti, alcuni dei quali (come gli affitti di lungo periodo) tendono a promuovere tale sviluppo, mentre altri (come gli affitti revocabili anno per anno e diverse forme di mezzadria) tendono a frenarlo. A questo fine è importante anche l'organizzazione del commercio dei prodotti agricoli; in molti paesi sottosviluppati, accanto a gruppi commerciali, spesso collegati con i latifondisti, che controllano le attrezzature dell'intermediazione (mezzi di trasporto, magazzini di deposito, frigoriferi), troviamo le grandi masse dei contadini poveri e analfabeti, spesso indebitati con gli stessi commercianti all'ingrosso.
Come conseguenza, spesso si osservano differenze cospicue fra i prezzi al consumatore (alti) e i prezzi al produttore (molto bassi), differenze che solo in parte possono essere spiegate con vere e proprie spese di distribuzione, e che si traducono in guadagni aggiuntivi per coloro che controllano gli acquisti (gli economisti parlano di guadagni di tipo ‛monopsonistico'). Come ulteriore conseguenza, gli abbondanti raccolti non si traducono necessariamente in prezzi minori al consumatore: possono anche tradursi in prezzi minori al produttore (con quote di raccolto che restano invendute); allo stesso modo, gli aumenti della domanda non si traducono necessariamente in aumenti dei prezzi al produttore e, via via, in una maggiore produzione stimolata da quegli aumenti: possono anche risolversi, prevalentemente, in maggiori prezzi al consumatore e in maggiori prezzi all'ingrosso, mentre i prezzi al produttore restano invariati. Questo secondo caso si verifica in condizioni di espansione dell'intera economia, industria compresa; le persone che si trasferiscono dalle zone rurali a quelle urbane, per lavorare o per accompagnare i familiari che lavorano, accrescono la domanda di prodotti agricolo-alimentari: la pressione della domanda fa aumentare i prezzi al consumo e, solo con ritardo, i prezzi al produttore: lo stimolo ad accrescere la produzione risulta smorzato, mentre risulta alimentata un incessante pressione inflazionistica. Non si tratta di una ‛rigidità' naturale nell'offerta dei prodotti agricoli ma, piuttosto, di una rigidità economica.
Una situazione come quella ora descritta è caratteristica di diversi paesi dell'America Latina. Sembra invece che sia assai meno frequente in Asia e quasi assente in Africa, dove già nel periodo coloniale funzionavano organismi pubblici o semipubblici per la commercializzazione di alcuni prodotti (marketing boards). L'obiettivo è di ridurre i guadagni privati di monopsonio, per favorire i produttori agricoli; in questo modo si rende l'offerta più reattiva agli aumenti della domanda e lo Stato si assicura una parte dei guadagni realizzati. Il sistema è valido e, a quanto pare, ha già dato risultati positivi, anche se, in alcuni casi, i guadagni devoluti allo Stato sotto forma di particolari tributi sono andati a vantaggio di un piccolo strato di burocrati privilegiati, piuttosto che della generalità dei cittadini.
9. Il problema della fame e la politica demografica
È opportuno, a questo punto, riprendere in considerazione la tab. II: i divari fra il reddito individuale americano e il reddito dei paesi sottosviluppati, specialmente nei paesi a reddito basso, sono risultati cospicui e sembrano addirittura astronomici se si usano i rapporti non corretti. Abbiamo visto che la causa principale dell'indebita esagerazione dei divari va ricercata nell'ambito dei servizi. Per un'analisi più approfondita, allora, conviene mettere da parte in blocco i servizi (sulla scia degli economisti classici) e concentrare l'attenzione sulla produzione di merci, agricole e industriali.
Se si parte dall'agricoltura, si scopre che i divari sono nettamente inferiori alla media: ciò è ben comprensibile, dato che, man mano che procede lo sviluppo, la domanda e la produzione delle merci agricole e, in particolare, delle merci agricolo-alimentari crescono in proporzione molto minore della domanda e della produzione delle merci industriali. È allora opportuno prendere in considerazione altri indici, in particolare gli indici fisici dei fabbisogni alimentari. I dati elaborati dalla FAO (Food and Agriculture Organization) mostrano che le disponibilità medie per individuo, in diversi paesi sottosviluppati a reddito basso, sono inferiori ai livelli considerati necessari: l'insufficienza è dell'ordine del 20-30% nel caso delle calorie e del 30-40% nel caso delle proteine. Naturalmente, le medie coprono situazioni molto differenziate, non solo fra i diversi paesi a reddito basso, ma anche al loro interno: i redditieri ricchi si nutrono in modo più che soddisfacente, in termini sia quantitativi che qualitativi, mentre i redditieri poveri si nutrono male e in modo insufficiente. Di conseguenza, non si tratta solo di accrescere la quantità di alimenti, ma anche di migliorare la distribuzione del reddito. Tenendo presente il problema della distribuzione, importante soprattutto a bassi livelli di reddito, si può affrontare il problema dell'accrescimento delle disponibilità medie. Alla soluzione di questo problema può dare un contributo il commercio estero; ma un tale contributo può essere rilevante solo in paesi relativamente piccoli: i paesi grandi non possono non puntare sull'espansione della produzione agricola interna.
A un primo esame, almeno, il problema non si presenta così drammatico come i rapporti (pur se corretti) fra i redditi individuali potrebbero indurre a credere: nel caso dei prodotti agricolo-alimentari si tratta infatti di accrescere la disponibilità media individuale in una misura che può andare dal 30 al 50%. (Ciò significa che, per quanto riguarda la produzione agricola, il rapporto fra paesi sviluppati e paesi arretrati è solo di 1 : 1,4 circa e che il divario fra i redditi individuali, che nel caso dei paesi poveri varia da 30 a 12, è quasi completamente imputabile all'industria).
Tuttavia, pur non avendo dimensioni macroscopiche, il problema delle disponibilità alimentari è grave per due ragioni fondamentali. In primo luogo, perché nei paesi sottosviluppati, per accelerare lo sviluppo della produzione agricola, è necessario riformare l'assetto della proprietà terriera e il sistema dei contratti, riorganizzare il sistema della conservazione e del commercio dei prodotti, istruire e assistere tecnicamente i contadini poveri (per ricordare solo le più importanti trasformazioni necessarie), e queste trasformazioni urtano contro ostacoli di tipo politico prima ancora che di tipo tecnico e finanziario. In secondo luogo, il problema è grave perché l'aumento del 30 o del 50% non riguarda la produzione complessiva, ma quella pro capite, e si scontra quindi col problema demografico.
Questo problema, non meno di quelli connessi con lo sviluppo produttivo e coi livelli del reddito, viene ancor oggi posto in termini catastrofici. In verità, l'espansione demografica - per i paesi sottosviluppati nel dopoguerra si è parlato di ‛esplosione' demografica - non è stata determinata da un aumento del saggio di natalità, che per molti anni è rimasto sostanzialmente stazionario o è diminuito con estrema lentezza, ma, soprattutto, da una flessione del saggio di mortalità. Infatti, l'arretratezza economica e sociale persistente ostacola i mutamenti che favoriscono la diminuzione della natalità, mentre non impedisce la penetrazione di miglioramenti sanitari di vario genere.
Una situazione di questo tipo si era creata in passato anche nei paesi oggi sviluppati. In Inghilterra, per esempio, nel secolo scorso (e probabilmente anche in epoche precedenti) la popolazione era rapidamente cresciuta per una caduta della mortalità, mentre la natalità era rimasta stazionaria fino al settimo decennio del secolo. Da allora, tuttavia, la natalità è diminuita, dapprima lentamente, poi rapidamente, e l'espansione demografica è divenuta sempre più lenta ed è oggi sul punto di annullarsi. Con molte probabilità, un'esperienza analoga potrebbe oggi essere fatta da un numero crescente di paesi sottosviluppati, per di più a tappe ravvicinate nel tempo. Di conseguenza, l'opinione, tuttora diffusa, che nella grande maggioranza dei paesi sottosviluppati non vi siano segni di un indebolimento dell'espansione demografica, un'opinione che ancora una decina di anni fa appariva fondata, deve oggi essere radicalmente riconsiderata, non solo e non tanto perché la flessione della mortalità, pur sempre notevole, è divenuta meno rapida che nel passato (come, per ragioni naturali, non poteva non avvenire) quanto perché, in un numero crescente di paesi sottosviluppati si è profilata, o è diventata meno lenta di prima, la flessione del saggio di natalità. Di conseguenza, l'espansione demografica, pur restando sempre ragguardevole, sta rallentando, e questa tendenza può essere verificata con i dati della tab. VI (colonna 1). In questa stessa tabella sono indicate le proiezioni oggi considerate attendibili da diversi demografi e riportate dal rapporto del 1980 della Banca Mondiale; tali proiezioni riguardano il ventennio 1980-2000 (colonna 2) e il periodo in cui si presume che la popolazione diventerà stazionaria. Sebbene queste proiezioni tengano conto della recente flessione della natalità, non si può affatto escludere, ricordando quanto è accaduto con le precedenti previsioni, che esse conducano a sovrastimare la futura espansione e a spostarne in avanti nel tempo la fine.
La flessione della natalità va imputata in parte allo sviluppo produttivo che, nonostante tutti gli ostacoli, si sta manifestando nella massima parte dei paesi sottosviluppati (v. tabb. II e III): man mano che cresce il reddito individuale, infatti, i genitori divengono più istruiti e più responsabili e tendono a consolidare i miglioramenti ottenuti riducendo il numero dei figli; inoltre, con la diminuzione della mortalità infantile (v. tab. VII), si tende a generare un minor numero di figli. Infine, con lo sviluppo, si riducono gradualmente le condizioni favorevoli a un'alta prolificità. (Queste condizioni si riscontrano specialmente nell'agricoltura di sussistenza: coloro che nelle loro piccole aziende lavorano duramente con strumenti rudimentali tendono a generare un elevato numero di figli per avere un aiuto nella loro fatica).
La diminuzione della natalità può essere sollecitata non solo da queste spinte, che si possono considerare spontanee, ma anche da spinte determinate dalla politica demografica. Fino a poco tempo fa numerosi demografi erano inclini ad attribuire un'efficacia limitata a tale politica. Oggi le opinioni stanno mutando per il fatto che un numero crescente di paesi, specialmente in Asia, ha adottato misure restrittive con risultati degni di rilievo. Sono state prese misure di diverso genere: incentivi e disincentivi pecuniari, forme varie di depenalizzazione dell'aborto, diffusione capillare di conoscenze sui più moderni metodi antifecondativi. In questo campo la Cina sta realizzando un'esperienza che può costituire un importante punto di riferimento: dal 1960 al 1978 il saggio di natalità è sceso dal 36 al 18‰. Tuttavia anche in molti altri paesi in via di sviluppo il saggio di natalità è oggi in sensibile diminuzione (v. tabb. II eVI).
Come risultato di questa tendenza, il saggio di espansione demografica è diminuito e il problema alimentare, pur sempre gravissimo, sta divenendo oggi meno drammatico. Dalla tab. VIII appare la rilevanza del saggio di espansione demografica: con un saggio di accrescimento produttivo di circa il 3% basterebbero poco più di 10 anni per accrescere del 30% la disponibilità di prodotti alimentari, mentre ne occorrerebbero circa 15 per accrescerla del 50%; il periodo diviene invece circa il doppio (rispettivamente 20 e 30 anni) se si considera il probabile saggio di espansione demografica, pur ammettendo che tale saggio vada diminuendo nel tempo. Ora, un saggio annuale medio di aumento della produzione agricola del 3% non sembra affatto un obiettivo irraggiungibile. Negli anni più recenti (1970-1978) i paesi sottosviluppati a reddito medio sono riusciti a ottenere un saggio di aumento anche superiore (v. tab. IX). È vero che proprio i paesi a basso reddito, dove più acuto è il problema della malnutrizione, hanno accresciuto la produzione agricola a un saggio minore (il 2% annuo), ma far salire di un punto il saggio di aumento della produzione agricola, che pure avrebbe effetti di grande importanza nel giro di uno o due decenni, non appare davvero un compito arduo. Occorrono, certo, profonde trasformazioni istituzionali e organizzative, occorre un maggiore aiuto, finanziario e tecnico, da parte dei paesi industrializzati; ma l'obiettivo può essere raggiunto.
In questo ambito va dato il giusto rilievo agli aiuti tecnici: la cosiddetta rivoluzione verde degli anni recenti - consistente in un programma, sostenuto da istituzioni internazionali, per la diffusione di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici e di nuove specie di cereali più resistenti e più produttive - non ha dato i risultati attesi; ma, considerati i formidabili ostacoli da superare, i risultati raggiunti non sono stati affatto trascurabili. Come conseguenza, l'area della fame si va restringendo in termini relativi, anche se in termini assoluti va crescendo; probabilmente, in mancanza di cospicui sforzi addizionali, andrà crescendo nei prossimi due o tre decenni: secondo stime attendibili gli esseri umani di quest'area alla fine del secolo potrebbero essere più di un miliardo (oggi sono 800 milioni, e si tratta sempre di cifre largamente indicative).
10. Lo sviluppo industriale
Come abbiamo visto precedentemente, lo sviluppo dell'agricoltura comincia prima di quello dell'industria vera e propria e procede generalmente secondo fasi che si succedono uniformemente nei vari paesi; anche lo sviluppo industriale nel passato è stato contrassegnato da una sequenza abbastanza regolare: 1) in un primo tempo si sviluppano le industrie alimentari e tessili e altre industrie produttrici di beni di largo consumo; 2) poi si sviluppano le industrie meccaniche per la produzione di macchine usate nelle due industrie anzidette; 3) infine si sviluppano le industrie che producono beni capaci di soddisfare bisogni meno urgenti e non essenziali. Le industrie siderurgiche e la meccanica pesante cominciano a svilupparsi solo dopo che la base industriale ha raggiunto una dimensione minima: in precedenza, l'acciaio e le macchine produttrici di altre macchine vengono importati.
Le industrie ricordate tendono a prevalere, nell'una o nell'altra fase, in una successione temporale. Ma, pur così intese, le diverse fasi non possono essere divise nettamente tra loro. Inoltre, già nel passato quella sequenza - che per brevità chiameremo classica - poteva essere profondamente modificata per l'influenza del commercio con l'estero; anche se, in paesi relativamente grandi e popolosi, è sempre il mercato interno che offre lo sbocco più importante, poteva esser conveniente sviluppare industrie che producevano beni per l'esportazione, procurandosi all'estero i beni più richiesti all'interno. Per i moderni paesi sottosviluppati, tuttavia, la sequenza schematicamente ricordata può subire rilevanti modifiche, per cinque ordini di ragioni: 1) per la accresciuta importanza delle economie di scala; 2) per il tipo di politica riguardante la distribuzione del reddito; 3) per l'effetto dimostrativo, fortemente accentuato dai mezzi di comunicazione di massa e dalle forme moderne di pubblicità; 4) per le nuove forme di divisione internazionale del lavoro rese possibili dalla riduzione dei costi di trasporto e dallo sviluppo dei mezzi di comunicazione; 5) per mutamenti nel sistema economico-sociale.
Dell'accresciuta importanza delle economie di scala si è già detto, brevemente (v. cap. 5), quando si è fatto riferimento al salto tecnologico: tale salto rende inevitabile un intervento pubblico ben più ampio che nel passato nell'area stessa della produzione, anche in paesi a tendenze conservatrici e pur con tutti gli sprechi e gli abusi che gli interventi pubblici comportano, specialmente nei paesi sottosviluppati. (In diversi paesi latino-americani lo Stato è controllato da militari, che si trovano così a giocare il triplice ruolo di capi politici e militari e di dirigenti industriali).
Questa situazione, paradossalmente, può far anticipare, rispetto a quanto avveniva in passato, la creazione e lo sviluppo di alcune industrie di base, come l'industria dell'acciaio, specialmente là dove sono disponibili le materie prime in quantità rilevanti. Oggi spesso accusa dei ritardi anche la creazione d'industrie che producono beni di largo consumo, in quanto i paesi industrializzati dispongono di tecnologie più efficienti di quelle accessibili ai paesi sottosviluppati, i quali, per la ristrettezza del mercato, non sono in grado di sfruttare le economie di scala. In generale, tuttavia, sia pure lentamente, l'economia di questi paesi si sviluppa e i loro mercati si ampliano. Non è detto, naturalmente, che le industrie vengano impiantate non appena i mercati superano le dimensioni minime, giacché gli imprenditori locali sono scarsi e le imprese straniere che vendono in quei paesi possono compiere azioni deterrenti di vario genere. Prima o poi però, superata una certa soglia, le industrie locali tenderanno a svilupparsi in sostituzione delle importazioni; e ciò avverrà per iniziativa pubblica o privata, o per iniziativa delle stesse imprese straniere esportatrici, le quali possono trovare vantaggioso attuare investimenti diretti, specialmente se i paesi interessati introducono dazi protettivi. Questo terzo caso non può essere posto sullo stesso piano degli altri due dal momento che - a parte i problemi politici - le imprese straniere non investono localmente tutti i loro profitti ma, in parte almeno, li esportano, sottraendo così ai diversi paesi una quota del sovrappiù investibile. In ogni caso, l'iniziativa delle imprese straniere è meglio di nulla, qualora gli imprenditori privati e pubblici non siano in grado di avviare lo sviluppo dell'industria considerata. Se poi sussistono condizioni particolarmente favorevoli, come un basso costo del lavoro, dopo la sostituzione delle importazioni con una produzione locale, il processo può proseguire con un espansione della produzione orientata verso le esportazioni: ciò è avvenuto e sta avvenendo in un numero crescente di paesi.
Il secondo ordine di cause che tendono a modificare la sequenza classica dello sviluppo industriale è, come è stato accennato, il grado di diseguaglianza nella distribuzione del reddito. Tale diseguaglianza dipende principalmente da fattori istituzionali (come l'assetto della proprietà terriera) e da fattori politici. In effetti, minore è la diseguaglianza, più rapido è lo sviluppo dei prodotti di largo consumo (di ‛consumo popolare'); maggiore è la diseguaglianza, meno rapido è lo sviluppo di quei prodotti e più rapido, sin dal principio, è lo sviluppo dei prodotti non essenziali. Più precisamente, sembra che la diseguaglianza nella distribuzione non sia affatto una costante, come sospettava V. Pareto, ma sia sensibilmente diversa secondo i tempi e i paesi. Questo è sempre stato vero; ma mentre nel passato non erano state sperimentate certe trasformazioni istituzionali e organizzative e certe politiche economiche, oggi sembra evidente che la distribuzione del reddito può essere notevolmente modificata dall'azione politica, con rilevanti effetti sulla velocità e sul tipo dello sviluppo produttivo complessivo e sulle sequenze dello sviluppo industriale. La questione è tanto importante da richiedere un cenno particolare.
Sulla base delle stime e dei dati raccolti dalla Banca Mondiale, riguardanti 28 paesi, si può fare l'ipotesi che la diseguaglianza distributiva sia bassa nelle fasi iniziali dello sviluppo, vada poi crescendo in una fase centrale e scenda infine da un certo punto in poi (è un'ipotesi simile a quella proposta da Kuznets): graficamente, l'andamento del processo sembra quello di una curva di Gauss. Ma così come non c'è una ‛legge' che in un dato momento costringa entro limiti circoscritti i valori del grado di diseguaglianza distributiva, non c'è neppure una ‛legge dinamica', ossia un'evoluzione del fenomeno rigidamente predeterminata. In effetti, se in un diagramma indichiamo sulle ascisse i rapporti (corretti) fra il reddito americano e quello dei diversi paesi e sulle ordinate l'indice di diseguaglianza descritto nel cap. 6, abbiamo dei punti che possono essere racchiusi in una fascia, i cui confini sono dati da due linee ondulate, una alta e una bassa, come quelle tracciate nella fig. 1 . Così l'India del 1964 (quando lo sviluppo produttivo del paese, e in particolare lo sviluppo industriale, era ancora in una fase iniziale) ha un indice relativamente basso, come hanno un indice relativamente basso gli Stati Uniti (nei Paesi Scandinavi, in Australia e in Giappone l'indice è ancora più basso). Molto alto è invece l'indice di diseguaglianza dell'Egitto e del Brasile, che già prima erano (e ancor più si trovano oggi) in una fase di sviluppo più avanzata dell'India, ma sono pur sempre in una fase assai meno avanzata dei paesi industrializzati. Le curve e la fascia da queste delimitata mostrano la variabilità e l'indeterminazione riscontrabili nella distribuzione del reddito. Sembra inevitabile che per un lungo tratto dello sviluppo il grado di diseguaglianza vada crescendo; ciò se non altro perché, specialmente all'inizio, lo sviluppo non può procedere con la stessa velocità in tutte le industrie e in tutte le regioni; e l'indice di diseguaglianza rispecchia anche queste disparità. Ciò premesso, rimane pur sempre una cospicua area d'intervento che può essere usata discrezionalmente dalle forze politiche nei diversi paesi.
Le relazioni fra distribuzione del reddito e sviluppo industriale (velocità e composizione) non sono state studiate in modo sistematico; eppure, si tratta di un campo molto importante sia ai fini analitici sia ai fini della politica economica. Non bisogna dimenticare, infatti, che il mercato, di cui tanto i conservatori quanto gl'innovatori parlano come di uno straordinario strumento di misura e di registrazione delle spinte economiche, non può essere considerato isolatamente: dietro il mercato c'è una data distribuzione della ricchezza e del reddito, e questa distribuzione a sua volta dipende dalle istituzioni, dalle leggi e dalla politica economica e, in particolare, dalla politica fiscale. Nei paesi sottosviluppati le diseguaglianze distributive dipendono principalmente dall'assetto della proprietà terriera, che per ragioni storiche in alcuni paesi - come El Salvador e il Guatemala - è concentrata nelle mani di un numero relativamente limitato di famiglie e di imprese, mentre in altri paesi - come il Costa Rica - è assai meno disegualmente distribuita. Diversi gradi di diseguaglianza nella distribuzione comportano non solo differenze economiche nella configurazione del mercato e nel tipo di sviluppo, ma anche importanti differenze politiche: un'elevata concentrazione nella distribuzione della proprietà terriera mal si concilia con un assetto relativamente democratico.
C'è un terzo ordine di motivi per cui nel nostro tempo la sequenza classica dello sviluppo industriale può subire cospicue modifiche: a causa della grande diffusione dei mezzi di comunicazione di massa e del correlativo sviluppo delle tecniche pubblicitarie, si è progressivamente accentuato, al livello mondiale, il cosiddetto effetto dimostrativo e i bisogni dei consumatori sono sempre più condizionati dalle imprese, soprattutto dalle grandi imprese multinazionali. L'ordine di priorità dei bisogni ne viene modificato, e mentre in certi casi è difficile stabilire se tali modifiche possano determinare situazioni irrazionali rispetto al benessere fisico e psichico delle persone, in altri casi il giudizio negativo è evidente, nello stesso senso per cui si può dire che la diffusione delle droghe è irrazionale. È possibile, quindi, distinguere i bisogni in due categorie: essenziali e non essenziali (tra i quali rientrano i bisogni nocivi). Da un punto di vista razionale lo sviluppo dovrebbe cominciare con i beni che servono a soddisfare i bisogni essenziali; ma l'azione delle grandi imprese, che fanno leva sull'effetto dimostrativo e sulla pubblicità, può modificare tale ordine perfino presso le fasce più basse dei redditieri. La modifica può risultare tanto più accentuata quanto meno la politica economica è egualitaria. Così, in Brasile, dove il governo ha seguito una politica deliberatamente antiegualitaria per favorire un certo tipo di accumulazione, il contrasto fra lo sviluppo relativamente lento delle produzioni di beni essenziali e lo sviluppo rapido di produzioni non essenziali è molto rilevante. È importante osservare, però, che il consumo dei beni non essenziali cresce non solo per la domanda dei ceti privilegiati (ai quali appartiene anche l'aristocrazia operaia; v. cap. 6), ma anche di una parte dei ceti non privilegiati.
La drastica riduzione dei costi di trasporto nel nostro tempo ha reso economicamente possibili nuove forme di divisione del lavoro; questo rappresenta il quarto ordine di cause che hanno modificato la sequenza classica. Generalmente, tuttavia, si ragiona come se le nuove forme di divisione del lavoro dipendessero da decisioni prese da diverse nazioni o dalle imprese appartenenti a diverse nazioni. Bisogna invece rendersi conto che non sempre è così: in diversi importanti casi le nuove forme di divisione internazionale del lavoro hanno luogo nell'ambito di grandi imprese che operano in diversi paesi e hanno i centri decisionali nei paesi capitalistici più sviluppati, in primo luogo gli Stati Uniti, ma anche il Giappone e diversi paesi europei, fra cui l'Italia. Queste imprese trovano conveniente spostare certe operazioni produttive dai paesi d'origine ai paesi in via di sviluppo per una serie di fattori: perché i salari sono sensibilmente minori (e non si debbono pagare oneri sociali), perché nei paesi d'origine (che sono paesi industrializzati) non si trovano più operai disponibili per certe lavorazioni particolarmente monotone e faticose, o perché certe lavorazioni sono inquinanti e non sarebbero consentite nei paesi d'origine, o risulterebbero assai più costose, per l'obbligo, vigente in questi paesi, di introdurre apparecchiature antinquinamento. D'altra parte, le grandi imprese multinazionali tendono a trasferire tecnologie che servono di regola a risparmiare lavoro, poiché nelle economie di origine il lavoro è relativamente costoso: ciò non corrisponde però all'interesse delle economie in via di sviluppo, dove il lavoro è invece molto abbondante e dove il principale problema sociale è quello di allargare progressivamente l'area dell'occupazione non precaria.
C'è infine da considerare il sistema economico-sociale: in un paese come la Russia sovietica il meccanismo di sviluppo non poteva ripetere la sequenza classica dei paesi occidentali; per una lunga fase le industrie dei beni di largo consumo si sono sviluppate lentamente, mentre è stata accordata la massima priorità alla produzione di beni strumentali e, in particolare, all'industria pesante. Si deve osservare, tuttavia, che una tale politica perseguita nei primi piani quinquennali (1928-1938) non rispondeva soltanto a obiettivi di sviluppo economico, ma, almeno in parte, era condizionata da fini di ordine militare. In effetti, un altro grande paese a economia pianificata, la Cina, ha seguito un altra via, assegnando fin da principio una priorità elevata, anche se non assoluta, all'agricoltura, all'industria alimentare e a quella tessile. In ogni caso, nei paesi a economia pianificata dominano le scelte politiche e non è possibile indicare nessuna sequenza sistematica.
11. Le imprese multinazionali
Abbiamo ricordato più volte le imprese multinazionali; a questo punto è opportuno formulare qualche osservazione specifica sull'azione di queste imprese nei paesi sottosviluppati.
I ruoli svolti sono diversi, secondo che si tratti di imprese che hanno organizzato piantagioni o miniere, ovvero di imprese che hanno avviato produzioni industriali. Il ruolo delle imprese multinazionali che operano nell'agricoltura e nelle miniere è scarsamente dinamico sotto l'aspetto economico e tendenzialmente reazionario sotto l'aspetto politico. (In particolare, le imprese che basano la loro attività sulla proprietà della terra sono costituzionalmente contrarie a qualsiasi riforma agraria; inoltre, in certi casi queste imprese hanno sollecitato lo sviluppo di prodotti agricoli da vendere sui mercati internazionali provocando una riduzione delle produzioni agricole per la sussistenza). In parte diverso è il ruolo delle imprese multinazionali agricolo-alimentari, il cui ciclo, verticalmente integrato, va dalle materie prime agricole alla produzione e perfino al commercio al minuto dei beni di consumo, sia sui mercati interni che su quelli internazionali. Decisamente diverso - più dinamico e non necessariamente reazionario - è il ruolo delle imprese multinazionali propriamente industriali. Qui conviene distinguere le imprese che hanno organizzato produzioni a ciclo integrale o a ciclo parziale o, infine, che hanno affidato a piccole unità produttive, in subappalto, particolari lavorazioni. Le imprese che operano nel settore industriale e, in particolare, nell'industria manifatturiera hanno, nel loro paese di origine, ampie dimensioni, che sono il risultato di lunghi processi di trasformazione tecnico-economica; le ampie dimensioni operano da barriere di protezione, addirittura a livello internazionale. Non tutte le grandi imprese oligopolistiche dei paesi più sviluppati sono imprese multinazionali, ma tutte le imprese multinazionali sono, all'interno del paese d'origine, oligopolistiche poiché, per potersi espandere in altri paesi, hanno bisogno di una robusta base di partenza. Le imprese che hanno una tale base non possono non essere imprese dominanti in un dato ramo produttivo o perfino in diversi rami (v. mercato).
Le imprese oligopolistiche che spostano in paesi sottosviluppati certe operazioni o promuovono produzioni in subappalto vendono i prodotti finiti principalmente sui mercati internazionali, aggirando così l'ostacolo rappresentato dalle dimensioni limitate, pur se in espansione, dei mercati nei paesi sottosviluppati. Resta vero che l'inserimento o la comparsa, in paesi sottosviluppati, di nuove grandi imprese, straniere o nazionali, che producono a ciclo integrale per il mercato interno sono condizionati negativamente dalle dimensioni dei mercati: solo dopo una prolungata fase di sviluppo, prima lento poi via via più celere, questo ostacolo può essere superato.
Le valutazioni del ruolo che le grandi imprese multinazionali hanno avuto e tuttora hanno nei paesi sottosviluppati sono spesso divergenti. Per gli economisti marxisti tale ruolo è radicalmente negativo: esse contribuirebbero, secondo alcuni, addirittura allo ‟sviluppo del sottosviluppo". Per gli economisti a tendenza conservatrice, viceversa, il ruolo sarebbe senz'altro positivo. Un giudizio più obiettivo deve essere più differenziato e critico. Gli abusi economici e politici delle imprese multinazionali sono stati e sono rilevanti, ma entro certi limiti possono essere ridotti da una decisa azione politica e da leggi ben congegnate. Degli abusi cui possono dar luogo le imprese che decentrano certe operazioni nei paesi sottosviluppati si e gia fatto cenno nel precedente capitolo. Ma, quali che siano le intenzioni, lo sviluppo delle piccole unità locali o di imprese che producono beni intermedi, favorito dalle imprese multinazionali, a lungo andare non può non promuovere lo sviluppo generale dei paesi interessati, anche attraverso lo sviluppo di piccole imprese che producono per un mercato locale ancora ristretto, ma in espansione. Lo sviluppo della Corea del Sud, di Taiwan, di Hong Kong, di Singapore è certo fondato in primo luogo sui bassi salari e su un duro sfruttamento dei lavoratori a beneficio delle imprese multinazionali giapponesi, americane e britanniche, che in quei paesi hanno investito o promosso produzioni in subappalto; ma questo sviluppo dura oramai da anni e comincia a dar frutti positivi, in ciascuno di quei paesi, per la società intera, compresi gli operai, i cui salari, pur essendo ancora nettamente inferiori a quelli dei paesi industrializzati, sono andati crescendo notevolmente negli ultimi anni.
I paesi asiatici ora ricordati sono fra quelli che mostrano i più alti saggi di sviluppo industriale registrati negli ultimi anni. Ciò è noto. Meno noto è il fatto che i paesi che sono entrati in una fase di rapida industrializzazione sono numerosi: dal 1960 al 1978, in ben 32 paesi, con una popolazione totale di oltre 960 milioni di persone, il saggio di aumento ha superato, in media, il 6%; in altri 9 paesi, con una popolazione di circa 760 milioni, si è registrato un saggio di aumento compreso fra il 5 e il 6% (v. tab. X).
Per valutare il significato e le conseguenze di saggi di aumento di questo ordine di grandezza si tenga presente che un saggio del 5% comporta il raddoppio della produzione in circa 14 anni e che lo stesso risultato lo si ottiene in soli 10 anni con un saggio di circa il 7% (si tratta sempre di saggi composti). Certo, in paesi che partono da una base industriale estremamente limitata, come è stato per molti dei paesi ricordati, il raddoppio di tale base non significa ancora la presenza di dimensioni veramente rilevanti del settore industriale. Tuttavia, in molti di tali paesi, si è trattato di aumenti ben superiori: il saggio di aumento annuale è stato infatti in parecchi casi superiore al 9% e, inoltre, in alcuni di quei paesi la base di partenza era si limitata, ma non limitatissima.
In ogni modo, per tener conto anche dell'incidenza relativa raggiunta dal settore industriale, nella tab. X sono indicate tra parentesi anche le quote % dei lavoratori occupati nell'industria. Esaminando tali dati, non si può non riconoscere che una parte cospicua dell'umanità che vive nei paesi sottosviluppati è entrata ormai nella spirale dello sviluppo. Pur trattandosi di un obiettivo universalmente perseguito (l'alternativa di restare fuori dal meccanismo dello sviluppo è risultata non praticabile nelle condizioni moderne), è altrettanto universalmente riconosciuto che il processo di sviluppo, comunque portato avanti, risulta doloroso e gravido di contrasti e di tensioni. Il contrasto principale, destinato a durare a lungo anche se non indefinitamente, è quello fra il settore industriale moderno, nel quale le retribuzioni sono relativamente elevate e, da un certo momento in poi, in rapido aumento, e il settore tradizionale - agricoltura, artigianato e piccolo commercio - nel quale i guadagni restano a lungo molto inferiori a quelli del settore moderno. Le tensioni diventano particolarmente acute quando, per ragioni etniche e sociali, si creano situazioni ‛di ghetto', ossia là dove si formano o si rafforzano barriere che rendono arduo, a certi segmenti della popolazione, partecipare allo sviluppo ottenendone man mano i frutti. In molti casi, oltre alle tensioni interne risultano aggravate anche quelle esterne, tra paesi diversi. È motivo di amara riflessione osservare che il primo obiettivo del governo di un paese sottosviluppato che riesce a sollevarsi, sia pure in misura modesta, da una condizione di miseria generalizzata è spesso quello di sviluppare l'apparato militare, se non addirittura di attaccare paesi vicini, anch'essi sottosviluppati. Alcuni di questi conflitti sono stati voluti o provocati da una delle due superpotenze; ma altri sono nati da decisioni autonome. È doloroso constatare che uno dei commerci più lucrosi e importanti del mondo è quello delle armi: le superpotenze, insieme con le potenze minori, lo alimentano sia per ragioni economiche che per ragioni politiche.
12. Commercio estero e progresso tecnico
Sul più circoscritto piano economico, l'industrializzazione di un numero sempre maggiore di paesi sottosviluppati sta creando preoccupazioni crescenti nei paesi già industrializzati per la concorrenza dei prodotti provenienti da quei paesi, nei quali il costo del lavoro è pur sempre molto più basso. Su questo punto vanno fatte alcune osservazioni.
In primo luogo è opportuno sottolineare che, nel caso dei paesi considerati, non si tratta sempre di vera e propria concorrenza internazionale: in certi casi, come si è visto, si tratta della concorrenza che le grandi imprese di un paese sviluppato muovono ad altre imprese dello stesso paese o di altri paesi sviluppati, avvantaggiandosi del basso costo del lavoro che si registra in certi paesi sottosviluppati. In secondo luogo occorre ricordare che, se lo sviluppo industriale dei paesi sottosviluppati riguarda beni intermedi la cui produzione è stata praticamente abbandonata nei paesi sviluppati, non c e concorrenza, ma solo complementarità. Infine, non bisogna dimenticare che le esportazioni di un buon numero di paesi in via di sviluppo si dirigono più verso altri paesi sottosviluppati che verso i paesi industrializzati. Sono invece numerosi i paesi asiatici che incrementano le loro esportazioni, in particolare verso i paesi industrializzati; ma in questi casi si tratta solo in parte di vera concorrenza internazionale: per un'altra parte valgono invece le due osservazioni precedenti.
Una parte di queste tendenze sono illustrate dalla tab. XI, la quale indica alcune variazioni nelle quote delle esportazioni, nel periodo 1960-1978, dei primi due gruppi di paesi considerati nella tab. X. (Sono considerate le esportazioni totali, ma il quadro nella sostanza non cambia se si considerano le sole esportazioni industriali).
Se il crescente interscambio fra diversi paesi asiatici e i principali paesi industrializzati indica una crescente interdipendenza fra i due gruppi di paesi, con un'evidente supremazia dei secondi, si deve osservare che sono numerosi e importanti i paesi dell'America Latina che hanno accresciuto le esportazioni principalmente verso altri paesi sottosviluppati; pertanto, il grado di interdipendenza economica fra quei paesi e quelli industriali, segnatamente gli Stati Uniti, appare meno elevato di quanto generalmente si ritenga e comunque in diminuzione e non in aumento. È vero che diversi paesi sottosviluppati hanno accresciuto le loro esportazioni verso altri paesi sottosviluppati anche in conseguenza delle barriere che i paesi industrializzati hanno eretto a difesa delle loro produzioni; ed è ben comprensibile che i paesi sottosviluppati chiedano ai paesi industrializzati di ridurre le loro barriere o per lo meno di non elevarle ulteriormente, come è stato fatto per es. negli ultimi anni per proteggere i prodotti tessili. Nei paesi industrializzati le spinte verso il protezionismo sono cresciute a causa delle difficoltà conseguenti alla crisi petrolifera del 1974-1975; ma le possibili ritorsioni sarebbero tanto più dannose in quanto i paesi del Terzo Mondo che sono entrati in un processo di rapido sviluppo cominciano a rappresentare mercati assai promettenti: chi vende di più compra anche di più. In ogni modo, l'espansione dei traffici all'interno dei paesi sottosviluppati testimonia l'elevata capacità di sviluppo, nonostante tutto, di numerosi paesi del Terzo Mondo. Inoltre, sopra si è parlato di ‛quote': il valore assoluto delle esportazioni dei paesi arretrati verso quelli industrializzati è cresciuto praticamente in tutti i casi, ed è cresciuto a un saggio molto elevato, oltre il 10% l'anno; nell'ambito dei paesi arretrati le esportazioni sono cresciute a un saggio anche più elevato. Tali sviluppi riguardano le esportazioni dei prodotti industriali: quelle dei prodotti agricoli e minerari - a parte il caso del petrolio - sono aumentate a saggi molto minori; di conseguenza le esportazioni dei prodotti industriali, che nel 1960 rappresentavano solo l'11% delle esportazioni totali dei paesi arretrati, oggi rappresentano oltre il 30% e la quota è in aumento. Finora l'espansione delle esportazioni ha riguardato principalmente i prodotti industriali intermedi a tecnologie agevolmente accessibili, come i filati, i tessuti, certi componenti elettronici, l'acciaio, il cuoio, diversi prodotti chimici; le esportazioni di beni d'investimento e di beni finali di consumo sono cresciute molto meno: solo i più sviluppati fra i paesi arretrati, come la Spagna, la Iugoslavia, il Brasile e l'Argentina, sono riusciti a espandere queste esportazioni in misura significativa.
L'espansione del mercato costituisce una condizione essenziale dello sviluppo industriale e può dipendere sia dalla domanda interna (che, come si è accennato, è condizionata dallo sviluppo della produzione agricola) sia dalla domanda estera e quindi dallo sviluppo delle relazioni economiche internazionali. Tuttavia, le differenze che si registrano nello sviluppo industriale dei diversi paesi e nelle direzioni delle correnti di esportazione e di importazione mostrano l'inconsistenza delle interpretazioni che assegnano alla dotazione di ‛risorse' il ruolo principale nello sviluppo produttivo generale, anche se in alcuni paesi la disponibilità di certe risorse ha costituito un'importante condizione permissiva. Il ruolo principale spetta invece, come si è già osservato (v. cap. 3), alle conoscenze tecniche e organizzative e al loro progresso; le prime s'incorporano, di regola, in macchine, le seconde in strutture di vario genere, spesso create da leggi. In ultima analisi, tali innovazioni sono il risultato di idee nuove, scientifiche o organizzative, ma in questo campo è possibile anche un processo di imitazione e di diffusione, un processo che comporta adattamenti piuttosto che nuove idee. Ai fini dello sviluppo produttivo, un tale processo può essere - e per i paesi ritardatari è stato - non meno importante delle innovazioni originate da idee propriamente nuove.
Il progresso tecnico è all'origine del sistematico aumento della produttività per lavoratore; gli aumenti della produzione industriale cui poco fa si è fatto cenno e che in diversi casi superano il 9-10% l'anno dipendono solo assai limitatamente da un aumento dell'occupazione (1-2%): in parte dipendono dall'aumento, nell'aggregato, del peso delle industrie a più alta produttività rispetto a quelle a produttività più bassa, ma in gran parte dipendono piuttosto dal progresso tecnico.
In diversi importanti rami industriali è stato proprio il progresso tecnico e organizzativo a rendere necessario l'ampliamento delle dimensioni delle imprese: tutto sommato, le economie di scala (o di dimensione) sono essenzialmente il risultato di un processo dinamico. Sono proprio le economie di scala che hanno reso arduo, in quei rami industriali, uno sviluppo graduale e hanno richiesto l'intervento dello Stato anche nel settore industriale. Sebbene le economie di scala condizionino in modo determinante diversi importanti rami produttivi, lasciano pur sempre notevoli spazi alle piccole imprese: alcune di queste sono satelliti delle grandi, ma altre possono essere considerate autonome. Inoltre, certe recenti innovazioni tecnologiche, come le macchine a controllo numerico e certe innovazioni introdotte dall'industria elettronica, hanno addirittura accresciuto lo spazio per 19 sviluppo di unità piccole ed efficienti. Una volta raggiunta una certa diffusione dell'istruzione, questo fatto potrebbe avere grande importanza per i paesi sottosviluppati, poiché l'ampiezza dei tre ‛salti', di cui si e piu volte parlato, risulterebbe ridotta.
Numerosi economisti hanno messo in evidenza le conseguenze negative che comporta la dipendenza tecnologica dei paesi sottosviluppati rispetto agli altri: consolidamento della supremazia economica delle imprese straniere, freno allo sviluppo di un'industria meccanica locale, ostacolo allo sviluppo dell'occupazione (in quanto le macchine prodotte nei paesi sviluppati, che sono paesi ad alti salari, tendono a risparmiare lavoro). Lo sviluppo delle nuove tecnologie e delle piccole unità che le applicano può essere via via attuato anche localmente. Non ci si deve nascondere, però, che la questione della ristrettezza del mercato è solo uno degli ostacoli che si oppongono allo sviluppo industriale. Un altro ostacolo è il basso grado d'istruzione delle masse dei lavoratori: per far funzionare le macchine, infatti, e ancor più per fabbricarle o addirittura per crearle tenendo conto dei bisogni specifici dell'industria locale, è necessario un numero relativamente ampio e potenzialmente crescente di operai con una buona istruzione di base, di ingegneri e di amministratori con una buona istruzione superiore, oltre che di ricercatori e di specialisti con un addestramento universitario di livello elevato (ma questa terza condizione - non è un paradosso - è la più facile da realizzare). È dunque un fatto decisamente positivo, anche dal punto di vista economico, che negli ultimi anni i progressi compiuti da numerosi paesi sottosviluppati nel campo dell'istruzione siano stati ragguardevoli: nelle condizioni dell'industria moderna, tuttavia, la riduzione dell'analfabetismo costituisce di per sé un elemento di scarso peso, mentre rappresenta un progresso molto più importante nelle campagne, dove solo contadini non analfabeti possono apprendere nuove tecniche produttive (e metodi per programmare il numero dei figli).
Non alle risorse, dunque, ma al progresso delle conoscenze spetta il ruolo principale nel processo di sviluppo. Sulla disponibilità delle risorse, invece, ha insistito la teoria tradizionale del commercio estero (in particolare, la teoria dei costi comparati), secondo la quale ciascun paese ha convenienza a specializzarsi in quelle produzioni in cui ha una superiorità relativa, lasciando agli altri paesi la produzione di quei prodotti in cui esso è economicamente inferiore o in cui non ha una superiorità relativa, sempre in termini di costi. Questa teoria (originariamente proposta da Ricardo: Smith aveva una diversa concezione) è stata utilizzata a lungo per giustificare una divisione internazionale del lavoro caratterizzata da una rigida opposizione tra paesi industrializzati e paesi produttori di materie prime agricole e minerarie. Se è certo vero che lo scambio può essere spesso un mezzo più economico rispetto alla produzione diretta per procurarsi certi beni, è anche vero però che una tale proposizione - come quella, più raffinata, dei costi comparati - non può esser presa isolatamente. Bisogna tener conto della ineguale capacità di sviluppo delle diverse attività produttive (maggiore, per es., nel caso dell'industria manifatturiera rispetto ad altre attività) e del grado di occupazione della forza lavoro; così, se sono numerosi i disoccupati, non ha senso risparmiare lavoro. Infine, se si riconosce che la superiorità produttiva non dipende in primo luogo dalla disponibilità di risorse (essenziale solo nel caso delle risorse minerarie), ma dal grado di sviluppo delle conoscenze, ne discende che raccomandare una determinata specializzazione produttiva come un assetto relativamente stabile può avere significato per i paesi industrializzati, mentre ne ha assai meno per i paesi che intendono svilupparsi. Conseguenza di queste osservazioni è che per promuovere lo sviluppo industriale non si possono prescrivere, come regola generale, nè il liberismo nè il protezionismo, anche se si deve riconoscere che il protezionismo praticato dai paesi industrializzati tende a frenare lo sviluppo dei paesi arretrati.
13. Le politiche di sviluppo
Non c'è dunque e non ci può essere ‛una' politica di sviluppo: le politiche di sviluppo non possono non essere molteplici, secondo i tempi e secondo i paesi. Come si è osservato nei capitoli precedenti, alcune questioni riguardanti siffatte politiche, a causa dell'influenza culturale, oltre che tecnologica ed economica, dei paesi sviluppati, sono state trascurate o mal poste nei paesi sottosviluppati. Così, è stata trascurata la necessità di concentrare gli sforzi produttivi nei settori relativi ai beni essenziali - che poi, almeno in parte, è un altro modo per raccomandare un'azione, anche fiscale, volta a ridurre la diseguaglianza nella distribuzione del reddito - e non è stata messa in sufficiente rilievo l'opportunità di sviluppare tecnologie adatte alle esigenze locali, come l'esigenza di allargare l'occupazione nell'industria moderna e quella di favorire le piccole unità (senza sacrificio naturalmente per l'efficienza e fatto salvo lo sviluppo delle industrie di base, dove non possono operare che imprese di grandi dimensioni).
Un'altra questione importante, che si ricollega a un'analisi di R. Nurkse, riguarda la possibilità di mobilitare la ‛disoccupazione nascosta' nelle economie arretrate: una disoccupazione che si potrebbe definire ‛a intarsio temporale', giacché la gamma assai limitata di merci che vengono prodotte dalle piccole aziende contadine generalmente comporta periodi di ozio forzato. Se i contadini potessero essere mobilitati in questi periodi per opere di sistemazione dei terreni e delle acque, opere che possono essere compiute con l'ausilio di strumenti semplicissimi, si potrebbe ottenere un cospicuo aumento nella produttività della terra con un minimo impiego di capitale, non solo per il basso costo degli strumenti necessari, ma perché i contadini debbono nutrirsi anche nei periodi di ozio forzato e questo costo grava comunque sull'economia dei diversi paesi. (Programmi di questo genere sono stati attuati, su vasta scala e con notevole successo, in Cina. Il problema principale in queste imprese è quello organizzativo: si tratta di vedere chi mobilita e coordina i gruppi di contadini. In Cina questo ruolo è stato svolto dal Partito Comunista).
La mobilitazione dei disoccupati nascosti è un modo per rendere minimo il fabbisogno di capitale nella fase di avvio dello sviluppo agricolo in un paese arretrato. E proprio in questa fase che si presenta il problema di fondo dello sviluppo: il problema del ‛sovrappiù' e della sua destinazione.
Nella formulazione più semplice, la relazione fra sovrappiù e sviluppo può essere chiarita con un caso limite: una società primitiva, che produce quanto è appena sufficiente per la sua sopravvivenza, non può ‛accumulare', ossia non può distrarre dagli impieghi necessari nessuna quota della produzione corrente. Ciò è possibile solo se esiste, o se si forma a un certo momento, un sovrappiù, ossia un'eccedenza di prodotti rispetto agli impieghi necessari per la riproduzione. Se, dunque, concettualmente la definizione di sovrappiù non presenta difficoltà, i problemi sorgono quando si fa riferimento alle situazioni concrete, poiché i consumi necessari riferiti ai singoli soggetti non sono costanti, ma variano secondo le condizioni storico-sociali. Conviene allora distinguere il concetto di sovrappiù riferito a condizioni stazionarie e alla prima fase dello sviluppo dallo stesso concetto riferito a una situazione in cui il processo di sviluppo è già avviato. In questo secondo caso, si deve osservare che, ai fini dello sviluppo, non contano tanto i livelli, quanto gli ‛aumenti' dell'eccedenza agraria rispetto ai bisogni dei produttori e gli aumenti del prodotto industriale: man mano che si ottengono, infatti, quegli aumenti non sono ancora entrati nei consumi socialmente necessari e sono quindi ‛liberi'. Invece, in una fase in cui si tenta di avviare un processo di sviluppo, il concetto è diverso (è il concetto cui in sostanza facevano riferimento gli economisti classici): la grande massa della popolazione è in condizioni di grande povertà e non ha alcun sovrappiù utilizzabile per l'accumulazione; anzi, almeno per gli strati più poveri, il problema è di elevare subito i consumi proprio per accrescere la loro durata di vita e la loro capacità lavorativa. Gli strati più ricchi, invece, dispongono di un sovrappiù, di norma ottenuto sotto qualche forma di rendita agraria o di profitti commerciali, e possono anche disporre, come risultato di precedenti redditi netti, di ricchezze accumulate privatamente (per esempio oggetti preziosi, monete auree ecc.). Prima che venga avviato un processo di sviluppo, i soggetti appartenenti agli strati più ricchi consumano il sovrappiù in modi non produttivi (consumi di lusso, spese o investimenti all'estero); con l'avvio di un processo di sviluppo, una quota almeno dei redditi dei soggetti più ricchi deve essere destinata a impieghi produttivi, o per libera decisione di quei soggetti (risparmio) o per coazione, attraverso la politica fiscale. Sul piano della coazione si colloca anche la soluzione di una riforma agraria radicale, con l'intento di spostare una parte del reddito netto da coloro che l'impiegano in modo improduttivo verso coloro che presumibilmente lo impiegheranno (almeno in parte) in modo produttivo. Oltre che dai redditi interni, i mezzi per sostenere l'avvio di un processo di sviluppo possono venire anche dall'estero, sotto forma di aiuti e di prestiti. Sotto questo aspetto il sovrappiù di certi paesi relativamente ricchi diviene rilevante per l'accumulazione a livello mondiale.
Un altro mezzo per spostare una quota del reddito nazionale verso fini di accumulazione può essere, ed è stato, l'inflazione. In certi paesi l'inflazione è stata l'alternativa a una decisa azione redistributiva condotta attraverso il fisco. Si deve osservare, tuttavia, che l'inflazione ha colpito soprattutto certi strati dei redditieri medi e bassi, aggravando spesso la malnutrizione dei ceti più poveri. Più in generale, in diversi paesi, specialmente dell'America Latina, l'inflazione è la conseguenza, da un lato, di deficienze di tipo strutturale (in particolare: sistema fiscale, assetto della proprietà terriera e organizzazione del commercio dei prodotti agricoli) e, dall'altro, di particolari linee di politica economica (ampliamento delle spese pubbliche - produttive e improduttive, spese militari - e politica delle sistematiche svalutazioni, compiute, fra l'altro, a scopi di protezione di certe produzioni interne).
In generale, l'inflazione è piu grave nei paesi in cui piu acuti sono i conflitti sociali: fra i ceti privilegiati, che riescono a sottrarsi all'aumento della pressione fiscale, e gli altri ceti; fra l'esigua aristocrazia del lavoro, che riesce a ottenere retribuzioni che crescono con la stessa velocità o anche più rapidamente dei prezzi, e gli altri lavoratori. Sotto questo aspetto si comprende perché il processo inflazionistico sia più grave nei paesi dell'America Latina, meno grave nei paesi sottosviluppati dell'Asia e ancora meno nella maggioranza dei paesi africani.
L'armamentario delle misure di politica economica rivolte ad avviare e a sostenere un processo di sviluppo è diventato comunque sempre più ricco e articolato. A parte le già ricordate azioni di riforma, sulle quali ritorneremo, vi sono gli investimenti nelle cosiddette infrastrutture, gli investimenti diretti nell'industria e tutta una serie d'incentivi di tipo fiscale e creditizio.
14. Conflitti interni e conflitti internazionali
Quelli appena ricordati sono solo alcuni tipi di conflitti economici interni; ve ne sono altri, come quelli fra proprietari e amministratori di terre e di imprese, da un lato, e lavoratori, specialmente lavoratori salariati, dall'altro. Ma non ci sono solo conflitti economici; ci sono altre specie di conflitti, che si combinano con i primi: conflitti etnici, o razziali, e conflitti religiosi; anche questi hanno grande importanza e sbaglierebbe l'economista che pensasse di poterli ignorare. A loro volta, i molteplici conflitti interni sono condizionati dai conflitti internazionali. Dopo la seconda guerra mondiale i conflitti di tipo militare sono stati numerosi (non meno di 200) e terribilmente costosi in termini di vite umane - molto più costosi di quanto in generale si creda - ma sono stati conffitti militari circoscritti territorialmente e quasi tutti hanno avuto luogo nel Terzo Mondo. Il principale conflitto del nostro tempo, che ha condizionato tutti gli altri e che non ha assunto (e si spera che non assuma) carattere militare ma solo carattere politico, è quello fra Unione Sovietica e Stati Uniti. Si deve osservare che il problema dei paesi sottosviluppati è divenuto d'importanza primaria a livello internazionale come conseguenza della rivalità, politica e ideologica, delle due superpotenze.
Solo in questo dopoguerra i problemi del Terzo Mondo hanno raggiunto dimensioni gravissime, soprattutto come conseguenza dell'esplosione demografica. Quei problemi erano gravi già prima e non pochi uomini di cultura avevano denunciato la situazione; ma fino alla seconda guerra mondiale molti di quei paesi erano ancora colonie ed erano quindi oggetti e non soggetti della politica internazionale. Si può stabilire un parallelo tra l'evoluzione dei problemi del Terzo Mondo e quella del problema della schiavitù: per secoli uomini di cultura (laici e religiosi) avevano denunciato le atrocità della schiavitù e ne avevano proposto l'abolizione, ma solo quando si furono sviluppate vigorose spinte provenienti dalla convenienza economica dei gruppi sociali di certi paesi coloniali o già coloniali si arrivò all'abolizione della schiavitù. Anche in questo caso, tuttavia, sarebbe erroneo trascurare o sottovalutare l'importanza delle spinte culturali, specialmente quelle di tipo democratico ed egualitario che hanno caratterizzato la cultura europea negli ultimi due secoli: le spinte dei due ordini si affermano solo quando, combinate, superano una certa intensità.
Comunque sia, in questo dopoguerra, soprattutto per iniziativa delle Nazioni Unite (ma anche per iniziativa della Comunità Economica Europea), sono stati deliberati importanti aiuti finanziari a carico dei paesi industrializzati e a favore dei paesi sottosviluppati, e sono stati organizzati anche aiuti tecnici, specialmente attraverso la FAO. Secondo i programmi iniziali gli aiuti avrebbero dovuto ascendere all'1% del reddito dei paesi industrializzati, per contribuire in modo significativo ai piani di sviluppo dei paesi arretrati. Nella realtà gli aiuti sono stati sensibilmente inferiori a tale percentuale, come risulta dalla tab. XII. Anche più grave è il fatto che una quota non precisabile, ma certo rilevante, di questi aiuti non riguarda lo sviluppo produttivo, ma gli armamenti. Nella stessa tab. XII è indicato l'ordine di grandezza dei prestiti netti, a medio e a lungo termine, pubblici o garantiti da organismi pubblici (sono, fra questi, i prestiti concessi dalla Banca Mondiale); sono poi indicati anche i livelli e le percentuali cui dovrebbero arrivare, in un tempo relativamente breve, rispettivamente i prestiti e gli aiuti secondo il Rapporto Brandt (un rapporto sul Terzo Mondo elaborato di recente da una Commissione internazionale indipendente presieduta dall'ex cancelliere tedesco Willy Brandt). Questo Rapporto sottolinea che nel 1978 le spese militari, nel mondo, ammontavano a 450 miliardi di dollari, mentre gli aiuti (in parte militari) ammontavano solo a 20 miliardi.
Oltre le spinte politiche di carattere generale, di cui si è già detto, alcune vicende e condizioni particolari hanno accresciuto il peso politico di un gruppo di paesi sottosviluppati, ma in via di rapido sviluppo, e cioè dei paesi arabi. Le vicende sono, principalmente, quelle delle guerre fra paesi arabi e Israele. Le condizioni particolari sono quelle, in ultima analisi, determinate dal rapido sviluppo di un numero crescente di paesi e dal ruolo essenziale che in tale sviluppo gioca il petrolio. L'enorme aumento del prezzo del petrolio e, quasi contemporaneamente, il cospicuo aumento dei prezzi delle materie prime sono fenomeni che vanno collegati anche alla crisi del sistema monetario internazionale, cominciata nel 1971 e non ancora risolta, crisi che ha acuito le spinte speculative sui mercati internazionali delle materie prime, i cui prezzi hanno registrato fluttuazioni molto più ampie di prima e rivolte più verso l'alto che verso il basso. Il risultato di queste tensioni è stato un'accentuata pressione inflazionistica a livello mondiale. (L'aumento assoluto e relativo nel prezzo del petrolio ha decisamente favorito certi paesi sottosviluppati, ma ne ha danneggiati altri, soprattutto nella fascia dei paesi a reddito basso. Tuttavia, poiché sono aumentati anche i prezzi assoluti e relativi di diverse materie prime, altri paesi sottosviluppati hanno ottenuto vantaggi).
Numerosi economisti hanno elaborato proposte di riforma del sistema monetario internazionale; e anche lo stesso Rapporto Brandt, come si è detto, ne formula alcune. Molte di queste proposte riguardano, in modo particolare, i cosiddetti diritti speciali di prelievo, che costituiscono una sorta di moneta creditizia internazionale, già esistente ma, finora, di limitata importanza. I paesi industrializzati dovrebbero accordarsi per allargare l'uso dei diritti speciali di prelievo come moneta di riserva e come strumento di finanziamento dei traffici mondiali; contemporaneamente, dovrebbero essere resi più liberali i criteri seguiti dalla Banca Mondiale per finanziare i progetti di sviluppo dei paesi arretrati. La conseguenza sarebbe un allargamento del credito a breve termine, di competenza del Fondo Monetario Internazionale, e del credito a lungo termine, di competenza della Banca Mondiale, con vantaggio precipuo dei paesi arretrati. In ogni modo la riforma del sistema monetario internazionale non può avere alcun ragionevole successo se non si fonda su una rete coordinata di accordi internazionali, volti a stabilizzare i prezzi del petrolio e delle principali materie prime e a regolare gli approvvigionamenti di questi prodotti. Alcuni passi in questa direzione sono stati compiuti, ma è necessario andare avanti con decisione molto maggiore.
Si è osservato che, in ultima analisi, i cospicui aumenti nei prezzi del petrolio e di molte materie prime sono stati determinati da un processo di sviluppo che si è ormai generalizzato sul piano mondiale. Alcuni studiosi hanno formulato previsioni molto pessimistiche sul progressivo esaurimento del petrolio e di altre risorse minerarie. Queste previsioni non danno però il giusto peso alle risorse della tecnologia e alle possibilità di nuove scoperte. (Per es., per il petrolio i paesi dell'Africa centrale sembrano avere prospettive molto promettenti). Se mai la scarsezza relativa, almeno per periodi non brevi, di certe materie prime potrà determinare, come ha già determinato, aumenti nei costi industriali e, per questa via, un ulteriore indebolimento del processo di sviluppo dei paesi industrializzati. Ma una cosa è l'indebolimento di un tale processo, un'altra il suo arresto. Un saggio più lento di sviluppo dei paesi industrializzati non costituisce un problema dal punto di vista della disponibilità dei beni; costituisce piuttosto un problema sotto l'aspetto dell'assorbimento delle nuove leve di lavoro - un problema peraltro risolubile nel lungo periodo con la riduzione delle ore lavorate da ciascun lavoratore. Tuttavia, l'indebolimento dello sviluppo di quei paesi indirettamente tende a frenare lo sviluppo dei paesi arretrati, parecchi dei quali sono già stati colpiti dal rincaro del prezzo del petrolio: questo è un problema più grave sotto ogni aspetto. Il primo passo per scongiurare il rallentamento nello sviluppo dei paesi arretrati consiste nell'accrescere prestiti e aiuti: quanto finora si è fatto è insufficiente.
Oltre ai prestiti e agli aiuti di carattere finanziario, i paesi industrializzati, direttamente o tramite l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dovrebbero fornire in maggior misura aiuti tecnici. Una tale raccomandazione è contenuta nello stesso Rapporto Brandt, anche se forse questo Rapporto non dà suggerimenti sufficientemente precisi sull'aiuto internazionale necessario per la formazione su larga scala di esperti agrari e non dedica al problema dell'acqua l'attenzione che esso meriterebbe. (In diversi importanti paesi africani c'è un problema di grave scarsezza d'acqua, che provoca periodicamente drammatiche siccità e che andrebbe affrontato anche attraverso un programma di ricerche idrogeologiche di ampie proporzioni; in diversi paesi asiatici, invece, specialmente in certe stagioni c'è il problema opposto, che andrebbe affrontato con un programma sistematico per il controllo delle acque). Comunque, gli aiuti finanziari dei paesi industrializzati possono servire, soprattutto nel futuro immediato, per attenuare l'angoscioso problema della fame e della malnutrizione che, come si è ricordato, colpisce più di un sesto del genere umano, mentre gli aiuti tecnici - assistenza e programmi speciali - possono contribuire ad accelerare lo sviluppo produttivo, soprattutto nell'agricoltura.
15. Gli obiettivi dello sviluppo e le prospettive economiche
Negli ultimi tempi ha perso sempre più terreno l'opinione secondo cui i paesi sottosviluppati sarebbero costretti a ripetere la via percorsa dai paesi oggi sviluppati. Abbiamo già mostrato che le vie finora percorse sono state in realtà diverse e diversi sono stati gli obiettivi perseguiti: molte indicazioni inducono a ritenere che le differenze, già notevoli, andranno crescendo in futuro.
In primo luogo, c'è una spiegazione naturale molto semplice di queste differenze: il clima, tropicale o equatoriale, della maggior parte dei paesi arretrati comporta diversi (e più limitati) obiettivi di consumo. (Questo è un altro motivo per cui le distanze economiche fra i paesi sviluppati e gli altri, per quanto riguarda l'industria, tendono a essere sopravvalutate). Oltre alla spiegazione di carattere naturale, c'è poi un altro motivo di carattere storico. Oggi, nei paesi sviluppati, sono diffuse le critiche al consumismo, ossia alla frenesia per ogni sorta di beni di consumo, utili o inutili o addirittura dannosi nel senso precedentemente specificato. È vero che i gruppi ristretti di privilegiati dei paesi arretrati tendono a imitare il modello di consumo dei paesi industrializzati; ma è anche vero che un'azione politica volta a contrastare questa influenza potrebbe avere successo, specialmente in certi paesi, come quelli asiatici, che hanno diverse tradizioni culturali. D'altra parte gli stessi sindacati di quella che è stata chiamata aristocrazia operaia si battono per ottenere - e hanno in gran parte già ottenuto - una settimana lavorativa eguale a quella attuale dei paesi industrializzati e non a quella prevalente nel passato, quando questi paesi si trovavano in condizioni di sviluppo analoghe a quelle degli attuali paesi arretrati. Ciò può indicare che i lavoratori tendono a preferire un minor lavoro subito a un consumo più rapidamente crescente. (Ricordiamo che al principio dell'Ottocento nei paesi allora in via di sviluppo la settimana lavorativa superava le 90 ore, mentre oggi nei paesi industrializzati è scesa a 40 ore). Se saranno portati avanti con giudizio e con misura - e attraverso azioni concertate sul piano internazionale - i programmi di riduzione delle ore settimanali potranno avere successo. Si tratta di un'evoluzione auspicabile, specialmente per i paesi sviluppati, dove i bisogni ‛essenziali' sono stati soddisfatti da un pezzo; ma si tratta di un'evoluzione che mostra quanto sia sbagliato concentrare l'attenzione sugli aspetti puramente quantitativi della produzione.
V'è poi la questione dell'inquinamento. I governi dei paesi sottosviluppati, che non siano governi asserviti a interessi stranieri, debbono imporre norme severe alle imprese intenzionate ad attuare investimenti inquinanti nei loro paesi, senza farsi fuorviare dall'argomento dell'aumento dell'occupazione. L'economista W. Leontief ha calcolato che l'eliminazione pressoché totale dell'inquinamento nelle aree industriali del mondo comporterebbe un costo non superiore all' 1,5-2% del reddito di ciascun paese: un costo non trascurabile, ma neppure proibitivo; un costo che potrà essere generalmente sopportato solo con specifici accordi internazionali che pongano le imprese di tutti i paesi in condizioni di relativa parità.
Un modello, anzi, un gruppo di modelli radicalmente diversi da quelli delle economie dette di mercato è rappresentato dalle economie pianificate. I modelli sono fondamentalmente di due categorie: quelli che si rifanno all'Unione Sovietica e quelli che si rifanno alla Cina. Prima delle rivoluzioni che hanno condotto ai nuovi sistemi sociali, Russia e Cina erano paesi gravemente arretrati: la popolazione, in grande maggioranza occupata in agricoltura, aveva per lo più un tenore di vita bassissimo; gli operai dell'industria moderna rappresentavano un'esigua minoranza fra i lavoratori occupati (meno del 10%).
Da un punto di vista qualitativo, non pare che si sia data sufficiente importanza alla storia del primo paese che ha intrapreso la strada della pianificazione centralizzata: l'Unione Sovietica. Si tratta di una storia in cui l'esperienza liberal-democratica (o fase democratico-borghese) è stata quasi completamente assente. I metodi autoritari e centralizzati dell'antico regime per diversi aspetti si ritrovano, in forma più efficiente e penetrante, nel nuovo sistema economico-sociale.
Da un punto di vista quantitativo, l'andamento dello sviluppo economico dei paesi a economia pianificata, pur attraverso alterne vicende, induce a un giudizio positivo, anche se il ritmo di sviluppo nel complesso non appare superiore a quello dei paesi a economia non pianificata, lasciando da parte il caso dei paesi esportatori di petrolio (v. tab. XIII).
Un confronto particolare conviene compiere tra l'India e la Cina, due grandi paesi orientali che, pur avendo straordinarie tradizioni culturali, sono partiti entrambi da livelli economici molto bassi. Il primo paese, l'India, ha un'economia nella sostanza di mercato, anche se il settore industriale pubblico è relativamente importante e anche se la struttura sociale è caratterizzata da una forte eredità derivante dalla struttura antica; il secondo paese, la Cina, ha un'economia pianificata, ma assai meno centralizzata di quella sovietica. Il confronto, come appare dalla sintesi della tab. XIV, sembra favorevole alla Cina; probabilmente, risulterebbe ancora più favorevole se si potesse confrontare la distribuzione del reddito.
16. Riforme e rivoluzione
L'esperienza cinese aveva fatto sorgere in Asia, ma non solo in Asia, la speranza che attraverso una rottura rivoluzionaria si potesse uscire rapidamente dall'arretratezza e addirittura cambiare, in un senso più umano, i contenuti stessi della vita sociale. In seguito, Cuba ha fatto sorgere analoghe attese in America Latina. E poi venuto il tempo delle delusioni, tanto più gravi quanto più forti erano state le illusioni. I due esperimenti non si possono dire falliti, ma i costi sono apparsi molto alti rispetto ai risultati: si è visto che la strada delle trasformazioni sociali non ammette scorciatoie. La rivoluzione cinese aveva alle sue spalle una lunga storia e quindi un'assai complessa e tormentata preparazione; considerata la base di partenza, quel che è stato realizzato in Cina è certo un risultato degno del massimo rispetto e addirittura di ammirazione anche da parte di quanti non condividono la composita ideologia cinese; tuttavia, non solo il sistema economico e sociale, ma neppure il metodo adottato dai cinesi si presenta come un prodotto esportabile; e altrettanto poco esportabile appare l'esperienza rivoluzionaria cubana.
Numerosi intellettuali, europei e non europei (specialmente latino-americani) si erano andati convincendo che, nel Terzo Mondo, solo una soluzione rivoluzionaria avrebbe potuto fornire a quei paesi una via d'uscita dal sottosviluppo, perché l'oppressione dell'imperialismo americano era tale da rendere non praticabili le altre vie: l'alternativa sarebbe stata tra cambiare violentemente le cose attraverso una rivoluzione o marcire senza scampo in una palude economica e sociale.
Alcuni importanti mutamenti, avvenuti negli ultimi anni, hanno però fatto tentennare, in diversi intellettuali, una tale convinzione. In primo luogo, le delusioni provocate dall'evoluzione della Cina e di Cuba; in secondo luogo, l'accentuarsi dell'espansionismo sovietico e l'accresciuta autonomia - se pure condizionata e circoscritta - di molti paesi del Terzo Mondo nei confronti sia dell'Unione Sovietica che degli Stati Uniti. Infine - ed è forse l'elemento decisivo - negli ultimi anni si è dimostrata sempre più erronea la convinzione che il sottosviluppo, senza una rottura rivoluzionaria, sia destinato a perpetuarsi e anzi ad aggravarsi (lo sviluppo del sottosviluppo). Per convincersene, basta riflettere sui dati della tab. II. Ma c'è un caso esemplare da considerare a questo proposito. Nel 1967 due futurologi americani, Kahn e Wiener, avevano formulato una previsione secondo cui al Brasile occorrevano non meno di 130 anni per raggiungere il livello del reddito individuale americano di quell'anno. Nè Kahn nè Wiener erano intellettuali di estrema sinistra. Ciononostante, un intellettuale brasiliano dichiaratamente rivoluzionario, Darcy Ribeiro, accettò senza riserve quella previsione, probabilmente perché sembrava dare piena conferma alla sua convinzione della mancanza di alternative a una soluzione rivoluzionaria. Pochi anni sono stati sufficienti per mostrare che quella previsione era infondata, a causa sia di una premessa errata, sia di un fatto nuovo intervenuto nel frattempo. L'errore era quello di usare acriticamente, come termine di confronto, il rapporto fra il reddito individuale americano e quello brasiliano (già prima del 1967 alcuni economisti avevano messo in guardia contro i possibili equivoci insiti nella procedura allora e tuttora generalmente seguita nel calcolo). Il fatto nuovo è stato il notevole sviluppo realizzato dal Brasile negli anni settanta, cosicché già il rapporto non corretto fra i due redditi individuali oggi è molto diminuito rispetto a quindici anni fa; ancora più basso risulta il rapporto corretto. In ogni modo, nessun economista o futurologo serio assegnerebbe oggi la minima validità alla previsione di Kahn e Wiener. È vero che il recente sviluppo brasiliano è stato molto sbilanciato e finora è andato, in prevalenza, a beneficio di una minoranza di persone: alti funzionari e impiegati privati e pubblici, industriali, privati e pubblici, commercianti, proprietari terrieri e, inoltre, una frazione non trascurabile della classe operaia (l'anstocrazia del lavoro); un'altra parte, la più ampia, della classe operaia, come anche i contadini, hanno ottenuto miglioramenti relativamente modesti; i lavoratori marginali o precari, numerosi soprattutto nel Nord del Brasile, dal loro canto, sono rimasti quasi del tutto tagliati fuori dai benefici dello sviluppo. Tutto questo è certo vero, ma escludere che con la prosecuzione dello sviluppo si possa progressivamente allargare la cerchia delle persone che partecipano ai frutti dello sviluppo stesso significa essere gravemente condizionati da preconcetti ideologici. D'altro canto, se è facile pervenire a conclusioni pessimistiche nell'esaminare le condizioni di ampi strati della popolazione in paesi come il Brasile, diventa molto difficile indicare le forze sociali che dovrebbero attuare la rivoluzione. Su chi si dovrebbe far leva? Sulla schiera infelice e disorganizzata dei lavoratori marginali? Sui contadini poveri che si trovano in condizioni non molto diverse da quelle dei lavoratori marginali? Su una classe operaia divisa fra un gran numero di operai sparpagliati in tante piccole aziende e un'aristocrazia operaia che ha l'orrore di precipitare nell'area dei lavoratori marginali ed è gelosa di quel che è riuscita a conquistare? Marx vedeva nel proletariato creato dall'industria moderna la forza rivoluzionaria per eccellenza. Ma nelle condizioni odierne lo sviluppo industriale non può non essere avviato da un nucleo di grandi imprese, che si fondano su impianti di ampie dimensioni e che sono in grado di pagare - e per la pace sociale nell'azienda sono disposte a pagare - alti salari: queste imprese non possono quindi non generare un'aristocrazia operaia che via via si allarga solo col procedere dello sviluppo industriale, ma che non sembra, nè al principio nè poi, incline a fare rivoluzioni. E in effetti i pochi tentativi rivoluzionari sono stati promossi da minoranze di intellettuali piccolo-borghesi che hanno fatto leva su frange molto limitate di operai e di contadini; tutti i tentativi rivoluzionari che non avevano alle spalle - e probabilmente non potevano avere - una valida base sociale, sono finiti in bagni di sangue e in dittature fasciste.
Abbiamo ricordato il caso del Brasile, il cui sviluppo sta smentendo le previsioni catastrofiche di futurologi e di altri intellettuali. Ma il numero dei paesi arretrati che sono entrati in una spirale di rapido sviluppo è cresciuto e va ulteriormente crescendo, senza che siano intervenute rivoluzioni, anche se (com'è inevitabile) ciò è accaduto in mezzo a ogni sorta di tensioni, di sofferenze e di conflitti. Ciò mostra che la via delle trasformazioni profonde, ma non traumatiche, può essere percorsa; mostra anche che le visioni (e le previsioni) catastrofiche non sono fondate. Tuttavia, pur essendo infondate, quelle visioni non sono irrilevanti, perché spingono a radicalizzare le ideologie politiche, non solo verso l'estrema sinistra, ma anche, per reazione, verso l'estrema destra; inoltre sono le ideologie che, combinate con interessi economici e di potere, guidano in ultima analisi la vita politica per il bene o per il male. Se poi si considera il ruolo svolto dagli intellettuali, particolarmente nella vita politica dei paesi arretrati, si ricava quanto sia importante approfondire il dibattito sulle riforme che occorrono per avviare lo sviluppo o, meglio, per indirizzarlo verso obiettivi socialmente e civilmente validi e per ridurre le pene del processo di trasformazione. Le riforme fondamentali di questo processo - oramai è chiaro - sono quattro: la riforma agraria, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma fiscale e, infine, la riforma del sistema educativo, con particolari riflessi sull'agricoltura. A questo proposito occorre tuttavia esser molto cauti, perché le stesse etichette possono essere applicate ai contenuti più diversi. Così, la riforma agraria può essere ampia o circoscritta; può essere realizzata a beneficio della massa dei contadini poveri ovvero delle fasce più ristrette dei contadini medi o ricchi; può essere o non essere accompagnata da misure di assistenza creditizia e tecnica. E distinzioni analoghe valgono anche per le altre riforme.
La politica delle riforme, che negli ultimi cento anni in diversi paesi europei ha avuto successi di rilievo, sia pure attraverso aspre lotte e temporanei regressi, nei paesi del Terzo Mondo è sembrata a lungo, come si è detto, destinata a un quasi certo fallimento, sia per la gravità dei problemi che per la debolezza delle forze riformiste. In certi paesi, come quelli per es. dell'America Latina, le prospettive di una politica riformista sembrano oggi ancora più oscure non solo per la forza relativa delle classi privilegiate, ma anche perché gli Stati Uniti, che in quella parte del mondo vantano i maggiori interessi economici e politici, hanno spesso appoggiato le forze più reazionarie. Tuttavia, a differenza dei programmi rivoluzionari quelli riformisti possono trovare sostenitori in quasi tutte le classi e categorie sociali. D'altra parte, le intenzioni sono poco rilevanti: si possono promuovere riforme con obiettivi di trasformazione, che poi vengono frustrati, e viceversa.
La via delle riforme è certo ardua, ma una conclusione totalmente pessimistica non sarebbe giustificata, per diverse ragioni che qui mi limito a elencare: a) se le forze riformiste hanno di fronte prospettive difficili, quelle rivoluzionarie ne hanno di ancora peggiori; anzi, nelle attuali condizioni storiche rischiano di creare solo tremende illusioni; b) non è giusto guardare soltanto al lato oppressivo e imperialistico del ruolo svolto dagli Stati Uniti: le tradizioni liberali e democratiche americane non sono state completamente cancellate neppure nei periodi più oscuri della loro storia, cosicché non è affatto inevitabile che gli Stati Uniti debbano appoggiare le forze reazionarie; c) se si considera la storia di certi importanti paesi latino-americani, come il Messico e il Venezuela, non si può parlare di totale fallimento delle forze riformiste, mentre si può invece parlare di fallimento e comunque di mancanza di prospettive delle forze rivoluzionarie; d) sebbene sbilanciati e circoscritti, i progressi economici compiuti da numerosi paesi latino-americani senza rotture traumatiche mostrano che la rivoluzione non è l'unica alternativa al sottosviluppo; e) infine, non deve essere trascurato l'aiuto politico che può venire - e che in qualche misura è già venuto - dalle forze riformiste europee, aiuto che gli Stati Uniti non possono permettersi di avversare decisamente.
In definitiva, per i paesi latino-americani non è lecito alcun facile ottimismo e anzi, nel breve periodo, i motivi di preoccupazione prevalgono, specialmente se si considerano le dichiarate intenzioni degli Stati Uniti. Ma, almeno con riferimento al medio e lungo periodo, un totale pessimismo sarebbe egualmente ingiustificato, oltre che sterile.
Le prospettive economiche del Terzo Mondo non appaiono oramai cosi cupe come apparivano fino a pochi anni fa. L'espansione demografica mostra chiari segni di rallentamento e il numero dei paesi che sono entrati in una spirale di rapido sviluppo industriale è cresciuto e sta crescendo. D'altra parte, due problemi che riguardano l'umanità intera non appaiono più così drammatici come prima apparivano: l'inquinamento può essere messo sotto controllo (in parte, sia pure ancora modesta, ciò è già accaduto); gli allarmi per l'esaurimento di certe risorse minerarie e di alcune fonti energetiche hanno messo in evidenza un problema di costi crescenti piuttosto che un problema di paralisi nello sviluppo. Il vero incubo, per l'umanità, è ancora rappresentato dal rischio di un olocausto nucleare. Questo rischio è anzi aumentato negli ultimi anni per la proliferazione delle armi atomiche, accessibili oramai a un numero crescente di paesi sottosviluppati, che hanno dimostrato di non essere affatto meno aggressivi delle grandi potenze. Anche in considerazione di un tale terribile rischio, reso più grave dalle connessioni tra conflitti interni e conflitti internazionali, l'intellettuale deve sforzarsi di controbattere, invece di alimentare, le ideologie e i programmi fondati sulla violenza.
bibliografia
Agarwala, A. N., Singh, S. P. (a cura di), The economics of underdevelopment, New York 1963 (tr. it.: L'economia dei paesi sottosviluppati, Milano 1966).
Arrighi, G., Sviluppo economico e sovrastrutture in Africa, Torino 1969.
Bairoch, P., Révolution industrielle et sous-développement, Paris 1964 (tr. it.: Rivoluzione industriale e sottosviluppo, Torino 1967).
Baran, P., The political economy of growth, New York 1957 (tr. it.: Il surplus economico e la teoria marxista dello sviluppo, Milano 1962).
Barros de Castro, A., Ensaios sôbre a economia brasileira, São Paulo 1969.
Bauer, B. T., Yamey, B. S., The economics of under-developed countries, Cambridge 1957.
Berardi, G. F., Saggio sullo sviluppo economico dei paesi arretrati, Milano 1969.
Bhagwati, J. N., Eckaus, R. S. (a cura di), Development and planning: essays in honor of Paul Rosenstein Rodan, Cambridge, Mass., 1973.
Brandt, W., North-South. A programme for survival, New York 1980 (tr. it.: Rapporto Brandt Nord-Sud. Un programma per la sopravvivenza, Milano 1980).
Chenery, H. e altri, Redistribution with growth, London 1971.
Chenery, H., Keesing, D., The changing composition of developing country exports, in The world economic order: past and prospects (a cura di S. Gressman ed E. Lundberg), London 1981.
Clark, C., The conditions of economic progress, London 1957.
De Giorgi, U., Un'analisi critica della teoria del sottosviluppo, in ‟Politica internazionale", ottobre-novembre 1978.
Eckaus, R. S., The factor proportions problem in underdeveloped areas, in ‟American economic review", 1955, XLV.
Ellis, H. S. (a cura di), Economic development for Latin America, New York-London 1961.
FAO, La quatrième enquête mondiale sur l'alimentation, Roma 1977.
Filippi, A., Teoria e storia del sottosviluppo latinoamericano, 2 voll., Napoli 1981.
Frank, A. G., Riflessioni sulla nuova crisi economica mondiale, Catania 1978.
Fuà, G., Problemi dello sviluppo tardivo in Europa. Rapporto su sei paesi appartenenti all'OCSE, Bologna 1980.
Furtado, C., Formação econômica do Brasil, Rio de Janeiro 1959 (tr. it.: La formazione economica del Brasile, Torino 1970).
Furtado, C., Théorie du développement économique, Paris 1970 (tr. it.: Teorie dello sviluppo economico, Bari 1972).
Galbraith, J. K., The nature of mass poverty, New York 1979 (tr. it.: La natura della povertà di massa, Milano 1980).
Germani, G., Sociologia della modernizzazione, Bari 1971.
Gerschenkron, A., Economic backwardness in a hsitorical perspective, Cambridge, Mass., 1962 (tr. it.: Il problema storico dell'arretratezza economica, Torino 1965).
Gilbert, N. e altri, Comparative national products and price levels, Paris 1958.
Guerrieri, P., Luciani, G., L'Italia e il nuovo ordine internazionale, Milano 1979.
Hirschman, A. O., The strategy of economic development, New Haven 1958 (tr. it.: La strategia dello sviluppo economico, Firenze 1968).
Jossa, B. (a cura di), Economia del sottosviluppo, Bologna 1973.
Kahn, A. E., Investment criteria in development programs, in ‟Quarterly journal of economics", 1951, LXV.
Kahn, H., Wiener, A., The year 2000, New York 1967 (tr. it.: L'anno 2000, Milano 1968).
Kalecki,. M., The last phase in the transformation of capitalism, New York-London 1972.
Kalecki, M., Essays on developing countries, Hassocks 1976.
Kindleberger, C. P., The terms of trade: a European case study, Cambridge, Mass., 1956.
Kravis, I. B., Heston, A. W., Summers, R., Real GDP per capital for more than one hundred countries, in ‟The economic journal", 1978, LXXXIII.
Kula, W., Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego. Pròba modelu, Warszawa 1962 (tr. it.: Teoria economica del sistema feudale. Proposta per un modello, Torino 1970).
Kuznets, S., Economic growth and structure, New York 1965 (tr. it.: Sviluppo economico e struttura, Milano 1965).
Lacoste, Y., Géographie du sous-développement, Paris 1965 (tr. it.: Geografia del sottosviluppo, Milano 1968).
Leontief, W. e altri, The future of the world economy, New York 1977.
Lewis, W. A., Economic development with unlimited supply of labour, in ‟The Manchester school", maggio 1954 (tr. it.: Sviluppo economico con disponibilità illimitate di mano d'opera, in Economia del sottosviluppo, a cura di B. Jossa, Bologna 1973).
Lewis, W. A., The theory of economic growth, London 1955 (tr. it.: Teoria dello sviluppo economico, Milano 1963).
Marrama, V., Saggio sullo sviluppo economico dei paesi arretrati, Torino 1958.
Marx, K., Das Kapital, 3 voll., Hamburg 1867-1894 (tr. it.: Il capitale, 3 voll., Roma 1970).
Meier, G. M., Leading issues in economic development, New York 1964.
Myint, H., The economics of developing countries, London 1969 (tr. it.: L'economia dei paesi in via di sviluppo, Bologna 1973).
Myrdal, G., Asian drama. An inquiry into the poverty of nations, 3 voll., London 1968 (tr. it.: Saggio sulla povertà di undici paesi asiatici, Milano 1971).
National Bureau of Economic Research, Foreign trade regimes and economic development, New York 1975.
Nurkse, O., Problems of capital formation in underdeveloped countries, Oxford 1958 (tr. it.: La formazione del capitale nei paesi sottosviluppati, Torino 1965).
Pareto, V., Manuale di economia politica, Milano 1906.
Pasinetti, L. L., I problemi dello sviluppo economico e i paesi del terzo mondo', in ‟Rivista internazionale di scienze sociali", 1972, LXXX.
Patel, S. J., The economic distance between nations: its origin, measurement and outlook, in ‟The economic journal", 1964, LXXIV.
Ribeiro, P., El dilema de América Latina, Ciudad de México 1971 (tr. it.: Il dilemma dell'America Latina, Milano 1976).
Ricardo, D., On the principles of political economy and taxation, London 1821 (tr. it.: Sui principî dell'economia politica e della tassazione, Milano 1976).
Robinson, J., Aspects of development and undervedelopment, Cambridge 1979 (tr. it.: Sviluppo e sottosviluppo, Bari 1981).
Robson, P., Lury, D. A., The economics of Africa, London 1969.
Rosenstein Rodan, P. N., Problems of industrialization of eastern and south-eastern Europe, in ‟The economic journal", 1943, LIII.
Rosenstein Rodan, P. N., Notes of the theory of the ‛Big Push', in Economic development for Latin America (a cura di H. S. Ellis), New York-London 1961.
Sachs, I., La découverte du Tiers Monde, Paris 1971.
Sachs, I., Stratégies de l'écodéveloppement, Paris 1980.
Seers, D., Joy, L. (a cura di), Development in a divided world, Harmondsworth 1971.
Singer, P., A crise do ‛Milagre' - Interpretação critica da economia brasileira, Rio de Janeiro 1978.
Smith, A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776), London 1977 (tr. it.: Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, 2 voll., Milano 1977).
Spaventa, L. (a cura di), Nuovi problemi di sviluppo economico, Torino 1962.
Streeten, P., The frontiers of development studies, London 1972.
Streeten, P., Foreign investment, transnational and developing countries, London 1977.
Sylos-Labini, P., Precarious employment in Sicily, in ‟International labour review", 1964, LXXXIX.
Sylos-Labini, P., Problemi dello sviluppo economico, Bari 1970.
Sylos-Labini, P. e altri, Problemi dell'economia siciliana, Milano 1964.
Tinbergen, J. (a cura di), Reshaping the international order (RIO) - Report to the Club of Rome, New York 1976 (tr. it.: Progetto Rio per la rifondazione dell'ordine internazionale, Milano 1977).
Tsuru, S., Essays on economic development, Tokyo 1968.