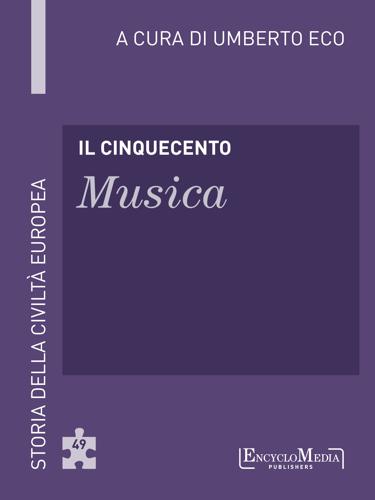Tomás Luis de Victoria
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Victoria è il più grande compositore spagnolo del Cinquecento e una delle principali figure della civiltà musicale dell’Europa rinascimentale. Per secoli il suo stile sarà, insieme a quello di Palestrina, modello classico della polifonia liturgica.
Avila
Tomás Luis de Victoria nasce nel 1548 ad Avila, la città situata a metà strada fra Salamanca e Madrid, che vede nascere una delle più fervide e luminose figure del cattolicesimo cinquecentesco: santa Teresa.
Durante l’infanzia di Tomás, la sua famiglia può vantare un elevato tenore di vita; ma nel 1557 il padre muore, lasciando alla moglie 11 figli da allevare. È allora uno zio prete, Juan Luis, a prendersene carico. All’età di 9 anni, in qualità di fanciullo cantore, Victoria entra nella cattedrale di Avila, dove riceve un’educazione musicale sotto la guida dei maestri di cappella Jerónimo de Espinar e Bernardino de Ribera.
È poi molto probabile che in questi anni di apprendistato incontri anche Antonio de Cabezón che, oltre a essere un formidabile organista, è anche fra i compositori più rappresentativi di Spagna.
Si ritiene inoltre che il giovane Victoria riceva anche una solida istruzione letteraria, presso la scuola di San Gil, fondata ad Avila dai gesuiti nel 1554 e apprezzata anche da santa Teresa.
Roma
Quando Victoria lascia i pueri cantores viene inviato a Roma (probabilmente nel 1565) in qualità di cantore presso il Collegio Germanico. Fondata nel 1552 da sant’Ignazio di Loyola, questa istituzione ha come scopo principale la preparazione dei missionari, ma accetta anche studenti a pagamento. Dal 1569 al 1574 Victoria è stipendiato come cantore e organista presso la chiesa di Santa Maria di Monserrato. Dal 1571 tiene anche lezioni di musica per i convittori del Collegio Germanico, diventandone in seguito maestro di cappella.
Nel 1572 pubblica intanto la sua prima raccolta a stampa, un libro di mottetti a 4, 5, 6 e 8 voci, dedicato al cardinale Otto Truchsess, presso il quale Victoria ha probabilmente coperto la mansione di maestro di cappella negli anni immediatamente precedenti. Nel 1575 riceve infine gli ordini religiosi e, in seguito, lascia il Collegio Germanico per passare alla Congregazione dei Preti dell’Oratorio, fondata da san Filippo Neri. Dal 1578 al 1585 è cappellano presso San Girolamo della Carità.
Nei rimanenti anni del suo soggiorno romano Victoria pubblica altre importanti sillogi di composizioni, che costituiscono il nocciolo della sua opera. Nel 1576 vede la luce una raccolta di messe, salmi e magnificat. Nel 1581 vengono pubblicate una raccolta di magnificat e antifone (Cantica Beatae Virginis), e una di inni (Hymni totius anni). Nel 1583 escono una raccolta di messe (Missarum libri duo) a 4, 6 e 8 voci, e una di mottetti a 4, 5, 6 e 8 voci. Nel 1585 vedono la luce una terza raccolta di mottetti a 4, 5, 6 e 8 voci, e l’Officium Hebdomadae Sanctae.
Madrid
La raccolta di messe del 1583 è dedicata a Filippo II di Spagna e nella lettera dedicatoria Victoria manifesta il desiderio di rientrare in patria. Accogliendo la sua richiesta, nel 1587 il re lo nomina cappellano della sorella, l’imperatrice Maria, che, rimasta vedova, viveva in ritiro con la figlia Margherita presso il Monasterio de las Descalzadas di Madrid. Victoria mantiene questo posto fino alla morte dell’imperatrice (1603), rimanendo anche, fino all’anno successivo, maestro di cappella. In seguito passa, sempre presso lo stesso convento, al posto meno impegnativo (ma non meno remunerativo) di organista, che ricopre fino alla morte.
Quando Victoria arriva al convento, vi risiedono 33 monache, per le quali viene servita messa quotidianamente. Alla cappella sono assegnati 12 preti (tutti esperti di musica e di canto), cui si aggiungono quattro pueri cantores per intonare messe e mottetti polifonici. Per le funzioni più importanti vengono chiamati anche alcuni strumentisti, a maggior ornamento della liturgia. È dunque in un ambiente selezionato, e con il conforto di una solida condizione economica, che si svolge quietamente l’ultima parte della vita di Victoria.
Egli rifiuta infatti le prestigiose offerte, pervenutegli prima da Siviglia e poi da Saragozza, di diventare maestro di cappella delle locali cattedrali.
Fra i vantaggi del servizio presso il Monasterio de las Descalzadas c’è anche una notevole libertà di movimento. Nel 1592 Victoria è a Roma per seguire da vicino la stampa del secondo libro delle messe, e qui viene accolto con molti onori, in particolare presso il Collegio Germanico. Nel febbraio del 1594 si trova ancora a Roma per partecipare ai funerali di Palestrina; tornerà a Madrid nel 1595.
Nel 1600 viene pubblicata un’altra raccolta di messe, magnificat, mottetti, salmi, a 3, 4, 8, 9 e 12 voci; e nel 1605 un Officium defunctorum, composto “in obitu et obsequiis sacrae imperatricis”, cioè in memoria dell’imperatrice Maria.
La morte coglie Victoria nella residenza dei cappellani del convento il 20 agosto del 1611, circondato dalla stima internazionale.
Bilancio critico
A differenza degli altri grandi maestri rinascimentali, Victoria ha composto soltanto musica sacra. E questa sembra una circostanza alquanto insolita, se si pensa che anche Palestrina, campione della musica liturgica, non si è sottratto alla composizione di madrigali (due libri a 4 voci, uno a 5, uno di madrigali spirituali, e numerosi altri pezzi sparsi in raccolte collettive). La cosa trova numerose concause.
Intanto Victoria (a differenza di Palestrina e di Lasso, nati rispettivamente nel 1525 ca. e nel 1532 ca.) nasce e vive nel tempo della Controriforma, subendone in pieno l’influenza. Poi la sua formazione, che ha inizio in una città dal sentimento religioso particolarmente fervido, avviene presso il collegio dei Gesuiti, cioè in un acceso clima di militanza cattolica. Il ritorno in Spagna, dove la Controriforma ha assunto toni particolarmente intensi, sembra una naturale conseguenza di queste premesse; inoltre il servizio come cappellano della devotissima imperatrice Maria appare come la circostanza più adatta al loro pieno compimento. Influisce poi forse su Victoria anche l’esempio di un altro importante compositore spagnolo, Cristóbal de Morales, autoconfinatosi nell’ambito sacro per l’influenza dell’intensa devozionalità di Carlo V. Si aggiunga poi la personalità stessa del compositore, caratterizzata dal riserbo (tanto che non ne possediamo alcun ritratto), e dalla tendenza alla solitudine contemplativa che ha comportato negli ultimi anni di vita l’allontanamento dall’attività compositiva e, di conseguenza, la mancanza di nuove pubblicazioni.
Nell’opera di Victoria le grandi forme della tradizione musicale liturgica raggiungono l’equilibrio della classicità, grazie alla combinazione di una sincera ispirazione religiosa, un sicuro senso della proporzione formale, e una solida conoscenza della tradizione. La sua musica ha goduto di straordinaria fama in tutto il mondo cattolico e, grazie all’espansione coloniale spagnola, ha avuto un’influenza indelebile sulla produzione compositiva del secolo successivo nel nuovo mondo.