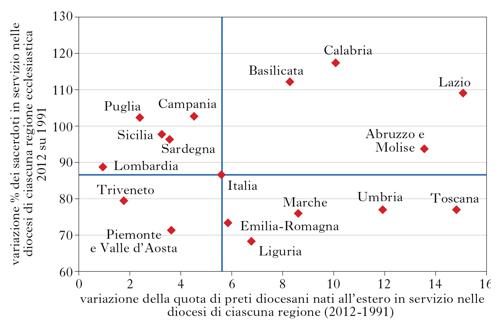Trasformazioni della struttura dell'autorità religiosa cattolica
Trasformazioni della struttura dell'autorità religiosa cattolica
Come ha insegnato Max Weber (1864-1920) «per Chiesa si deve intendere un’impresa istituzionale di carattere ierocratico» identificata dalla capacità di concedere o di rifiutare beni sacri (‘coercizione ierocratica’) «nella quale – e nella misura in cui – l’apparato amministrativo avanza la pretesa di monopolio della coercizione ierocratica legittima» (1922; trad. it. 1995, p. 53). In modo particolarmente efficace, e adeguato a contesti esposti alle tensioni della secolarizzazione, Mark Chaves (1993; 1994) ha impiegato le più recenti risorse della sociologia dell’organizzazione per studiare le forme e i problemi di quell’apparato amministrativo. Tale apparato è stato isolato e studiato come struttura dell’autorità religiosa (religious authority structure), espressione che indica dunque semplicemente una componente di un sistema religioso e di una tradizione religiosa. In questo contributo si cercherà di mettere in luce le modifiche, le de-formazioni, che la struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia ha sperimentato e che risultano più facilmente visibili – per così dire – se di quella struttura si confrontano, idealmente, due fotografie: una scattata all’inizio degli anni Settanta e l’altra ai giorni nostri. Per valutare i risultati di questo approccio è importante non dimenticare che esso non intende considerare l’intera multiforme influenza del cattolicesimo sulla vita della società italiana, dalla quale non avrebbe senso escludere la religiosità individuale (o il lato della ‘domanda religiosa’), né, per es., fenomeni come il cattolicesimo politico o le correnti artistiche che del cattolicesimo sono state espressione nei rispettivi ambiti. Tale approccio, inoltre, non intende considerare il cattolicesimo religioso in tutte le sue varie manifestazioni. Di questo, infatti, si limiterà a considerare, e solo da un punto di vista sociologico, la struttura organizzata dell’autorità (religiosa, appunto) che vi si esercita. Più precisamente – per dirla con Niklas Luhmann (2005) – se ne analizzeranno principalmente due componenti: la forma di alcune delle principali strutture di quell’autorità (le diocesi e le parrocchie) e le principali caratteristiche del personale che in tali strutture riveste un ruolo.
Le strutture organizzate
Le diocesi
Partendo dalle diocesi è possibile mettere a fuoco due primi aspetti della complessa trasformazione conosciuta dal cattolicesimo religioso in Italia tra il 1970 e gli inizi del secondo decennio del 21° secolo. Tra l’inizio e la fine del periodo considerato, la base di questa struttura ha conosciuto un restringimento, o, meglio ancora, un assottigliamento della propria rete territoriale. Al contempo, quello che era un elemento poco sviluppato di raccordo tra diocesi, la Conferenza episcopale italiana (CEI), ha accresciuto enormemente il proprio potere al punto che è ormai percepita come una sorta di centro e di vertice, anche se non assoluti, dell’organizzazione dell’autorità religiosa cattolica nel Paese. In breve: al termine dei quarant’anni qui considerati, la struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia ha manifestato – tra gli altri – i segni, per un verso, di una forte verticalizzazione e di una ancora più forte centralizzazione e, per altro verso, di una contrazione, forse non solo quantitativa, dei propri terminali territoriali. Così, rispetto a quarant’anni fa, questa struttura appare con un vertice più grande e forte e una base composta di terminali meno numerosi e potenti.
Per comprendere adeguatamente questi due aspetti è indispensabile tenere presenti altri due elementi cui si accennerà rapidamente. In primo luogo va detto che il periodo di tempo qui considerato segue da vicino la chiusura nel 1965 del Concilio ecumenico Vaticano II (sicuramente l’evento più importante nella storia del cattolicesimo degli ultimi quattro o cinque secoli). Per quanto conflittuale, non lineare e controversa possa essere stata la sua ricezione, non deve stupire che al termine di questo arco temporale si siano verificati avvenimenti impensabili prima del Concilio, come le dimissioni di papa Benedetto XVI (Joseph Ratzinger) nel 2013 e il presentarsi del suo successore papa Francesco (Jorge M. Bergoglio) come «vescovo di Roma». Tutto ciò non costituisce in alcun modo una discontinuità assoluta nella lunga storia delle istituzioni religiose cattoliche. Semmai si è trattato di eventi emblematici della chiusura di una fase, di una parentesi durata qualche secolo e profondamente intrecciata con le vicende della variante europeo-continentale della modernizzazione (Prodi 2010).
Nel corso di questa parentesi il vescovo di Roma ha assunto e, a volte, persino esasperato le forme del sovrano, emerse nella variante della modernità cui si è appena accennato. Entro questa vicenda la Chiesa cattolica ha acquistato – per non pochi aspetti – la forma di uno ‘Stato’ (che si riflette, ma non si esaurisce nella formazione di uno Stato della Chiesa). La chiusura di questa parentesi sarebbe stata inimmaginabile senza il ritorno a ragioni di ecclesialità in misura diversa dominanti per almeno quindici secoli e comunque mai negate (almeno in linea di principio) neanche nei quattro secoli successivi. È impossibile non tenere conto di questo primo elemento per capire la storia degli ultimi cinquant’anni di ogni provincia del cattolicesimo religioso. Tuttavia ciò vale in modo particolare per comprendere qualcosa del cattolicesimo religioso italiano. Nel corso del processo di ricezione dell’evento e del magistero del Concilio Vaticano II sono maturate (nei modi più diversi e a volte anche conflittuali) grandi novità relative alla comprensione, all’autocomprensione e all’esercizio dell’ufficio del vescovo di Roma. Tali novità non sembravano dover segnare profondamente la struttura delle relazioni tra le diocesi italiane e, più in generale, tutta la vicenda del cattolicesimo religioso italiano, la cui storia si intreccia, nel bene e nel male, con la Sede di Pietro.
E si giunge così al secondo elemento che va ricordato. Nel corso del quarantennio cui si fa riferimento, l’élite ecclesiastica italiana ha perso il controllo del ‘trono di Pietro’. Da quasi trentacinque anni (ottobre del 1978), infatti, e per la prima volta dopo più di quattro secoli, il papa non è più stato italiano. Come era prevedibile, questo cambiamento non ha significato assolutamente una riduzione dell’intensità del rapporto tra la Chiesa di Roma e le altre Chiese particolari presenti in Italia, ma ha prodotto un profondo cambiamento nelle forme e nei contenuti di questo rapporto. Infatti, era probabilmente dai tempi di Pio XI (pontefice dal 1922 al 1939) che un papa non elaborava ex novo e non perseguiva con altrettanta sistematicità un progetto di governo religioso sull’Italia come è accaduto con papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła) dal 1978 al 2005 (Acerbi 2006). Durante il papato wojtyłiano si sono verificate molte innovazioni relative alla struttura dell’autorità religiosa nel cattolicesimo italiano, e di almeno alcune di queste si analizzeranno gli effetti. Nel processo di attenuazione dell’influenza delle élites e delle istituzioni ecclesiastiche italiane sui vertici della curia vaticana – per quanto contraddittorio possa apparire a prima vista – è di fondamentale importanza l’aumento del potere a disposizione delle organizzazioni centrali della CEI. Queste divengono prima strumenti e poi partner nell’elaborazione ed esecuzione del nuovo programma di governo del cattolicesimo religioso italiano emanato da Roma. In proposito è sufficiente ricordare le originali modalità di elezione dei vertici della CEI (per lo meno quelle in vigore sino agli inizi del 2014). In effetti, solo nel caso di questa conferenza episcopale nazionale (e in pochissimi altri di minore rilievo) i vertici non sono eletti dai vescovi delle diocesi dei singoli Paesi, ma vengono nominati dal pontefice. Per di più, e a lungo, il ruolo di presidente della CEI ha coinciso con quello di vicario del papa per la diocesi di Roma.
Per intendere correttamente il significato del processo di centralizzazione non bisogna cedere al pensiero che i vertici di questa organizzazione abbiano sostituito (in qualsiasi senso) il ruolo del papa rispetto al cattolicesimo religioso italiano. Contemporaneamente occorre avere chiaro che quel particolare progetto di governo e la sua esecuzione non avrebbero avuto corso se non per mezzo degli organismi centrali della CEI e del loro accresciuto potere.
In questa sede la dinamica di centralizzazione-verticalizzazione interessa in modo particolare poiché investe e trasforma a livello regionale il ruolo della cooperazione tra le diocesi e quello delle organizzazioni e delle istituzioni religiose cattoliche. Queste per un verso vengono valorizzate: i presidenti delle conferenze episcopali regionali entrano a far parte del Consiglio permanente della CEI (una sorta di ‘parlamentino’ che si riunisce tre o quattro volte l’anno – unica occasione di controllo da parte dei vescovi sui vertici CEI, insieme a una sessione dell’assemblea ordinaria annuale – e nel quale siedono anche i responsabili delle commissioni episcopali con competenze settoriali). Nello stesso tempo il lavoro degli uffici nazionali per le pastorali di settore si dota di terminali territoriali regionali. Tuttavia, l’impatto del processo di centralizzazione-verticalizzazione regionale trasforma sempre più spesso il ruolo della Conferenza episcopale regionale da supporto alla vita diocesana a ‘cinghia di trasmissione’ tra il centro (i vertici della CEI) e la periferia (le organizzazioni diocesane) della struttura dell’autorità religiosa.
I poteri di controllo e anche il grado di informazione dei vescovi diocesani e dei loro rappresentanti regionali sull’organizzazione centrale della CEI e sui suoi uffici (diretti da elementi del clero scelti direttamente dal presidente) sono, nell’insieme, modesti. Si pensi solo al ritmo quotidiano del lavoro di tale apparato e all’ammontare delle risorse a sua disposizione, a fronte delle poche occasioni annuali nelle quali i presidenti delle conferenze episcopali regionali e i vescovi che presiedono le commissioni settoriali hanno modo di incontrarsi con i responsabili dei rispettivi uffici e tra loro. Vista la portata di questo processo di centralizzazione-verticalizzazione, esso può aver concorso alla riduzione delle differenze interregionali che si vedrà più avanti. Certamente correlato a questo processo è il fatto che, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, almeno alcune delle più avanzate esperienze di cooperazione tra le diocesi di una stessa regione cominciarono a declinare per poi scomparire o ridursi sensibilmente, nonostante avessero fornito spesso buona prova di sé (Diotallevi 2010).
Alcuni dati possono fornire la misura dell’intensità del processo di verticalizzazione e centralizzazione vissuto dalla struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia in poco più di quarant’anni. Nella prima metà degli anni Ottanta le diocesi italiane vennero ridotte quasi di un quarto, passando da 285 circa a poco più di 220, secondo i dati forniti dall’Annuarium statisticum Ecclesiae (ASE). Per contro, a partire dalla seconda metà dello stesso decennio, l’organizzazione centrale della CEI (che operava da decenni, ma aveva mantenuto piccole dimensioni e aveva potuto contare su risorse materiali e simboliche molto modeste) conobbe uno sviluppo più che esponenziale. In questa sede è sufficiente indicare l’ordine di grandezza di questo incremento, relativamente al quale il «Notiziario» CEI (NOT) fornisce annualmente dati finanziari aggiornati.
Proprio alla CEI, e in particolare ai suoi organi centrali, venne attribuito il compito di gestire importanti applicazioni del nuovo Concordato tra Santa Sede e Repubblica italiana (1984), frutto dell’opzione per la libertà religiosa della Costituzione italiana del 1946 e del Concilio Vaticano II con la dichiarazione Dignitatis humanae (1965). In particolare alla CEI venne assegnato il compito di amministrare il gettito derivante dalla sostituzione del vecchio sistema di sostentamento del clero con il nuovo, ovvero il passaggio dal sistema beneficiale (imperniato su benefici assicurati in parte importante dall’amministrazione statale italiana e collegati a incarichi ecclesiastici come quello di parroco) al sistema basato sulla libera scelta del contribuente riguardo alla destinazione dell’otto per mille dell’intero gettito IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), su offerte liberali e deducibili per il sostentamento del clero, oltre che sull’amministrazione dei beni della Chiesa trasferiti da parrocchie e da enti ecclesiastici agli istituti diocesani e nazionali. Notevoli e importantissimi sono i significati di questo cambiamento (perfezionatosi nel 1988). Qui interessa richiamarne solo due. Grazie al nuovo sistema la struttura dell’autorità religiosa cattolica cessò di dipendere economicamente dall’amministrazione statale per rimettersi in larghissima parte (oltre che a risorse proprie) alla libera determinazione dei contribuenti e dei cittadini. Tuttavia, il sistema ha tracciato anche nuovi percorsi. Le risorse economiche cessarono di essere distribuite dallo Stato capillarmente o di affluire alle organizzazioni ecclesiastiche diocesane dalle rispettive periferie dell’apparato organizzativo (per es. le parrocchie). Quel flusso finanziario entrò nel sistema da quello che in virtù di tale ragione ne divenne il centro: appunto, dai vertici della Conferenza episcopale italiana.
Tra il 1990 e il 2013 si è assistito a un afflusso crescente di risorse provenienti dalle decisioni dei contribuenti sulla destinazione dell’otto per mille a favore della Chiesa cattolica. Questi sono passati da 209,7 milioni di euro a 1032,7 milioni. Non è difficile immaginare quale incremento di potere sia stato generato dal percorso di un flusso di tali e tanto crescenti dimensioni a vantaggio degli organismi centrali della Conferenza episcopale italiana. A questi organismi infatti era demandato il compito di istruire e di seguire tutto quanto concernesse la raccolta e l’impiego di tali risorse, salvo l’annuale approvazione del bilancio da parte dell’assemblea plenaria dei vescovi. Di per sé il crearsi di queste nuove e così grandi risorse non ha messo in discussione il grado – qualunque esso fosse – di autonomia economica (e non solo) mantenuto sino a quel momento dalle diocesi rispetto al vertice nazionale della struttura dell’autorità religiosa cattolica (cioè la CEI prima del 1984). Per comprendere il ridursi di questa autonomia è necessario spostare l’analisi sulle forme e gli scopi dell’amministrazione di queste nuove e ingenti risorse. Il processo di centralizzazione-verticalizzazione di cui si sta parlando non inficia i principi giuridici che hanno portato al Concordato del 1984, né comporta limiti in termini di trasparenza e di pubblicità nell’amministrazione economica dei beni della Chiesa che, forse non solo con riferimento all’Italia, ha raggiunto in questo settore standard elevatissimi e con pochi eguali. Semplicemente, se le scelte procedurali e materiali di gestione di tali risorse non contraddicono né quei principi né quegli standard, esse però non ne derivano automaticamente. Altre scelte gestionali sono state, e sono, altrettanto compatibili con gli stessi principi e gli stessi standard.
Ciò che di fatto si è verificato, e che giustifica ampiamente l’impiego di categorie come quella di ‘centralizzazione’, è: a) il progressivo aumento della dipendenza della ‘periferia’ dal ‘centro’, delle diocesi dalla CEI (di diocesi che preferiscono sempre più spesso le risorse certe trasferite dal centro alla fatica e al valore, anche ecclesiale, di una maggiore autonomia economica e finanziaria); e b) la quota notevole e crescente delle risorse che il ‘centro’ trattiene per sé. È per questa via che i vertici della CEI sono riusciti a combinare una forte investitura ricevuta dal pontefice con un’inedita, notevole e sempre maggiore disponibilità di risorse finanziarie.
L’andamento della ripartizione dei fondi provenienti dalle scelte dell’otto per mille fornisce l’indicazione sintetica utile in questa sede. L’insieme dei fondi assegnati in sede CEI alle diocesi e di quelli destinati al sostentamento del clero è cresciuto di oltre il 350% tra il 1990 e il 2010. La dimensione reale di questa crescita di dipendenza economica delle diocesi dalla CEI è in realtà ancora più marcata se si considera che, nello stesso periodo, la capacità di produrre risorse finanziarie da parte delle diocesi, attraverso le proprie attività e i processi di partecipazione su scala locale, era diminuita in modo sensibile. Ciò risulta da un cospicuo numero di informazioni e di indizi che ancora devono essere studiati sistematicamente, mentre è già facilmente documentabile attraverso l’avvenuto cambiamento delle quote con cui le diverse fonti previste provvedono a finanziare il sostentamento del clero. Nel 1991 i fondi provenienti dall’otto per mille assicuravano il 33,4% del fabbisogno (il 28,7% l’anno successivo e già il 47,3% nel 1993), per poi giungere attraverso una crescita costante al 61,8% del 2010 e al 63,2% nel 2012. Nello stesso periodo il contributo delle diocesi al sostentamento del clero (attraverso i redditi propri del clero, la quota delle offerte fatte dai fedeli in parrocchia, i profitti degli istituti diocesani e le offerte deducibili specificamente finalizzate a esso) è sceso da circa il 70% del fabbisogno a meno del 40% e addirittura al 36,8% nel 2012, secondo i dati forniti dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC).
Sempre nello stesso intervallo di tempo, la quota di risorse proveniente dall’otto per mille e destinata agli organismi centrali della CEI è cresciuta in misura più che proporzionale rispetto a quella assegnata alle diocesi direttamente o attraverso il sostentamento del clero. Se tra il 1990 e il 2010 i fondi alle diocesi erano cresciuti del 350%, quelli assegnati agli organismi centrali della CEI crebbero del 1151% (più del triplo). Anche se si esclude il sostentamento del clero, resta che nel 1990 alla competenza delle diocesi erano rimessi (in euro) 28 milioni e agli organismi centrali della CEI 37 milioni, nel 2010 – rispettivamente – 253 milioni (9 volte di più che nel 1990) e 426 milioni (15 volte di più rispetto al 1990).
Per avere un’immagine più nitida dei profili generali di questo processo, vale la pena sottolineare anche un altro punto. La quota fondi provenienti dall’otto per mille e assorbita dal sostentamento del clero (difficilmente comprimibile e sottoposta a una serie di semiautomatismi) è calata dal 69% del 1990 al 33,5% del 2010 (per effetto della crescita dei proventi, quintuplicati, assicurati da quella fonte alla CEI, e del suo combinarsi incerto con una crescita numerica del clero da sostenere). Per effetto della riduzione della quota di gettito otto per mille richiesta dalle esigenze di finanziamento del sostentamento del clero, è aumentata in misura notevolissima la quota di fondi provenienti dalle firme otto per mille a destinazione di fatto non predeterminata (ferme restando le finalità-quadro di «carità, culto e pastorale» previste dagli accordi con lo Stato italiano). Di conseguenza, è aumentato il potere delle organizzazioni centrali della CEI che istruiscono e controllano la destinazione di queste risorse, ovvero il potere del centro (e del vertice) della struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia su quello della periferia (o base) della stessa.
Tra il 1990 e il 2010 è anche aumentata la forza di quel centro e vertice costituito dalla CEI mentre è diminuita in periferia l’intraprendenza del clero (in passato capace di generare opere anche di elevato profilo economico) e certo non è decollato come si sarebbe voluto l’impegno nel promuovere l’esercizio della responsabilità dei fedeli – a partire dal laicato – ad assistere e anche a controllare la vita economica della Chiesa. In sintesi: mentre sino agli inizi degli anni Ottanta il sistema di sostentamento del clero (porzione decisiva della dimensione economica della vita ecclesiale) si caratterizzava (Consorti 2010) per un mix di forte dipendenza dalla decisione di un’autorità extraecclesiastica che determinava l’ammontare dei trasferimenti e dall’assenza di un’autorità religiosa centrale capace di regolare la distribuzione degli stessi, con il nuovo regime si è realizzata sia una fortissima riduzione dello stato di dipendenza dall’autorità extrareligiosa, sia una forte centralizzazione attraverso la formazione di un’autorità religiosa preposta alle decisioni in questo ambito. Il problema che si presenta è quello del contrasto tra il valore attribuito dalla costituzione ecclesiastica cattolica alle diocesi o Chiese particolari, di molto maggiore rispetto a quello attribuito alle istanze di cooperazione ecclesiale (soprattutto a livello nazionale), e la redistribuzione reale di potere intervenuta tra diocesi e CEI attraverso questa particolare interpretazione pratica del nuovo regime di sostentamento: interpretazione che non sarebbe stata certamente l’unica possibile.
Per valutare correttamente le trasformazioni appena richiamate occorre evitare alcuni luoghi comuni, privi di qualsiasi fondamento: in primo luogo le nuove forme del sovvenire alle necessità economiche della Chiesa non sostituiscono le altre (salvo il vecchio sistema beneficiale), ma vi si affiancano e, come una consistente letteratura (giuridica e teologica) ha messo in chiaro, in termini istituzionali costituiscono un enorme passo in avanti sia sul piano civile sia su quello ecclesiale. Anche su scala internazionale il sistema introdotto a seguito del Concordato del 1984 ha offerto una delle più qualificate espressioni del combinarsi di una doppia opzione per il modello della libertà religiosa: quella operata dalla Costituzione italiana del 1948 (art. 8) e quella operata dal magistero con il Concilio Vaticano II. In secondo luogo il flusso economico generato dall’otto per mille (e dalle offerte deducibili per il sostentamento del clero) è sottoposto a un livello di revisione e di controllo (anche bilaterale, ovvero con il coinvolgimento dell’amministrazione statale), ovviamente sempre perfettibile, che ha pochi analoghi non solo in ambito religioso, ma anche in altri ambiti sociali (politici inclusi). I possibili impieghi del flusso finanziario generato dall’otto per mille sono definiti per accordi tra le parti aventi valore di legge. Nella pratica, poi, la nuova entità di potere dei vertici della CEI, generata dalla possibilità di curare l’amministrazione di questi fondi, è stata spesso impiegata per indurre comportamenti virtuosi e per sostenere elementi di modernizzazione nella vita delle diocesi: come, per es., quando si è deciso di subordinare il trasferimento dei fondi alle diocesi alla condizione che esse rendessero pubblici i bilanci, pratica raramente applicata fino ad allora. Infine, tutte le politiche di raccolta e di spesa adottate dal 1988 in sede CEI, a partire dai bilanci annuali, hanno ricevuto l’approvazione dell’assemblea dei vescovi italiani.
In sintesi, solo una volta chiariti i caratteri del sistema e la sua elevata qualità civile ed ecclesiale è possibile portare l’attenzione sull’interpretazione pratica che di questo sistema è stata effettivamente data: una interpretazione con forti tratti di centralizzazione e di verticalizzazione, senz’altro legittima, ma non l’unica possibile. Nulla avrebbe impedito, per es., di ripartire i fondi tra le diocesi e da queste liberamente riconferirli alla CEI per esigenze comuni e preventivamente condivise. È evidente che la soluzione adottata implica un giudizio sulla pratica disponibilità alla condivisione da parte delle autorità ecclesiastiche locali. Non si sarebbe trattato di un’interpretazione più legittima di quella effettivamente data, ma semplicemente di un’altra, anche se ecclesiologicamente e sociologicamente di segno molto diverso. È dunque nel confronto tra alternative egualmente legittime, ma non equivalenti, che va cercato il significato reale – sociologico nel caso specifico – della soluzione che, tra le varie possibili, si è affermata.
Anche se questi numeri e le considerazioni che li hanno accompagnati sono già sufficienti a fornire i dati necessari alla trattazione, una misura ulteriore può essere offerta dalla crescita di potere che tra il 1970 e il 2010 si è verificata a livello nazionale nella struttura dell’autorità religiosa cattolica, in luogo di una precedente assai modesta cooperazione tra le diocesi con riflessi quasi esclusivamente intraecclesiali. In quegli stessi anni gli organismi centrali della CEI, in particolare il suo presidente, sono divenuti anche attori dell’arena politica nazionale e sono stati riconosciuti (e anche combattuti) come tali (Diotallevi 2007). Sono intervenuti nel dibattito culturale con una serie di iniziative non solo estemporanee, ma anche stabili (spesso coordinate sotto l’etichetta e la struttura del ‘progetto culturale’). Hanno avuto una presenza nel sistema dei media (tradizionali, come la stampa – anche quotidiana – e la televisione, ma anche di nuova generazione). Hanno intrapreso un’azione di penetrante e sistematico orientamento praticamente in ogni settore della pastorale ordinaria e straordinaria. Hanno sviluppato o supportato un’azione di produzione di magistero (con centinaia di documenti). Hanno esercitato in modo sistematico un potere di convocazione che ha avuto la sua massima espressione nei convegni ecclesiali nazionali, con cadenza decennale a partire dal 1976, e soprattutto in quelli del 1996 e del 2006.
Il processo di verticalizzazione e centralizzazione appena descritto, come ogni processo sociale, non è mai la pura e semplice applicazione di un progetto. Tuttavia, in alcuni casi avviene che determinati processi, magari solo per periodi medi o brevi, siano sistematicamente controllati e diretti da una organizzazione, più di quanto non si verifichi in genere. In questo senso – pur sempre con la dovuta prudenza – per il processo sin qui descritto si può ragionevolmente utilizzare la categoria di ‘progetto’. Vale a dire che non si possono considerare del tutto casuali gli effetti di centralizzazione e verticalizzazione della struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia fin qui indicati. Tali effetti debbono essere riconosciuti anche come originalissimi e come ecclesialmente inediti, perché localizzati a un livello (quello nazionale e per di più italiano) in linea di principio di scarsa importanza per la vita e l’autocoscienza religiosa cattolica, oltre che di recente formalizzazione. E alla esplicita formulazione ed esposizione di un ‘progetto’ somigliava molto ciò che il cardinale Camillo Ruini dichiarò in una delle sue prime uscite pubbliche da presidente della CEI, in occasione del Consiglio permanente dell’11 marzo 1991. In quell’intervento si poneva in chiaro che lo sviluppo della CEI avrebbe dovuto essere la risposta alla «necessità di una presenza pubblica della Chiesa in Italia che abbia una vera e adeguata dimensione nazionale, ruolo che in via principale, anche se certamente non esclusivo, può essere esercitato soltanto dal corpo dei vescovi e quindi, nella pratica quotidiana, attraverso lo strumento della Conferenza episcopale» (Acerbi 2006, p. 84).
Le parrocchie
Il processo di semplificazione o, se si vuole, di riduzione della capillarità della base nella struttura del cattolicesimo religioso, si riflette anche a livello parrocchiale. Tra il 1976 e il 2011 le parrocchie italiane sono passate da 28.379 a 25.503 (secondo i dati forniti dall’ASE), diminuendo dunque circa del 10%. Se però si considerano le sole parrocchie con un parroco (non importa se in esclusiva o condiviso con altre parrocchie, e se appartenente al clero diocesano o a quello religioso), il saldo negativo diviene più marcato. Il numero delle parrocchie passa da 25.067 a 20.742, con un calo non del 10%, ma del 17%.
Dagli anni Novanta è a disposizione un’ulteriore fonte per affinare l’analisi, l’ICSC, secondo cui, tra il 1991 e il 2012, il numero delle parrocchie attive è restato sostanzialmente invariato e anzi è cresciuto (con riferimento alla penisola nel suo complesso) del 2,3%. In un periodo di riduzione dei terminali territoriali di quasi tutte le istituzioni, la struttura dell’autorità religiosa cattolica è riuscita ancora a mantenere la sua diffusione sul territorio della penisola, e ciò addirittura in concomitanza di un processo di centralizzazione e verticalizzazione. Tuttavia questo non significa che ciascuna parrocchia, pur rimanendo centro di una vitalità religiosa, spesso anche capace di influenze esterne sociali e culturali, abbia ancora un parroco. In media, alla fine del 2012, hanno ancora un parroco l’87,1% delle parrocchie che l’avevano nel 1991, e hanno ancora un parroco in esclusiva (senza cioè alcun ruolo in altre parrocchie) solo il 60,1% di quelle del 1991.
I dati appena riportati possono essere compresi in modo più adeguato solo se si rammenta cosa sia e quale valore religioso e sociale abbia tuttora l’istituzione parrocchiale nel panorama della società italiana, e quali aspettative nutrano nei suoi confronti la larga popolazione di praticanti e anche l’intera opinione pubblica. E non solo presso le frontiere dell’emergenza sociale e civile, ma praticamente ovunque.
Tra gli italiani adulti oltre tre su quattro dichiarano di conoscere il nome della propria parrocchia, oltre il 90% tra coloro che partecipano alla messa almeno due o tre volte al mese. Se richiesti di indicare una realtà che rappresenti gli aspetti belli e positivi della Chiesa, più del 40% degli italiani adulti (pressoché la metà tra i praticanti regolari o quasi) indica la propria parrocchia. Nella medesima classifica il papa è secondo da ormai un decennio, mentre valori molto bassi sono raggiunti dal proprio gruppo o movimento e dalla propria diocesi.
Se di questo tenore sono le valutazioni e le aspettative generali nei confronti dell’istituzione parrocchiale, è estremamente probabile che la riduzione della quantità e della qualità del servizio (religioso e non religioso) offerto dalle parrocchie avrà con il tempo un effetto negativo e conseguenze di vario genere. D’altra parte la risposta ecclesiastica, che ancora una volta per isomorfismo mimetico si sta diffondendo nel cattolicesimo italiano, rischierà di assecondare questo processo di alleggerimento della presenza territoriale della Chiesa. Nella maggior parte dei casi, infatti, davanti all’aumento di parrocchie senza clero, i vescovi hanno iniziato a far fronte al problema con la creazione di ‘unità pastorali’ o simili. Alcune parrocchie vengono cioè affidate a un piccolo numero di preti cui sono attribuite responsabilità pastorali poco distinte e spesso ancor meno gerarchizzate. Conseguentemente, il clero diocesano viene sospinto verso forme di vita (e di autocomprensione) più simili a quelle proprie della vita religiosa, i laici sono attratti verso impegni intraecclesiastici alternativi a quelli secolari e l’istituzione parrocchiale viene trasformata da centro – non importa quanto forte – di una vita sociale e civile in mero sportello erogatore di servizi religiosi. Tutti effetti che non si verificherebbero se le stesse parrocchie fossero unite in una sola e tra gli stessi preti vi fosse una precisa relazione gerarchica. Con le medesime risorse si può dar luogo ad almeno due soluzioni organizzativamente ed ecclesiologicamente molto diverse. Resta che la parrocchia alla quale la maggior parte degli italiani – praticanti o no – è legata è molto più simile a un municipio che a un supermercato religioso, e il suo sagrato a una piazza di paese più che alla hall di un centro commerciale. Non che la scelta di sostituire le parrocchie con unità pastorali non abbia futuro, anzi essa va nella direzione di una religione a bassa intensità (low intensity religion, concetto utilizzato tra gli altri da Bryan S. Turner, Religion and modern society. Citizenship, secularisation and the State, 2011). Si tratta evidentemente di un futuro, non l’unico possibile, certo molto diverso dal passato, e nel quale si potrebbero verificare tensioni insostenibili tra le forme di questa religione a bassa intensità e la matrice cristiana da cui essa trae i materiali che rielabora.
Il personale
Per tutte le organizzazioni le risorse umane sono alcune delle più preziose (Luhmann 2005). Per le organizzazioni religiose, come per tutte quelle professionali, ciò vale in modo ancor più stringente (Abbott 1988). Il problema del reclutamento è dunque uno dei problemi cruciali cui ogni organizzazione religiosa, soprattutto se di tipo ecclesiale, deve dare costantemente una risposta (La parabola del clero, 2005).
Tuttavia ciò non significa che – a differenza di quanto avviene per la qualità – vi sia una relazione necessaria e proporzionale tra quantità del personale a disposizione e livello di potere raggiunto dalla organizzazione. Anzi, una tale relazione, pur restando cruciale, si attenua proprio con l’avanzare del processo di modernizzazione (Abbott 1988).
Un’adeguata valutazione delle cifre che seguono può trarre vantaggio dal ricordare che nei quarant’anni considerati in questa trattazione la popolazione residente in Italia è cresciuta circa del 20%, passando da poco più di 50 milioni a poco più di 60 milioni di residenti.
Il clero diocesano
In questo segmento della nostra analisi è il caso di partire dalla componente costituita dal clero diocesano sia per il grado di controllo che esso ordinariamente esercita sulla struttura dell’autorità religiosa cattolica, sia per le dimensioni che ha raggiunto questa componente del personale ecclesiastico maschile rispetto a quelle dei religiosi nel corso del Novecento (Brunetta 1991). Nel 1970 erano presenti in Italia e in servizio per le diocesi italiane 42.868 preti diocesani. Nel 2011 il loro numero era pari a 32.475, cioè diminuito di un quarto in quarant’anni. Una seconda e più affidabile fonte, che si basa su criteri leggermente diversi e su altre procedure di raccolta dei dati, fornisce valori ancora più ridotti (29.646 preti diocesani a fine 2012), ma nella sostanza per i vent’anni per i quali quest’ultima fonte è in grado di produrre informazioni, essa conferma la tendenza appena riportata.
Questa importante contrazione, tuttavia, non è in grado di rappresentare per intero i problemi incontrati dal reclutamento di personale per il clero diocesano. Nella composizione di questa popolazione, infatti, sono intervenute trasformazioni assai rilevanti, ma non bene espresse dal pur macroscopico calo assoluto.
I preti diocesani del 2011 non sono solo in numero inferiore rispetto a quello dei loro colleghi del 1970, ma sono anche mediamente più anziani, per effetto del combinarsi di tre principali processi: a) la diminuzione delle ordinazioni pur con andamento non lineare (Molina in La parabola del clero, 2005); b) l’aumento dell’età media all’ordinazione; c) un aumento della speranza di vita nel clero maggiore di quella registrata nella popolazione maschile italiana. Solo nel decennio 2003-12, per il quale si dispone di studi più precisi, mentre l’età media dei maschi sopra i 24 anni è passata da 49,5 anni a 51,4, quella dei preti diocesani nati in Italia è salita da 60,3 anni a 61,5. A fine 2012, tra i preti diocesani nati in Italia, il 16% aveva più di 80 anni, mentre nel 2002 il 12,5% e nel 1991 solo il 5,4%.
Anche altri indicatori segnalano un allentamento dei processi di formazione e di selezione delle nuove leve di clero diocesano. Innanzitutto negli ultimi anni è cresciuto il rapporto tra ordinati e seminaristi, mentre è diminuita la quota di seminaristi maggiori che abbandona il percorso di preparazione al ministero. Entrambi i fenomeni si verificano nel quadro di un calo degli ingressi in seminario. In pratica, secondo i dati ASE, chi oggi chiede di entrare in seminario ha molte più probabilità di diventare prete rispetto a un suo collega di alcuni decenni orsono (senza contare la tendenza a rivolgersi ad altri seminari, spesso con successo, da parte di quei candidati ai quali non fosse consentito di continuare il percorso di formazione presbiterale). Inoltre la fortissima riduzione della quota di ordinati che ha iniziato il proprio iter nel seminario minore, comporta l’arrivo all’ordinazione di individui sui quali è stata esercitata una minore azione formativa (culturale e umana) per durata, certamente, e, probabilmente, anche per intensità e selettività (Bressan 2006).
Entrano dunque nel ministero individui tra loro molto meno omogenei di quanto verificatosi negli ultimi tre o quattro secoli, mentre la loro omogeneità resta un requisito largamente presupposto dalle organizzazioni ecclesiastiche che impiegano clero diocesano. L’innalzamento dell’età media all’ordinazione porta nel ministero individui che hanno nel loro bagaglio biografico le più diverse esperienze umane e sui quali un’azione formativa quantitativamente ridotta produce inevitabilmente effetti ancora meno profondi. Senza supporre che questo costituisca necessariamente una trasformazione di segno negativo, ma certamente una grande diversità rispetto al passato, va detto che anche nel clero diocesano italiano ha fatto la sua comparsa quello che in letteratura è noto come second career clergy, ‘clero alla seconda carriera’ (Nesbitt 2007). Nel 1970, a livello nazionale l’età media all’ordinazione era per i preti diocesani di 26 anni; era cresciuta di meno di due anni rispetto al trentennio precedente (1940-70), mentre era destinata a crescere di quattro anni nel trentennio successivo (1970-2003), e ancora in seguito sino a toccare i 32 anni nel 2012 (Molina, in La parabola del clero, 2005; ICSC).
E, infine, tra tutte le altre pratiche di reclutamento non convenzionale poste in essere dalle diocesi, e certo facilitata dall’arrivo del primo papa non italiano, si è andata diffondendo la pratica del ricorso al clero straniero, principalmente proveniente da aree come l’Est Europa, l’Africa, alcune zone del Sud America e dell’Asia. Tra il 1983 e il 2012 entrarono nel clero diocesano attivo in Italia circa 3.700 presbiteri provenienti dall’estero: 1.426 come seminaristi ordinati in Italia e 2280 come presbiteri già ordinati che si escardinarono da diocesi estere per incardinarsi in diocesi italiane. Ancora una volta si è in grado di seguire con una certa precisione questo fenomeno soltanto a partire dal 1990 ed è possibile dire che in quel momento poco meno del 5% dei 31.492 preti diocesani incardinati in diocesi italiane era di origine straniera. Secondo stime per difetto quella percentuale era solo del 2% nel 1971.
A fine 2012 lo stesso valore era salito a poco meno del 7% dei 29.646 preti diocesani in servizio per le diocesi italiane. Se per un verso il fenomeno ha dimensioni inferiori a quelle raggiunte dalla presenza di stranieri nella popolazione in Italia, la sua valutazione richiede alcune attenzioni. Mentre è ancora rara la presenza di stranieri tra i professionisti in Italia, essa risulta assai diffusa tra gli individui con occupazioni largamente percepite come meno qualificate. Il risultato è che lo scarso interesse dei nativi per quei tipi di impegno finisce prima con il produrre le condizioni del ricorso a personale straniero e poi a trovarvi un ulteriore alimento. Una componente di rischio è dunque evidente nel diffondersi di questa, ma anche di altre pratiche di reclutamento non convenzionale. Come si vedrà più avanti, quella del ricorso a clero di origine non locale non è una politica diffusa in modo omogeneo tra le regioni, ma ha tratti simili ovunque essa venga praticata.
Infine, e questo è l’elemento i cui effetti si proiettano più profondamente verso il futuro della struttura religiosa del cattolicesimo italiano, si ricorre a clero straniero innanzitutto per affrontare la carenza di giovane clero di origine italiana. Al momento, in alcune aree del Paese, il clero sotto i 40 anni è di origine straniera per quasi il 50% e, comunque, a fronte di un’età media del clero diocesano nato in Italia che a fine 2012 è pari a 61,5 anni, quella del clero nato all’estero è di 46,7 anni. A questo si aggiunga anche che i dati elaborati dall’ICSC sulla base di informazioni ufficiali per un verso sottostimano il fenomeno (non potendo considerare presenze informali, come quella di clero straniero impegnato per gli studi ecclesiastici in facoltà romane o nel resto d’Italia), mentre, per altro verso, non rendono ancora percepibile un lieve rallentamento del ricorso al clero straniero che sembra in atto dal 2010.
Nel complesso, dopo quarant’anni le diocesi italiane possono contare su meno preti diocesani, su preti diocesani mediamente più anziani e su preti diocesani passati per una formazione meno intensa e forse anche (ma questo è più difficile da stabilirsi) attraverso una selezione meno severa. Anche nel caso del clero, insomma, si verifica in un modo o nell’altro quello che si sta verificando per le élites in pressoché tutti i settori della società italiana.
I religiosi
Purtroppo solo pochi dati sono a disposizione per una delle componenti più importanti e più caratteristiche del cattolicesimo religioso: la vita religiosa – maschile e femminile – con i suoi ordini, le sue congregazioni, le sue varie e molteplici forme di organizzazione.
Per quanto riguarda l’Italia e il periodo che si sta considerando si può dire che i presbiteri religiosi presenti nelle diocesi di questo Paese sono passati da 22.423 nel 1970 a 15.202 nel 2012, perdendo circa un terzo della propria consistenza e subendo un calo molto più forte di quello conosciuto dal clero diocesano. Se poi ci sono indizi per ritenere probabile che nel calo quantitativo non si esprima che una parte delle trasformazioni sperimentate da questo settore del personale ecclesiastico, non ci sono però informazioni empiriche in grado di documentarlo con precisione. Tra le poche disponibili vi è quella per cui tra i presbiteri religiosi inseriti nel sistema di sostentamento del clero gestito dalla CEI (in ragione dei loro impegni pastorali a livello diocesano o parrocchiale) l’età media sale lievemente dai 55 anni ai 55,8, per effetto della crescita dell’età media dei nati in Italia da 55,4 a 59,2 e del calo da 46,9 a 44,56 anni di coloro che non sono nati in Italia. Sempre tra i presbiteri religiosi inseriti nel sistema di sostentamento del clero della CEI la quota di nati all’estero passa dal 4,5% al 23%.
Un insieme di altre informazioni consente di documentare un ulteriore processo che ha interessato la componente religiosa maschile e clericale. In primo luogo sono evidenti una continua chiusura di opere gestite da religiosi e il mantenimento da parte di costoro di un ruolo di guida, mentre per tutte o quasi le altre funzioni si ricorre a personale esterno. Risulta chiaro che tale sostituzione di personale è tutt’altro che ininfluente sulle caratteristiche del servizio: la preparazione professionale e quella spirituale variano di molto, anche se, a seconda degli aspetti e dei casi, è più difficile dire con certezza in quale direzione. Nonostante diminuisca il numero di parrocchie rette da presbiteri religiosi (dalle 2014 del 1976, dopo un breve periodo di incremento, alle 1748 del 2012), il rapporto tra presbiteri religiosi e parrocchie rette da clero religioso cala da 10,4 a 8,7% secondo i dati ASE. Insomma: il lavoro parrocchiale (spesso non primario rispetto al carisma dell’ordine o della congregazione di appartenenza) assorbe, rispetto ad alcuni decenni orsono, una quota più alta delle risorse di una popolazione di religiosi nel frattempo divenuta più piccola, mediamente più anziana e più eterogenea. Infine cresce la quota di presbiteri religiosi il cui sostentamento economico viene assicurato dal sistema CEI. Nel 1991 secondo i dati dell’ASE su 19.509 presbiteri religiosi presenti in Italia, 4049 erano inseriti nel sistema di sostentamento economico del clero della CEI (ICSC). Nel 2012 i valori sono divenuti, rispettivamente, 15.202 e 5004, con un valore percentuale salito da 20,8 a 32,9%. In breve, il complesso di questi tre processi propone un’immagine di vita religiosa maschile che in Italia, non solo conosce una significativa contrazione numerica, ma è anche sottoposta a un certo declino della propria specificità e della propria autonomia. Le stesse istituzioni dedicate alla formazione teologica dei novizi, e il relativo personale docente, sempre più spesso sono condivise tra realtà religiose diverse e tra queste e clero diocesano.
Le religiose
Nel caso della componente femminile della vita religiosa la varietà delle forme e il difetto di un’informazione empirica sistematica crescono ulteriormente rispetto alla componente maschile. Analiticamente ciò costituisce un grave problema, considerando quanto grande è l’importanza della vita religiosa femminile, in Italia e non solo, per la comunità ecclesiale e per la comunità civile. Certamente non senza contraddizioni, né sempre ottenendo gli stessi livelli di successo, le religiose hanno garantito nella comunità civile una testimonianza spirituale unica, una rete di servizi varia e capace di costante rinnovamento, e un canale di emancipazione femminile (le prime laureate in medicina in Italia, per es., furono delle suore). Contemporaneamente nella comunità ecclesiale le consacrate hanno aperto alle donne spazi inediti e ben strutturati (anche giuridicamente) di espressione, di partecipazione e di autonomia.
Sostanzialmente l’informazione empirica affidabile si riduce a un solo dato, di tipo complessivo. Esso ingloba, ma anche vela, molte altre informazioni che invece sarebbe urgente far emergere distintamente. Ciò nonostante si tratta di un dato importante e inequivoco. In Italia, secondo i dati ASE, dal 1976 al 2011 le religiose professe (quelle che hanno pronunciato voti definitivi o equivalenti) sono passate da 145.090 a 89.264. In quarant’anni la perdita è stata dunque di circa 56.000 unità, pari al 61,5% di quattro decenni fa. Con tutta evidenza si tratta di una contrazione molto più consistente di quella fatta segnare dai religiosi, e ancor più rispetto al clero diocesano.
È poi molto probabile che questo saldo nasconda – come nel caso del clero diocesano e dei religiosi – trasformazioni anagrafiche e di provenienza che al momento non possono però essere quantificate. Così com’è molto probabile che in non tutti i settori della vita religiosa femminile lo scarto negativo appena indicato abbia le stesse dimensioni. Anche in questo caso è ragionevole ipotizzare che nelle forme di ‘vita attiva’ esso abbia un’intensità superiore per lo meno rispetto ad alcune esperienze di vita contemplativa e di clausura. Quello che però è possibile documentare, sebbene attraverso numeri piuttosto piccoli, è che la vita religiosa femminile resta ancora, almeno in parte, spazio di ricerca e di sperimentazione. Il calo degli ultimi trent’anni sembra infatti da attribuirsi per intero a organismi di diritto pontificio (ordini e congregazioni tradizionali), mentre le realtà di diritto diocesano (spesso più recenti, più flessibili e anche con maggior ricambio) in termini complessivi presentano una tenuta (e anzi un lievissimo incremento).
Altri attori
Una comparazione tra le dimensioni del personale e le forme della struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia intorno al 2010 e intorno al 1970 fa emergere un’altra serie di de-formazioni (termine esente da ogni connotazione valutativa). Queste si aggiungono e si intrecciano, ma non possono essere spiegate solo con quelle illustrate sin qui. Nella struttura in questione, infatti, hanno influito anche una parte dei cambiamenti intervenuti nelle forme della partecipazione laicale alla vita delle istituzioni ecclesiastiche. Essa ha dovuto fare i conti anche con il nuovo protagonismo assunto nell’ambito del cattolicesimo religioso da organizzazioni non controllate dall’episcopato e molto diverse dalle tradizionali associazioni ecclesiali del laicato cattolico, tuttora ben vive. Come è noto, il fenomeno in questione non si è verificato solo in Italia, anzi, altrove si è manifestato in modo ancora più evidente.
Nel corso dei quarant’anni analizzati hanno acquistato visibilità alcune organizzazioni religiose non controllate dalle ordinarie istanze ecclesiasiche e che hanno sviluppato rapporti, via via sempre più stretti, con la struttura dell’autorità religiosa cattolica sino a esercitare al suo interno una crescente influenza. Una elevata capacità di varietà è caratteristica del tessuto religioso cattolico e ha sempre influenzato la forma della struttura dell’autorità in quell’ambito. Per molti secoli la gran parte di quella varietà aveva trovato espressione nelle organizzazioni della vita religiosa. Oggi sembra invece esprimersi anche al di fuori di queste e indipendentemente dalle mediazioni tra queste e la componente del clero diocesano, mediazioni che, più o meno efficacemente, si erano imposte e avevano funzionato durante gli ultimi quattro secoli.
Tra queste nuove organizzazioni, nuove per l’opinione pubblica e non certo per l’analisi sociale dei fenomeni religiosi, il tipo attualmente più famoso è quello dei cosiddetti nuovi movimenti religiosi cattolici. Per la verità, la loro comparsa andrebbe accuratamente distinta dall’aumento della loro visibilità e collocata lungo l’asse temporale della storia della Chiesa. Rispetto all’opinione corrente, tale operazione produce una decisa retrodatazione della comparsa di gran parte di quei movimenti, e soprattutto dei più famosi. La stessa idea di una loro omogeneità tipologica andrebbe accantonata a favore di uno schema analiticamente più raffinato, capace di mettere in luce tipi molto diversi e il succedersi di ondate dai caratteri altrettanto diversi.
Per nulla originale, e anzi manifestatosi nel cattolicesimo italiano con un certo ritardo, il sorgere di queste nuove realtà rappresenta una variante del più generale processo di diversificazione sia dell’offerta sia della domanda religiosa. Nonostante alcuni ‘nuovi movimenti’ cerchino di egemonizzare l’immagine e la rappresentanza di questo complesso fenomeno di diversificazione dell’offerta religiosa cattolica, essi non solo non rappresentano la totalità o i caratteri generali di questo processo, ma neppure la parte quantitativamente più consistente. Semmai ne costituiscono la porzione con maggiore capacità di autorappresentazione, intra ed extrareligiosa, e ciò – paradosso solo apparente – proprio grazie al livello di organizzazione e di centralizzazione maggiore in loro più che negli altri. In realtà, dello stesso processo di diversificazione interna dell’offerta religiosa cattolica sono parte integrante e quantitativamente prevalente forme di religiosità popolare nuove o profondamente rinnovate, nuove esperienze di monachesimo (alcune delle quali già ben strutturatesi e influenti), e, soprattutto, una vastissima platea di gruppi religiosi di modeste dimensioni e spesso privi di etichetta e di legami con altre realtà.
Non si tratta di un fenomeno che si manifesta solo nel cattolicesimo religioso, né in questo prima che altrove (a partire dalla società statunitense come mostrato, tra gli altri, da Robert Wuthnow e Mark Chaves), ma di un processo che caratterizza, per lo meno dagli inizi del 20° sec., tutto l’ambito religioso delle società a modernizzazione avanzata, e quindi anche a individuazione avanzata. Nel caso del cattolicesimo, e particolarmente di quello italiano, l’originalità sta nei rapporti che (a vari livelli) vengono negoziati e rinegoziati tra molte di queste nuove realtà e l’autorità religiosa. È in questi termini, e senza raggiungere neppure gli apici che tocca in altri contesti nazionali (come nell’area di lingua spagnola e portoghese), che il processo di diversificazione dell’offerta religiosa e degli stili di consumo si manifesta anche in Italia. Pur non essendo necessario in questo contributo offrirne un’analisi dettagliata, è comunque indispensabile dare conto della capacità dimostrata da molti di questi attori di avere un impatto significativo sulla struttura dell’autorità religiosa cattolica sino a produrvi delle de-formazioni molto accentuate.
Va subito chiarito che per comprendere questo fenomeno è sconsigliabile scegliere la quantità come chiave interpretativa primaria. Infatti, la tesi molto diffusa di una sostituzione dell’associazionismo laicale tradizionale – in primis quello di Azione cattolica italiana (ACI) – con i ‘nuovi movimenti’ non è confortata da elementi empirici. È sicuramente vero che l’ACI, secondo i suoi dati, dal 1970 a oggi ha perso circa due iscritti su tre, ma per valutare questo dato va innanzitutto tenuto presente che la formalizzazione dell’adesione è divenuta fenomeno sempre più raro e socialmente costoso in ogni ambito, non solo in quello religioso. Inoltre, per quello che è possibile ricostruire dalle fonti empiriche disponibili (Burgalassi 1970; Garelli 1991; Cesareo, Cipriani, Garelli et al. 1995), anche solo considerando il periodo che va dagli anni Novanta a oggi, si è dimezzata la quota di popolazione adulta partecipante a una forma qualsiasi di aggregazione religiosa. Entro questo trend generale, l’ACI conserva tuttora le dimensioni quantitative più consistenti. Dichiara infatti di parteciparvi circa il 2% della popolazione italiana adulta: una quota superiore a quella raggiunta sommando i dati raccolti di tutti gli altri principali ‘nuovi movimenti’ religiosi cattolici (VDS). Per es., con riferimento al 2011, l’ACI conta una presenza formalizzata in circa 6000 parrocchie italiane (su oltre 25.000), il Cammino neocatecumenale in circa 1100 (Cicchini 2013). Semmai, stabilmente più diffusa dell’Azione cattolica appare la miriade di gruppi parrocchiali senza etichetta.
Se poi ci si riferisce alla popolazione di età inferiore ai 18 anni, la sua diffusione è ancora meno contrastata da quella dei nuovi movimenti, e affiancata piuttosto dalla diffusione di altre esperienze associative storiche come le varie forme di scoutismo cattolico. In questa fascia d’età, la tipologia del gruppo spontaneo conosce una diffusione ancora più larga che tra gli adulti. Pertanto, invece che di un fenomeno di sostituzione dell’associazionismo con i nuovi movimenti, si dovrebbe parlare di: a) una generale contrazione della partecipazione della popolazione ad aggregazioni religiose di qualsiasi tipo; b) un notevole turnover e una diffusissima improvvisazione ed estemporaneità educativa e formativa in questa partecipazione; c) un’enorme diversificazione di questo fronte con un impatto notevole sulla sua effettiva qualità ecclesiale e civile. Non a caso nel 1991 la CEI dovette pubblicare una Nota concernente i ‘criteri di ecclesialità’ di queste esperienze e poi, alla metà degli anni Duemila, ribadirne alcuni contenuti in diversi documenti.
I nuovi movimenti religiosi cattolici, nelle forme più diverse, tendono a offrire alternative rispetto alle normali prassi catechetiche, liturgiche, spirituali, sino a ritagliarsi di fatto uno spazio nei processi di formazione e di selezione del clero diocesano (giungendo sino all’istituzione e gestione di seminari separati per candidati al presbiterato, provenienti da qualche esperienza di movimento). La scelta della CEI, imitata dalle diocesi in qualche caso per isomorfismo mimetico, in qualche altro per isomorfismo coercitivo (Il neoistituzionalismo nell’analisi organizzativa, 2000), è stata quella di sostituire l’antica opzione dell’associazionismo prevalentemente affidato alla responsabilità laicale – tipico il caso dell’Azione cattolica, ribadito solennemente dal magistero del Concilio Vaticano II (si veda tra l’altro l’Apostolicam actuositatem nr. 20 del 1965) – con la scelta di creare uffici pastorali settoriali affidati al clero, e con un laicato retrocesso a ruoli subalterni, una sorta di blanda istanza di compensazione e coordinamento, o di diretta mobilitazione, e raramente di governo e di orientamento. Si tratta di una soluzione i cui maggiori successi sono ottenuti di norma nell’organizzazione di eventi o nell’assunzione di ruoli di rappresentanza presso altre istanze pubbliche extraecclesiali, in particolare politiche. In questa direzione tanto la CEI quanto le diocesi hanno investito una quota enorme delle loro risorse materiali e simboliche. È per questa via che è maturata una prima grande de-formazione delle istituzioni che regolavano il rapporto tra autorità religiosa e laicato cattolico, e per la stessa via si è ricercata sistematicamente una inedita egemonia della ‘pastorale’ sull’‘apostolato dei laici’. Più che i nuovi movimenti le strutture ecclesiastiche della pastorale hanno preso il sopravvento su quelle forme di associazionismo che avevano fatto da vettore all’emancipazione religiosa e civile del laicato cattolico nel corso dell’Ottocento e del Novecento.
Certamente tra le cause di questo fenomeno ci sono anche la crisi culturale e spirituale dell’associazionismo laicale tradizionale, le nuove condizioni di estrema diversificazione della domanda religiosa, un progetto o semplicemente un istinto ‘neoclericale’ che ha ripreso vigore in tempi di transizione e di crisi. Sta di fatto che il nuovo ruolo dell’associazionismo laicale, maturato a partire dalla fine del 19° sec., con il determinante contributo dei cattolici italiani, dopo tanti aspri contrasti anche intraecclesiali, alla fine riconosciuto e consacrato dal magistero del Concilio, ha subito una sorte inattesa. Entrato negli anni Settanta del 20° sec. legittimato come mai prima, esso è uscito dal primo decennio del 21° sec. avendo subito un pesante ridimensionamento, non della propria formale legittimazione, ma degli spazi e delle risorse di cui poteva materialmente avvalersi. Tale ridimensionamento è stato operato dalle strutture della pastorale a guida ecclesiastica, e dunque proprio a opera di quella autorità religiosa cattolica dalla cui struttura i ‘nuovi movimenti’ o i piccoli gruppi informali si erano prima tenuti lontani e al riparo, guadagnando enormi spazi di discrezionalità, per poi rinegoziare vantaggi da posizioni di una qualche forza (caso per caso: socialmente strutturata o puramente mediatica). La domanda è: l’autorità religiosa cattolica sta tentando di governare il processo dall’interno o si è arresa a questo trend e ai suoi attori?
Rifacendoci nuovamente agli insegnamenti di Weber, il sociologo probabilmente si chiederebbe se, nell’ambito del cattolicesimo religioso italiano, esiste ancora un ‘monopolio della coercizione ierocratica legittima’, ovvero se questo ha ancora forma ecclesiale.
Non va quindi commesso l’errore di considerare i protagonisti e i risultati del processo di diversificazione e di frammentazione dell’offerta religiosa come frutto del Concilio Vaticano II (1962-65). Un’analisi delle date, dei documenti, dei programmi e dei repertori d’azione aiuterebbe a evitare un tale errore. Qui è sufficiente ricordare che il primo manifestarsi di queste nuove organizzazioni religiose non ecclesiastiche (piccole e grandi) si verifica in periodi poco o molto precedenti al Concilio. Del resto, tutto il Novecento religioso italiano è percorso dai tentativi di far fronte ai crescenti segni della diversificazione della domanda religiosa (Diotallevi 2001). L’originalità del modello di cattolicesimo italiano novecentesco sta proprio nel fatto che l’autorità religiosa (a partire da Pio XI e secondo un disegno esplicito) ha cercato di affrontare questa nuova situazione socioreligiosa immaginando e realizzando una forma di modernizzazione ecclesiastica che consentisse un grado di diversificazione interna non incontrollato. Più elevato di quanto avveniva nei cattolicesimi religiosi dell’Europa centro-occidentale, ma meno di quanto avveniva nei cattolicesimi iberici. Questo mix in linea di principio usciva rafforzato dal Concilio.
È però proprio con la fine degli anni Sessanta che si manifestarono in Italia i primi effetti culturali e morali della drastica accelerazione della modernizzazione sociale che si era verificata a partire dal decennio precedente. Quel salto di ritmo ebbe la meglio sulle capacità di risposta di quella geniale, e a lungo efficace, forma di mediazione elaborata negli anni successivi alla Prima guerra mondiale. In queste condizioni, sul rinnovamento proposto dal Concilio e largamente celebrato sul piano delle affermazioni dottrinali, su mediazioni non tempestive o non adeguate nella pratica del rinnovamento conciliare, finì per prevalere quello che può essere definito un recupero selettivo della tradizione (Finke 2004). Una platea vastissima di soggetti, grandi, medi e piccoli, elabora e si caratterizza per i più vari mix di ‘vecchio’ e di ‘nuovo’. In termini di mercato religioso è una soluzione apparentemente vincente. Essa consente ancora all’insieme del cattolicesimo religioso italiano di rivolgersi quasi a ciascuna nicchia di domanda religiosa.
Evidentemente, però, si tratta di un successo fatto di numerosissimi e non componibili microsuccessi. Presto o tardi, a seconda dei casi, nel corso dei decenni successivi questo successo si è rivelato, se non una sconfitta, certamente la causa di una gravissima crisi di compatibilità tra forma ecclesiale e cattolicesimo religioso. Dopo quarant’anni è ormai chiaro che tale crisi non ha risparmiato neppure la formazione e la selezione del clero o gli standard liturgici. Ormai, quasi senza suscitare reazione, il pluralismo dei singoli imprenditori religiosi cattolici e l’arbitraggio individuale del consumatore religioso finale sono penetrati nel tessuto ecclesiale ben più in profondità di quanto era avvenuto con la pluralizzazione delle opzioni politiche, a proposito delle quali erano stati celebrati tanti drammi e agiti tanti conflitti. Quella in corso appare così una fase con i riflessi tipici che i momenti di grande discontinuità sociale producono dentro le grandi tradizioni religiose. Ciò non toglie che – anche sotto questo profilo – al momento sia più facile osservare questa ulteriore de-formazione che non intravedere l’approdo e l’affermazione di rinnovate istituzioni ecclesiali. Per alcuni versi questa fase di estrema diversificazione ricorda quella conosciuta dal cristianesimo statunitense (in particolare di quello ‘protestante’) nella prima metà del Novecento, i cui grandi numeri non sono che il prodotto di frammenti sempre più numerosi e sempre più piccoli ed extrareligiosamente meno rilevanti.
Da un lato ciascuno dei frammenti, dal movimento più consistente al gruppo parrocchiale più piccolo, tende a sottrarsi al controllo e alla regolazione del vertice della struttura dell’autorità religiosa. Dall’altro lato, diversamente da quello che si è verificato nell’ambito del protestantesimo nord e sudamericano, questi frammenti non escono definitivamente dal campo religioso cattolico, non coniano un nuovo brand e una nuova identità. Essi non fanno mancare la legittimazione simbolica al pontefice (più critica è la relazione con i singoli vescovi), né la cooperazione a singole iniziative, ma in genere le rinegoziano in cambio di altri vantaggi a partire da quello minimo di una certa visibilità. In una situazione come quella italiana, dove la dominanza del cattolicesimo sul campo religioso ha da tempo assunto forme di larga flessibilità, ‘uscire’ sarebbe allo stesso tempo molto costoso (implicherebbe sostenere un conflitto e farebbe lievitare il prezzo dei propri beni e servizi religiosi) e poco redditizio (anche perché il controllo che l’autorità ecclesiastica di fatto esercita non è poi così asfissiante). Dunque questa miriade di piccoli e grandi frammenti, dopo essersi sottratta a una già modesta presa, ricontratta il proprio contributo in termini di partecipazione e di legittimazione simbolica, non di rado con abbondanti ricorsi a eccezioni ed esenzioni, quali neppure gli ordini religiosi più forti avevano ottenuto (Prodi 2010). Molto interessanti, sotto questo profilo, sono le vicende che hanno caratterizzato la discussione degli statuti e delle prassi di tanti soggetti, dall’Opus Dei a Comunione e liberazione, al Cammino neocatecumenale e così via.
Il risultato, analiticamente inedito e interessante, del processo menzionato è il formarsi di una nuova struttura dell’autorità religiosa cattolica, altrove definita multi channels: fatta non più di un canale, ma di molti e tra loro diversi (Diotallevi 2001). I canali di questa struttura, le ‘vie di comunicazione’ e poi inevitabilmente anche i ‘programmi’ (Luhmann 2005), non solo si moltiplicano e per tanti versi divengono paralleli e tra loro non comunicanti, ma si diversificano per tipologia. In alcuni casi diventano addirittura estremamente informali. Ciò implica anche una netta perdita della distinzione tra carisma e autorità e, dunque, la messa in crisi di uno dei tratti distintivi di un’istituzione religiosa di tipo ecclesiale, ovvero di quella forma sociale che il cattolicesimo, forse più di qualsiasi altra tradizione cristiana, aveva tenacemente cercato di conservare. In secondo luogo, il processo di moltiplicazione e di diversificazione dei canali dell’autorità religiosa cattolica, quando non azzera l’autorità del vescovo diocesano (vero caposaldo della ecclesiologia cattolica e base dello stesso primato petrino), relativizza l’appartenenza di ogni battezzato a una determinata Chiesa particolare, come se questa non fosse che un gruppo tra gli altri (magari anche di valore residuale) o una semplice struttura di servizio. Autorità del vescovo diocesano e appartenenza a una Chiesa particolare possono essere scavalcati attraverso un riferimento più o meno formalizzato, e sempre molto labile, all’autorità del papa. Insomma, nel primo e nel secondo caso (separazione tra autorità e carisma, messa in crisi dell’autorità del vescovo diocesano) in gioco ci sono due capisaldi della grande e originaria tradizione della Chiesa che erano stati recuperati in pienezza e riproposti con il Vaticano II, per mezzo della sua Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium (1964). Perché anche a questo proposito l’impiego assolutamente avalutativo del concetto di de-formazione appare appropriato.
Infine un terzo tipo di de-formazione risulta dall’impatto del processo appena descritto su ruoli e istituzioni tradizionali della Chiesa cattolica: il prete, la parrocchia, gli uffici pastorali di curia. Anche questi subiscono l’impatto, quando non anche il fascino, del modello appena descritto, ovvero di una potenzialmente illimitata proliferazione della diversificazione interna dell’offerta religiosa cattolica. A volte si tratta di un’influenza non programmata, interpretabile attraverso il ricorso alla nozione di isomorfismo mimetico (Il neoistituzionalismo nell’analisi organizzativa, 2000). Altre volte si tratta di un effetto programmato, come nel caso in cui ruoli di responsabilità in ambito della struttura dell’autorità religiosa vengono assunti da individui di cui carriera, interessi e cultura sono, prevalentemente o del tutto, radicati proprio in quelle realtà protagoniste del processo di diversificazione interna dell’offerta religiosa cattolica (Melloni 2013). Gli analisti hanno impiegato concetti e teorie diverse per interpretare il diffondersi di queste tendenze all’interno del cattolicesimo religioso (settarizzazione, denominazionalizzazione, congregazionalizzazione). Questi tentativi di concettualizzazione sono accomunati dalla volontà di comprendere la grave tensione alla quale sono sottoposte le istituzioni che in questi ultimi secoli avevano garantito al cattolicesimo religioso forma ecclesiale, in Italia e in misura non piccola, grazie al ruolo e al peso del cattolicesimo italiano, nel cattolicesimo universale.
Se alle de-formazioni descritte in precedenza affianchiamo queste ultime, la base empirica che consente di parlare di ‘neoclericalismo’ assume contorni più chiari. Un clericalismo nuovo perché fatto più di esposizione e di visibilità che di volontà e possibilità di effettivo governo. Un clericalismo con più risorse e, nello stesso tempo, con meno politiche e con progetti di raggio più corto. In definitiva, il processo di centralizzazione e di verticalizzazione della struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia si combina non solo con l’assottigliarsi della quantità del personale a disposizione, ma anche con le tre de-formazioni appena descritte, le quali riducono non solo la capacità di governo della struttura dell’autorità religiosa cattolica, ma persino la possibilità di governo su questa stessa struttura. Il processo di centralizzazione-verticalizzazione in parte si conferma, in parte si depotenzia, in parte funge da bilanciamento di quelle stesse tendenze de-formanti. Il costo complessivo di questo fascio di tensioni è un ridursi (non un annullarsi) del raggio di influenza della tradizione cattolica oltre il perimetro del religioso. Non a caso, questi quarant’anni sono quelli della centralizzazione dell’autorità religiosa cattolica in Italia, sono gli anni del dominio della ‘pastorale’ su tutte le altre forme di apostolato nella Chiesa, e sono inevitabilmente anche gli anni di crisi del cattolicesimo politico, della rilevanza del cattolicesimo nel mondo economico (sindacale, imprenditoriale ecc.), della scienza e della cultura, così come sono gli anni del declino del grado di correlazione tra le varie dimensioni della religiosità individuale (partecipazione, identificazione, conoscenza, credenza, esperienza). Perciò, alla fine, sembra abbia senso parlare proprio di ‘neoclericalismo debole’.
In questo orizzonte di neoclericalismo debole, la CEI ha cercato per tre lustri di introdurre criteri di razionalità e di conseguire dei risultati, investendo le notevoli e variegate nuove risorse a sua disposizione. I suoi organismi centrali hanno in parte prodotto e in parte cercato di supplire alla crisi di un intero mondo di opere e di associazioni; hanno cercato di coordinare o almeno di non essere scavalcati dalla schiera dei soggetti grandi e piccoli della diversificazione interna dell’offerta religiosa cattolica; hanno dedicato un particolare impegno al controllo della rete dei media cattolici di vecchia generazione (stampa, radio e televisione) e di nuova generazione. Ora, però, alcune condizioni interne ed esterne sembrano mutare, e la strategia dei vertici CEI appare sempre più chiaramente aver svolto, nel migliore dei casi, una terapia di mantenimento.
Da questa terapia di mantenimento, a guida fortemente centralizzata e a regime fortemente verticalizzato, le aree regionali hanno subito un effetto duplice, solo apparentemente contraddittorio. Per un verso alcune differenze subnazionali si sono attutite, per altro verso le prestazioni del sistema dell’autorità religiosa non potevano avere in periferia la stessa efficacia che avevano al centro e, dunque, hanno finito con il lasciare, rispetto al passato, più spazio alla varietà, (in grado maggiore o minore a seconda dei casi), spesso tollerandola semplicemente per l’impossibilità di regolarla. Chiesa, in termini sociologici, significa anche integrazione di dimensioni di religiosità e pretesa di influenza (significativa anche se non coercitiva) extrareligiosa, e dunque Chiesa significa territorio. Nella misura in cui la religione e la religiosità cattolica tendono a perdere forma ecclesiale, anche nella struttura della loro autorità, esse perdono anche contatto con il territorio, e viceversa.
Differenze interregionali
Il processo attraverso il quale il cattolicesimo religioso italiano ha conosciuto la trasformazione fin qui descritta non solo differisce da quanto nello stesso periodo di tempo si è verificato in altri cattolicesimi religiosi nazionali, ma al proprio interno conosce ancora altre differenze. In parte, infatti, il processo così com’è stato descritto a livello nazionale non è altro che il risultato prodotto dal comporsi di traiettorie diverse di diverse aree subnazionali. È il momento di mettere in luce il significato di almeno alcune di queste differenze, osservandole a livello regionale. Nel farlo verranno tenuti presenti i valori riferibili alle sedici regioni ecclesiastiche nelle quali è suddiviso il territorio italiano. Queste regioni tendenzialmente coincidono con quelle amministrative salvo l’accorpamento di Piemonte e Valle d’Aosta, Triveneto, e Abruzzo e Molise.
L’analisi territoriale del processo descritto a livello nazionale non condurrà alle singole regioni. Quanto risulterà è piuttosto la presenza di un certo numero di aree ben più omogenee di quella nazionale, costituite in qualche caso da una e spesso da più regioni. L’obiettivo, da qui in poi, è porre il problema di una stima del peso da attribuire alle politiche religiose assunte dagli organismi ecclesiastici di livello regionale, in ordine all’evoluzione formale e funzionale della struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia. Al termine, il risultato sarà una serie di indizi che suggeriscono di orientarsi verso una zona molto lontana da ogni illusione di ‘regionalismo ecclesiastico generalizzato’, senza però per questo finire con l’accogliere l’idea di un’assoluta irrilevanza degli organismi collocati a livello regionale della struttura dell’autorità religiosa cattolica. Fa pensare il fatto che i due soli casi nei quali una singola regione mostra andamenti piuttosto diversi da quelli della macroarea circostante siano quelli delle due regioni che tendono spesso a mostrare i valori (relativamente) più positivi: la Lombardia e la Puglia.
Il semplice avvio, certo non esaustivo, delle complesse operazioni richieste da una comparazione socioreligiosa a livello regionale con riferimento al caso italiano, esige un paio di premesse. Innanzitutto occorre chiarire il punto di partenza qui adottato. Esso coincide con una domanda: in quale misura e in quale direzione alcune delle trasformazioni socioreligiose intervenute nei singoli casi regionali nel quarantennio 1970-2010 divergono da quanto osservato a livello nazionale? Impostare l’analisi in questi termini appare significativo e utile proprio perché non ci sono gli elementi empirici per affermare che qualche area regionale ha conosciuto, nel periodo considerato, un mutamento significativamente diverso per direzione o intensità rispetto a quello sperimentato dal Paese nel suo insieme.
Negli ultimi quarant’anni nessuna delle regioni italiane è andata in assoluta controtendenza rispetto al Paese in generale. Dunque, le differenze con cui fare i conti sono quelle utili a dettagliare il quadro senza però stravolgerlo. In secondo luogo è opportuno ricordare che una corretta analisi comparativa dei diversi casi regionali pretenderebbe un’attenta considerazione di numerosi gruppi di variabili. Tra queste si possono ricordare le enormi differenze tanto di ordine fisico e climatico quanto di ordine sociale e culturale che esistono tra le aree territoriali, sia in termini sincronici sia diacronici. È sufficiente a questo proposito fare un esempio: come è possibile considerare il numero delle diocesi e, a maggior ragione, quello delle parrocchie e la distribuzione del clero sul territorio indipendentemente dal fatto che questo abbia un aspetto pianeggiante e una certa concentrazione urbana, oppure che esso sia montuoso e la popolazione sia, o sia stata, fortemente dispersa?
Diverse sono anche le caratteristiche demografiche delle varie realtà regionali e si può facilmente intuire quanto questo influisca, per es., sulle dinamiche di reclutamento del personale ecclesiastico (La parabola del clero, 2005). Nondimeno incidono sul presente religioso delle regioni i diversissimi passati civili ed ecclesiastici. Per certi versi dalla mappa dell’attuale cattolicesimo religioso italiano è ancora relativamente facile intuire sia i profili dei numerosi cattolicesimi preunitari, sia i successi e gli insuccessi delle politiche di modernizzazione ecclesiastica intraprese a partire dal pontificato di Pio XI (1922-39) e imperniate sul trasferimento al Centro e al Sud della penisola di elementi importanti del modello ecclesiastico ambrosiano (Diotallevi 1999). Non si dovrebbe dimenticare che, nel corso del quarantennio preso in esame, spesso sono state diverse le scelte pastorali compiute dalle realtà ecclesiastiche regionali e che, dunque, il panorama attuale non sarebbe comprensibile senza tenere conto anche di queste politiche differenti e di differente grado di successo (o insuccesso).
Nessuno di questi gruppi di fattori può essere assolutizzato, né a esso si possono attribuire a priori alcuni effetti, dacché ciascuno di quei gruppi, e ciascuno dei fattori che ne fanno parte, reagisce diversamente a seconda delle combinazioni in cui viene a trovarsi. La complessità di queste circostanze fa sì che con notevole prudenza l’analisi socioreligiosa possa passare dal livello nazionale a quello della comparazione interregionale. Solo entro queste condizioni sarà possibile individuare un paio di elementi che per consistenza possono effettivamente essere isolati. Per comodità di lettura conviene che essi vengano anticipati. In primo luogo, la trasformazione della struttura del cattolicesimo religioso osservata a livello nazionale risulta, non senza modulazioni, da una riduzione delle differenze infranazionali. La forza istituzionale del cattolicesimo religioso italiano diminuisce al Nord e al Centro più di quanto invece avviene nell’Italia meridionale. Per questa via si colma una parte del gap in ragione del quale sino a meno di mezzo secolo fa la struttura dell’autorità religiosa cattolica appariva nell’Italia settentrionale ben più solida rispetto a quella del Sud. In secondo luogo, si può dire che il processo appena citato sembra più accelerato negli anni Settanta e Ottanta rispetto al periodo successivo. Questo però non va preso come un dato finale. Il ritardo con il quale i dati regionali giungono rispetto a quelli nazionali non consente di dire, per es., se la nuova accelerazione dei processi di segno negativo registrata a livello nazionale a partire dalla seconda metà del primo decennio del 21° sec. si sia riflessa in modo più o meno omogeneo nelle singole regioni.
Un esempio di quanto appena detto è offerto dalle modifiche intervenute nella rete delle diocesi, il principale segmento della struttura dell’autorità religiosa cattolica (tab. 1). Come già precedentemente ricordato, agli inizi degli anni Ottanta del Novecento venne operato un sostanziale taglio del numero delle diocesi presenti in Italia. Questo intervento, tuttavia, non riguardò in misura proporzionale tutte le aree del Paese. Infatti al Nord le diocesi passarono da 70 a 63, con un calo del 10%, al Centro da 91 a 61, con un calo del 33%, al Sud da 129 a 101, con un calo del 22%. Il risultato fu dunque quello di una certa riduzione della differenza in termini di dimensioni demografiche medie delle diocesi presenti nelle varie aree del Paese. Nonostante ciò tale differenza resta consistente, se si considera che agli inizi della seconda metà degli anni Ottanta la diocesi media contava al Nord poco più di 400.000 abitanti, al Centro poco meno di 180.000 abitanti (ma molti di meno se non si considera la diocesi di Roma), e al Sud poco più di 200.000 abitanti (Istituto nazionale di statistica-ISTAT; ASE). La situazione risulta sostanzialmente invariata al 2012. Sempre al 2012 l’ampiezza demografica media delle parrocchie risulta rispettivamente di 2141 residenti al Nord, 2180 al Centro e 2697 al Sud (ISTAT; ICSC).
Per quanto riguarda le parrocchie le serie storiche più affidabili vanno meno indietro nel tempo e mostrano una situazione più articolata di quella relativa alle diocesi. L’effetto complessivo che si conferma è ancora quello di una riduzione delle differenze tra le varie aree del Paese. Essa risulta (nel raffronto tra dati ASE del 2012 e del 1986) da una modesta contrazione del numero delle parrocchie nella maggior parte del Nord e del Centro e da un modesto incremento delle stesse nella maggior parte del Mezzogiorno. L’unica eccezione di rilievo è costituita dall’Umbria. Nel periodo considerato, in questa regione scompare circa un quarto delle parrocchie. Il risultato probabilmente più significativo è quello che si produce dalla combinazione di questo processo con quello relativo al reclutamento di clero (sul quale si tornerà tra breve). Oggi solo una parte delle parrocchie può avvalersi di un parroco in esclusiva, ovvero di un presbitero (diocesano o religioso) residente nella stessa parrocchia e senza responsabilità di altre parrocchie (nel frattempo, infatti, è enormemente cresciuta la quota di presbiteri cui sono affidate due o più parrocchie). Sempre più spesso, ormai, le autorità ecclesiastiche si trovano alle prese con la necessità di scegliere tra mantenimento della capillarità del tessuto parrocchiale e grado di copertura dello stesso con personale presbiterale. L’arco temporale durante il quale è possibile osservare l’evolversi delle soluzioni adottate copre solo la seconda metà del quarantennio preso in esame. Se allora si confrontano i valori relativi al 2012 con quelli relativi al 1991 si può osservare che dopo vent’anni solo il 60,8% delle parrocchie che avevano un parroco in esclusiva lo hanno conservato. Tutte le regioni meridionali più le Marche e il Lazio vedono questo valore calare meno della media (dal 96% della Puglia al 62,5% delle Marche), mentre quelle settentrionali e centrali lo vedono calare più della media (dal 54,4% dell’Umbria e dell’Emilia-Romagna al 44,9% del Triveneto).
La tendenza appena descritta (una riduzione delle differenze interregionali ‘in discesa’) si ripropone, seppure con dettagli e sfumature diverse, quando si passa all’analisi delle principali figure del personale ecclesiastico. In questo caso sulla cartina della penisola si disegnano quattro o cinque aree a seconda dell’intensità della contrazione di clero diocesano, di religiosi e di religiose intervenuta a partire dagli anni Ottanta. Una ‘prima area’ è caratterizzata da valori negativi molto accentuati e da contorni piuttosto nitidi. Si tratta di quella sorta di falce che va dalla Valle d’Aosta all’Emilia-Romagna passando per il Piemonte e la Liguria. In queste regioni si registra una contrazione molto forte tanto di clero diocesano, quanto di religiosi e di religiose. Per dare un’idea dell’ordine di grandezza del calo basti dire che in Piemonte è presente il 61,6% del clero rispetto al 1986 e che in Liguria questa percentuale è del 62%. Una tendenza analoga, anche se con intensità lievemente inferiore, può essere osservata in una sorta di bordo esterno di questa area falciforme – la ‘seconda area’ – costituita da tre regioni: Toscana, Umbria e Marche.
Al contrario, sul bordo superiore della ‘falce’ è situata l’area dell’Italia settentrionale in cui i processi di decremento appaiono attenuati e in qualche caso addirittura meno intensi di quelli medi del Paese. Il cuore di questa ‘terza area’ è costituito dalla Lombardia. I dati complessivi relativi al Triveneto risultano più o meno intermedi tra quelli lombardi e quelli dell’area piemontese-ligure-emiliano-romagnola. Tuttavia, se scomposti, da quei dati si può osservare che il Veneto occidentale presenta valori non troppo lontani da quelli lombardi, mentre soprattutto la zona friulana presenta valori negativi più accentuati e, dunque, più vicini a quelli delle regioni della prima area.
In generale, se al Nord si cerca un valore comune deve essere trovato nella regressione quantitativa delle religiose, ancora superiore a quella media nazionale; più diversificata, invece, è l’intensità del calo del clero. Rispetto a quello dell’Italia settentrionale, uno scenario opposto appare al Sud. Come già accennato, qui il calo assume un’intensità di molto inferiore alla media nazionale, quando invece non si verifica una sostanziale tenuta. In questa porzione del Paese, seppure in forza di differenze meno nette di quelle viste al Nord, è possibile individuare nell’area pugliese il nucleo più vitale – una ‘quarta area’ – e nella zona campana-lucana-calabrese-siciliana la ‘quinta area’ con valori in genere di poco inferiori rispetto a quelli pugliesi. Per fare un esempio, in Puglia, Calabria e Basilicata il clero diocesano presente nel 2012 è quantitativamente più o meno lo stesso di quello presente nel 1986. Lo scenario è completato dalla Sardegna, che nella maggior parte dei casi presenta valori molto vicini a quelli medi nazionali, e da due regioni ecclesiastiche, Lazio e Abruzzo-Molise, i cui dati, talvolta vicini alla media nazionale, talvolta addirittura superiori (come nel Lazio), sono fortemente condizionati da fattori quali, per es., il massiccio ricorso a forme di reclutamento non convenzionale. Infine, anche al Sud il fenomeno più omogeneo è costituito dal decremento delle religiose.
Laddove è possibile compiere approfondimenti emerge uno scenario molto simile. Con riferimento al tipo di personale ecclesiastico di gran lunga più studiato, quello del clero diocesano, si può affermare che il trend osservato corrobora uno degli scenari ventennali elaborati nel 2003. Ci sono insomma buoni argomenti per sostenere che si è in presenza di una tendenza dai contorni piuttosto definiti e dotata di una certa costanza nel tempo, e dunque anche di una certa inerzia. Ciò significa anche – come allora si era osservato – che quello analizzato è un processo che può essere in qualche grado corretto e orientato, ma non facilmente arrestato o invertito (La parabola del clero, 2005).
Anche quando si analizzano le differenze interregionali tra le componenti collaterali del sistema dell’autorità religiosa cattolica in Italia si riscontra la medesima tendenza. Il maggiore spessore istituzionale del cattolicesimo religioso nel Nord del Paese non è in discussione, ma la distanza tra questo e quello del Sud si riduce. È quanto emerge dall’analisi di alcuni casi di partecipazione religiosa aggregata. L’area in cui si registra il decremento più consistente delle adesioni all’Azione cattolica italiana è quella di Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Umbria e Liguria. Al contrario la principale associazione ecclesiale italiana ha raggiunto il suo punto di massima espressione quantitativa in Puglia. In questa regione esiste un’associazione di Azione cattolica nel 60% delle parrocchie, mentre la stessa percentuale scende al 18% in Liguria, al 14% in Piemonte, al 12% in Toscana e al 10% in Umbria (ACI). Anche nella principale organizzazione dello scoutismo cattolico, l’Associazione guide e scout cattolici italiani (AGESCI), sembra ridursi il dislivello, un tempo molto marcato, a vantaggio delle aree settentrionali del Paese. Questa forma di scoutismo cattolico presenta in Sicilia più o meno gli stessi numeri che in Lombardia, in Puglia più o meno gli stessi numeri che in Piemonte. Interessante è anche osservare la distribuzione territoriale dei cosiddetti nuovi movimenti ecclesiali e della miriade di nuovi gruppi e nuove comunità religiose cattoliche. Tra i pochi dati a disposizione, i più attendibili sono quelli – già ricordati – relativi al Cammino neocatecumenale, una delle realtà più importanti in questo settore. Mentre al Nord il rapporto tra comunità neocatecumenali e popolazione residente varia da 0,1 a 0,4 ogni 10.000 individui, questo rapporto cresce al Centro e al Sud sino a superare l’1,3 nelle Marche e in Sicilia, e l’1,5 in Abruzzo-Molise e in Umbria (Cicchini 2013).
Se si considera il settore dei servizi sociali e sanitari promossi e/o gestiti da istituzioni ecclesiastiche, per il quale sono disponibili dati recenti molto dettagliati ma non serie storiche, si osserva uno scenario nel quale le differenze tra Nord e Sud non sono drammatiche. Secondo i dati forniti dal IV Censimento nazionale delle Opere ecclesiali sanitarie e sociali in Italia (OESSI), promosso nel 2010 dalla Consulta ecclesiale nazionale degli organismi socioassistenziali, dalla Caritas italiana, dall’Ufficio nazionale per la pastorale della sanità della CEI, in collaborazione con l’OSR (Osservatorio Socio-Religioso) e il SICEI (Servizio Informatico CEI), la capacità delle parrocchie di esprimere questi servizi è superiore alla media nazionale in Lombardia, in Toscana, nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, in Sardegna. La quota di forze di lavoro costituita dal personale retribuito impegnato in questi servizi, anche se in media maggiore al Nord rispetto al Sud, tocca i suoi massimi livelli in Liguria e in Lombardia, ma anche nel Lazio e in Puglia. Se calcolata sulle sole forze di lavoro impiegate nel settore dei servizi alla persona, essa raggiunge i livelli più alti in Liguria e Lombardia, ma anche in Puglia e in Basilicata. Al contrario, il divario tra Nord e Sud appare ancora elevato, e non di rado anche crescente, quando si considera la presenza di istituzioni religiose cattoliche nel settore dell’istruzione (dell’infanzia, primaria, secondaria) e in quello della formazione professionale. Nelle regioni del Nord si distribuisce una quota delle scuole d’infanzia promosse dalle istituzioni religiose pari a quasi il 65% del totale nazionale, mentre nelle stesse regioni è presente circa il 30% delle scuole d’infanzia promosse dallo Stato. Per l’area del Centro-Sud i rapporti si invertono (ICSC). Secondo l’osservazione svolta dal Centro studi per la scuola cattolica (CSSC), il gap tra Nord, Centro e Sud non è così macroscopico nel caso delle scuole primarie e secondarie, ma è comunque consistente e in alcuni casi in crescita. Ciò vale sia per gli istituti, sia per le scuole, le classi e gli alunni.
Un approfondimento
Per quanto il quadro sin qui ricostruito mostri una sua consistenza, esso avrebbe bisogno di numerosi approfondimenti. Tante sono le variabili in gioco, tanti i valori che ciascuna di esse può assumere e, dunque, tante e tanto diverse le combinazioni possibili. Inoltre, dal reagire di ciascuna di queste combinazioni con i diversi contesti regionali può scaturire che combinazioni molto diverse producano effetti molto simili e viceversa. Insomma, in modi molto differenti si può produrre una tendenza di sensibile calo, e in modi altrettanto differenti si può produrre una tendenza negativa attenuata, o addirittura una discreta tenuta. Tuttavia, quelle che nell’immediato appaiono come equivalenze, con il tempo possono generare tendenze radicalmente divergenti. Così, quello che sul momento può rivelarsi un sacrificio (per es., non ricorrere a forme non convenzionali di reclutamento del clero, o non a tutte indiscriminatamente), con il tempo potrebbe rivelarsi un saggio investimento. Al contrario, le scelte che hanno prodotto in tempi brevi i risultati migliori possono rivelarsi nei tempi medi del tutto improvvide.
In qualche ambito l’analisi può spingersi ancora un poco più avanti. È il caso – del resto tutt’altro che marginale – del clero diocesano. Per esso, a partire dagli anni Novanta, si dispone infatti di maggiori e migliori informazioni, sulla base delle quali è possibile osservare alcune differenze tra le strategie regionali di reclutamento e di gestione dei presbiteri diocesani che hanno concorso ai risultati appena descritti, e che nel medio periodo potrebbero dare luogo a qualcosa di diverso.
Tra il 2003 e il 2012 il clero diocesano si è ridotto in Italia di circa il 10%. Ciò si è verificato con una forte oscillazione tra le varie regioni ecclesiastiche. In Calabria il clero è aumentato del 10% mentre in Piemonte e in Liguria è calato di circa il 20%. In Basilicata (+4% circa), in Sardegna (−0,2%), in Campania (−0,4%), in Sicilia (−2,5%), in Puglia (−3,1%), nel Lazio e in Abruzzo-Molise (−7,2%), e in Lombardia (−9,3%) la contrazione è inferiore alla media nazionale. Nelle Marche (−14,1%), in Emilia-Romagna (−15%), nel Triveneto (−15,1%), in Toscana (−16,1%) e in Umbria (−17,2%) la contrazione è superiore a quella media nazionale. Ciò nonostante il rapporto tra clero diocesano e popolazione residente in tutto il Nord e il Centro, Lazio escluso, ha valori ancora superiori a quelli della media nazionale, mentre in tutto il Sud e nel Lazio gli stessi valori risultano inferiori alla media nazionale. Ciò valeva nel 2004 quando la densità media del clero diocesano in Italia era di 0,55 per 1000 abitanti, e sostanzialmente vale ancora nel 2012 quando il rapporto è sceso a 0,5. Tuttavia, per comprendere questo dato, non si può neppure trascurare che, a partire dagli anni Ottanta, ai sistemi tradizionali di reclutamento del clero se ne sono aggiunti degli altri (ordinazione di seminaristi provenienti da fuori diocesi – dall’Italia o dall’estero – e incardinazione di presbiteri provenienti da altre diocesi – italiane o estere – o da ordini religiosi, o ancora, servizio in una diocesi di un presbitero incardinato in un’altra) nel tentativo di far fronte o almeno di mitigare gli effetti di un calo significativo nelle ordinazioni, uniti agli effetti di una stagione di intensificazione degli abbandoni che ha toccato i suoi vertici quantitativi negli anni Settanta. Così è aumentato il ricorso a clero di origine straniera e il ricorso a quello che la letteratura chiama ‘clero alla seconda carriera’ – fenomeno facilmente visibile per l’aumento dell’età media del clero all’ordinazione – e, in generale, è aumentata la disponibilità da parte dei vescovi ad accogliere nella propria diocesi clero (e seminaristi) in uscita da ordini religiosi o da altre diocesi (Nesbitt 2007).
I dati mostrano con grande evidenza che molto diversa è stata nelle singole regioni la disponibilità a ricorrere a politiche non convenzionali di reclutamento del clero, a tutte indiscriminatamente o anche solo a qualcuna delle tre principali appena ricordate.
L’età media all’ordinazione di individui nati in Italia è cresciuta di 3,3 anni tra il 1991 e il 2012, ma tale crescita è stata superiore alla media nazionale in Calabria e nelle Marche, e molto superiore in Toscana e in Emilia-Romagna. Ancora più disomogeneo risulta il ricorso a clero di origine straniera. A fine 2012 esso è quasi un quarto del clero diocesano nel Lazio, quasi il 20% del clero diocesano in Abruzzo-Molise e in Toscana, il 15% del clero diocesano umbro, intorno al 10% del clero diocesano in Calabria e nelle Marche. All’opposto, è nato all’estero il 2% del clero diocesano della Lombardia, il 3% di quello della Puglia e del Triveneto, tra il 5% e il 7% del clero di Campania, Emilia-Romagna, Piemonte e Sicilia. Come facilmente immaginabile, le percentuali appena citate crescono tra i presbiteri con meno di 40 anni: in Umbria, per es., è di origini non italiane quasi la metà. Anche nel corso del tempo le politiche variano molto. Negli ultimi dieci anni è cresciuta di solo un paio di punti la presenza di clero straniero nel Lazio, mentre è continuata a crescere in modo sostenuto in Abruzzo, Molise, Toscana e Umbria. È cresciuta poco in Lombardia o in Puglia o nel Triveneto, ma è quasi raddoppiata in Basilicata (dal 3% all’8%), in Calabria (dal 5% all’11%), in Emilia-Romagna (dal 3% al 7%), in Liguria (dal 3% all’8%), nelle Marche (dal 4% al 9%). A fronte di questo dato vale la pena ricordare che i presbiteri del clero diocesano presenti in Italia a fine 2012 sono circa l’82% di quelli presenti a fine 1991, ma sono cresciuti di numero in Calabria, Puglia e Basilicata, e calati comunque meno della media nazionale in Lombardia, Lazio e in tutte le altre regioni del Sud, mentre sono calati assai di più rispetto alla media nazionale in tutto il resto del Centro e del Nord del Paese. Combinando ora le due serie di informazioni è evidente che tanto tra gli incrementi o tra i cali meno accentuati della media, quanto tra i decrementi ancora maggiori rispetto a questa, si possono rintracciare mix causali ben differenti, alcuni basati su di un consistente ricorso a pratiche di reclutamento non convenzionale e altri meno o per nulla. Il quadro si chiarifica, almeno in parte, ponendo in relazione le due informazioni (costruite sul rapporto dei valori al 2012 con quelli al 1991): il totale degli individui appartenenti al clero diocesano presenti in una regione e la quota di questi nati all’estero (fig. 1).
Per questa analisi è possibile individuare cinque gruppi di regioni ecclesiastiche. In Piemonte e Valle d’Aosta, in Emilia-Romagna e nel Triveneto, il clero diocesano cala più di quanto avvenga a livello nazionale e meno rispetto al livello nazionale cresce il ricorso a clero straniero. In Liguria, nelle Marche, in Umbria e in Toscana il clero diocesano si contrae numericamente più di quanto si verifica a livello nazionale e anche il ricorso a clero di origine straniera cresce più rapidamente della media nazionale, e particolarmente nel caso di Umbria e Toscana.
In Lombardia, in Puglia, in Sicilia, in Sardegna e in Campania il clero diocesano diminuisce meno che nel resto d’Italia, e cresce meno anche il ricorso a clero straniero. In Calabria e in Basilicata tutti e due i valori sono più elevati rispetto alla media nazionale. Infine nel Lazio e in Abruzzo-Molise il clero diocesano nel 2012 è più numeroso rispetto al 1991 e a questo risultato ha contribuito un ricorso a clero di origine non italiana molto più intenso della media nazionale, paragonabile solo a quanto verificatosi in Umbria e in Toscana. Come si può facilmente osservare, questa mappa non contraddice e anzi dettaglia, arricchisce e precisa la prima.
Un ulteriore passo in avanti è possibile affinando l’analisi delle combinazioni tra forme convenzionali e non convenzionali di reclutamento per il clero diocesano adottate a livello regionale (attraverso le ricerche ISTAT e ICSC). Emergono così importanti diversità che, se non altro, convincono a seguire con attenzione un processo che in futuro potrebbe comportare il rafforzamento delle divergenze già osservabili. Intanto i risultati di quest’ultimo passaggio corroborano e riassumono i quattro principali elementi sin qui emersi e li dettagliano ulteriormente.
In primo luogo, comunque si misuri la capacità di reclutamento, ciò che emerge è una forte riduzione delle differenze interregionali: la forbice tra i risultati migliori e quelli peggiori si restringe radicalmente, come si riduce drasticamente la varianza territoriale del fenomeno. Questo stesso risultato diventa ancora più significativo se si considera che le fonti informative utilizzate coprono il fenomeno delle ordinazioni sacerdotali solo per difetto, per il periodo 1962-81 (durante il quale hanno avuto luogo più ordinazioni di quelle per le quali si dispone di informazioni individuali). Per il periodo che va dal 1982 a oggi la capacità di reclutamento di nuovo clero diocesano è variata da regione a regione molto meno di quanto variava tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta.
In secondo luogo, dall’analisi emerge con chiarezza che la riduzione delle differenze tra regioni si produce per un Nord e un Centro che conoscono un decremento molto più forte della media nazionale e un Sud che cala meno velocemente. In termini concreti ciò significa che nel corso delle cinque decadi considerate il cattolicesimo popolare, o meglio i cattolicesimi popolari, dell’Italia settentrionale, sul piano del reclutamento di clero diocesano, non sono più in grado di produrre performance notevolmente superiori a quelle dell’Italia meridionale, che avevano caratterizzato tutto il Novecento. Inoltre, nello stesso arco di tempo dissolve il proprio vantaggio rispetto al Sud anche la rete dei localismi ecclesiastici a forte impronta clericale che caratterizzavano tre regioni dell’Italia centrale: Toscana, Umbria, Marche.
In terzo luogo, quanto appena indicato non presenta un andamento omogeneo nel corso delle cinque decadi prese in considerazione da questa analisi. A grandi linee appare opportuno assumere la seguente periodizzazione: calo drastico della capacità di reclutamento dagli anni Sessanta agli inizi degli anni Ottanta; forte rallentamento di questo calo fino agli inizi del 21° sec. (insieme a qualche segno di tenuta o addirittura di incremento); ripresa, anche se molto meno rapida del declino, nella prima decade del 21° secolo. Inoltre, rispetto a quanto si era verificato in precedenza, nelle ultime due decadi la forbice tra i valori di reclutamento peggiori e migliori torna lievemente ad allargarsi. Forse, ma occorre un’osservazione prolungata, potrebbero cominciare a farsi sentire gli effetti delle diverse strategie di reclutamento adottate finora nelle varie regioni. Il futuro potrebbe riservare ulteriori novità.
In conclusione, a livello regionale si può applicare nuovamente, seppure con qualche modifica (Molina in La parabola del clero, 2005), l’indice di reclutamento e porne i valori in relazione alla misura con cui in ciascuna regione si è ricorso a individui nati in altre regioni italiane o all’estero per integrare la capacità di reclutamento convenzionale. Il quadro che ne risulta è simile a quello sin qui ricostruito e, al contempo, ulteriormente dettagliato. Assumendo come riferimento la media nazionale, due gruppi di regioni ottengono risultati migliori per entrambi i parametri. Al Nord la Lombardia, e a seguire il Triveneto, al Sud la Puglia (con valori molto simili a quelli lombardi), e a seguire Sicilia, Sardegna e Campania mostrano una capacità di reclutamento locale superiore a quella media nazionale e ricorrono a forme non convenzionali di reclutamento meno della media nazionale. Anche Calabria e Basilicata mostrano una capacità di reclutamento convenzionale superiore a quella media nazionale, e anche delle regioni appena citate, ma contemporaneamente più di queste ultime e meno della media nazionale ricorrono a forme non convenzionali di reclutamento. Al polo opposto possiamo individuare tre altri gruppi di regioni con le stesse caratteristiche (capacità di reclutamento convenzionale inferiore alla media nazionale e ricorso a forme non convenzionali di reclutamento superiore alla media nazionale), ma con intensità crescenti. Un primo gruppo è costituito da Piemonte-Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna; un secondo gruppo da Marche, Liguria e Toscana; un terzo gruppo da Abruzzo-Molise, Lazio, Umbria. Per dare un’idea delle differenze tra questi ultimi tre gruppi, basti dire che le prime due regioni ricorrono a forme non convenzionali di reclutamento in misura simile o di poco inferiore rispetto alla media nazionale, mentre le ultime tre regioni vi ricorrono in misura da tre a sei volte superiore rispetto alla media nazionale. Nel complesso le due variabili – capacità di reclutamento convenzionale e intensità del ricorso a reclutamento non convenzionale – si mostrano discretamente correlate (in modo inverso con un R2 pari a 0,439), il che lascia spazio per ipotizzare un certo margine di componibilità tra i due tipi di politiche di reclutamento, ma sostanzialmente corrobora l’impossibilità di immaginare che un prolungato ricorso a politiche non convenzionali di reclutamento possa, in qualche misura, giovare alla ripresa di quelle convenzionali (La parabola del clero, 2005). Non ce n’è a sufficienza per trarre delle conclusioni, ma si può osservare che il ricorso a politiche non convenzionali di reclutamento nella maggior parte dei casi (e con le eccezioni tutte da interpretare di Basilicata e Calabria) sembra non accompagnarsi a buoni risultati in termini di reclutamento locale, e non solo nel breve periodo.
Se i risultati dell’analisi di reclutamento di nuovo clero (attraverso le ordinazioni) si sommano a quelli provenienti dalla incardinazione di clero escardinato da altre diocesi (italiane o estere) o da ordini religiosi, il quadro appena mostrato si rafforza ulteriormente.
Concludendo, lo studio del reclutamento di nuovo clero diocesano conferma l’ipotesi che alcune differenze interregionali si sono notevolmente attenuate e che le modalità attraverso cui ciò avviene fungono da incubatore di altre differenze, percepibili anche se non facilmente decifrabili. Le une e le altre si riflettono molto incisivamente sulla struttura dell’autorità religiosa cattolica attiva in Italia e così confortano l’idea di un suo notevole mutamento. Se si tiene sotto osservazione la struttura dell’autorità religiosa cattolica assumendo come punto di osservazione il livello regionale, il periodo dal 1970 a oggi appare non solo un periodo di verticalizzazione e centralizzazione e di contrazione in termini di quantità e forse qualità del personale a disposizione, ma anche un periodo durante il quale sono fortemente sfumate le differenze subnazionali, soprattutto a causa della crisi subita dai grandi cattolicesimi popolari dell’Italia settentrionale, di quello piemontese, emiliano-romagnolo e veneto, e, seppure in misura minore, di quello lombardo (per certi versi, è successo qualcosa di simile a quanto avvenuto al sistema politico e in particolare all’amministrazione statale – nonostante l’istituzione delle regioni, o forse a causa della forma da queste di fatto assunta –, ossia che con la centralizzazione si è prodotta anche una certa ‘meridionalizzazione’). La reale portata di questa mutazione si può comprendere se si considera che i cattolicesimi popolari dell’Italia settentrionale, e in particolare quello lombardo, erano stati il modello e la base su cui, a partire da Pio XI, era stato costruito il programma di modernizzazione e di unificazione religiosa della penisola. Ed erano stati anche qualcosa di più, per la verità, se si considera che da quelle regioni e da quei cattolicesimi provenivano i due pontefici che vollero e gestirono il ConcilioVaticano II (un bergamasco, Giovanni XXIII, e un bresciano, Paolo VI) e cinque degli ultimi sei papi italiani. La crisi dei cattolicesimi popolari delle regioni dell’Italia settentrionale probabilmente ha segnato anche la storia del cattolicesimo universale.
Più difficile è dire quale sarà l’esito della crisi dei cattolicesimi del Nord Italia, e se si tratti di crisi di lungo periodo o solo di ingresso in una fase di trasformazione. A riguardo va ricordata sia la relativa tenuta del più forte di quei cattolicesimi (quello lombardo) sia la scelta, operata soprattutto in questa regione ecclesiastica e nel Triveneto, di affrontare i minori successi delle forme convenzionali di reclutamento ricorrendo per nulla, o molto meno che altrove, a forme di reclutamento non convenzionale. Anche se con numeri ridotti, le organizzazioni ecclesiastiche di quell’area stanno conservando i loro caratteri culturali e pastorali e questo potrebbe rivelarsi una premessa positiva per il loro futuro.
Una mappa di sintesi
Da questa breve e parziale ricognizione delle differenze infranazionali è possibile ricavare alcune osservazioni che fanno da contorno all’individuazione dei due o tre principali processi fin qui analizzati.
Le differenze territoriali emerse disegnano una mappa fatta di aree più spesso pluriregionali (fig. 2). Ciò però non esclude che due casi, con caratteristiche tra loro molto diverse, emergano positivamente rispetto ai propri contesti: la Lombardia e la Puglia. In questo senso, ma in negativo, si potrebbe anche citare il caso del Lazio, la cui originalità è ovviamente in larga parte determinata dalla presenza in questa regione della città e della diocesi di Roma.
Il prevalere, anche se non in via esclusiva, di aree pluriregionali non significa che le politiche assunte a livello regionale non abbiano alcun peso. Esse vanno annoverate tra i fattori che possono influire positivamente o negativamente sull’evoluzione dei processi socioreligiosi, rifiutando opposte semplificazioni che ritengono questo livello della struttura dell’autorità religiosa cattolica o totalmente ininfluente o assolutamente decisivo. Semmai è ipotizzabile che siano i tempi medi più di quelli brevi a mostrare gli effetti positivi, o negativi, di cui possono essere portatrici determinate politiche ecclesiastiche regionali.
Inoltre, dall’insieme dei dati presentati è emerso anche che per le politiche regionali non è possibile individuare ricette vincenti. Piuttosto è possibile indicare casi in cui certe caratteristiche del tessuto ecclesiastico locale sono state interpretate in modo da massimizzarne i vantaggi e contenerne i limiti, o viceversa. Per fare solo un esempio, si può osservare che i dati a disposizione non consentono assolutamente di concludere che il modello di diocesi dalle dimensioni demografiche grandi o medio-grandi sia a priori preferibile rispetto a quello di diocesi dalle dimensioni medie, medio-piccole o piccole. Nessuno dei risultati a disposizione mostra una correlazione significativa tra la dimensione della diocesi e la sua vitalità pastorale. È invece possibile osservare che situazioni diverse richiedono una diversa interpretazione e che, in questo caso, le politiche assunte al livello regionale dell’autorità religiosa cattolica possono giocare un ruolo molto importante. Per es., il prevalere di diocesi medie o piccole può essere efficacemente bilanciato da un più elevato grado di cooperazione pastorale a livello regionale. I buoni risultati ottenuti dall’esperimento pugliese, caratterizzato da intense dinamiche e da numerose istituzioni di cooperazione ecclesiastica regionale, e, al contrario, i cattivi risultati fatti invece segnare da un’altra regione – l’Umbria – caratterizzata da diocesi piccole se non piccolissime, la quale a partire dagli anni Ottanta ha ridotto se non smantellato il precedente regime di intensa cooperazione ecclesiastica regionale, costituiscono al momento la coppia di casi opposti meglio documentata (Diotallevi 2010).
Da ultimo si può dire che la riduzione del gap che separava il Sud dal Nord è reale, ma non è un fenomeno concluso. La migliore tenuta del Sud è in genere segnata dal bisogno di ulteriori gradi di istituzionalizzazione, perché basata su soluzioni che nel medio periodo potrebbero non garantire una proporzionata qualità ecclesiale. A questo proposito giova ricordare che il livello regionale, nel caso del sistema religioso, si presta più facilmente a essere interpretato come livello al quale è possibile migliorare i risultati di alcuni processi più sensibili alle economie di scala. Esso dunque non può essere il riferimento di una opzione, o di un rifiuto, indifferenziati. I processi ecclesiastici e religiosi regionalmente rilevanti vanno con pazienza identificati; certamente non mancano, anche se forse sono inferiori per numero, non per importanza, e diversi, rispetto a quanto si verifica nel sistema politico e nel sistema economico. Anche in questo caso spunti importanti potrebbero venire, tra l’altro, da un’attenta osservazione di quanto avviene nel sistema delle professioni.
Conclusioni
Per riassumere quanto emerso dall’insieme delle analisi sin qui esposte si può affermare che la struttura dell’autorità religiosa cattolica, rispetto agli inizi degli anni Settanta del Novecento, presenta oggi alcune significative de-formazioni: a) ha subito un processo di marcata centralizzazione e verticalizzazione; b) ha perso non tanto in capillarità quanto in robustezza delle sue articolazioni territoriali, soprattutto a causa di una crisi di personale, crisi forse non solo di carattere quantitativo; c) ha subito anche un processo di moltiplicazione e di diversificazione dei propri canali con effetti rilevanti, a partire da un incrinamento della tipica distinzione ecclesiale tra autorità e carisma per arrivare a una crisi di un altro pilastro della forma ecclesiale: il ruolo del vescovo diocesano; d) da parte dell’autorità religiosa cattolica è calato sensibilmente il sostegno all’apostolato specifico dei laici, e a quello dei religiosi, mentre più spesso è stata perseguita un’accentuata egemonia della ‘pastorale’, ovvero del ruolo e delle prospettive dei vescovi e del clero diocesano, una egemonia che continuamente genera tensioni profonde alla forma ecclesiale.
Per valutare il grado di avanzamento e l’eventuale reversibilità o correggibilità di queste de-formazioni sarà necessaria un’analisi approfondita che le metta in relazione con le forti trasformazioni intervenute nello stesso periodo nell’ambiente in cui opera la struttura dell’autorità religiosa cattolica: sia nell’ambiente sociale in generale, sia nella dimensione religiosa di questo stesso ambiente. Rispetto ai primi anni Settanta del Novecento, dimensione globale e locale si intrecciano ormai in modi profondamente diversi e il modello delle società imperniate sullo Stato (State societies) è entrato in crisi. I processi di differenziazione sociale e di individuazione iniziati in quel periodo sono proseguiti oltre l’immaginabile. Ciò ha prodotto pressioni di secolarizzazione – quantitative e morfologiche – altrettanto raramente intuite allora. Nel frattempo il pluralismo religioso è divenuto una realtà anche nella società italiana (Le religioni nell’Italia che cambia, 2013).
Solo uno studio integrato e attento riuscirà a chiarire meglio in quale misura le de-formazioni dell’autorità religiosa cattolica in Italia sono state frutto di pressioni esterne e in quale misura, al contrario, di scelte interne. I risultati esposti consentono solo alcune provvisorie conclusioni. Innanzitutto il vero e proprio progetto che ha guidato le politiche ecclesiastiche che hanno consentito o contribuito a quelle de-formazioni (e che va inquadrato tra le strategie ecclesiastiche che si sono confrontate nel secondo post-Concilio) non è stato il frutto di una scelta obbligata, ma si è affermato in alternativa a opzioni altrettanto realistiche. Poi, la grande varietà di situazioni regionali è anche il riflesso di un margine di manovra costantemente rimasto a disposizione tanto dei livelli diocesani quanto dei livelli regionali della struttura dell’autorità religiosa cattolica. Lo testimonia il grado diverso con cui – anche in situazioni regionali simili – si è fatto ricorso a politiche non convenzionali di reclutamento del clero, alla parziale sostituzione della parrocchia con unità pastorali, a una compressione dello specifico ruolo del laicato da parte della pastorale e delle sue organizzazioni. Inoltre nel periodo considerato si è prodotta una sorta di parziale ‘meridionalizzazione’ del cattolicesimo religioso italiano, dopo quasi un secolo in cui il ruolo guida era stato svolto dai cattolicesimi dell’Italia settentrionale. Lo testimoniano la crescita del controllo clericale o ‘paraclericale’ sulla vita ecclesiale, la sua perdita di strutturazione e una riduzione delle sue influenze extrareligiose, una maggiore dipendenza delle forme dell’offerta religiosa dalle istanze della domanda con la conseguenza di una maggiore diversificazione e competizione tra attori diversi dell’offerta religiosa ‘cattolica’ e i conseguenti rischi di de-ecclesializzazione (The many faces of Italian catholicism in the 21st century, 2013). In tutto questo si possono individuare i rischi di cedimento al modello di una religione a bassa intensità. Questa meridionalizzazione del cattolicesimo religioso italiano è avvenuta in un periodo durante il quale, per la prima volta dall’Unità d’Italia, il cattolicesimo religioso italiano è stato guidato non solo da Roma, ma da una cultura romana (nel senso corrente e non in quello canonico del termine). Non va confusa infatti l’influenza del cattolicesimo lombardo in particolare e dell’Italia settentrionale in generale sul Vaticano (e da lì su tutta l’Italia e oltre), fortissima sino a Paolo VI, con l’influenza sul cattolicesimo religioso italiano esercitata da Roma a seguito di una forte centralizzazione della sua autorità a partire dai primi anni Ottanta. Del resto, basta ricordare che, su scala nazionale, non poche sono state le tensioni e le differenziazioni che a partire da quegli anni hanno distinto i vertici della CEI e importanti espressioni delle Chiese del Nord Italia. È sufficiente pensare a figure come quelle degli arcivescovi di Torino, Milano e Venezia in quel periodo – rispettivamente: Ettore Balestrero, Carlo Maria Martini (1927-2012) e Marco Cé (1925-2014) –, a istituzioni come l’Università cattolica di Milano, sino almeno a tutto il rettorato di Giuseppe Lazzati, ad alcune presidenze dell’Azione cattolica come quella di Alberto Monticone. Infine, il periodo analizzato appare come quello dell’elaborazione e del perseguimento di un progetto ‘neoclericale’ (diverso da quelli del passato perché più debole, tanto sul fronte interno quanto su quello esterno). Questo neoclericalismo debole ha ottenuto non trascurabili successi se lo si considera in uno scenario di comparazione internazionale, ma anche insuccessi se non si dimentica quali erano i problemi che esso era convinto di dover affrontare, ritenendo – non senza ragione – che il primo postconcilio a essi non avesse dato risposta. Il neoclericalismo debole appare dunque una sorta di supplenza protrattasi per alcuni decenni. La sua realizzazione ha richiesto un massiccio investimento di risorse e il suo principale risultato, probabilmente, è stato quello di guadagnare tempo. Mentre questa supplenza esaurisce la propria forza, o tende a degenerare istituzionalizzandosi, la questione che si apre è se restano energie sufficienti per mettere a frutto positivamente il tempo guadagnato, e se la risposta che verrà potrà essere più o meno simile nelle diverse aree della penisola.
Dal 1970 la struttura dell’autorità religiosa cattolica in Italia ha accettato la sfida della secolarizzazione, sia a livello nazionale sia a livello regionale, non si è data per vinta, facendo buon viso a cattiva sorte come invece avvenuto altrove in Europa. Mentre erano impegnati in questa sfida i vertici dell’autorità religiosa cattolica hanno in alcuni casi prodotto e in altri accettato delle de-formazioni di quella struttura. Queste de-formazioni hanno consentito, o almeno non hanno impedito, di reggere la sfida, meglio di quanto non si sia verificato altrove, ma, ormai è evidente, hanno anche compromesso – per dirla con Weber – l’esercizio in regime di monopolio della coercizione ierocratica legittima, ovvero la forma e la funzione ecclesiale distintiva della struttura dell’autorità religiosa cattolica.
Le de-formazioni sin qui descritte andranno ancora avanti e si radicalizzeranno? Non è possibile rispondere, ma si può tuttavia riconoscere la serietà della situazione che si è venuta a creare e la gravità dell’interrogativo che essa pone.
Bibliografia
M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, t. 1, Gemeinschaften, Tübingen 1922 (trad. it., Economia e società, 1° vol., Comunità, a cura di W.J. Mommsen in collab. con M. Meyer, 1995).
S. Burgalassi, Le cristianità nascoste, Bologna 1970.
A. Abbott, The system of professions. An essay on the division of expert labor, Chicago 1988.
G. Brunetta, Il clero in Italia dal 1888 al 1989, «Polis», 1991, 3, pp. 423-50.
F. Garelli, Religione e Chiesa in Italia, Bologna 1991.
M. Chaves, Denominations as dual structures: an organizational analysis, «Sociology of religion», 1993, 54, pp. 147-69.
M. Chaves, Secularization as declining religious authority, «Social forces», 1994, 72, pp. 749-74.
V. Cesareo, R. Cipriani, F. Garelli et al., La religiosità in Italia, Milano 1995.
L. Diotallevi, Religione, Chiesa e modernizzazione: il caso italiano, Roma 1999.
Il neoistituzionalismo nell’analisi organizzativa, a cura di W.W. Powell, P.J. Di Maggio, Torino 2000, (in partic. P.J. Di Maggio, La gabbia di ferro rivisitata. Isomorfismo istituzionale e razionalità collettiva nei campi organizzativi, pp. 88-115).
L. Diotallevi, Il rompicapo della secolarizzazione italiana, Soveria Mannelli 2001.
R. Finke, Innovative returns to tradition. Using core teachings as the foundation for Innovative accommodation, «Journal for the scientific study of religion», 2004, 43, 1, pp. 19-35.
N. Luhmann, Organizzazione e decisione, Milano 2005.
La parabola del clero. Uno sguardo socio-demografico sui sacerdoti diocesani in Italia, a cura di L. Diotallevi, Torino 2005 (in partic. S. Molina, Il clero diocesano in Italia: uno sguardo al presente e al recente passato, pp. 25-74).
A. Acerbi, La Chiesa italiana e Giovanni Paolo II, in A. Acerbi, G. Frosini, Cinquant’anni di Chiesa in Italia, Bologna 2006, pp. 67-114.
L. Bressan, Preti nel nuovo millennio. Alcuni dati di una recente inchiesta sui preti e sui seminaristi, «La scuola cattolica», 2006, 134, pp. 393-436.
L. Diotallevi, Meno siamo, meglio stiamo? Il referendum sulla fecondazione assistita e il peso del fattore religioso, «Polis», 2007, 3, pp. 489-515.
P. Nesbitt, Keepers of the tradition. Religious professionals and their careers, in The sage handbook of the sociology of religion, ed. J.A. Beckford, N.J. III Demerath, London 2007, pp. 295-322.
P. Consorti, Diritto e religione, Bari 2010.
L. Diotallevi, Chiesa e cattolici nell’Umbria di oggi: alcuni adattamenti inutili, in Poliarchia e bene comune. Chiesa, economia e politica per la crescita dell’Umbria, a cura di S. Angeletti, G. Armillei, Bologna 2010, pp.179-205.
P. Prodi, Il paradigma tridentino. Un’epoca di storia della Chiesa, Brescia 2010.
A. Melloni, Tutto e niente. I cristiani d’Italia alla prova della storia, Roma-Bari 2013.
S. Cicchini, Religione e capitale sociale. Approfondimenti, con riferimento al caso italiano, su di una relazione complessa e rilevante per il servizio sociale, Tesi per il dottorato di ricerca in Sociologia e Servizio sociale presso la Scuola dottorale in pedagogia e servizio sociale, Università di Roma Tre, XXIV ciclo, 2013.
The many faces of Italian catholicism in the 21st century, ed. M. Marzano, E. Pace, «Social compass», 2013, 3, pp. 299-361.
Le religioni nell’Italia che cambia. Mappe e bussole, a cura di E. Pace, Roma 2013.