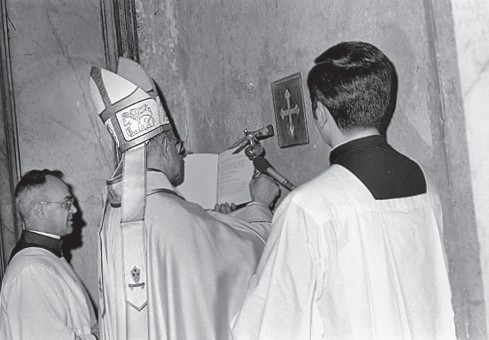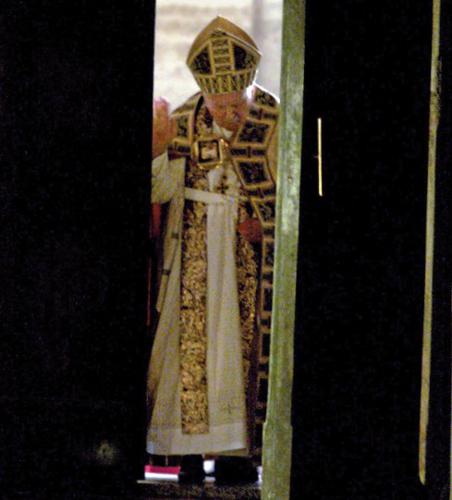Giubileo della misericordia
Giubileo della misericordia
L’Anno santo indetto da papa Francesco differisce dai precedenti non solo perché ‘straordinario’, ma per la tematica scelta, che pone al centro riforma della Chiesa, pace, vicinanza ai poveri e misericordia come risposta alle sfide della modernità.
La storia dei giubilei della Chiesa romana supera in questo inizio del 21° secolo i 700 anni di vita con una indizione inattesa nella sostanza e straordinaria nella forma. Questa istituzione, nata in modo non certo lineare con l’anno 1300, conosce infatti un nuovo appuntamento fissato a sorpresa da papa Francesco, quando nel tempo pasquale del 2015 ha annunciato la celebrazione di un Anno santo esteso dall’8 dicembre dello stesso anno alla domenica di Cristo re del 2016. Un Giubileo straordinario che non prende spunto da una ricorrenza biografica (come quelli indetti per l’elezione del pontefice o quelli per gli anniversari tondi della sua ordinazione sacerdotale o della sua consacrazione episcopale, che erano stati usati in precedenza). E neppure intende solennizzare i presunti anniversari della vita di Gesù come fu nel 1933 e nel 1983, fissati assumendo che fosse il 33 l’anno della passione, morte e resurrezione di Gesù di Nazareth («se nel 2033» diceva Pio XI «i calcoli saranno altri, altro si farà»). L’Anno santo di papa Francesco si fissa su una tematica – la misericordia – e solennizza il 50° del Concilio vaticano II, con una scelta senza precedenti né per un dato né per l’altro, e si pone in sequenza stretta con il secondo sinodo dei vescovi convocato per discutere del matrimonio e della famiglia, luogo di un conflitto aperto fra chi ritiene che nulla si debba fare davanti al moltiplicarsi di situazioni che il diritto canonico e la prassi penitenziale della Chiesa cattolica non riescono a riconoscere, se non deprecarne l’incremento, e chi invece si sente interpellato dalla condizione di fedeli che cercano una vita spirituale.
Descritto così, anche il Giubileo del 2015-16 potrebbe al fondo essere giudicato come un evento iscritto in una tendenza generale del pontificato romano recente – impersonata in modo differente da Giovanni Paolo II, da Benedetto XVI e proprio dallo stesso Francesco – che sostituisce una lettura diversa alla narrazione intransigente del papato come il luogo dove nulla si muta.
Jorge Mario Bergoglio si può senz’altro definire il pontefice delle ‘sorprese’, e in questa serie di sorprese si colloca anche l’indizione del Giubileo, col suo corredo di forme, procedure, usanze e regole, e con la serie di ritocchi, cambiamenti, sfumature, scarti che hanno permesso a ogni papa di rivendicare al proprio Anno santo (raramente ai propri Anni santi) un significato peculiare.
Trattandosi di un Anno santo straordinario, il papa ha dovuto definire in modo abbastanza rapido i contenuti della propria bolla e gli obiettivi che ha inteso assegnargli: e questi stanno tutti dentro la sua visione del pontificato e nelle conseguenze di uno stile che ha restituito la libertà di parola come un dovere di parresia – il ‘parlar franco’ della tradizione cattolica – dentro la Chiesa.
Fin dall’inizio del suo pontificato, infatti, alcuni nuclei tematici sono affiorati, anche se con un grado di formalizzazione inusualmente basso nella storia della istituzione pontificia. Fra questi spicca il fascio di questioni esistenziali e teologiche connesse alla povertà – povertà della Chiesa e nella Chiesa, Chiesa dei poveri e per i poveri – che s’è immediatamente imposto, fin dalla scelta del nome che Francesco, seguendo uno stilema classico della narrazione del papa, fa apparire come un nome scelto all’improvviso: ai giornalisti radunati nell’aula Nervi all’indomani della elezione, infatti, dice di aver pensato al nome Francesco solo quando il cardinale Hummes gli ha raccomandato, appena superato il quorum, di «No te olvides de los pobres». Il tema della povertà della Chiesa e della Chiesa dei poveri spicca per la lunga rimozione che ne ha accompagnato la storia recente, quella cioè che segue il Concilio vaticano II nel quale la tematica viene per la prima volta dipanata, nell’organo che ha piena e suprema potestà sulla Chiesa, come un nodo teologico fondamentale della misericordia di Dio che passa dal mistero del Cristo povero.
Insieme a questo e in una certa dipendenza da quello c’è il tema della pace, cui il papa, digiuno di politica internazionale ma corroborato da un segretario di Stato che viene dalla miglior tradizione diplomatica del Novecento vaticano, si trova posto innanzi abbastanza presto con l’esplosione della crisi siriana e ucraina: anche qui le sfumature dei registri del magistero sulla pace (e sulla guerra) sono molte, ma la freschezza evangelica che connota profondamente lo stile-Francesco (esattamente come la schiva professoralità che connotava quello ratzingeriano o l’attorialità carismatica di quello wojtyliano) punta a una decostruzione del magistero sulla guerra che, nei pontificati precedenti, aveva conosciuto significative oscillazioni e concessioni sulla ingerenza umanitaria e la guerra difensiva di tipo indipendentista. Nella predicazione di Bergoglio la concentrazione del discorso sulle vittime scardina sia le casistiche morali prevalenti in precedenza sia un discorso sulla pace che aveva imparato a condannare la guerra come sintomo e pena della insubordinazione moderna alla autorità ecclesiastica e al suo magistero.
Rigoroso nel rivendicare la pastoralità del Concilio, papa Francesco ha anche affrontato i nodi istituzionali che si connettono al suo stile (anche qui inteso nel senso denso del termine che Christoph Theobald ha utilizzato); quelli connessi a una riforma della Chiesa non solo nel senso della espunzione di vizi secolari e ritornanti legati alla gestione del potere o del denaro, ma anche quelli connessi al bisogno di ritrovare una adesione al Vangelo ‘di’ Gesù (e non solo al Vangelo ‘su’ Gesù): cioè a un annuncio di salvezza che non esclude e al quale la Chiesa non può conformarsi in toto e per sempre, ma solo adeguarsi custodendone in modo quanto più possibile rigoroso la alterità. Per Francesco la vicinanza ai poveri – e dunque la stessa predicazione della pace come assimilazione alle vittime della guerra – ha una funzione essenziale e infungibile in questa custodia: ma non è l’unico luogo. Anche la sinodalità nelle Chiese e fra le Chiese, perfino la sinodalità così poco effettiva della Synodus episcoporum istituita da Paolo VI, può servire e per questo ha voluto che lì si discutesse dei probemi delle famiglie e delle relazioni interpersonali, luogo nei quali la simultaneità di culture premoderne, moderne e postmoderne che connota lo spazio globale e lo spazio ecclesiale diventa una sfida lacerante. L’appello del papa, anzi la certezza di Francesco è che la misericordia sia e debba essere la risposta adeguata a queste sfide (convinzione che ha una sua tradizione antirigorista che inizia col canone 8 del primo concilio di Nicea): per questo l’Anno santo non va collocato soltanto sullo sfondo della ‘storia dei giubilei’ come faranno molte pubblicazioni in questo momento.
Occasione non certo per una rivendicazione trionfalista come quella del 1950 o per enunciare verbis et operibus una centralità mediatica della cattedra petrina come nel 2000, il giubileo di papa Francesco si pone così come un modo per offrire la misericordia (enunciata nel marzo 2013 dal cardinale Sodano nella omelia Pro eligendo romano pontifice e da Bergoglio utilizzata fin dal primo Angelus con una citazione di Walter Kasper che segnava una svolta rispetto alle posizioni ratzingeriane) come chiave del balzo innanzi del Vaticano II, come punto d’incontro con la vita vissuta del popolo di Dio, come antidoto a una autosufficienza ideologica della dottrina. La misericordia espressa dunque non solo come un principio ‘benignista’ di stampo alfonsiano, ma come principio ecclesiologico che ispira una riforma del papato che – dopo le aperture della enciclica Ut unum sint negli anni Novanta e una famosa serie di lezioni di monsignor John Quinn, allora vescovo di San Francisco – non ebbe implementazione alcuna.
Che Bergoglio lo abbia in mente lo dice uno dei terreni chiave del principio di ‘misericordia’ sul quale il papa si è applicato, vale a dire quello della posizione delle persone separate o divorziate o richiedenti la nullità di un matrimonio fallito. Con Mitis iudex, un motu proprio replicato per adattarlo alla disciplina delle Chiese orientali in comunione con Roma, Francesco ha infatti deciso di aggirare le prevedibili resistenze del Sinodo dei vescovi in materia di riconciliazione dei divorziati risposati e ha devoluto ai vescovi poteri in precedenza accentrati nelle mani del pontefice in materia di accertamento della nullità. Una applicazione del principio di misericordia in sé non molto rilevante ma che ha indicato che la strada per riformare il papato spogliandolo di un eccesso di poteri e di un pleonasmo di competenze esclusive è stata imboccata e si è rivelata possibile, a norme invariate; lo stesso Giubileo della misericordia indica che il recupero della dimensione ‘pastorale’ come principio ecclesiologico strutturante e dinamico, anziché come sottoprodotto applicativo di una dottrina atemporale e immobile, incontra un consenso nel quale non c’è il successo di un populismo cattolico, ma la voce del sensus fidei, che inverte l’ordine usuale fra chi segue e chi guida nella comune sequela dell’unico Maestro.
Il giubileo nella Bibbia
Giubileo deriva dall’ebraico yobel, che significa «capro» e richiama più precisamente il corno del capro, cioè lo strumento col quale veniva annunziato l’inizio dell’anno giubilare, che si celebrava ogni 50 anni, mentre ogni 7 anni ricorreva l’anno sabbatico, durante il quale si lasciava riposare la terra. Durante l’anno del giubileo i terreni dovevano rimanere incolti e i debitori rientravano in possesso del patrimonio che avevano perduto, mentre i servi venivano liberati. Si trattava di una sorta di ritorno alle origini e di un nuovo inizio della storia umana: il giubileo ricordava il primato di Dio, che «il settimo giorno si riposò» e al quale appartiene la Terra, mentre l’uomo deve anzitutto lodarlo e ringraziarlo e condividere i beni terreni con gli altri uomini. Gli studiosi ritengono che esso abbia costituito un ideale utopico di giustizia e che le norme del Levitico sul condono dei debiti non siano mai state concretamente applicate. Esse evocavano comunque l’ideale messianico, poi richiamato dai profeti e da Gesù, che «con le parole del profeta Isaia» disse di essere venuto a ridare la libertà agli schiavi e ai prigionieri e a «predicare un anno di grazia del Signore».
700 anni di Giubilei
Lista degli Anni santi ordinari e dei principali Anni santi straordinari
- 1300 Bonifacio VIII (Benedetto Caetani)
- 1350 Clemente VI (Pierre Roger)
- 1390 Bonifacio IX (Pietro Tomacelli)
- 1400 Bonifacio IX (Pietro Tomacelli)
- 1423 Martino V (Oddone Colonna)
- 1450 Niccolò V (Tommaso Parentucelli)
- 1475 Sisto IV (Francesco Della Rovere)
- 1500 Alessandro VI (Rodrigo Borgia)
- 1525 Clemente VII (Giulio de’ Medici)
- 1550 Giulio III (Giovan Maria Ciocchi del Monte)
- 1575 Gregorio XIII (Ugo Boncompagni)
- 1600 Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini)
- 1625 Urbano VIII (Maffeo Barberini)
- 1650 Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphili)
- 1675 Clemente X (Emilio Altieri)
- 1700 aperto da Innocenzo XII (Antonio Pignatelli), concluso da Clemente XI (Giovanni Francesco Albani)
- 1725 Benedetto XIII (Pietro Francesco Orsini)
- 1750 Benedetto XIV (Prospero Lambertini)
- 1775 Pio VI (Giovannangelo Braschi)
- 1825 Leone XII (Annibale Della Genga Sermattei)
- 1875 Pio IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti)
- 1900 Leone XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci)
- 1925 Pio XI (Achille Ratti)
- 1933 Pio XI (Achille Ratti), Anno santo della redenzione
- 1950 Pio XII (Eugenio Pacelli)
- 1966 Paolo VI (Giovanni Battista Montini), Anno santo per la chiusura del Concilio vaticano II
- 1975 Paolo VI (Giovanni Battista Montini)
- 1983 Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła), Anno santo delle redenzione
- 2000 Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła)
- 2015-16 Francesco (Jorge Mario Bergoglio), Anno santo della misericordia nel 50° del Concilio vaticano II
Le parole ‘scandalose’ di papa Francesco
di Francesco Ursini
Se quella di estrapolare singole frasi o parole dal loro contesto resta una pessima pratica giornalistica, è vero anche che poche cose danno l’idea di come il magistero di papa Francesco non sia riducibile agli schemi precostituiti che lo vorrebbero in contrasto con quello dei predecessori, quanto alcune espressioni che hanno scosso l’opinione pubblica per il loro carattere estremamente diretto e insieme per il background ideologico al quale – a una lettura superficiale e banalizzante – sembravano far riferimento. Il 2015 si è aperto con due frasi che a molti sono parse sconcertanti: la ‘giustificazione’ del terrorismo sulla base del fatto che «se qualcuno dice una parolaccia su mia madre, lo aspetta un pugno, è normale» e la ‘negazione’ di decenni di dottrina e pastorale sulla famiglia attraverso l’esortazione a «non essere come conigli»; ma questo stesso 2015 si va chiudendo con l’incontro con Kim Davis – l’impiegata statunitense finita in carcere per essersi rifiutata di rilasciare i documenti necessari a celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso –, alla quale il pontefice avrebbe detto, secondo le ricostruzioni, «brava, continua così». Due immagini che possono apparire a prima vista eterogenee, sinanche inconciliabili, certamente non riconducibili – come pure è stato proposto – a una banale dicotomia tra scelte di rottura nella forma e di continuità nella sostanza, ma due immagini che – al pari di quelle degli ultimi tre pontificati – potranno e dovranno trovare, invece, una sintesi nel tempo lungo della tradizione e della storia.