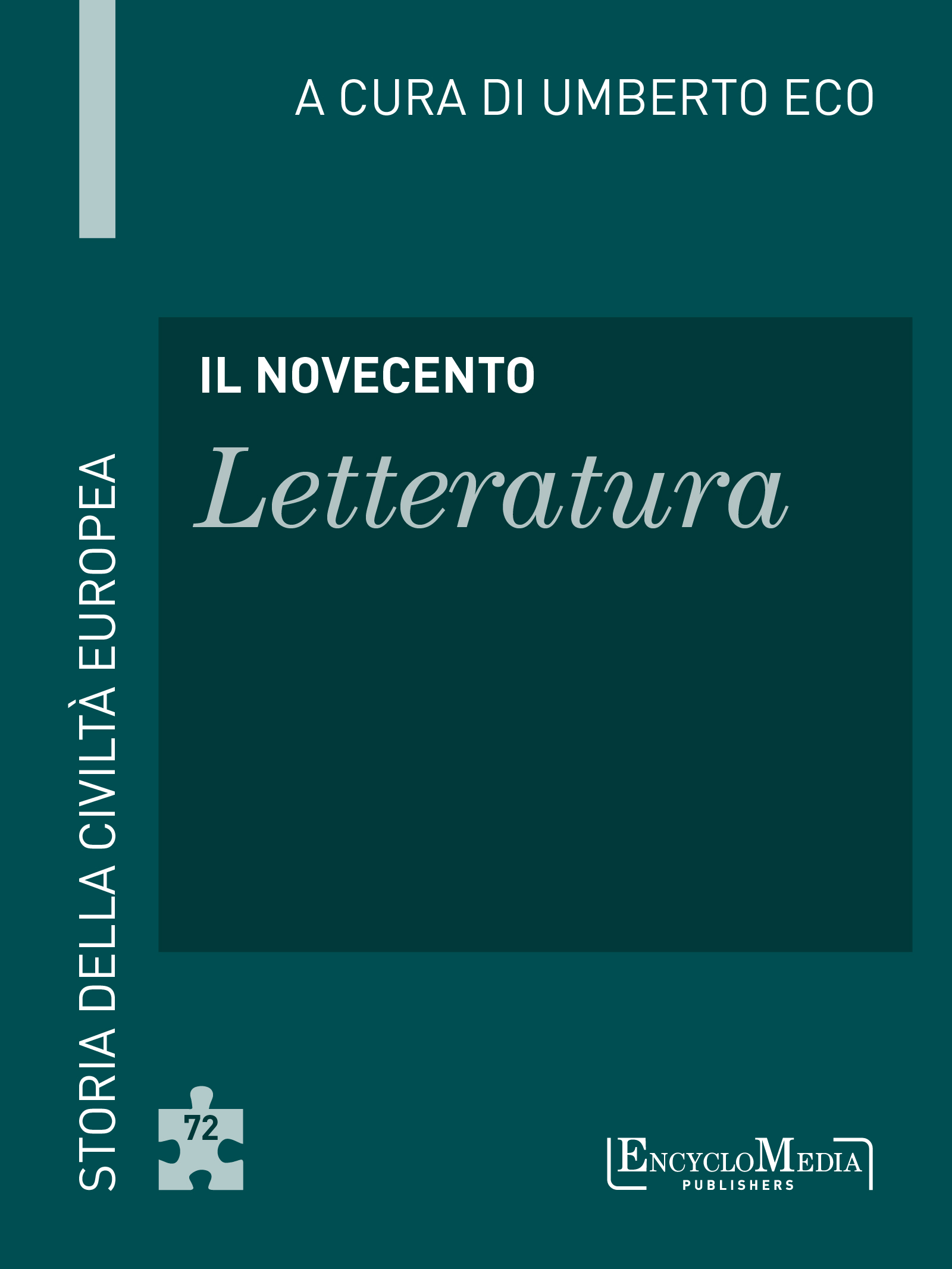Il modernismo, uno stile europeo. La poesia
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Fin dall’inizio del secolo lo stile modernista in poesia avvicina esperienze di diversa provenienza e formazione, creando una specie di tendenza europea che si interrompe per intervalli più o meno lunghi ma ritorna in vita spesso, con continue variazioni e riprese. Importante è la mescolanza, nel testo poetico, di elementi del romanzo, con un emergere esplicito nella seconda metà del secolo di raccolte poetiche dalle caratteristiche narrative.
Verso nuovi ritmi
Dino Campana
La notte
1. Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa su la pianura sterminata nell’Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo. Archi enormemente vuoti di ponti sul fiume impaludato in magre stagnazioni plumbee: sagome nere di zingari mobili e silenziose sulla riva: tra il barbaglio lontano di un canneto lontane forme ignude di adolescenti e il profilo e la barba giudaica di un vecchio: e a un tratto dal mezzo dell’acqua morta le zingare e un canto, da la palude afona una nenia primordiale monotona e irritante: e del tempo fu sospeso il corso.
2. Inconsciamente io levai gli occhi alla torre barbara che dominava il viale lunghissimo dei platani. Sopra il silenzio fatto intenso essa riviveva il suo mito lontano e selvaggio: mentre per visioni lontane, per sensazioni oscure e violente un altro mito, anch’esso mistico e selvaggio mi ricorreva a tratti alla mente. Laggiù avevano tratto le lunghe vesti mollemente verso lo splendore vago della porta le passeggiatrici, le antiche: la campagna intorpidiva allora nella rete dei canali: fanciulle dalle acconciature agili, dai profili di medaglia, sparivano a tratti sui carrettini dietro gli svolti verdi. Un tocco di campana argentino e dolce di lontananza: la Sera: nella chiesetta solitaria, all’ombra delle modeste navate, io stringevo Lei, dalle carni rosee e dagli accesi occhi fuggitivi: anni ed anni ed anni fondevano nella dolcezza trionfale del ricordo.
D. Campana, Canti orfici e altri scritti, Milano, Mondadori, 1972
In un saggio degli anni Sessanta, Il linguaggio mondiale della poesia moderna, Hans Magnus Enzensberger sostiene che la poesia moderna entra in una fase nuova pressappoco intorno al 1910. Nel 1908, infatti, appare la prima raccolta poetica di Ezra Pound, A lume spento, l’anno seguente escono il manifesto dei futuristi e Image à Crusoé di Saint-John Perse; nel 1910 esordiscono gli espressionisti in Germania, Velimir Chlebnikov in Russia, Costantinos Kavafis ad Alessandria; nel 1912 pubblicano Gottfried Benn (Morgue), Vladimir Majakovskij, Antonio Machado (Campos de Castilla), nel 1913 Guillaume Apollinaire (Alcools) e Giuseppe Ungaretti (le poesie poi raccolte nel Porto sepolto del 1917). Inizia così un processo di diffusione del linguaggio poetico che permette alla poesia di superare le barriere nazionali. I contesti provinciali in cui spesso queste poesie nascono e i linguaggi nazionali che utilizzano vengono proiettati su uno scenario mondiale. La caratteristica principale di questo nuovo linguaggio poetico è senza dubbio quella di essere spesso oscuro, ai limiti del comprensibile, fondato su analogie e metafore virtuosistiche, con apparente predominio del gioco formale sui contenuti. In un famoso libro degli anni Cinquanta, La struttura della lirica moderna (Die Struktur der modernen Lyrik, 1956), Hugo Friedrich sintetizza le difficoltà della poesia moderna in due indirizzi, riconducibili ad Arthur Rimbaud e a Stéphane Mallarmé: per il primo si tratta di liberare attraverso la lirica il linguaggio dalla logica, per il secondo di portare la lirica verso la perfezione astratta delle forme. Friedrich sintetizza con le due formule “crollo dell’intelletto” di André Breton e “festa dell’intelletto” di Paul Valéry, unite nello scopo di rifuggire dalla comprensibilità, dalla mediocrità e dal quotidiano, nella volontà di rendere la poesia una forma di espressione fine a se stessa, “il cui contenuto sussiste soltanto grazie alla sua fantasia illimitata o al suo irreale giuoco di sogno, e non grazie a una riproduzione del mondo”.
Per Friedrich si tratta dunque di innovazioni tecniche, della ricerca esasperata di una nuova lingua distante dalla lingua d’uso. Per questo egli indica nel gruppo di poeti spagnoli che riscoprono il loro predecessore barocco Luis de Góngora (in occasione del terzo centenario della sua morte) quanto di meglio la poesia europea produce all’inizio del secolo: Antonio Machado, Ramon Jiménez, Jorge Guillén, Federico García Lorca, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti. E si ferma sullo scritto di Apollinaire, L’esprit nouveau et les poètes (apparso nel 1918 sul “Mercure de France”), il proclama per la nuova libertà assoluta della poesia, libertà che consente al poeta di accogliere nei suoi testi qualsiasi oggetto, dalle cose più grandi e potenti a quelle più quotidiane, dalle innovazioni della tecnica ai miti del passato. Il fine di questa poesia è la sintesi del conoscibile, una mescolanza veloce ed efficace di oggetti disparati che hanno come scopo quello di provocare stupore. Ne derivano le più importanti soluzioni formali. Friedrich parla di una esplicita “ostilità verso la frase” che caratterizza questa poesia, e di una ricerca della contrazione, di un’alterazione esplicita della sintassi: una poesia di Jorge Guillén, Niño, in 20 versi non contiene un solo verbo, e soprattutto nessun riferimento al bambino promesso dal titolo, ma una serie di immagini simboliche che rimandano all’esperienza del poeta; così Nacht di Gottfried Benn, contiene solo sostantivi, ognuno correlato a un’immagine notturna; e O notte di Giuseppe Ungaretti inizia con un’enunciazione puramente nominale (“Dall’ampia ansia dell’alba / Svelata alberatura. // Dolorosi risvegli”). I sostantivi e le immagini a essi correlate acquistano un valore assoluto, una tensione simbolica e un’intensità che fanno della poesia un insieme di frammenti, collegati attraverso processi analogici. Così molti testi poetici diventano spesso il risultato di un montaggio di immagini simboliche, di sensazioni ridotte a pura sonorità con fini suggestivi ed evocativi. In Zone, del 1912 (la poesia che apre la raccolta Alcools), Apollinaire elimina la punteggiatura e lascia i versi o isolati o a gruppi per restituire il ritmo di una passeggiata per le strade di Parigi e il sovrapporsi di ricordi e immagini che la compongono (“Io amo la grazia di questa strada industriale”, afferma a un certo punto il poeta). Ne nasce un testo chiave della nuova poesia simultanea.
Come spiega il critico ginevrino Marcel Raymond in un libro fondamentale degli anni Trenta (De Baudelaire au surréalisme, 1933) “su di un unico piano si giustappongono senza prospettiva, senza passaggio e spesso senza apparente rapporto logico, elementi disparati, sensazioni, giudizi, ricordi che si confondono nel flusso della vita psicologica”. Si potrebbe affermare che la nuova tecnica sintetica giunge in anticipo a elaborare quel flusso di coscienza di cui poi si impadroniranno i romanzieri. La stessa tecnica del montaggio di immagini che rimandano a tempi e mondi diversi, si trova nei Fiumi di Ungaretti, una poesia del 1916 che fa parte del primo libro del poeta, Il porto sepolto, poi rifuso nella raccolta più ampia del 1919, Allegria di naufragi. Dal presente della guerra, rappresentato attraverso l’immagine di un “albero mutilato”, il poeta risale a epoche lontane della sua vita, ognuna espressa attraverso un fiume. Nello stesso tempo, l’acqua del fiume acquista un profondo valore simbolico dove si mescolano morte e rigenerazione, senso dell’isolamento e armonia cosmica, fino all’immagine analogica finale dove la vita appare “una corolla / di tenebre”. Non a caso una delle fonti di ispirazione di Ungaretti è stata individuata da Fausto Curi nella filosofia di Henri Bergson, e nell’idea della vita interiore come flusso ininterrotto di immagini che dal passato premono sul presente.
Maschere e racconto
Una tendenza molto particolare del modernismo in poesia è quella di adottare alcune modalità della prosa per organizzare i singoli testi poetici in insiemi più ampi dall’andamento esplicitamente narrativo. Al di là di quello che fanno gli ermetici, per esempio, che tendono a una forte astrazione di situazioni e personaggi (la voce dell’io lirico è spesso anonima, vagamente connessa al poeta), molti poeti italiani creano complesse strutture dove il poeta si mette in scena direttamente, o con maschere differenti, e rappresenta episodi della propria esistenza con riferimenti concreti a luoghi e persone. I nomi più notevoli di questa tendenza sono Guido Gozzano (che se ne può considerare il capostipite), Umberto Saba, Camillo Sbarbaro, Cesare Pavese per la prima parte del secolo, Giorgio Caproni, Attilio Bertolucci, Pier Paolo Pasolini e Vittorio Sereni per la seconda.
I Colloqui (1911) di Gozzano sono l’esempio di una rappresentazione compiuta – la Letteratura – che allude di continuo a una rappresentazione drammaticamente inconcludibile – la Vita. Ma né la prima giustifica la seconda, né la seconda riscatta la prima. La messa in scena del “personaggio” Gozzano mette al riparo da qualsiasi rischio di identificazione con il Gozzano “autore”. Inizia così un lungo processo di esibizione in poesia dei fatti della vita che si differenzia dall’autobiografia di stampo dannunziano. L’io registra un limite (i 25 anni) prima del quale esiste un repertorio di memorie utilizzabili ma oltre il quale c’è il vuoto. E proprio perché dopo c’è questo vuoto, anche il prima si riduce a manifestazione falsa, non reintegrabile in un’esperienza vissuta che continua. La prima poesia della raccolta, che ne ripete il titolo, parla della gioventù come di un “bel romanzo” non vissuto però dal poeta, che ha travasato solo nella finzione (“nei miei sogni d’arte”) quanto un suo alter ego (“quello / che mi seguì”, il “mio fratello muto”) ha invece effettivamente vissuto: “muto sulle mute carte / ritrassi lui, meravigliando spesso”. A parte l’introduzione del tema romantico del doppio in poesia (che ha precedenti comunque in Pascoli), non è senza importanza che il termine “romanzo” venga introdotto qui a designare quanto il soggetto lirico sente distante da sé. È come se l’esperienza lirica nascesse dalla sconfessione di un possibile intreccio narrativo: la poesia “parla” dell’impossibilità del racconto.
Un’esplicita attenzione al racconto si trova anche nei Canti orfici (1914) di Dino Campana, il poeta che più di altri si trova all’incrocio tra tardo simbolismo ed espressionismo. Se la biografia del poeta è fatta di pochi episodi drammatici (la fuga da casa, l’erranza in tutta Europa e in America del Sud, le crisi di nervi, l’internamento in manicomio), nell’opera invece tutti i fatti della vita vengono trasfigurati per assumere un significato assoluto. Unendo Carducci a d’Annunzio, i futuristi a Rimbaud, il filosofo Weininger a Nietzsche, Campana propone un libro a tendenza mitica che deve alludere a tutte le esperienze poetiche moderne filtrate attraverso il racconto dell’iniziazione di un personaggio che parla di sé e del suo complesso rapporto col mondo della poesia. Il libro è definito “orfico” perché contiene il racconto di un contatto col mistero, simile a quello degli antichi riti di iniziazione, ma nello stesso tempo esibisce drammaticamente l’impossibilità del poeta di realizzare l’opera perfetta alla quale allude solo per improvvise illuminazioni della memoria.
Un vero e proprio romanzo in versi è quello contenuto nel Canzoniere (1921, poi 1945, poi 1948) di Umberto Saba, testo complesso nato dall’aggregazione di tante singole raccolte. È come se Saba, di raccolta in raccolta, volesse continuamente rifare la storia della propria poesia, ricapitolandone i momenti fondamentali in uno sforzo cosciente di oggettivazione e trasfigurazione (Furio Brugnolo). Alla crescita del personaggio interno alle singole poesie corrisponde di continuo la crescita del libro, con un effetto di simultaneità che molti lettori hanno riportato al pensiero nietzschiano dell’unità come circolo. L’operazione complicata dei parallelismi strutturali e metrici, delle riprese, delle mise en abîme, porta a una specie di manufatto che da una parte sembra perfettamente chiuso in se stesso, dall’altro rivela un inesauribile bisogno di comprensione e ascolto. Ma questo movimento opposto si riflette dal libro al suo autore. Lo stesso Saba, come ha notato Gian Luigi Beccaria, è riconducibile al gruppo dei numerosi “io divisi” della cultura moderna, per cui ogni simbolo di pienezza (Trieste, il lavoro, la vita militare, i corpi giovani, il passato) è anche segno di privazione, in un’alternanza continua tra possesso e perdita, tra aggressione e regressione.
Diversa l’esperienza poetica di Cesare Pavese. Le “short stories” (come le definisce Mengaldo) di Lavorare stanca, raccontate da una ben riconoscibile voce monologante che modula la serie paratattica di lunghi versi ritmati, costruiscono un intreccio dove un personaggio indefinito scivola inavvertitamente dall’esperienza della campagna a quella della città. Questa specie di primitivo e raffinatissimo monologo si accompagna a un altrettanto primitivo delinearsi di immagini simboliche: il mare, la collina, la vigna, il fiume, le vie. Il tutto sembra ripetersi a ondate regolari, con lievissime progressioni, fino a giungere a una specie di cancellazione dell’umano a favore di simboli estatici e assoluti (simili a quelli che persegue anche il Pavese narratore).
Tra gli anni Venti e gli anni Trenta alcune delle grandi esperienze poetiche europee confermano il ritorno, dopo il predominare di una poesia frammentaria e sintetica, a forme ampie, poematiche, spesso fondate su densi e intricati recuperi mitologici. Basti pensare alle due fondamentali raccolte di Rainer Maria Rilke, le Elegie duinesi e i Sonetti a Orfeo (entrambe le raccolte, dopo lunga gestazione, vengono compiute nel 1923), dove si insegue una visione interiore del mondo, connessa esplicitamente alla superiorità del linguaggio poetico, o al lungo poema in prosa Anabase (1924) del premio Nobel Saint-John Perse, una specie di cosmogonia oscura dove si parla di un conquistatore irrequieto che cerca il luogo adatto per far sorgere una nuova città, metafora dell’ansia di novità e di cambiamento dell’uomo moderno.
Tra le riprese moderniste della seconda parte del secolo, si segnala per l’Italia quella che riunisce intorno a Pasolini i componenti del gruppo della rivista “Officina”, in particolare il bolognese Roberto Roversi. Sia Pasolini sia gli amici Attilio Bertolucci e Vittorio Sereni cercano un’alternativa alla cultura ermetica imperante recuperando stili e forme dalla poesia ottocentesca (Tommaseo, Carducci, Pascoli) e primo-novecentesca – i vociani, in particolare Clemente Rebora e Sbarbaro, ma anche Saba. Per Pasolini, sono i poemetti riuniti nelle Ceneri di Gramsci (1957) a costituire il momento di maggior riuscita in questa direzione. Bertolucci arriverà ad alti risultati con la raccolta Viaggio d’inverno (1971) e proseguirà il tentativo del romanzo in versi fino alla lunga autobiografia intitolata La camera da letto (1984 e 1988), dove la ripresa del tema memoriale di Proust si unisce alla tecnica cinematografica del montaggio. Per Sereni, vanno ricordate le raccolte Gli strumenti umani (1965) e Stella variabile (1981). Soprattutto negli Strumenti è intensa la tendenza a interrompere il flusso della voce lirica con vere schegge di racconto, evocate dal soggetto e colte nel loro mostrarsi momentaneo. Al senso crescente di vuotezza dell’io corrisponde un aumento progressivo di flash psichici, insieme sensoriali e memoriali: colpi di vento, muoversi di foglie, scrosci di pioggia, lamine di luce, toppe di sole, macchie di colore sono le figure in cui si manifesta un essenziale contatto con il mondo (come ha ipotizzato Enrico Testa). L’io non può raccontare il mondo, ma il mondo offre un supporto indispensabile dove l’io può appoggiare la propria inconsistenza.
Un interessante tentativo di racconto su base modernista si trova nel poemetto La ragazza Carla di Elio Pagliarani, che si muove in area sperimentale. La narrazione di Pagliarani si imposta con un distacco netto tra il personaggio che racconta e quello che è raccontato. Da una parte c’è Carla, personaggio di un mondo ben definito (si è parlato della scapigliatura, di Delio Tessa e di Carlo Porta, ma anche di Brecht e Majakovskij, di neorealismo e di Erwin Piscator), dall’altra c’è la voce lirica e colta del poeta che fa da controcanto morale e che è capace di mimare stili e toni diversi. Il genere potrebbe essere quello del romanzo di formazione, dal momento che Carla vive un passaggio da adolescente a donna che trova corrispondenza nella ricerca del lavoro e nei fenomeni sociali di una realtà impiegatizia oggetto di sfruttamento. “Romanzo espressionistico-crepuscolare” lo definisce Pasolini in una lettera all’autore. L’effetto più forte deriva dal montaggio alternato di frammenti che si relativizzano a vicenda: la lingua della prosa sottopone a trattamento ironico i moduli poetici, anche se non si può negare che in certe zone del testo la densità stilistica si conquisti evidenti priorità. Ma in questo modo si accentua proprio il fatto che il personaggio viene messo sullo stesso piano uniforme di tutti gli altri elementi del racconto (i luoghi milanesi, gli uffici, il paesaggio, il linguaggio tecnico) anche se il narratore non può fare a meno di avvicinarsi spesso a Carla, con la stessa ottica di un romanziere tradizionale. Alla fine del Novecento la poesia recupera le caratteristiche del romanzo di un secolo prima: lo sperimentalismo può anche non rinnegare la memoria culturale.