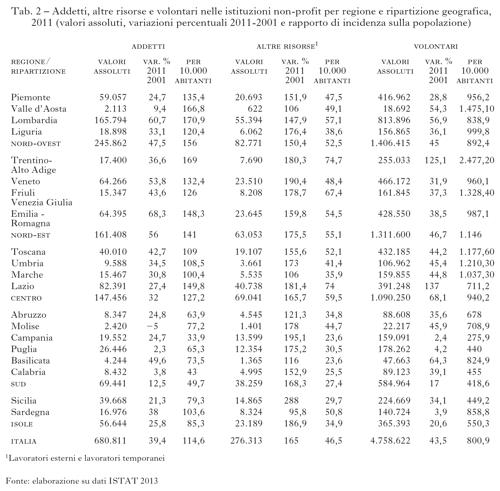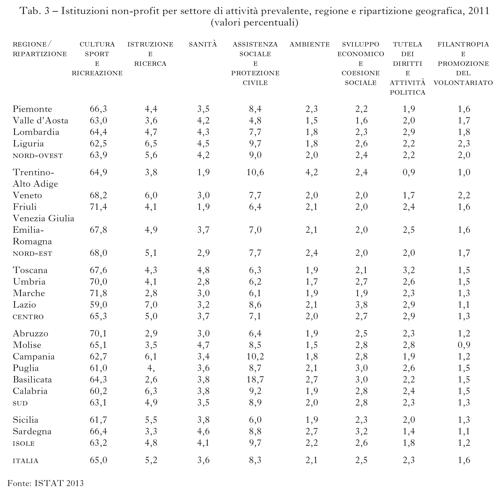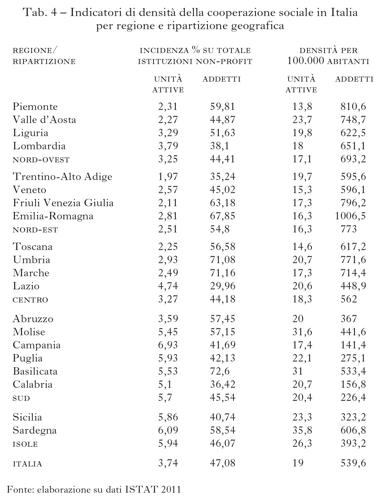La geografia dell'economia civile dell'Italia repubblicana
La geografia dell'economia civile dell'Italia repubblicana
La letteratura sulla persistenza dei divari regionali nell’Italia del periodo postunitario è ormai molto ampia. La molteplicità degli studi di taglio sia teorico sia empirico fornisce un quadro esauriente dell’evoluzione dei tanti dualismi tra Centro-Nord e Sud: dualismo economico (in termini di livelli di reddito pro capite, ricchezza delle famiglie, stato delle infrastrutture); dualismo sociale (speranza di vita, livelli di istruzione, servizi sanitari, sicurezza, giustizia sociale); dualismo civile (in termini di partecipazione democratica, natura dei processi politici, tasso di imprenditorialità, vitalità delle organizzazioni delle società civile). Tuttavia l’imponente lavoro di ricerca finora svolto, mentre è valso a fissare correlazioni di grande interesse conoscitivo tra le tante variabili in gioco, non è ancora riuscito a rintracciare credibili nessi di causalità tra le stesse (tra i lavori più recenti, cfr. Iuzzolino, Pellegrini, Viesti 2011; Acciari, Mocetti 2012). Il dato che emerge è che, nel caso delle regioni italiane, né la convergenza sigma – con cui si misura la dispersione nel tempo del prodotto pro capite delle regioni – né la convergenza beta – con cui si accerta se le regioni più arretrate realizzano un tasso di crescita superiore a quello delle regioni più ricche – si sono andate realizzando nel periodo postunitario (Di Berardino, Sarra 2013).
Con una qualche semplificazione, due sono i paradigmi interpretativi a tutt’oggi dominanti. Per un verso, quello secondo cui sarebbe lo sviluppo economico a porre le premesse e a sostenere lo sviluppo sociale e civile di un territorio; per l’altro verso il paradigma opposto, secondo cui è lo sviluppo civile a generare quelle aspettative e a determinare quei comportamenti degli individui che conducono poi, nel corso del tempo, allo sviluppo economico. Per chi si riconosce nella prima posizione, il Mezzogiorno sarebbe rimasto indietro perché la bassa crescita del prodotto non avrebbe consentito un livello di accumulazione del capitale, fisico e umano, sufficiente per stabilizzare norme sociali e comportamenti virtuosi. Ciò spiegherebbe anche il motivo per cui i divari sociali e civili tra Centro-Nord e Sud sono ancora oggi più accentuati dei divari economici. Donde l’implicazione pratica: occorre che lo sviluppo economico marci a ritmi più sostenuti, anche con interventi di policy dall’esterno, se si vuole che esso sia in grado di trainare lo sviluppo sociale e civile. È questa una variante della nota tesi della modernizzazione – rinverdita in tempi recenti da Seymour M. Lipset (Some social requisites of democracy, «American political science review» 1959, 53, 1, pp. 69-105) – secondo cui la democrazia sarebbe il frutto maturo dello sviluppo economico e non viceversa.
Per l’altra linea di pensiero, invece, sarebbe vero il nesso causale opposto: è la scarsa dotazione di capitale civile, l’insieme cioè di capitale sociale e capitale istituzionale, a fare in modo che le risorse naturali, fisiche e finanziarie, pur affluite in abbondanza al Sud nel corso degli ultimi centocinquant’anni, non siano riuscite a innescare il circolo virtuoso della crescita di lungo periodo. «Il ritardo dello sviluppo del Mezzogiorno […] è soprattutto non economico. È nei servizi essenziali per i cittadini e per le imprese che i divari territoriali appaiono particolarmente marcati» (P. Cipollone, P. Montanaro, P. Sestito, L’istruzione, in Il Mezzogiorno e la politica economica dell’Italia, a cura della Banca d’Italia, 4, 2010, p. 77). Ora, dato che il basso livello di capitale civile del Mezzogiorno è un’eredità della storia degli ultimi cinque/sei secoli, l’implicazione di policy che ne deriva è che continuare a immettere risorse produttive in tali regioni è come trasportare acqua con un secchio bucato. Dunque ci vuole pazienza e attendere che l’evoluzione culturale svolga il suo compito, quello di modificare endogenamente le tradizioni sociali e le mappe cognitive delle persone. È in ciò il fondamento della linea di pensiero neoconservatrice.
Occorrerebbe poter applicare il metodo delle ‘variazioni entro la regione’ (un metodo che va a cercare la risposta a domande del tipo: «se il Sud diventasse relativamente più ricco del Nord, riuscirebbe anche ad accumulare un più alto livello di capitale civile del Nord?» o viceversa) per decidere quali dei due paradigmi interpreta più fedelmente la realtà italiana. Ma, a quanto ci consta, analisi del genere non sono ancora state applicate: come noto, gli usuali metodi di indagine econometrica basati su relazioni cross-country non sono in grado di accertare l’esistenza di nessi causali. Non resta dunque che ricorrere all’indagine teorica. Ebbene, la tesi che in questa sede viene avanzata è che sia giunto il momento di dilatare il quadro concettuale di riferimento. Questo, infatti, si è finora limitato a considerare due soli pilastri dell’ordine sociale: lo Stato, inteso come l’insieme composito delle pubbliche istituzioni, e il mercato concepito come luogo economico occupato esclusivamente da soggetti che perseguono fini individualistici. È mancata la considerazione del terzo pilastro, quello della società civile che si organizza in maniera acconcia per svolgere compiti prettamente economici ma con una logica diversa da quella basicamente capitalistica. È bensì vero – si dirà – che nessuno ha mai negato la rilevanza della società civile, ma a questa è sempre stata riconosciuta una valenza solo sociale e/o culturale. Mai è stata a essa attribuita anche una piena soggettività economica. La nostra tesi è allora che quel che è mancato (e manca) al Sud, rispetto al Centro-Nord, è una vitale economia civile. Questo comporta che si arrivi ad ammettere che reddito e ricchezza non sono generati solamente dal mercato capitalistico e dallo Stato imprenditore (o dalla pubblica amministrazione). Immediata l’implicazione di policy che discende dall’accettazione di una tesi del genere: la politica, anziché reprimere e soffocare, come finora ha fatto, i vari tentativi di far fiorire l’economia civile soprattutto nel Mezzogiorno, deve intervenire sull’assetto istituzionale per modificare le regole del gioco economico così da consentirne il pieno sviluppo. Alla difesa di questa posizione sono dedicate le pagine che seguono.
Cos’è l’economia civile
Quella dell’economia civile è una tradizione di pensiero che affonda le sue radici nell’Umanesimo civile del Quattrocento e che è continuata, con alterni successi, fino al suo periodo d’oro, quello dell’Illuminismo italiano, milanese e soprattutto napoletano (L. Bruni, S. Zamagni, Economia civile, 2004). Mentre con Adam Smith e David Hume si delineavano in Scozia i principi della political economy, a Napoli negli stessi anni prendeva corpo con Antonio Genovesi, Gaetano Filangieri, Giacinto Dragonetti e altri il programma di ricerca dell’economia civile. Tra la scuola scozzese e quella italiana, sia napoletana sia milanese, sono molte le analogie: la polemica antifeudale (il mercato è soprattutto un mezzo per uscire dalla società feudale); la lode per il lusso come fattore di cambiamento sociale, senza eccessive preoccupazioni per i ‘vizi’ di chi consuma quei beni; una grande capacità di cogliere il mutamento culturale che lo sviluppo dei commerci stava operando in Europa; la presa d’atto del ruolo essenziale della fiducia per il funzionamento di una economia di mercato; la ‘modernità’ delle loro visioni della società e del mondo.
Al tempo stesso però esiste tra Scozia (political economy) e Italia (economia civile) una differenza profonda. Smith, pur riconoscendo che l’essere umano possiede una naturale tensione alla socievolezza (alla sympathy e alla correspondence of sentiments con gli altri), non considera che la socievolezza, cioè la relazionalità non strumentale, sia faccenda rilevante per il funzionamento dei mercati:
La società civile può esistere tra persone diverse […] sulla base della considerazione della utilità individuale, senza alcuna forma di amore reciproco o di affetto» (Theory of moral sentiments, 1759, II. 3.2., corsivo dell’autore).
Anzi, in alcuni passaggi sia della Theory of moral sentiments, sia della Wealth of nations (1776), Smith dice esplicitamente che sentimenti e comportamenti di benevolenza complicano il meccanismo di funzionamento del mercato, il quale sarebbe estremamente più efficiente se dotato di rapporti più strumentali al suo interno. Il mercato, per Smith e per la tradizione che dopo di lui diverrà ufficiale in economia, è mezzo per costruire relazioni autenticamente sociali (non c’è società civile senza mercati), perché libera da legami verticali e di status non scelti, ma non è in se stesso luogo di relazionalità. Che le relazioni mercantili siano impersonali e mutuamente indifferenti non è per Smith un aspetto negativo, ma positivo e civilizzante: solo in questo modo il mercato può produrre benessere e sviluppo.
Amicizia e rapporti di mercato appartengono dunque a due ambiti ben distinti e separati; anzi, l’esistenza delle relazioni di mercato nella sfera pubblica (e solo in questa) garantisce che nella sfera privata i rapporti di amicizia siano autentici, scelti liberamente e sganciati dallo status: se il mendicante si reca dal macellaio a chiedere l’elemosina, non potrà mai avere con lui un rapporto di amicizia al di fuori del mercato. Se invece l’ex mendicante entra un giorno nella bottega del macellaio o in quella del birraio per acquistare le loro merci, la sera quell’ex mendicante potrà incontrarsi al pub con i suoi fornitori su un piano di maggiore dignità, e magari può diventare loro amico. Per Smith e per la tradizione ufficiale della scienza economica il mercato è civiltà ma non è amicizia, reciprocità non strumentale, fraternità (Bruni, Sugden 2008).
Su questi aspetti, centrali nella prassi e nella teoria economica contemporanea, la tradizione dell’economia civile dissente in modo radicale. Per Genovesi, Filangieri, Dragonetti a Napoli, e per Pietro Verri, Cesare Beccaria, Gian Domenico Romagnosi a Milano, e poi nel Novecento Luigi Sturzo e, in un certo senso, Luigi Einaudi, ma anche per economisti più applicati come Ugo Rabbeno o Luigi Luzzatti, o il fondatore dell’economia aziendale Gino Zappa (anche la tradizione dell’economia aziendale italiana è un’espressione dell’antica tradizione dell’economia civile), il mercato, l’impresa, l’economico sono in sé luoghi anche di amicizia, reciprocità, gratuità. L‘economia civile non accetta l’idea (oggi sempre più diffusa e data per scontata) che il mercato sia qualcosa di radicalmente diverso dal civile, retto da principi diversi: l’economia è civile, il mercato è vita in comune, e condividono la stessa legge fondamentale, ossia la mutua assistenza. La mutua assistenza di Genovesi non è solo il mutuo vantaggio di Smith: per il mutuo vantaggio basta il contratto, per la mutua assistenza occorre la philia, e forse l’agape. L’economia civile si pone oggi in alternativa nei confronti dell’economia di tradizione smithiana che vede il mercato come l’unica istituzione davvero necessaria per la democrazia e per la libertà: l’economia civile ricorda che una buona società è frutto certamente del mercato e della libertà, ma ci sono esigenze, riconducibili al principio di fraternità, che non possono essere eluse, né rimandate alla sola sfera privata e alla filantropia in particolare. Al tempo stesso, l’economia civile non sta con chi combatte i mercati e vede l’economico in endemico e naturale conflitto con la vita buona, invocando una decrescita e un ritiro dell’economico dalla vita in comune. L’economia civile, piuttosto, propone un umanesimo a più dimensioni, in cui il mercato non è combattuto o ‘controllato’, ma è visto come un luogo civile al pari degli altri, come un momento della sfera pubblica, che se concepito e vissuto come luogo aperto anche ai principi di reciprocità e di gratuità, contribuisce alla costruzione della civitas.
L’economia come se la persona contasse: questa potrebbe essere la perifrasi per esprimere il nucleo del programma di ricerca dell’economia civile. Per cogliere il senso della perifrasi, si considerino le due visioni antitetiche del modo di concepire il rapporto tra la sfera economica (che possiamo per comodità, e con accezione ampia del termine, chiamare mercato) e la sfera del sociale (la sfera della solidarietà). Da una parte vi sono coloro che vedono nell’estensione dei mercati e del principio di efficienza la soluzione a tutti i mali sociali; dall’altra chi invece vede l’avanzare dei mercati come una ‘desertificazione’ della società e quindi cerca di proteggersi. La prima visione considera il mercato come un ente basicamente ‘a-sociale’: secondo questa concezione, che si rifà ad alcune versioni dell’ideologia liberale, il ‘sociale’ è distinto dalla meccanica del mercato, che si presenta come un’istituzione eticamente e socialmente ‘neutrale’. Al mercato è richiesta l’efficienza e a esso è demandato il compito di creare quanta più ricchezza possibile. La solidarietà, invece, inizia proprio laddove finisce il mercato, quando si tratta di fissare criteri per la suddivisone della ricchezza prodotta.
Agli antipodi di questa visione troviamo l’altro approccio, che vede il mercato come essenzialmente ‘antisociale’. Questa concezione, che risale a Karl Marx e a Karl Polanyi e ha come espressioni oggi più visibili le varie forme di economia alternativa (‘economia solidaria, economia comunitaria’ e simili), si caratterizza invece per concepire il mercato come luogo dello sfruttamento e della sopraffazione del forte sul debole, e per vedere la società minacciata dai mercati: «il mercato avanza sulla desertificazione della società» – aveva scritto Polanyi. Da qui l’appello a «proteggere la società» dal mercato con l’argomento che i rapporti veramente umani (come l’amicizia, la fiducia, il dono, la reciprocità non strumentale, l’amore, ecc.), verrebbero distrutti dall’avanzare della cultura del mercato. Questa visione tende a vedere l’economico e il mercato come di per sé disumanizzanti, come meccanismi distruttori di quel ‘capitale sociale’ indispensabile per ogni convivenza autenticamente umana oltre che per ogni sostenibile crescita economica.
La concezione del rapporto mercato-società tipica dell’economia civile si colloca in una prospettiva radicalmente diversa rispetto alle due precedenti. L’idea centrale è quella di vivere l’esperienza della socialità umana, all’interno di una normale vita economica, né a lato, né prima, né dopo. Essa ci dice che i principi ‘altri’ dal profitto e dallo scambio di equivalenti possono trovare posto dentro l’attività economica. In tal modo si supera certamente la prima visione che vede l’economico come luogo eticamente neutrale basato unicamente sul principio dello scambio di equivalenti, poiché è il momento economico stesso che, in base alla presenza o assenza di questi altri principi, diventa civile o ‘in-civile’. Ma si va oltre anche l’altra concezione che vede il dono e la reciprocità appannaggio di altri momenti o sfere della vita sociale, una visione questa ancora oggi radicata in non poche espressioni del terzo settore – una visione che non è più sostenibile. E ciò per almeno due ragioni specifiche. Primo, nella stagione della globalizzazione la logica dei ‘due tempi’ (prima le imprese producono e poi lo Stato interviene per redistribuire la ricchezza), su cui è fondato il rapporto tra economia e società (si pensi al welfare state), non funziona più, perché è venuto meno l’elemento base di quella logica, e cioè il nesso stretto tra ricchezza e territorio. Ne consegue che all’impresa è chiesto di prestare attenzione al sociale nella normalità della sua attività economica. È questo il senso del movimento di idee della responsabilità sociale dell’impresa (Zamagni 2013): la Carta della responsabilità sociale condivisa approvata dal Consiglio d’Europa il 22 gennaio 2014 ne è chiara evidenza. Secondo, l’effetto ‘spiazzamento’. Se il mercato e più in generale l’economia diventano solo scambio strumentale, si entra dentro uno dei paradossi più preoccupanti di oggi. La «moneta cattiva scaccia la buona», recita la legge di Grisham, una delle più antiche e note leggi dell’economia. È questo un meccanismo che ha una portata assai vasta, e agisce per es. tutte le volte in cui motivazioni intrinseche (come la gratuità) si confrontano con motivazione estrinseche (quali il lucro): le cattive scacciano le buone. Lo scambio basato solo sul perseguimento dell’interesse proprio scaccia altre forme di rapporti umani. Così il mercato – se è solo questo – sviluppandosi ‘erode’ la condizione del suo stesso esistere, cioè la fiducia e la propensione a cooperare.
Tutte le società infatti hanno bisogno di fare leva su tre principi diversi per potersi sviluppare in modo armonico ed essere quindi capaci di futuro: lo scambio di equivalenti, la redistribuzione della ricchezza, la reciprocità. Tutte le società conoscono questa struttura triadica; anche se è vero che due soli di questi principi sono stati, volta per volta, incorporati nei modelli di ordine sociale storicamente succedutisi nel corso degli ultimi secoli. Con esiti sempre insoddisfacenti. Cosa succede infatti quando uno dei tre principi viene a mancare? Se si elimina la reciprocità si arriva al modello di ordine sociale basato sulla dicotomia Stato-mercato: il mercato produce, e lo Stato benevolmente ridistribuisce secondo un qualche canone di equità. Se si elimina la redistribuzione ecco il modello del ‘capitalismo compassionevole’ (il welfare capitalism dell’esperienza americana). Il mercato è la leva della società e deve essere lasciato libero di agire senza intralci, come insegna il neoliberismo. In questo modo il mercato produce ricchezza, e i ‘ricchi’ fanno ‘la carità’ ai poveri, ‘utilizzando’ la società civile e le sue organizzazioni (le charities e le foundations). D’altro canto l’eliminazione o la sottovalutazione dello scambio di equivalenti produce i collettivismi e comunitarismi di ieri e di oggi, dove si vive volendo fare a meno della logica del contratto (anche a costo di inefficienze e sprechi devastanti). Ebbene, l’idea centrale dell’economia civile è quella di mirare a un modello di ordine sociale nel quale tutti e tre i principi possano coesistere simultaneamente, possano cioè trovare spazi reali di attuazione pratica.
Per concludere e sintetizzare: quella dell’economia civile è una prospettiva di sguardo sulla realtà economica che accoglie tre tesi principali. La prima è il rifiuto del principio del NOMA (Non Overlapping Magisteria) formulato nel 1829 per primo da Richard Whately, influente economista dell’Università di Oxford. Secondo il NOMA le norme etiche avrebbero tanto impatto sulla scienza economica quanto ne hanno sulle leggi della fisica. Vale a dire che la sfera dell’economico va tenuta separata dalle sfere dell’etica e della politica, con le quali non avrebbe nulla a che vedere. Anzi, l’infiltrazione nell’area del mercato di valori e norme appartenenti alle altre due aree potrebbe mettere a repentaglio il perseguimento del fine ultimo per il quale il mercato esiste: quello dell’efficienza. Se dunque il discorso economico vuole ambire ad acquisire lo statuto della scientificità (neopositivisticamente inteso) deve tagliare quel cordone ombelicale che da secoli lo tiene unito all’etica e alla politica. Chiaramente l’economia civile non può accettare un tale principio di separazione (tuttora egemone) per l’ovvia ragione che oggetto del problema economico è l’uomo nella sua integralità. E dunque economia ed etica si riflettono vicendevolmente e si comprendono l’una nello specchio dell’altra. L’economia va bensì tenuta distinta e resa autonoma dall’etica e dalla politica, ma non separata. La seconda tesi è che compito non secondario dell’indagine economica è quello di occuparsi anche del disegno dell’assetto istituzionale della società, il quale non può essere assunto come un dato fissato dall’esterno, quasi che fosse un dato di natura. L’economista civile non può cioè limitarsi a cercare l’adattamento ottimale delle risorse a un dato insieme di regole del gioco. E ciò per la semplice ragione che non tutte le istituzioni economiche sono egualmente capaci di assicurare gli stessi risultati: si tratta dunque di scegliere tra esse quelle che meglio favoriscono il progresso civile della società. Il quale dipende sia dai comportamenti individuali sia dal tipo di istituzioni economiche che vengono selezionate.
Infine, la terza tesi è che i tre principi dell’ordine di mercato – scambio di equivalenti, redistribuzione, reciprocità – devono stare tra loro in una relazione moltiplicativa, non additiva. Questo significa che tutti e tre i principi devono essere simultaneamente all’opera, se si vogliono attivare circolo virtuosi. Non è ammissibile alcun trade-off tra gli stessi, come rinunciare, poniamo, alla reciprocità per aumentare lo spazio riservato allo scambio di equivalenti o viceversa. In altri termini, cifra inconfondibile dell’economia civile è quella di avere come suo fine ultimo il bene comune – che è la produttoria dei beni individuali – e non il bene totale – che invece è la sommatoria dei beni individuali, come insegna l’utilitarismo benthamiano.
La civiltà cittadina: dove nascono le virtù civiche
Sorge spontanea una domanda: come ha potuto attecchire (dando frutti copiosi almeno fino a quasi tutto il Settecento) il seme dell’economia civile? Detto in altro modo: quale specifica matrice culturale ha potuto favorire la nascita dell’idea di un ordine sociale basato su tutti e tre i principi regolativi di cui si è appena detto? La risposta è la fioritura, al tempo del basso Medioevo, di quel modello di organizzazione sociale noto come civiltà cittadina, la quale condurrà poi all’humanitas, quale cifra dell’Umanesimo civile del 15° secolo. Si rammenti infatti che l’humanitas è un valore che si realizza prioritariamente nella civitas, la quale è a sua volta all’origine della civilitas. Vediamo di precisare.
La ripresa della vita culturale, emblematicamente espressa dalla nascita dell’Università a Bologna nel 1088, per un verso, e il successo straordinario della rivoluzione commerciale iniziata nell’11° sec., per l’altro, sono all’origine di un nuovo modello di ordine sociale centrato sulla ‘città’. Non però la metropoli, capitale di imperi, come erano state Roma o Costantinopoli, luoghi del potere centralistico e crocevia di etnie diverse. Ma la città-comunità di uomini liberi che si autogovernano mediante istituzioni appositamente create e che si attornia di mura per tutelarsi da chi non è parte della comunità e dunque non merita la pubblica fiducia. Lo stesso spazio urbano è disegnato in modo da rendere visibile e da favorire lo sviluppo degli assi portanti della nuova convivenza: la piazza centrale intesa come agorà, la cattedrale, il palazzo del governo, il palazzo dei mercanti e delle corporazioni, il mercato come luogo delle contrattazioni e degli scambi, i palazzi dei ricchi borghesi, le chiese che ospitano le confraternite.
Era entro questi luoghi, tutt’altro che virtuali, che venivano coltivate quelle virtù che definiscono una società propriamente civile: la fiducia reciproca; la sussidiarietà; la fraternità; il rispetto delle idee altrui; la competizione di tipo cooperativo. Questo impianto della città è qualitativamente diverso sia da quello dei villaggi agricoli – spesso un mero agglomerato di case senza un’urbanistica che rinviasse a pratiche di autogoverno – sia da quello dei villaggi annessi ai castelli dei signori feudatari. La cifra della città-comunità non è tanto la più grande dimensione, quanto piuttosto la capacità di realizzare coesione sociale e di esprimere un’autonomia politica ed economica. Nel Trecento, nell’Italia centrosettentrionale, dove il modello di civiltà cittadina ha trovato facile diffusione, si contavano già 96 città con più di 5000 abitanti – 53 delle quali con più di 10.000 abitanti – con un’incidenza del 21,4% sul totale della popolazione ivi residente, a fronte di un’incidenza europea del 9,5%. Solamente i Paesi Bassi riuscirono a imitare celermente il modello italiano, mentre l’Inghilterra ancora nel 1500 aveva un’incidenza della popolazione urbana pari solo al 4,6% (L. Bruni, S. Zamagni, Economia civile, 2004).
A una delle istituzioni che molto presto vennero create va fatta risalire l’organizzazione del lavoro manifatturiero, cui si deve non solamente l’aumento della produttività, ma anche l’incremento continuo della qualità dei prodotti. Si tratta delle corporazioni di arti e mestieri, il cui fondamentale ruolo civilizzatore si va ora riscoprendo. Era attraverso le corporazioni che avveniva la formazione delle nuove leve lavorative per il tramite dell’apprendistato (che terminava con il ‘capolavoro’, termine che viene coniato in questo periodo) ed è ancora a esse che si deve la predisposizione di quegli strumenti di misura e di controllo della qualità (i cosiddetti standard) che valsero a rendere il mercato più affidabile e trasparente, abbassando così i costi di transazione – in particolare i costi di raccolta delle informazioni. Col tempo si esagerò con il vincolismo, e le corporazioni si chiusero nei confronti dei vari gruppi di ‘infami’. Per questo già nel Settecento esse vennero smantellate, ma ciò avvenne dopo che avevano insegnato al mondo il principio dell’autorganizzazione dei produttori.
L’economia delle città italiane era costituita di manifattori e di mercanti, oltre che di navigatori nelle città costiere. Ai mercanti spettò il ruolo di aprire nuovi mercati, anche a grande distanza, verso i quali riversare i prodotti della manifattura e dai quali importare materie prime e quanto di interessante essi avevano da offrire. I mercanti furono non solamente i più attivi produttori di innovazioni organizzative in campo aziendale ma anche i più attivi soggetti di apertura culturale. Degno di nota è quanto scrive Benedetto Cotrugli nel suo Della mercatura et del mercante perfetto, pubblicato intorno alla metà del Quattrocento:
Et habbino pazienza alcuni ignoranti li quali dannano il mercante, che è sciente. Anzi incorrono in maggiore insolentia volendo che il mercante debba essere illetterato. Et io dico che il mercante non solo deve essere buono scrittore, abbachista, quadernista, ma anche letterato et buon retorico» (ed. 1602, p. 131).
Fu all’interno delle città che si affermò l’amore per il bello – la filocalia che crea e realizza la percezione di un’appartenenza, e quindi facilita le relazioni interpersonali. Se ne ha chiara manifestazione nella costruzione e nell’arredamento delle chiese, nell’edificazione di palazzi, dapprima pubblici e poi anche privati, inaugurando quel mecenatismo che non solo finanziò gli artisti, ma consentì la nascita del mercato dei beni durevoli di carattere artistico. Il mercante – si badi – non è semplicemente il filantropo che, mentre fa donazioni attingendo alla propria ricchezza, non si cura dei modi del loro utilizzo. Il mecenate invece si relaziona con l’artista, instaurando rapporti di collaborazione di lungo periodo, non sempre privi di conflitti, ma certo non anonimi, allo scopo di perseguire obiettivi di interesse collettivo in funzione dei quali egli pone le proprie risorse e il know-how organizzativo.
La città rappresentava l’ambiente ideale per tutto ciò e se ne comprende agevolmente la ragione. Di cosa aveva primariamente necessità il nuovo modello di ordine sociale che, in modo del tutto spontaneo, si andava imponendo? Soprattutto di fiducia e di credibilità reciproca, virtù queste che abbisognavano di norme sociali, la cui propagazione l’ambiente cittadino tendeva appunto a favorire. Al tempo stesso, però, un tale ordine sociale finiva con il distinguere nettamente tra coloro che prendevano parte attiva alla costruzione del bene comune attraverso attività economiche esercitate con competenza e con profitto e coloro invece – come gli usurai, gli avari, i manifattori incompetenti, ma anche quei poveri che, pur potendo fare qualcosa, si lasciavano andare all’accidia – che accumulavano solo per sé, tendendo a sterilizzare la ricchezza in impieghi improduttivi. Per garantire che la fiducia non venisse mal riposta, le città si dotavano sia di tutte quelle istituzioni di controllo dell’attività economica facenti capo alla Camera dei mercanti (in seguito, Camera di commercio), sia di quelle iniziative di solidarietà civica messe in atto dalle confraternite. Chi sono le persone degne di rispetto e di fiducia? Quelle che non lavorano solo per sé e per la propria famiglia, ma che si adoperano per realizzare opere di carità e che mantengono la parola data: in tal modo facendosi conoscere e apprezzare dalla comunità, esse accrescono il proprio capitale reputazionale (S. Zamagni, Avarizia. La passione dell’avere, 2009).
La diffusione e l’espansione delle città – conseguenza e causa, a un tempo, della fioritura del modello di civiltà cittadina – alle novità e ai punti di forza di cui si è detto in precedenza associano un esito del tutto indesiderato: lo spirito di fazione. Come suggerisce Francesco Bruni (La città divisa, 2003), Dante fu tra i primi a intuire che ciò costituiva un fattore di estrema pericolosità, capace di minare le fondamenta stesse della coesione e dell’armonia sociale. Nel libro IV del Convivio (1304-1307) il poeta non esita a indicare nella cupidigia l’origine dello spirito di parte, tanto che la ben nota proposta dell’impero universale viene giustificata come rimedio estremo all’avanzata di tale vizio: solo un dominio esteso a tutto il mondo potrebbe indurre l’imperatore a dar vita al migliore dei governi e ad amministrare con saggezza la giustizia. Ambrogio Lorenzetti, nella sua celebre Allegoria del buon governo (1337-1339), rappresenta l’avarizia come la causa di tutto quello (ruberie, rapine, violenza) che non consente lo sviluppo armonioso della città. Poiché il buon governo è sinonimo di buon commercio, la civiltà, sembra voler dire il pittore, è il mercato; l’avarizia del mercante invece accresce la faziosità e quindi induce al malgoverno.
La cura da tutti invocata per contrastare lo spirito di fazione è il bene comune, vale a dire l’esatto contrario del bene proprio. È ai francescani dell’Osservanza che si deve la prima sistematica traduzione della nozione di bene comune sul terreno propriamente economico. La figura che giganteggia a tale riguardo è quella di Bernardino da Siena che verrà proclamato santo da Pio II – il grande umanista Enea Silvio Piccolomini – già nella seconda metà del Quattrocento, a soli pochi anni dalla morte. In una predica senese del 1425, Bernardino incita alle pratiche di bene comune perché «Idio è comuno bene»; quanto a dire che la condanna dello spirito di parte trova il suo fondamento addirittura nella teologia. La nozione di bene comune, per il pensiero francescano, non riguarda la persona presa nella sua singolarità, ma in quanto è in relazione essenziale con l’altro. Comune è dunque il bene della relazione stessa fra persone; è il bene proprio della vita in comune. È comune ciò che non è solo proprio – è tale invece il bene privato – né ciò che è di tutti indistintamente – è tale il bene pubblico. Nel bene comune, il vantaggio che ciascuno trae per il fatto di far parte di una data comunità non può essere scisso dal vantaggio che altri pure traggono da esso. Quanto a dire che l’interesse di ognuno si realizza assieme a quello degli altri, non già contro – il che è quanto succede col bene pubblico. Come già Aristotele aveva chiarito nell’Etica Nicomachea (4° sec., a.C.), la vita in comune tra esseri umani è cosa ben diversa dalla mera comunanza del pascolo propria degli animali. Nel pascolo, ogni animale mangia per proprio conto e cerca, se gli riesce, di sottrarre cibo agli altri. Nella società umana, invece, il bene di ognuno può essere raggiunto solo con l’opera di tutti, e soprattutto il bene di ognuno non può essere goduto se non lo è anche dagli altri. È in questo preciso senso che il bene comune, ovvero il bene della civitas, è superiore al bene dei singoli individui.
Ciò spiega perché furono proprio i francescani dell’Osservanza a progettare e a dare vita a un tipo di istituzione economico-finanziaria veramente notevole, i Monti di Pietà, il primo dei quali fu fondato a Perugia nel 1462. Nati con l’obiettivo di arginare il prestito feneratizio e di recuperare entro la comunità la trama di relazioni che l’usura andava distruggendo, i Monti di Pietà si posero a scalzare gli istituti di prestito su pegno privati, assumendo un ruolo di mediatori tra gli interessi delle varie categorie di cittadini: garantendo l’accesso al credito dei meno abbienti; andando incontro alle necessità dei mercanti; favorendo la creazione di opportunità di investimento per i risparmiatori. Inizialmente, i depositi sono gratuiti, ma poi si arriva fino a una remunerazione intorno al 4%, mentre per gli impieghi si può arrivare a un tasso del 6%. Il differenziale tra tassi attivi e passivi serve a coprire le spese di gestione, assicurando così la sostenibilità nel tempo del Monte. È a Bernardino da Feltre (1439-1494) che si devono le prime sistematiche spiegazioni del significato economico dell’attività dei Monti. Nelle sue prediche a favore dell’erezione dei Monti – oltre 3600 sermoni pronunciati nelle principali città dell’Italia centrosettentrionale – Bernardino fornisce argomenti volti a dimostrare la superiorità della nuova istituzione rispetto all’elemosina nella lotta contro la miseria e nel finanziamento di chi è portatore di idee nuove. Il primo di tali argomenti è la superiorità di un’istituzione cui molti contribuiscono, pur in piccola parte, rispetto all’iniziativa dei singoli. Il secondo è l’argomento pluralitatis: a differenza dell’elemosina, il Monte è in grado di aiutare molti allo stesso tempo e per bisogni diversi. Il terzo è l’argomento sanctitatis, particolarmente caro ai francescani: il contributo dato al Monte, essendo finalizzato alle opere di misericordia, assicura il Paradiso più efficacemente che il contribuire all’ornamento di Chiese. Infine, fondare un Monte significa «adiuvare rem publicam, bonum commune», anche se ciò può danneggiare gli interessi degli usurai e dei ricchi mercanti che – non a caso – avversavano la nuova istituzione, talvolta in modi addirittura violenti (G. Todeschini, Ricchezza francescana, 2006).
Il declinare del 15° sec. vede l’inizio della secolarizzazione dell’Occidente e con essa la nascita dello Stato moderno. Dapprima si tratta di un movimento di idee messo in atto dai circoli del Rinascimento, da quello di Coluccio Salutati (1331-1406) a quello di Bessarione dopo il 1453, a quelli dell’accademia ficiniana, portatori di programmi di rinnovamento sia sociale sia economico. Poi, nel secondo Settecento, la secolarizzazione si diffonderà al di fuori dei circoli intellettuali fino a occupare gli spazi e i luoghi in cui si decide dell’esercizio del potere.
Età laicizzante quella moderna, ma non contraria alla religione. Con l’umanesimo l’uomo era stato posto al centro dell’universo, mentre la filosofia si era emancipata dall’aristotelismo, auspice il volontarismo francescano con i filosofi nominalisti. William Ockham – il più famoso dei nominalisti – e i suoi allievi, Jean Buridan e Nicolas de Oresme, avevano ormai resa obsoleta la dottrina tomista degli universali, mostrandone tutta l’irrilevanza (gli universali designavano le proprietà essenziali delle cose). La conoscenza – sostenevano i nominalisti – va cercata nello studio degli aspetti individuali, empirici delle cose, non già nella loro essenza universale. E mentre la politica con Niccolò Machiavelli aveva cessato di essere una branca della filosofia morale, per diventare scienza, con la Riforma era la fede stessa che si emancipava dall’autorità costituita – «ognuno sacerdote di se stesso», come dirà poi Friederich Nietzsche (1844-1900). Il Principe viene scritto da Machiavelli nel 1513; l’inizio della predicazione di Lutero è nel 1517. Nel trattato Del commercio e dell’usura (1524), Lutero si dice desolato nel constatare che «il male [l’usura] ha fatto progressi enormi e ha preso il sopravvento in tutti i paesi». Sposando una concezione rigorista del prestito, scrive:
Scambiare una cosa con qualcuno facendo nel cambio un guadagno, non è compiere opera di carità, è rubare. L’usuraio merita di essere impiccato e chiamo usurai quanti prestano all’interesse del 5 o 6 per cento» (p. 39).
E le nascenti compagnie commerciali sono condannate senza attenuanti:
In esse, tutto è senza fondamento e senza ragione, avendo come fine solo la cupidigia e l’ingiustizia. Se proprio devono esistere le società o compagnie, allora bisogna che scompaiono giustizia e carità; ma se giustizia e onestà devono continuare ad esistere, devono scomparire le compagnie» (p. 41).
È a dir poco sorprendente che parole del genere possano essere state dette dall’iniziatore di quell’etica protestante che di lì a un paio di secoli avrebbe costituito – secondo la ricostruzione di Max Weber – la matrice dello spirito capitalistico.
Sembra opportuno chiudere questo paragrafo con il seguente brano di Cicerone che bene illustra il senso profondo della civiltà cittadina:
Le città senza la convivenza umana non si sarebbero potute né edificare né popolare; di qui la costituzione delle leggi e dei costumi; di qui l’equa ripartizione dei doveri e una sicura norma di vita. Da tutto ciò ne conseguì la gentilezza degli animi e il rispetto reciproco. Onde avvenne che la vita fu più sicura e noi, col dare e col ricevere, cioè con lo scambiarci a vicenda i nostri averi e i nostri poteri, non sentimmo mancanza di nulla». (De officiis, 44 a.C., II, IV; corsivo aggiunto).
Un interessante contributo che dà conto della rilevanza della civiltà cittadina e delle modalità della sua evoluzione è quello di Luigi Guiso e Paolo Pinotti (2011).
Il capitale civile: cosa è e come si può accrescere
Da quanto precede si può comprendere perché è la città, la civitas il luogo privilegiato in cui si crea e si mette all’opera il capitale civile, vero e proprio motore di ogni processo di sviluppo umano sostenibile. È noto che la matrice culturale di una comunità è il fattore decisivo del suo progresso, dal momento che lo sviluppo economico moderno, più che il risultato dell’abbondanza di risorse naturali (e fisiche) e dell’adozione di efficaci schemi di incentivo, consegue piuttosto da una nuova cultura. Invero, non sono gli incentivi di per sé, ma il modo in cui gli agenti percepiscono e reagiscono agli incentivi a determinare gli esiti finali. E i modi di reazione dipendono proprio dall’ammontare disponibile del capitale civile. Un caso notevole che conferma l’asserto è quello della Rivoluzione industriale. Questa ebbe a realizzarsi in Inghilterra in un periodo (il 18° sec.) in cui le istituzioni economiche e gli incentivi erano rimasti basicamente gli stessi di quelli dei secoli precedenti. Un solo esempio: le opportunità di profitto assicurate dalla conversione dei terreni a proprietà comune in terreni a proprietà privata – opportunità già presenti da secoli – cominciarono a essere sfruttate solamente quando lo spirito imprenditoriale di tipo capitalistico iniziò a diffondersi in seguito a un marcato rivolgimento culturale associato alla linea di pensiero Hobbes-Locke-Hume-Mandeville-Bentham (un puntuale resoconto di tale vicenda è in Clark 2007). Altra autorevole conferma ci viene dal lavoro dello storico economico Avner Greif (Contract enforceability and economic institutions in early trade, «American economic review», 1993, 83, pp. 525-48) sulle comunità di mercanti medievali tra il Magreb e il Mediterraneo. Vi si mostra, con dovizia di particolari, come il successo comparato dei mercanti genovesi fosse da attribuire, in primis, alla prevalenza presso costoro di una cultura i cui codici simbolici e le cui norme di comportamento sociale favorivano la cooperazione economica e, in conseguenza di ciò, facilitavano l’attività di scambio grazie alla riduzione dei costi di transazione.
È ormai acquisito che valori e disposizioni quali la propensione al rischio, le pratiche di concessione dei crediti, l’atteggiamento nei confronti del lavoro, la disponibilità a fidarsi degli altri sono fortemente connessi alla cultura prevalente in un determinato contesto spazio-temporale. Il capitalismo, al pari di ogni altro modello di ordine sociale, ha bisogno per la sua continua riproduzione di una varietà di input culturali e di un articolato codice di moralità che esso stesso non è però in grado di generare, anche se concorre certamente a modificarne le componenti nel corso del tempo.
Quali sono dunque gli elementi costitutivi del capitale civile di una regione o di una comunità? Il primo è il capitale sociale strutturale; il secondo è il capitale istituzionale. Il terzo è il capitale culturale. Iniziamo dal primo. Sterminata è oggi la letteratura sul capitale sociale. Non mette dunque conto fornire qui una rassegna. Ci limitiamo a ricordare che questa espressione appare per la prima volta in un saggio di Lyda Judson Hanifan.
Nell’uso dell’espressione ‘capitale sociale’ qui non si fa alcun riferimento all’accezione usuale del termine capitale, se non in senso figurativo. Non ci riferiamo ad un patrimonio immobiliare o ad una proprietà personale o al denaro, ma piuttosto a ciò che consente a queste entità tangibili di contare nella vita di tutti i giorni […] Nella costruzione di una comunità, come pure di una organizzazione di mercato, deve esservi una accumulazione di capitale prima che il lavoro di edificazione possa essere intrapreso» (1920, p.121; corsivo dell’autore).
In tempi più vicini il concetto di capitale sociale viene ripreso da Pierre Bourdieu e da James Coleman. Nonostante le differenze tra le definizioni dei due celebri sociologi, un elemento è comune a entrambe: il capitale sociale è visto come risorsa a disposizione dell’individuo e non già come relazione interpersonale. Di fatto il capitale sociale viene confuso con il capitale reputazionale, che è appunto un asset fruito dal singolo soggetto.
È solo con l’opera del politologo americano Robert Putnam (1993) che la categoria di capitale sociale acquista l’accezione oggi universalmente accolta. Sulla scorta di un approccio di studio di tipo ecologico (approccio che utilizza dati riferiti a unità di analisi territoriali e non già dati raccolti direttamente presso gli individui, come esige l’approccio relazionale) Putnam traccia una netta distinzione tra capitale sociale di tipo bonding e capitale sociale di tipo bridging. Il primo è l’insieme delle relazioni che si stabiliscono tra persone che appartengono a un gruppo chiuso e caratterizzato da forte omogeneità di valori e di interessi: la famiglia, un’associazione, una comunità di paese. Questo tipo di capitale crea bensì rapporti fiduciari, ma di corto raggio; realizza bensì forme di solidarietà, ma solamente a favore dei membri del gruppo. Il capitale sociale di tipo bridging, invece, è quello che si crea quando persone che appartengono a gruppi sociali diversi, e culturalmente distanti, riescono a intrecciare forme stabili di relazioni tra loro. Nasce di qui la fiducia generalizzata, che è cosa ben diversa dalla fiducia particolaristica di cui sopra. Va ribadito che è la fiducia generalizzata il vero fattore di sviluppo economico e di progresso morale di un territorio. Solo essa, infatti, è capace di generare le condizioni che valgono ad abbassare significativamente i costi di transazione e a favorire così rapporti di scambio anche tra soggetti che non si conoscono. Secondo un modo di dire americano, «non si fanno buoni affari con gli amici e con i vicini!».
Vi è poi un terzo tipo di capitale sociale non considerato esplicitamente da Putnam: quello di tipo linking. Esso consiste nella rete di relazioni di aggancio tra organizzazioni della società civile (associazioni; fondazioni; ONG; Chiese) e istituzioni politico-amministrative (a livello sia centrale sia locale) volte alla realizzazione di opere che né la società civile né la società politica, da sole, potrebbero attuare. Tutte e tre le forme di capitale sociale sono necessarie ai fini dello sviluppo. Una condizione però deve essere rispettata: che l’accumulazione del capitale sociale di tipo bonding non avvenga a spese di quelle di tipo bridging e linking, come è accaduto (e accade) nelle regioni meridionali, dove sia i policy outputs (il rendimento istituzionale) sia i policy outcomes (gli effetti sulla qualità di vita della gente) sono significativamente inferiori a quelli delle regioni del Centro-Nord. Il problema del Mezzogiorno «non è tanto l’assenza di fiducia e di reti per sè, ma le loro caratteristiche particolaristiche, dal momento che fiducia e ampiezza delle reti sociali si restringono rapidamente al di fuori dei confini familiari», come scrive Paolo Sestito (2011, p. 55). Un lavoro recente (De Blasio, Scalise, Sestito 2014) indaga sulla dicotomia tra universalismo e particolarismo rispetto a diverse dimensioni del capitale sociale con riferimento specifico al caso italiano. L’accurata analisi empirica conferma appieno la congettura teorica secondo cui è la prevalenza al Sud del capitale sociale bonding a frenarne le prospettive di sviluppo. E ciò per la fondamentale ragione che dove sono dominanti le relazioni a corto raggio si viene a instaurare una partizione tra ‘noi’ (i membri del gruppo o del clan) e ‘loro’ (gli altri) e dove lo scopo del ‘noi’ è quello di costruire aggregazioni in grado di generare il fantasma del ‘loro’, degli altri. In questi casi, l’uso del ‘noi’ diviene funzionale, più che a una esigenza di identificazione, a una volontà di esclusione.
Con misurazioni compiute nell’arco di un ventennio, lo studio di Putnam (svolto con la collaborazione di Robert Leonardi e di Raffaella Nanetti) mostra come localismi, familismi, corporativismi, con le solidarietà di corto raggio che essi generano, hanno creato nel Mezzogiorno un tale ammontare di capitale sociale di tipo bonding che ha finito con il soffocare la costituzione degli altri due tipi, aggravando i problemi di governance delle società locali. Ben l’aveva compreso, con grande anticipo sui tempi, Antonio Genovesi quando, nel suo Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze del 1754, nell’occasione della prolusione per l’apertura del nuovo anno accademico dell’Università di Napoli, si chiese perché Napoli, pur essendo adeguatamente popolata, ben localizzata rispetto alle esigenze dei traffici commerciali, assai dotata di intelletti e di ingegni vari, non fosse una ‘nazione’ sviluppata al pari delle altre nazioni del Nord Europa. La ragione, secondo il fondatore dell’economia civile, era che Napoli difettava «dell’amore per il bene pubblico», non di capitale naturale.
Il sostegno primiero – scrive – e il più grande delle civili società, è l’amore del bene pubblico, che può preservare quelle società nello stesso modo in cui le ha fatte. Le società dove l’interesse privato regna e prevale, dove nessuno dei suoi membri è toccato dall’amore del bene pubblico, non solo non possono raggiungere ricchezza e potenza, ma se anche li hanno raggiunti, sono incapaci di mantenere questa posizione» (p. 8).
Il bene pubblico di cui parla Genovesi corrisponde al bene comune come qui inteso.
Come ci informa Emanuele Felice (2013), le prime stime del capitale sociale italiano risalgono al 1871 e già evidenziano una marcata divaricazione tra Nord e Sud: fatta 100 la media italiana, il Nord-Ovest aveva 126; il Nord-Est-Centro 117; il Mezzogiorno 67. Nel 2001 il Nord-Est-Centro si era portato a 119; il Nord-Ovest a 108; il Sud a 73. Si noti però che l’Abruzzo è passato da 42 a 103; la Sardegna da 69 a 109; la Basilicata da 45 a 83: quanto a dire che i divari nella dotazione di capitale sociale si possono colmare ma possono anche aumentare come è successo in Campania, Sicilia e Calabria. A scanso di equivoci giova osservare che il medesimo fenomeno affligge anche le regioni del Centro-Nord, sebbene con ben altra intensità (si rinvia a Sabatini 2009 e Cartocci 2007 per una puntuale analisi dei nessi tra capitale sociale bonding e bridging nelle diverse regioni italiane, per un verso, e tra eccessivo capitale sociale bonding e livelli di benessere, per l’altro verso). È in ciò il problema italiano. Non è certo la carenza di capitale umano, né di capitale fisico a impedire al nostro Paese di realizzare il suo straordinario potenziale. Sono piuttosto la separazione di società civile e società politica, per un verso, e la non sufficiente dotazione di fiducia generalizzata, per l’altro, a costituire la vera strozzatura dell’Italia, che aggrava inesorabilmente i problemi di governance della società. Questa strozzatura si fa maggiormente sentire in tre ambiti che a noi paiono più critici.
Il primo è quello che concerne la difficoltà a dare vita a un modello di welfare che sia compatibile con le esigenze di sviluppo del Paese. Il welfare italiano è rimasto ancora un modello di vecchio stampo, cioè risarcitorio: un modello che mira unicamente a migliorare le condizioni di vita dei gruppi maggiormente nel bisogno. Si spendono risorse, anche ingenti, per i poveri e gli emarginati, ma queste risultano scarsamente efficaci, perché si continua a seguire un approccio decontestualizzato. Ma ormai sappiamo che quel che occorre è un welfare generativo, che incida sulle ‘capacitazioni di vita’ dei portatori di bisogni. E senza capitale sociale di tipo linking ciò non può essere realizzato.
Il secondo ambito richiede una considerazione. L’Italia possiede un capitale umano di tutto rispetto; istituzioni di ricerca universitaria di buon livello; un mondo imprenditoriale vivace. Eppure, università, imprese, enti locali non riescono a creare sinergie dando vita a fondazioni di sviluppo, oppure a distretti industriali di nuova generazione e a distretti culturali evoluti. La diffidenza reciproca – cioè la mancanza di fiducia – che regna tra i vertici del triangolo indicato non consente di generare percorsi virtuosi di sviluppo – che pure sarebbero a portata di mano. Un indicatore parziale, ma eloquente, delle implicazioni di tale carenza è il notevole divario territoriale nei tassi di attivazione imprenditoriale. L’esigua creazione di nuove imprese nel Mezzogiorno è causa ed effetto, a un tempo, del modesto livello di capitale sociale bridging (Iacobucci, Micozzi 2014).
Il terzo ambito riguarda la mancanza di un ethos condiviso che condanna l’Italia al ‘corto-termismo’ – come sopra si diceva. Per sapere dove andare occorre conoscere il fine cui tendere. Ma il fine non può deciderlo la politica da sola: essa è piuttosto chiamata a servirlo. Né può fissarlo una élite di intellettuali oppure un’oligarchia detentrice del potere economico-finanziario. È la democrazia deliberativa il luogo dove società politica, società civile, società commerciale possono arrivare a convergere sulla definizione di un condiviso sentiero di sviluppo.
Se le cose stanno in questi termini, chi tra i primi deve cercare di rompere questa sorta di circolo vizioso per accrescere la dotazione del capitale sociale di tipo bridging e soprattutto linking? La nostra risposta è netta: i soggetti imprenditoriali, privati e sociali. Si badi: non solo imprese private ma anche e soprattutto imprese sociali. Quale la ratio di tale affermazione? È noto da tempo che la vasta letteratura sul capitale sociale, mentre è prodiga di informazioni sugli elementi costitutivi dello stesso, sulla sua tipologia, sugli effetti positivi che esso genera (in termini di livello di benessere della popolazione, di rendimenti delle politiche pubbliche ecc.), è pressoché silente su cosa fare per accrescerne la dotazione. Insomma, c’è tantissima diagnostica e pochissima terapeutica. Parecchie le ragioni di tale sconsolante stato di cose. La più ovvia è che è più facile e assai meno rischioso svolgere analisi ed esprimere desiderata che non adoperarsi per suggerire progetti che siano fattibili e implementabili. Una seconda ragione dell’inerzia tuttora imperante è quella che chiama in causa il tipo di sguardo con cui si scruta la realtà, considerato che una teoria altro non è, forse, che un particolare sguardo sulla realtà. Fino a tempi recentissimi è prevalso nella ricerca lo sguardo ‘domandista’ (Azzolina 2013). Si tratta di questo: una bassa dotazione di capitale sociale di tipo bridging e linking condiziona negativamente l’efficacia delle politiche pubbliche e causa scarsi rendimenti istituzionali perché il basso livello di civicness allontana i cittadini dalla partecipazione attiva alla vita pubblica e, in particolare, non li addestra all’uso dell’opzione voice (nel senso inteso dall’economista Albert O. Hirschman).
D’altro canto, un tale stato di cose ha determinanti e radici di lunga data, come detto più su, e pertanto sarebbe vano sperare in mutamenti radicali nella prospettiva del breve e medio termine. Il capitale civico, definito da Luigi Guiso, Paola Sapienza, Luigi Zingales (2011) come quel capitale sociale che risulta dall’insieme di credenze e di norme culturali condivise che valgono a risolvere i tanti problemi di azione collettiva, è persistente perché i modi della sua trasmissione, per via familiare o educativa, richiedono tanto tempo. Ne consegue che le comunità che, per un qualche accidente storico, hanno avuto la fortuna di partire da un’alta dotazione di capitale civico riescono a conservare nel tempo un vantaggio comparato nei confronti delle altre comunità. È dall’approccio domandista che deriva quel certo conservatorismo, figlio della rassegnazione, che sempre si impossessa di quei luoghi dove le ‘passioni tristi’, su cui ha elegantemente scritto Baruch Spinoza, ‘la fanno da padrone’.
Fortunatamente, però, c’è anche lo sguardo ‘offertista’, uno sguardo che si avvale del seguente schema di pensiero. Poiché è assai più agevole e più rapido puntare sul cambiamento della classe dirigente (economica e politica) che non sul mutamento delle mappe cognitive dei cittadini, saggezza e ragionevolezza suggeriscono di intervenire prioritariamente su un duplice fronte. Per un verso, sull’assetto di governo, cioè sul capitale istituzionale che è compito primario della classe politica sforzarsi di mutare. Come ha documentato Salvatore Vassallo (2013), a parità di cultura civica il disegno istituzionale influenza significativamente i rendimenti delle politiche pubbliche; quanto a dire che il capitale istituzionale svolge un ruolo autonomo rispetto al capitale sociale. Per l’altro verso, occorre dare ali alla classe imprenditoriale (privata e sociale) che, sia pure in percentuali diverse, esiste in ogni territorio, quanto meno allo stato potenziale. La storia insegna che i cambiamenti strutturali sono sempre stati innescati da minoranze profetiche che, in presenza di condizioni favorevoli, sono riuscite a portare la comunità di cui sono parte nelle vicinanze della massa critica, oltre la quale il sistema converge, per via endogena, all’equilibrio superiore. Quali sono queste condizioni favorevoli? Che si riescano a mantenere entro i limiti della decenza civile i due vizi capitali che impediscono ogni processo di autentico sviluppo: il burocraticismo e la rendita parassitaria. Ricordiamo a questo proposito il monito di David Ricardo: mai potrà aversi sviluppo duraturo laddove la quota della rendita sul prodotto nazionale supera il 15% circa. In Italia, siamo oggi a circa il 30%. Come ampiamente documentato da Daron Acemoglu e James Robinson (Why nations fail, 2012), sono questi due nemici del capitale civile a determinare la prevalenza delle istituzioni estrattive su quelle inclusive e perciò a impedire lo sviluppo: mai potrà avviarsi un qualche processo di sviluppo laddove le istituzioni sono progettate per premiare l’immobilismo.
Come si diceva, il secondo pilastro del capitale civile è il capitale istituzionale, cioè l’assetto di istituzioni, sia politiche sia economiche, prevalente in un Paese o in una regione. È oggi riconosciuto che è la diversa qualità del capitale istituzionale a determinare, in gran parte, le differenze di performance economica di Paesi pur caratterizzati da dotazioni sostanzialmente simili di capitale fisico e di capitale umano. In altri termini, senza nulla togliere alla perdurante importanza dei fattori geografico-naturali e di quelli fisici, è un fatto che l’assetto istituzionale di un Paese è, oggi, l’elemento che più di ogni altro spiega la qualità e l’intensità del processo di sviluppo di una determinata comunità. L’esempio più rilevante di istituzione politica è costituito dal modello di democrazia in atto in un determinato Paese: elitistico-competitivo, oppure populistico, oppure comunitarista, oppure deliberativo. Ebbene, con riferimento all’attuale passaggio d’epoca, il modello elitistico-competitivo di democrazia (la cui teorizzazione è associata ai nomi di Max Weber e Joseph Schumpeter) non è più in grado di assicurare elevati tassi di progresso e di dilatare gli spazi di libertà dei cittadini. È piuttosto il modello deliberativo di democrazia la meta verso cui tendere se si vuole che lo stock di capitale civile di un territorio abbia ad accrescersi.
Invero, la democrazia non può consistere solo nei meccanismi della rappresentanza e della tutela degli interessi. La vita democratica non riguarda solo le procedure ma la definizione di uno spazio aperto di garanzie e di diritti perchè ciò che non passa dalla politica non sia ridotto al rango di residuo o a qualcosa che tutt’al più può venire tollerato. E ciò per la fondamentale ragione che la società non è l’oggetto della politica; è piuttosto il fine che la politica, col suo organo principale che è lo Stato, deve servire. Il principio democratico – come si sa – si regge su due pilastri fondamentali. Il primo presuppone che tutti coloro i quali vengono direttamente o indirettamente influenzati da una decisione politica possano, almeno in una qualche misura, concorrere a determinarne i contenuti. Il secondo prevede, a sua volta, che coloro i quali hanno acquisito per via elettorale il potere di prendere decisioni, siano ritenuti responsabili delle conseguenze che ne discendono, rispondendone ai cittadini – è il cosiddetto principio dell’imputabilità personale dell’agire politico.
Quando in un determinato territorio le istituzioni politiche, per il modo in cui sono state disegnate, non riescono a dare ali ai due pilastri del principio democratico, quel che accade è una decumulazione del capitale istituzionale di quel territorio e perciò una riduzione delle sue possibilità di sviluppo. Si rifletta sul significato di quel fenomeno, così ampiamente diffuso nella prassi dell’agire politico, noto come ‘corto-termismo’ (short-termism). I partiti politici predispongono la propria piattaforma elettorale pensando alle elezioni successive e non agli interessi delle generazioni future. È questa, infatti, la strategia da seguire per sperare di vincere nella competizione elettorale. Ma la politica democratica è la visione degli interessi lontani. La responsabilità verso le generazioni future è questione che, soprattutto nella stagione attuale, non può essere elusa. La natura di gran parte delle questioni rilevanti in ambito sia sociale sia economico è oggi tale che le decisioni prese dai governi sulla base di un orizzonte temporale di breve periodo generano quasi sempre effetti negativi di lungo periodo, che si ripercuotono sulle generazioni future, alle quali però essi non rispondono elettoralmente (viene così a crollare il principio di imputabilità).
Crea un problema dunque la discrasia crescente tra assetti politici pensati per il breve periodo e le conseguenze derivanti da quegli assetti. L’argomento (tornato oggi di moda sull’onda di spinte di matrice populistica) secondo cui il politico non deve guidare il popolo ma deve essere guidato dall’opinione e dalle preferenze del popolo è privo di solido fondamento quando si consideri che il popolo dice ciò che vuole per l’oggi, non ciò che vuole per il domani. Di qui la miopia di cui sembra soffrire la gran parte delle scelte politiche. Di qui anche il paradosso per cui i contenuti dei programmi elettorali diventano sempre più generici, mentre sempre più spazio d’azione ottengono gli esperti nelle tecniche di persuasione usate per catturare, e spesso per manipolare, le preferenze degli elettori. È la deriva ‘economicistica’ della concezione della cittadinanza, a sua volta legata al dominio delle lobby economiche, a far sì che i cittadini siano indotti a svolgere un ruolo passivo nel processo democratico, in cui il dibattito elettorale è controllato da professionisti esperti.
Ma vi è di più. Nella esperienza italiana duplice è stato il ruolo svolto dall’élite politica soprattutto del Mezzogiorno: per un verso, essa si adopera per contrastare politiche significative di redistribuzione del reddito (e della ricchezza) con l’argomento di favorire il tasso di investimento; per l’altro verso, essa cerca di assicurarsi il mantenimento delle posizioni acquisite di rendita mediante l’erezione di barriere all’entrata, così da ostacolare l’ingresso nel mercato di potenziali entranti. Vi è a tale riguardo una specificità tutta italiana che vale la pena porre in luce. Contrariamente a quanto sostenuto nella letteratura sul federalismo fiscale secondo cui il decentramento politico, e non già il decentramento amministrativo, migliorerebbe la performance economica dei territori ai quali si applica, Luciano Mauro, Francesco Pigliaru e Gaetano Carmeci (2014) mostrano che le cose non stanno sempre in questi termini. Ciò in quanto i tratti caratteristici del capitale civile della popolazione possono influenzare il funzionamento delle istituzioni locali a tal punto da peggiorarne la performance. L’aveva ben compreso Edward C. Banfield quando nel suo celebre saggio scrisse:
In una società di familisti amorali vi saranno sempre pochi controlli sui burocrati, dal momento che il controllo su questi è sempre affidato ad altri burocrati solamente» (The moral basis of a backward society, 1958; trad. it. 1976, p. 45).
È agevole darsene conto. Quando lo stock di capitale civile è elevato, i cittadini sono più coinvolti nella partecipazione alla vita comunitaria, così che le autorità di governo locale si sentono monitorate e dunque si trattengono da pratiche di rent-seeking e di corruzione. Non solo, ma dove è alto il capitale civile, le preferenze politiche dei residenti tendono a privilegiare linee di policy che beneficiano tutta la popolazione piuttosto che quelle che favoriscono alcuni gruppi a spese di altri. Il contrario è vero quando il capitale civile si mantiene a bassi livelli. In situazioni del genere, il decentramento politico, trasferendo poteri e competenze dal livello centrale a quello regionale, non fa altro che accrescere i differenziali di sviluppo tra le regioni. Il che è proprio quanto è accaduto in Italia, come l’accurata indagine empirica di cui sopra conferma a tutto tondo. È questo un risultato importante che già Tommaso Nannicini, Andrea Stella, Guido Tabellini (2013) avevano trovato, sia pure per altra via, e che è stato ulteriormente confermato nello studio di Giacomo Ponzetto e Ugo Troiano (2014).
L’implicazione pratica che si trae da risultati del genere è che non è affatto sufficiente che la politica nazionale si adoperi per approvare leggi contro la corruzione e l’opportunismo dei burocrati senza pensare a come allocare l’autorità tra i diversi livelli di governo tenendo conto delle specificità del capitale civile delle singole realtà territoriali. Quello di Guido De Blasio e Giorgio Nuzzo (2010) è un’importante studio che conferma quanto ora asserito. Un punto, in particolare, merita attenzione: la relazione tra capitale civile, nelle sue due componenti di capitale sociale e istituzionale, e disuguaglianze nella distribuzione dei redditi. Si trova che a più alti livelli di capitale civile si associano assetti distributivi meno diseguali e pertanto più favorevoli allo sviluppo.
La terza componente essenziale del capitale civile è il capitale culturale, inteso quale insieme di credenze, tradizioni, costumi, valori condivisi che governano le interazioni tra individui e tra gruppi sociali. In quanto deputata a fissare l’identità di un popolo o di una comunità e a conservarne le caratteristiche di differenziazione da altri, la cultura è una variabile endogena determinata da fattori quali la storia, la geografia, la tecnologia. La matrice culturale non va confusa con la conoscenza, perché non viene scoperta empiricamente, né è dimostrabile analiticamente. Pure le istituzioni (politiche ed economiche) sono una variabile endogena e dunque il problema fondamentale, ancora lungi dall’essere risolto, è quello di stabilire se è il mutamento istituzionale a ‘nutrire’ la matrice culturale di una comunità, oppure se è vero il contrario. Purtroppo, non disponiamo ancora di una teoria in grado di dirci quale delle due entità si muove più lentamente nel tempo e quale delle due risulta più resiliente. Tuttavia quel che sappiamo è che il capitale culturale (Throsby 1999) ha a che fare con gli aspetti spirituali e relazionali della condotta umana – la quale è, in essenza, il comportamento umano più le sue motivazioni. In quanto tale, la cultura mira all’educazione della mente, e alla costruzione del carattere, piuttosto che all’acquisizione di abilità professionali e tecniche: a queste ultime provvedono, infatti, l’istruzione e la formazione. Come tutti i tipi di capitale, anche quello culturale è una grandezza di stock, dalla quale derivano flussi di beni e servizi dotati di valore. Trattandosi di uno stock, il capitale culturale si accumula per mezzo di investimenti specifici e si decumula se non si provvede alla bisogna in misura adeguata. Va ricordato che duplice è il tratto caratterizzante il capitale culturale. Per un verso, la creatività: occorre, cioè, ‘inventare’ qualcosa di nuovo e non solamente innovare (l’innovazione consegue all’invenzione, non viceversa). Per l’altro verso, il simbolismo: la cultura autentica riveste sempre un significato simbolico, comunicabile virtualmente a tutti e non solo alla cerchia di coloro che l’hanno posta in essere.
Si noti ora l’incongruenza. Mentre ai primi due pilastri del capitale civile, ossia quello sociale strutturale e quello istituzionale, sono state e continuano a essere dedicate attenzioni e risorse crescenti da parte sia degli studiosi sia delle pubbliche autorità – il che è certamente positivo – alla componente del capitale culturale vengono riservate ben più modeste e sporadiche attenzioni. Come dare conto di questo generalizzato disinteresse? Una prima ragione è che ancora diffusa nella mentalità corrente è l’idea secondo cui il capitale culturale sarebbe una sorta di dato di natura che, tutt’al più, deve essere ben conservato, qualcosa cioè di intrinseco alla costituzione morale degli individui che vivono in una certa regione. Si tratta di un’idea non solo errata, ma tendenzialmente pericolosa. (Si pensi a Fichte che definiva i tedeschi come ‘il popolo dello spirito’). Il fatto è che la matrice culturale ha bisogno, strutturalmente, di manifestarsi nelle costituzioni, nelle imprese, nel modo in cui si organizzano i mercati e di solidificarsi poi in istituzioni.
Una seconda ragione ha a che vedere con il fatto che non disponiamo ancora di una metrica condivisa per misurare il capitale culturale. Come noto, i nostri sistemi di contabilità nazionale continuano a essere focalizzati sul PIL, il reddito prodotto sull’arco temporale dell’anno. Ora, mentre il reddito è una grandezza di flusso, la ricchezza è una grandezza di stock. In condizioni di stato stazionario – insegna la teoria economica – la misurazione in termini di flusso e quella in termini di stock condurrebbe al medesimo risultato per quanto attiene la misurazione del capitale culturale. Ma fuori dello stato stazionario si ha che, mentre il capitale culturale concorre ad accrescere la ricchezza del Paese (o della regione), non altrettanto accade, necessariamente, al reddito. Di qui l’incongruenza anzidetta. Eppure l’inclusione culturale non è meno importante di quella sociale e di quella economica. È ormai acquisito che valori e disposizioni d’animo quali la propensione al rischio, l’imprenditorialità, la concezione del lavoro, la fiducia, la reciprocità – ingredienti, questi, tutti indispensabili al buon funzionamento di un’economia di mercato – sono strettamente correlati alla cultura prevalente in un determinato ambiente. Si osservi che, al contrario di quanto suggerisce Putnam, le culture non sono sistemi sostanzialmente statici e dipendenti dalla tradizione. Piuttosto sono sistemi plastici capaci di adattarsi ai mutamenti ambientali e, al tempo stesso, di far retroagire sulla società le proprie nuove configurazioni. È questa la proprietà morfogenetica della cultura di cui parla Margaret Archer (1995).
L’interrogativo che a questo punto spontaneamente sorge è: quale strategia una comunità (o una società) deve adottare per favorire l’accumulazione del suo capitale civile? La proposta di Luis Roniger (La fiducia nelle società moderne, 1992) è quella di concentrare la fiducia attorno a specifiche esperienze e attori sociali. È questo il cosiddetto processo di focusing, il cui scopo fondamentale è quello di permettere che i due elementi base della fiducia – e cioè il mutuo riconoscimento delle identità e l’impegno a non ingannare né a tradire – possano svilupparsi come doni gratuiti quando tale processo ha inizio. Si consideri, per es., una cooperativa o un’organizzazione non-profit; nel momento stesso in cui i soggetti decidono di farne parte essi accettano, almeno tacitamente, le norme sociali di comportamento, e così facendo sviluppano una disposizione interiore a rispettare gli accordi. In questo modo essi accrescono la capacità dell’organizzazione di produrre fiducia. Col tempo, il processo di focusing dovrebbe tendere a portare alla ‘fiducia generalizzata’, basata su immagini di credibilità più impersonale, segnando così il passaggio da una fiducia interpersonale a una fiducia istituzionale. Se questo non dovesse accadere, allora il risultato finale sarà l’affermazione del localismo: la costituzione di piccoli gruppi autoreferenziali e la predominanza degli interessi corporativi su quelli generali con il conseguente inevitabile disordine sociale. Ma come fare allora per giungere alla fiducia generalizzata?
La nostra risposta è di incoraggiare, intervenendo sul disegno istituzionale della società, l’emergenza di uno spazio economico in cui possano liberamente esprimersi tutti quei soggetti che pongono nel principio di reciprocità il fondamento del loro agire. La ragione di ciò è che l’economia civile non può prescindere dalla reciprocità, la quale è al centro del processo di generazione della fiducia. Solo chi pratica la reciprocità merita e riceve fiducia, come l’ampia evidenza sperimentale prodotta dall’economia comportamentale nell’ultimo ventennio documenta appieno. Non così l’opportunista. Al tempo stesso, l’homo reciprocans, non certo l’homo oeconomicus, tende a dare fiducia. Due osservazioni al riguardo. In primo luogo, è importante non confondere la fiducia con la reputazione. Mentre quest’ultima è un bene patrimoniale, tanto che le persone possono effettuare investimenti specifici in reputazione, la fiducia è piuttosto una relazione tra persone. È certamente vero che vi sono parecchi sostituti imperfetti della fiducia: la reputazione è uno di questi, così come lo sono l’assicurazione, il monitoraggio, gli incentivi, i contenziosi. Tuttavia, mai si dovrebbe dimenticare che solo in casi particolari la paura di un qualche danno al proprio capitale reputazionale può indurre agenti economici totalmente autointeressati a comportarsi come se fossero degni di fiducia.
La seconda osservazione riguarda il contenuto del principio di reciprocità. Come suggerisce Serge C. Kolm (Reciprocity. An economics of social relations, 2008), la relazione di reciprocità può essere visualizzata come una serie di trasferimenti bidirezionali indipendenti l’uno dall’altro, sebbene interconnessi. L’indipendenza implica che ogni trasferimento è in se stesso volontario, il che significa che nessun trasferimento costituisce un prerequisito per il verificarsi dell’altro, così come non c’è alcuna forma di obbligazione esterna nella mente dell’agente che effettua il trasferimento. Questo elemento distingue la reciprocità dal più comune scambio di equivalenti, che è anch’esso un insieme di trasferimenti volontari e bidirezionali, in cui tuttavia ogni trasferimento costituisce il prerequisito per l’altro, tanto che la legge può sempre intervenire per obbligare le parti al rispetto delle obbligazioni contrattuali. Non è questo il caso della reciprocità. In questo senso, c’è più ‘libertà’ nella reciprocità che nello scambio di equivalenti. Invero, è questo il punto cruciale: la relazione di reciprocità non è diversa dal comune scambio di mercato solo perché è diversa la specificazione del rapporto di scambio, cioè del prezzo; essa è diversa perché gli agenti non sono motivati all’azione dall’aspettativa di un segnale di prezzo. Il fatto che, ex post, si stabilisca un qualche grado di bilanciamento tra ciò che si è dato e ciò che si è ricevuto è solo un vincolo di fattibilità; il prezzo relativo che si stabilisce ex post è rilevante solo dal punto di vista contabile, ma non come base per la spiegazione del comportamento degli agenti. D’altra parte, la reciprocità va tenuta distinta dal puro altruismo o dalla filantropia, che si esprimono in trasferimenti isolati e unidirezionali. In buona sostanza, la reciprocità si colloca in una posizione per così dire intermedia tra lo scambio di equivalenti e l’altruismo puro.
Queste osservazioni permettono di capire perché, a differenza dello scambio di equivalenti e dell’altruismo, la reciprocità non può essere spiegata nei termini di una scelta da parte dell’individuo intesa a massimizzare la sua propria funzione di utilità, e questo anche qualora il dominio della funzione di utilità venisse adeguatamente espanso per tenere conto dell’interesse dell’altro. Sia le disposizioni interiori sia la relazionalità sono elementi costitutivi del concetto di reciprocità. Ciò che è in gioco nella relazione di reciprocità non è semplicemente l’avere o il ricevere (o il dare) ma anche l’essere – la dimensione ‘dell’essere con’. In quanto tale, la reciprocità è assai più di un possibile strumento per evitare alcune tipologie di fallimenti di mercato; essa è piuttosto una modalità per promuovere livelli di interazione sociale che non possono essere realizzati dagli usuali scambi di mercato, perché la natura profit-oriented oppure utility-oriented di questi ultimi tende a spiazzare le motivazioni intrinseche che stanno alla base delle interazioni sociali.
Ecco perché la reciprocità non è una risorsa scarsa che in quanto tale va risparmiata; piuttosto, essa è una virtù civica nel senso attribuito a questo termine dalla tradizione di pensiero degli umanisti civili. Come Aristotele ci ricorda, è assai probabile che lo ‘stock’ di reciprocità venga incrementato dall’uso frequente che se ne fa, piuttosto che essere consumato. Nella sua Etica, egli ci ricorda che le virtù non sono né innate né contrarie alla natura. Esse vengono in esistenza perché dalla natura siamo predisposti a riceverle, ma siamo noi a perfezionarle e a espanderle attraverso l’esercizio sistematico e la creazione di apposite strutture economiche.
Alla luce di quanto precede, si comprende perché un Paese o una regione che voglia progredire deve saper bilanciare in modo armonico le istituzioni economiche che presuppongono il solo self-interest e quelle che invece si fondano sulla reciprocità. Eppure così non è stato e non è tuttora, perchè le organizzazioni improntate al self-interest hanno assai più peso, nel nostro Paese delle altre. Tale squilibrio, va urgentemente corretto se si vuole seriamente superare il perdurante dualismo italiano tra Centro-Nord e Sud. Si consideri che il meccanismo di mercato offre agli agenti incentivi diversamente potenti per consentire loro di agire sulla base delle loro preferenze (per es., esso non incentiva affatto chi intende agire sulla base di preferenze relazionali o sociali). Ecco perché è necessario che l’assetto istituzionale della società non penalizzi quei soggetti i cui sistemi di valore sono avversi all’individualismo libertario – come oggi invece avviene. Si osservi che questo è quanto è esigito dal principio di libertà positiva, – la libertà di – secondo cui un ordine sociale accettabile è quello che tratta in maniera imparziale le aspirazioni e i progetti di vita di tutti i suoi membri, ai quali non può essere imposto, de facto, di accogliere determinate disposizioni comportamentali. Ma soprattutto è esigito dalla considerazione che l’evoluzione sociale è sempre favorevolmente influenzata dalla presenza di regole diverse a presidio del funzionamento dei vari ambiti economici vale a dire della biodiversità delle regole. Infatti, il celebrato principio ricardiano del vantaggio comparato si applica non solo alla sfera della produzione dei beni e dei servizi ma anche a quella delle istituzioni economiche.
Cenni storici sulle forme di solidarietà organizzata
L’esperienza storica italiana delle organizzazioni della società civile che ancora oggi chiamiamo convenzionalmente terzo settore è illuminante per comprendere quanto detto. Nei lustri immediatamente precedenti la creazione del Regno d’Italia la prospettiva dell’economia civile conosce un particolare momento di fervore, e nel campo degli studi una concezione integrata dello sviluppo connessa alla nozione di utilità pubblica e a forti preoccupazioni di giustizia sociale pare diffondersi soprattutto in circuiti meridionali, «forse perché Iddio manda i panni secondo il freddo», come ironicamente notato nel 1836 negli Annali universali di statistica (cfr. E. Di Ciommo, I confini dell’identità. Teorie e modelli di nazione in Italia, 2005, pp. 52-54). Alla nascita dello Stato unitario (1861) vi era nel nostro Paese una gran varietà di ‘istituzioni di carità’ ovvero di ‘opere pie’ come vennero chiamate nella l. 3 ag. 1862 nr. 753, che recepì nella sostanza la legge piemontese di tre anni prima (la cosiddetta legge Rattazzi). Secondo un’inchiesta dell’epoca, il numero delle stesse era stimato in 20.123 unità, in gran parte localizzate nelle regioni del Nord e in alcune aree del Centro. La legge in questione, di stampo liberale, tratteggiò una disciplina rispettosa dell’autonomia di tali enti, tesa a favorirne lo stretto collegamento con le istituzioni locali, riconoscendone la rilevante funzione in ordine alla tutela dei diritti sociali in generale e nella lotta al pauperismo in particolare.
La successiva legge Crispi del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficienza modifica parzialmente questa tendenza, mirando ad accrescere la rilevanza della mano pubblica nel settore dell’assistenza e beneficenza, e a predisporre al contempo gli strumenti di forme di controllo e disciplina uniforme degli enti privati. In ogni caso, in tutto questo periodo resta forte la vitalità della società civile organizzata che nella sua forza espressiva non incontra ostacoli rilevanti a opera dello Stato unitario, sebbene debba misurarsi con un crescente attivismo delle istituzioni pubbliche, in coerenza con una concezione che ritiene il perseguimento del benessere dei consociati compito fondamentale e pressoché esclusivo dello Stato. La riforma crispina, pur attenta in certa misura al ruolo delle forme organizzate di solidarietà, col calcare la mano sulla leva del coordinamento pubblico accentua significativamente quei tratti di ‘istituzionalizzazione del terzo settore’ che acute riletture storiografiche evidenziano quale profilo caratterizzante dell’esperienza italiana.
La situazione muta radicalmente con l’avvento del fascismo e soprattutto con la realizzazione dell’ordinamento corporativo, che inaugura una stagione di aperta ostilità tra Stato e organizzazioni sociali: queste vengono private della loro natura e inquadrate in enti pubblici che ne snaturano l’essenza e il ruolo. Le commissioni provinciali di assistenza e beneficenza, insieme al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza, vennero soppressi già nel 1923, mentre nel 1937 si provvide alla soppressione delle congregazioni di carità e alla loro sostituzione con enti comunali di assistenza. A ciò si aggiungano i noti provvedimenti relativi alle altre articolazioni della società civile organizzata, dalle associazioni ai sindacati, a conferma di come l’ordinamento sociale realizzato dal fascismo tendesse ad attribuire allo Stato stesso il monopolio della cura dei diritti delle persone, con la conseguenza che là dove lo Stato non arrivava, la persona rimaneva priva di qualsiasi forma di tutela. Più in generale la cultura del Ventennio tendeva ad affermare la pervasività del pubblico su ogni forma di autonomia privata, operazione funzionale all’affermazione del primato della politica e del suo condottiero su ogni forma di iniziativa sociale.
Ed è proprio sulla volontà di chiudere tale esperienza e di voltare radicalmente pagina che si fondano le scelte dell’Assemblea costituente, chiamata negli anni 1946-47 a elaborare il testo della nuova Costituzione. Il principio del pluralismo sociale è posto tra i principi fondamentali: anzi è inserito in quell’articolo 2 che secondo uno dei suoi padri, Giorgio La Pira, costituisce la ‘pietra angolare’ della nuova Costituzione. Con esso, nonchè con numerose disposizioni successive, si è affermata la piena autonomia delle formazioni sociali, riconoscendone la funzione sussidiaria nella tutela di alcuni diritti fondamentali (si pensi per es. all’assistenza sociale di cui all’art. 38). L’atteggiamento di grande rispetto dell’autonomia privata si è tradotto nella preoccupazione che un intervento legislativo potesse limitare tale autonomia, fino a suggerire un atteggiamento di astensione totale da ogni forma di regolamentazione: così da far ritenere la garanzia del pluralismo sociale, intesa nel senso della sua stessa esistenza, inscindibilmente connessa alla sua libertà (di organizzarsi secondo regole non imposte dall’esterno, di operare secondo linee di azione non imposte o vincolate, di regolare i rapporti interni mediante norme di autonomia). Da ciò l’ovvia conseguenza in favore della scelta di una disciplina di tipo privatistico e non pubblicistico, per la preoccupazione che una disciplina pubblicistica potesse agire in funzione limitatrice di quella libertà: il rovesciamento rispetto all’esperienza fascista e alla sua regolamentazione delle corporazioni non poteva essere più netto ed evidente.
A tale atteggiamento ha fatto riscontro un crescente interventismo dei soggetti pubblici (oltre a Stato e comuni, storicamente presenti nel panorama istituzionale italiano, con l’avvento della Costituzione repubblicana è venuto crescendo anche il peso delle regioni) nella tutela dei diritti, e in specie di quelli sociali, tradizionalmente più protetti dai soggetti del terzo settore. Tale interventismo si è tradotto in una crescente assunzione di responsabilità diretta da parte pubblica nella gestione ed erogazione di servizi alla persona, riservando ai soggetti privati una funzione complementare e di integrazione. Eppure, già nel 1948 Lord Beveridge – l’artefice del welfare state inglese – scriveva in Voluntary action:
La formazione di una buona società dipende non dallo Stato, ma dai cittadini che agiscono individualmente o in libere associazioni. La felicità della società in cui viviamo dipende da noi stessi quali cittadini, non dallo strumento del potere politico che chiamiamo Stato. Lo Stato deve incoraggiare l’azione volontaria di ogni specie per il progresso sociale» (trad. it. 1954, p. 48).
Questa situazione, che ha caratterizzato grosso modo la prima fase di attuazione della Costituzione, è venuta modificandosi a partire dalla fine degli anni Ottanta, che hanno visto crescere la funzione di cura di interessi generali svolta da soggetti privati non lucrativi, in una linea generale di tendenza che ha indotto a ripensare le tradizionali categorie del ‘pubblico’ e del ‘privato’ nella tutela di alcuni diritti fondamentali. Fino al decennio precedente consistenza e diffusione delle istituzioni non-profit paiono contenute, caratterizzate in prevalenza dalla matrice religiosa, e circoscritte territorialmente (soprattutto nelle aree più povere del Settentrione: è il caso del Veneto, a cui si riferisce E. Speranzini, Le organizzazioni della società civile in Italia: un profilo storico-economico, in Il non profit italiano al bivio, a cura di S. Zamagni, 2002, pp. 33-63). Ancora negli anni Settanta – ovvero un periodo di pervasività vistosa del modello dello Stato sociale – paiono quasi assenti dall’orizzonte culturale e operativo di queste organizzazioni sia il concetto sia le pratiche di orientamento al mercato: piuttosto emerge un dato di specularità/complementarietà rispetto alla crescita dei finanziamenti pubblici, specie in campo assistenziale. Fino a creare (come rileva ancora Speranzini) «a partire dagli anni Ottanta un forte collateralismo tra esperienze di economia sociale e partiti politici» (p. 40). Accanto a questo, si avvia un’evoluzione progressiva di associazioni prima basate sul mero ideale volontaristico verso la forma cooperativa, particolarmente acconcia all’erogazione di servizi sociali che spesso sono oggetto di affidamenti diretti da parte delle pubbliche amministrazioni. Si costituisce in questo periodo quasi un quarto delle istituzioni non-profit censite in Italia all’inizio del nuovo secolo. Ma sempre in tale periodo si registra l’esplosione di problemi notevoli sul versante dell’efficienza e dell’efficacia dell’offerta istituzionale di welfare, e questi fenomeni innescano una ricalibratura delle aspettative già ascritte alla mano pubblica, e inducono i diversi attori in campo a un ripensamento dei rapporti tra le amministrazioni in questione e le organizzazioni della società civile.
Questo risultato viene verosimilmente condizionato dalla rimodulazione dei sistemi di welfare state conseguente alle minori risorse economiche disponibili: ma certamente esso è stato il frutto anche di un mutamento connesso a una valutazione di qualità nell’erogazione dei servizi e anche a motivazioni tendenti a valorizzare la relazionalità, specie nel rapporto di cura e di assistenza. Siffatta evoluzione ha condotto a un cambiamento nell’atteggiamento del legislatore nei confronti dei soggetti del terzo settore, realizzatosi soprattutto a partire dall’inizio degli anni Novanta, sia mediante la regolamentazione in via legislativa di alcuni ‘segmenti’ del terzo settore (organizzazioni non governative, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali), sia attraverso il crescente coinvolgimento di essi in attività e servizi svolti dagli enti pubblici. Questa fase è proseguita per tutto l’ultimo scorcio del secolo scorso – in cui si registra la crescita tumultuosa di tutte le tipologie di istituzioni della società civile, fino a mostrare la necessità di funzioni di coordinamento e di rappresentanza prima ritenute poco rilevanti: nel 1997 nasce ufficialmente come associazione di terzo livello il Forum permanente del terzo settore. Tale evoluzione ha poi trovato riconoscimento e insieme nuovo slancio prospettico tramite l’introduzione nel testo costituzionale del principio di sussidiarietà, come sancito nel novellato art. 118, ultimo comma della Costituzione, introdotto con la l. cost. 18 ott. 2001 nr. 3. Di rilievo tutt’altro che secondario è poi il riconoscimento introdotto nella legge-quadro di riforma dell’assistenza, laddove il legislatore ha conferito massimo rilievo all’espressione dei punti di vista della cittadinanza, oltre che delle forme della società civile organizzata. La l. 8 nov. 2000 nr. 328, infatti, intende fin dall’art. 1 promuovere «la partecipazione attiva dei cittadini [...] e delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali» propri (cfr. il 6° co.). Ed è appena il caso di aggiungere qualcosa circa i diversi luoghi della legge 328 in cui viene espresso il ben noto favor relativo al contributo che promana dalle diverse organizzazioni del terzo settore, chiamate di fatto dal legislatore a esercitare una funzione di rilievo pubblico.
I dati del più recente Censimento delle istituzioni non-profit del 2011 (ISTAT 2013) consentono uno scorcio sulle dinamiche del settore negli anni 2001/2011 e un peculiare riferimento analitico alla dimensione regionale. Come evidenzia la tabella 1, la consistenza del comparto in tutto il Paese supera le 300.000 unità. L’incremento quantitativo è stato nel periodo in esame pari al 28%, con una dinamica più sostenuta nel Nord-Ovest e specie nel Centro dove la crescita corrisponde quasi a un terzo del dato 2001: ma se nel primo caso il superamento della media nazionale si deve soprattutto alla performance della Lombardia, nell’altro aggregato è ascrivibile a uno sviluppo di tutte le regioni interessate, con una più vistosa accelerazione nel caso delle Marche. A Sud l’aumento delle organizzazioni, pur apprezzabile dal punto di vista dei valori percentuali, è meno intenso, ma bisogna considerare che vi confluiscono situazioni differenziate: il terzo settore registra in Campania un ampliamento limitato all’11,2%, ben lontano dal corrispettivo tasso rilevato per la Basilicata (+41,5%: il più alto in Italia).
Al netto delle tendenze diacroniche, mette conto sottolineare che resta concentrata nelle aree settentrionali più della metà di queste espressioni di solidarietà organizzata: la quota delle regioni meridionali assomma a poco più di un quarto del totale, mentre è collocato nel Centro il 21,5% del non-profit italiano. I territori che esprimono le quote più significative sono quelli di maggior radicamento storico, come Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. L’universo del Mezzogiorno sfiora le 80.000 unità, di cui quasi la metà si deve a Sicilia e Puglia. Interessanti paiono le informazioni desumibili dal rapporto tra numero delle istituzioni e contesto demografico di riferimento: infatti l’incidenza sulla popolazione regionale varia clamorosamente. La numerosità delle forme di reciprocità descrive un indice di densità organizzativa pari per il Nord-Est a 64,9 ogni 10.000 abitanti e per il Sud a 35,7: nel primo caso spingono il rapporto verso l’alto le risultanze di Trentino-Alto Adige (100) e di Friuli Venezia Giulia (82,1), mentre nel secondo la ‘rarefazione’ della solidarietà pare potersi mettere in relazione soprattutto con il dato della Campania (25,1), che esprime una realtà di scarsa consistenza quantitativa ove riferita all’insieme assai elevato dei residenti (insieme che può interpretarsi tanto come potenziale associativo del territorio quanto come proxy della domanda di servizi). Lontane dal valore medio nazionale (50,7) sono pure Puglia, Sicilia, Calabria e Lazio. Nella ripartizione centrale, invece, risalta il caso dell’Umbria, che mostra un rapporto che sopravanza di 20 punti il valore nazionale e di 15 il dato medio dell’aggregato territoriale di riferimento.
Ragionamenti di analogo interesse possono desumersi da un’analisi – sia pure sintetica – dei numeri relativi alle dotazioni di risorse umane attive in tali organizzazioni. Dalla tabella 2 si può evincere che intorno a queste realtà gravitano circa 4.759.000 volontari e 680.000 addetti (a cui invero andrebbero cumulati secondo il censimento altri 276.000 soggetti che collaborano con altre modalità, per es. lavoratori temporanei). Nelle aree meridionali risiede un volontario su cinque, ma il corrispettivo peso degli occupati sul totale nazionale è proporzionalmente più basso. Dal punto di vista della dinamica 2001-2011, vale la pena notare che l’incremento del novero di quanti si attivano gratuitamente – in Italia +43,5% – è pressoché irrilevante in Campania, Puglia e Sardegna (mentre svetta in senso contrario il dato lucano). Nelle altre circoscrizioni si apprezza una volta di più la variazione del Centro (+68,1%), al cui interno tutte le regioni presentano dinamiche più positive della media nazionale.
Passiamo in veloce rassegna le informazioni sugli occupati di queste realtà non-profit. Poco meno di un quarto del totale degli addetti opera nel Nord-Est, ma è di gran lunga più ampio il peso corrispondente all’altra ripartizione settentrionale: al Nord-Ovest afferisce il 27,5 delle istituzioni non-profit italiane e una percentuale ancora più elevata di personale occupato nelle stesse realtà. Nel decennio intercorso tra i due ultimi censimenti la variazione del numero di addetti nelle aree settentrionali ha un’intensità quadrupla rispetto alla media del Mezzogiorno peninsulare (12,5%) e più che doppia rispetto al 25,8% delle Isole: il che rende manifesta la capacità di questo comparto di creare nuova occupazione in tali contesti (gli incrementi di gran lunga più importanti riguardano Emilia-Romagna e Lombardia). Nel Centro Italia un passo più sostenuto nel decennio in questione è segnalato in Toscana e in Umbria, mentre in senso inverso lo scenario del Sud peninsulare appare appesantito dagli andamenti di Puglia, Calabria e Molise, laddove il non-profit non solo non fa registrare un aumento degli addetti ma addirittura un decremento. La Basilicata è la sola regione meridionale che su questo versante mostra una dinamica migliore della media nazionale (a cui la Sardegna si avvicina soltanto).
I differenziali territoriali sono ulteriormente palesati dal ricorso alla densità demografica dei vari contesti: è utile perciò rapportare alla popolazione regionale i dati relativi alla dotazione di risorse umane in termini analoghi a quanto mostrato più su. Gli indici che ne derivano nel campo dell’occupazione nel non-profit confermano che tutte le realtà del Mezzogiorno (con situazioni più critiche per Campania e Calabria) sono ben distanti dal valore medio nazionale, che invece viene superato da tutte le regioni del Nord. Se invece si guarda al rapporto di incidenza relativo al numero di volontari, Basilicata e Sardegna si distinguono in positivo rispetto all’aggregato territoriale di riferimento, mentre nelle circoscrizioni in cui la dotazione di capitale civico pare più diffuso emergono in primo luogo le tre regioni a statuto speciale del Nord e poi tutte le aree del Centro Italia eccetto il Lazio: in questi sei ambiti (Trentino, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Toscana e Marche) la presenza di soggetti che operano a titolo gratuito dentro le organizzazioni dell’economia civile ha un’incidenza sulla popolazione regionale significativamente più alta che nel resto del Paese.
Va aggiunta a questo quadro un’altra serie di punti. Nel confronto intercensuario emerge pure una consistente crescita dell’impiego di lavoratori con forme non standard: soprattutto i contratti di collaborazione variano del 169,4%. Complessivamente è la dimensione media di queste istituzioni ad aumentare in misura rilevante (da 12,8 a 16,3 dipendenti). Due terzi del comparto a livello nazionale restano composti da associazioni non riconosciute, ma l’incidenza di questa tipologia sale di molto nelle aree del Triveneto. Il peso delle associazioni riconosciute sul terzo settore italiano diminuisce nel decennio dal 26,5 al 22,7%. Nello stesso periodo fondazioni e cooperative sociali raddoppiano la propria numerosità, pur se continuano a rappresentare proporzionalmente una parte circoscritta di questo mondo. Tra gli ambiti di attività, come evidenziato nella tabella 3, rimane comunque preponderante l’area cultura, sport e ricreazione (che solo nel Lazio aggrega meno di sei organizzazioni su dieci, mentre in tutte le altre regioni l’incidenza è maggiore); emerge, in seconda battuta, l’ambito dell’assistenza sociale e della protezione civile, rispetto a cui si rilevano pure nel Meridione delle specializzazioni relative di qualche interesse.
Un approfondimento su cooperazione sociale e dimensione territoriale
Le informazioni appena riportate danno conto della pertinenza del livello territoriale nell’analisi dei fenomeni connessi all’evoluzione dell’economia civile. Si tratta di un tema che può essere ulteriormente sottolineato con riguardo a diversi profili, relativi per es. alle scelte regolative e al crescente spazio della legislazione e programmazione regionale in materia (vi è fin dagli anni Ottanta contezza di interventi di legislatori regionali riferiti al ruolo del privato sociale, come nel caso di Veneto e Liguria); ma in realtà datano dall’inizio degli anni Novanta le leggi nazionali che hanno normato peculiari profili di settore e dato l’impulso alla crescita delle diverse tipologie di organizzazioni dell’economia civile. Sembra pertanto più utile concentrarsi sulla disamina dell’evoluzione di forme organizzative specifiche, riferendosi in particolare all’esperienza della cooperazione sociale che negli studi sul terzo settore viene comunemente ritenuta quella più capace di coniugare un orientamento genetico all’inclusività e al bene comune con il radicamento nelle comunità locali, che si traduce in vera e propria erogazione di servizi per il territorio. Oltre 11.000 cooperative sociali censite in Italia nel 2011 rappresentano per numerosità solo il 3,7% del non-profit nazionale, ma dal punto di vista della consistenza occupazionale – come mostra la tabella 4 –, e soprattutto dell’impatto sui processi di crescita dei territori, esse giocano ruoli di gran lunga più importanti. Si tratta di una fattispecie organizzativa che rappresenta una peculiarità del non-profit italiano e che testimonia efficacemente la diffusione di quegli aspetti specifici dell’economia civile più su evidenziati: siamo in presenza di forme non-profit che si sono storicamente orientate alla produzione di servizi di utilità sociale tramite il rafforzamento di meccanismi democratici a livello locale e la valorizzazione di processi partecipativi.
Tra gli esercizi disponibili in letteratura vi sono ricerche che si focalizzano sull’esistenza di una relazione positiva tra capitale sociale, benessere sociale e appunto imprese sociali: l’ipotesi di partenza è che l’esistenza di una fitta rete di interazioni che creano ponti per la diffusione della fiducia costituisca un terreno fertile per la creazione di organizzazioni come le cooperative sociali, le quali a loro volta rafforzano le ragioni della coesione, sia creando nuove reti sia mostrando l’efficacia dell’azione collettiva nel perseguimento di interessi comuni. La correlazione tra la presenza/densità della cooperazione sui territori e le altre due leve viene testata da Fabio Sabatini (2007) tramite analisi in componenti principali: se ne evince che la presenza di cooperative sociali è positivamente correlata con un’elevata qualità sociale e ambientale e con la presenza di fitte reti di relazioni informali. Un altro esito di tale disamina, nel quadro di una marcata polarizzazione tra Nord e Sud, riguarda il fatto che Campania, Sicilia e Calabria vengono considerate le regioni peggio attrezzate di fronte a un’evoluzione del welfare in senso federalista.
Il novero di dati riguardanti i rapporti tra dimensione regionale e organizzazioni cooperative è naturalmente più ampio e verrà richiamato nelle pagine che seguono nel tentativo di mettere a confronto chiavi di lettura non sempre attente alla compatibilità tra fonti informative e alla valorizzazione della letteratura preesistente. Innanzitutto, però, conviene ricordare che solo nel 1991 le organizzazioni in questione trovano una propria definizione giuridica con la l. 381: ma ciò che precede l’emanazione della disciplina delle cooperative sociali è tutt’altro che irrilevante, fin dalle esperienze pioneristiche di ‘solidarietà sociale’ che già un quarto di secolo prima la cooperazione di emanazione cattolica aveva generato in aree circoscritte (Brescia, il Tronto) per favorire l’inclusione di soggetti svantaggiati: infatti in casa Confcooperative la nascita di un organismo di rappresentanza del comparto sociale anticipa di tre anni la normativa nazionale precitata e si attiva per la creazione e diffusione capillare di tali esperienze, puntando sul radicamento nei diversi territori piuttosto che sulla crescita quantitativa delle dimensioni imprenditoriali. Tant’è che nel 1992, all’indomani dell’istituzionalizzazione normativa il numero di organizzazioni aderenti a quel movimento – particolarmente concentrato a Settentrione – è più che quadruplo rispetto alla base corrispondente di Legacoop, mentre se si analizza il fatturato medio delle cooperative sociali il rapporto tra le due Centrali cooperative si inverte.
Vi sono infatti peculiarità storiche delle strategie promosse in materia dai due maggiori contesti associativi che si distinguono anche per il diverso peso annesso allo spazio del volontariato, a cui la cooperazione ‘rossa’ ha guardato sempre con sospetto per il rischio di ‘sfruttamento’ dei prestatori (cfr. Felice, Menzani 2011): e dal punto di vista che qui maggiormente rileva, le disparità territoriali restano consistenti – con il ritardo del Mezzogiorno in lento recupero – ma con una significativa concentrazione in Lombardia delle organizzazioni di estrazione cattolica e una maggior presenza dell’altra sigla in Emilia-Romagna.
Sul punto si può aggiungere qualche dato che deriva da rilevazioni condotte in anni relativamente recenti all’interno delle due Centrali. Un discreto valore segnaletico può attribuirsi al fatto che secondo un’inchiesta condotta su 200 cooperative sociali iscritte a Legacoop (A. Bernardoni, D. Cutillo, Profili identitari, stakeholder e strumenti di rendicontazione sociale, in Imprese cooperative sociali, a cura di A. Bernardoni, 2008), nelle aree del Sud paiono più atipici i profili identitari di queste organizzazioni: il Mezzogiorno è l’unico aggregato territoriale in cui le finalità sociali delle cooperative vengono considerate rilevanti da meno della metà del campione indagato (superano i due terzi i valori delle altre aree), mentre come tratto caratterizzante viene con maggiore frequenza indicata la qualità del lavoro offerto: evidentemente qui pesa il confronto con la criticità dell’occupazione resa accessibile in altri comparti produttivi. La stessa fonte poi riferisce sugli elementi essenziali della missione delle imprese che stiamo analizzando: del tutto irrilevante tra le risposte localizzate a Sud il tema della competitività, e poco considerato quello della trasparenza così come la promozione dello sviluppo della comunità, mentre nel confronto con le altre aree geografiche paiono più significativi l’obiettivo di erogare servizi di qualità e di incentivare la partecipazione dei soci, nonché di garantire un lavoro gratificante; le cooperative del Centro in proporzione sembrano più orientate alla messa in rete con altri soggetti del territorio (ma anche alla crescita delle competenze degli operatori); e sempre in termini comparativi il Nord evidenzia maggiormente una finalità che potrebbe definirsi sistemica, quale l’innovazione delle politiche di welfare. Infine, la più scarsa rilevanza delle comunità di riferimento emerge al Sud, confermata dal fatto che le cooperative ivi localizzate mostrano tassi di gran lunga più evanescenti per quanto concerne il coinvolgimento di stakeholders esterni nelle pratiche di rendicontazione sociale.
A riguardo dell’altra Centrale, che si stima oggi in Italia raccolga all’incirca sei cooperative sociali su dieci, una cospicua rassegna di dati quantitativi attenti ai profili geografici è stata organizzata a vent’anni dall’emanazione della legge 381: e anche se le informazioni in questione non sono organizzate secondo criteri diacronici, la fotografia che offrono (Federsolidarietà 2012) merita qualche attenzione. Si desume da tale studio che oltre la metà dei comuni di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna è marcato da un ‘significativo potenziale di offerta di servizi’ delle organizzazioni aderenti a Federsolidarietà, con oltre 20 cooperative accessibili nell’arco di spostamenti di trenta minuti: per Campania e Puglia una situazione analoga connota i due terzi dei Comuni. La concentrazione occupazionale delle cooperative sociali iscritte a Federsolidarietà, oltre ad apprezzabili picchi nella pianura vercellese, segue in prevalenza i due assi pedemontani che a partire dal contesto metropolitano milanese si snodano sulla linea lombardo-veneta e sulla via Emilia. Forte variabilità si coglie nei livelli di produttività media per addetto, con dati eccellenti non solo nelle aree metropolitane di Roma e Milano, ma anche nei casi della Romagna, del Valdarno, delle provincie di Treviso e La Spezia e, scendendo ancora, nelle aree di Pescara e di Trapani.
Più interessanti ancora sono in questa fonte i riferimenti al grado di copertura della domanda di welfare e alla capacità delle cooperative di rispondere a fabbisogni sociali che emergono nei singoli territori: la distribuzione geografica delle imprese sociali viene qui combinata con fattori demografici e con criteri di accessibilità dei servizi. L’assistenza agli anziani pare per es. ben presidiata nel Piemonte meridionale, a Brescia, a Reggio Emilia, ma anche in taluni contesti del Molise e della Sardegna; maggiori criticità invece riguardano l’ambito dei servizi per l’infanzia e gli interventi di fronteggiamento del disagio dei disabili nelle aree urbane maggiori e a Sud. Un’ultima serie di dati che pare utile sunteggiare riguarda il contributo della cooperazione sociale allo sviluppo locale, e si incentra sull’analisi di 686 distinti sistemi territoriali presenti nei confini nazionali per tentare una rappresentazione approssimata dell’impatto che la base di Confcooperative ha sull’economia locale. Per otto ambiti – interni ai confini di Piemonte, Lombardia, Toscana, Liguria e Umbria – il peso sull’occupazione complessiva e sul reddito si attesta intorno al 5% e quindi è commensurabile a quello di un settore caratterizzante; ma se si abbassa la soglia di incidenza, pur restando sopra l’1%, emerge che l’impatto occupazionale delle cooperative risulta consistente per molti capoluoghi disseminati tra Veneto e dorsale del Medio Adriatico (Padova, Treviso, Belluno, Ravenna, Cesena, Pesaro, Ancona, Macerata, Teramo); tra Nord-Ovest e Toscana si apprezzano le situazioni delle città di Cuneo, Asti, Cremona, Piacenza, Parma, Massa e Siena; nel Mezzogiorno i casi positivi sono ascrivibili a contesti di rango urbano minore (Siracusa, Cefalù e Castelvetrano in Sicilia; Orosei e Macomer in Sardegna).
Come si intuisce pure dal semplice accostamento di queste fonti che descrivono la situazione di periodi a noi più vicini, la dimensione territoriale introduce nell’analisi apprezzabili elementi di variabilità. In questa ottica, la giustapposizione di varie letture del fenomeno cooperazione sociale susseguitesi nel corso del tempo fornisce buone approssimazioni degli elementi di differenziazione che il livello regionale contiene. Le analisi in questione in verità combinano fonti statistico-amministrative non sempre sovrapponibili tra loro, e naturalmente questo – insieme con l’enfasi prestata a taluni aspetti dai singoli osservatori – rende ragione delle diverse modalità con cui si è guardato all’evoluzione della cooperazione sociale, partendo da una prima apprezzabile stagione di vigenza della disciplina specifica. Va pure aggiunto che non è del tutto agevole comprendere se (e come) le amministrazioni territoriali abbiano condizionato e accompagnato efficacemente lo sviluppo del comparto, favorendo anche l’emersione di situazioni virtuose. Anche solo considerando le date di promulgazione di norme regionali di recepimento della disciplina dettata dalla legge 381/91 e comparandole con i periodi in cui nei singoli territori si è concentrata e rivelata più intensa la costituzione di queste forme cooperative (tab. 5), non sempre si colgono elementi correlabili né tanto meno andamenti omogenei: vi sono situazioni in cui i processi sono coevi, altri in cui il legislatore regionale è intervenuto a ‘ratifica’ della creazione di tale segmento, e altri ancora in cui la crescita pare talmente differita rispetto all’intervento normativo da non potersi inferire una diretta efficacia del secondo sulla prima.
Veniamo alle analisi abbozzate da vari autori nel corso del tempo sulla dimensione regionale del fenomeno. Con riferimento al periodo 1997-2003, Gianfranco Marocchi (2005) distingue cinque clusters:
a) regioni a cooperazione matura, alta consistenza e crescita limitata: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
b) regioni dinamiche di più recente maturità, con indicatori di consistenza più bassi che nel cluster precedente ma con un grado di sviluppo potenzialmente di grande interesse: Liguria, Toscana e Basilicata;
c) regioni emergenti a bassa intensità cooperativa, con indicatori di consistenza notevolmente più bassi ma dinamiche di sviluppo molto vivaci e potenziali importanti se sostenute nel medio periodo da percorsi di consolidamento: Umbria, Campania, Puglia, e Calabria;
d) regioni con caratteri intermedi, valori di consistenza apprezzabili ma dinamiche contenute: Marche, Molise e Sardegna;
e) regioni a bassa intensità e sviluppo moderato: Abruzzo e Lazio.
Fonti addizionali rispetto ai dati ISTAT (tra cui rilevano – oltre che informazioni del sistema camerale – registri e albi regionali) e un diverso arco temporale di riferimento vengono utilizzati per un confronto interregionale (V. Bendini, Assetti strutturali e profilo identitario, in La cooperazione sociale in Umbria, 2013) secondo il quale alla cooperazione sociale italiana possono ascriversi nel periodo in esame (2005-12) tre distinti posizionamenti.
Un primo raggruppamento contiene alcune regioni del Nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), un’unica regione del Centro e un’altra del Sud (la Toscana e la Campania) in cui le cooperative sociali hanno tradizionalmente assunto un ruolo storico nella costruzione e nello sviluppo dei sistemi locali di welfare: complessivamente considerate rappresentano il 36,4% dello stock nazionale. Questi contesti mostrano una diffusione della cooperazione sociale inferiore al dato medio nazionale e pertanto attestano la propria presenza di settore sulla struttura preesistente di imprese sociali: è possibile sostenere che si tratta di un raggruppamento che esprime posizioni di consolidamento della cooperazione sociale.
Nel secondo insieme sono presenti regioni di minori dimensioni, con un maggior grado di diffusione territoriale della cooperazione sociale. All’interno vi sono situazioni differenziate, con regioni in cui le cooperative sociali presentano performance adeguate di crescita, come nel caso della Valle d’Aosta, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, e regioni in cui la dinamica di sviluppo della cooperazione sociale sembra essere alquanto contenuta (Liguria e Basilicata).
Il terzo cluster infine raggruppa le regioni in cui la cooperazione sociale presenta sia una densità sia tassi di crescita più elevati rispetto ai valori medi nazionali. Si tratta prevalentemente di regioni del Sud che hanno assistito, nel corso degli ultimi anni, a un significativo incremento della numerosità delle cooperative sociali, attivando una sorta di ‘rincorsa’ nei confronti di quelle aree in cui il fenomeno era storicamente radicato. Tra queste realtà sono presenti anche tre regioni appartenenti al Centro Italia: oltre al Lazio, in cui la crescita del numero di cooperative sociali potrebbe derivare anche dalla scelta di localizzare la sede legale delle imprese in un ambito metropolitano come quello della città di Roma, emergono le posizioni di Marche e Umbria che potrebbero rappresentare contesti in cui la cooperazione sociale continua a mostrare segnali postivi di sviluppo.
Sempre partendo da dati camerali, un’altra recente indagine campionaria, che include anche le imprese sociali generate da una disciplina del 2006 (il d. legisl. 24 marzo 2006 nr.155, ultimo nato tra le norme di settore, e invero quasi sterile dal punto di vista della promozione di nuove iniziative, visto che si tratta di poche centinaia di unità in tutta Italia), enfatizza dal punto di vista dell’impatto sul totale dell’occupazione dipendente le realtà di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna, oltre che di parte della Lombardia (Pavia, Biella e Forlì vengono evidenziate come province più virtuose sotto questo aspetto). Nel quadro generalizzato di una prevalenza netta di servizi di profilo sociale, si coglie che Nord e Sud si orientano soprattutto nei confronti dei minori, mentre l’offerta delle organizzazioni attive nelle regioni del Centro privilegia la popolazione anziana. Viene altresì rimarcato nel confronto col Mezzogiorno la maggiore capacità delle organizzazioni localizzate al Centro di garantire la fornitura di interventi assistenziali a una platea più ampia di utenti: da un segmento più ridotto di cooperative sociali sono stati assicurati servizi a un numero più elevato di soggetti (Mauriello, Carini, 2012).
Da ultimo, uno studio da poco pubblicato (Picciotti, Bernardoni, Cossignani, et al. 2014) mira a correlare su scala regionale il peso economico della cooperazione sociale con la spesa sociale gestita dal sistema delle autonomie locali, con la struttura demografica del territorio – con particolare riguardo a classi di popolazione ‘vulnerabile’ – , e con il grado di propensione cooperativa di quel contesto. Anche in questo caso l’esito è una ‘clusterizzazione’ del territorio nazionale, che contempla gruppi diversi:
a) un insieme demand pull, composto da Liguria, Friuli, Toscana, Marche e Umbria, in cui le variabili demografiche rappresentano il principale fattore di sviluppo della cooperazione sociale in ragione dell’elevato fabbisogno di servizi assistenziali;
b) le regioni a limitata densità di cooperazione sociale – Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia – che presentano deviazioni negative dai valori medi del grado di propensione;
c) il caso della sola regione virtuosa con elevata intensità di cooperazione sociale, ovvero l’Emilia-Romagna;
d) il cluster costituito dal Lazio e da tutte le aree meridionali, in cui restano marginali i pesi di tutte le variabili considerate;
e) infine Trentino-Alto Adige e Sardegna che possono essere associati al caso del Veneto, caratterizzato da elevati livelli di spesa sociale (public finance push).
A completamento di questo sguardo retrospettivo potrebbero essere addotti altri elementi che confortano l’idea della significativa differenziazione – per es. riguardo alle fonti di entrata – e che lasciano intravedere per il futuro prospettive di ulteriore diversificazione: soprattutto in ragione della crescente tendenza a caratterizzare i sistemi di welfare su base regionale, senza che purtroppo sia stato portato a termine nel nostro ordinamento quanto previsto dalla legge 328/2000 (e non contraddetto affatto dalla riforma del titolo V della Costituzione) riguardo alla necessità dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Laddove questi non vengano codificati e garantiti, non solo l’accessibilità dei servizi, ma anche le caratteristiche di erogazione degli stessi (ivi inclusi quelli forniti dalle cooperative sociali) potranno avere esiti non ordinati, sviluppi erratici, andamenti condizionati da fatti congiunturali o dalla mera disponibilità residuale di risorse: non dal fabbisogno sociale e meno che mai dall’obiettivo dello sviluppo delle comunità.
Lo scenario pare naturalmente preoccupante soprattutto per il Sud, ovvero per quell’area che continua a identificarsi con una condizione problematica del nostro Paese, con un sistema dell’assistenza poco capace di intercettare la domanda sociale e corrisponderle efficacemente. Se è vero che uno sguardo d’insieme – su cui non si può qui insistere approfonditamente – conferma il profilo distintivo di sistemi regionali di welfare aventi caratteristiche peculiari e autonome, emerso già nel primo periodo di vigenza della legge quadro e di implementazione delle architetture istituzionali corrispondenti, è altrettanto vero che non va trascurato affatto il dato problematico di un contesto nazionale in cui i fattori di differenziazione interna vanno aumentando, e restano maggiormente in affanno proprio quei territori in cui i fenomeni di vulnerabilità sembrano più consistenti. In questi territori, le cooperative di cui si è dato conto (e in termini più ampi, tutte le organizzazioni solidaristiche attive a livello locale) possono – con molte difficoltà – provare a giocare una funzione di protagonismo sociale, se capaci di contrastare il rischio dell’involuzione e di misurarsi con la promozione dello sviluppo della comunità, oppure potranno – sul solco di una malintesa interpretazione delle ragioni della sussidiarietà – supplire alle carenze della mano pubblica e acconciarsi a una condizione di adattività subalterna. La prospettiva dell’economia civile è attendibilmente la sola che possa invertire quest’ultimo scenario.
Quanta economia civile c’è nelle regioni italiane
Cosa suggerisce il rapido excursus storico delle pagine precedenti? Che la causa remota del perdurante dualismo tra Centro-Nord e Sud nel nostro Paese è la penuria di capitale civile nel Mezzogiorno – una penuria resa evidente dalla scarsità numerica e soprattutto dalla scarsa incidenza, nella sfera economica e sociale, di quelle organizzazioni che fanno del principio di reciprocità il loro modo specifico di agire. A differenza di quel che si potrebbe pensare, l’osservazione, anche casuale, suggerisce che quello della reciprocità è un fenomeno alquanto diffuso nella realtà. Non solamente esso è presente, in varie forme e gradi, nella famiglia e nei piccoli gruppi informali di vario genere, ma le transazioni basate sulla reciprocità sono presenti in tutte quelle forme d’impresa che includono le cooperative di varia denominazione, dove la reciprocità assume la particolare forma della mutualità, le imprese sociali di nuova generazione, le fondazioni di comunità, fino alle organizzazioni di volontariato, dove la reciprocità sconfina nel dono come gratuità (per un resoconto dettagliato dell’incidenza di tali forme d’impresa nel nostro Paese cfr. L. Becchetti, Wikieconomia. Manifesto dell’economia civile, 2014). Come la vasta letteratura sullo sviluppo economico italiano ha posto in luce, il cosiddetto modello della ‘nuova competizione’ postula sia la disposizione a cooperare da parte degli agenti economici sia un network di relazioni fiduciarie. Invero, è proprio in ciò il segreto delle storie di successo dei nostri distretti industriali, storie che purtroppo non hanno che toccato marginalmente il Mezzogiorno.
Quanto diffuse sono, nella realtà delle regioni italiane, le varie pratiche della reciprocità? È a questo interrogativo che, nel prosieguo di questo saggio, volgiamo l’attenzione. Una risposta a una domanda, per così dire a monte, è tuttavia opportuna. È concettualmente possibile che soggetti economici che intendono informare la loro azione al principio di reciprocità possano convivere, operando entro il mercato, con soggetti che invece si appoggiano sul solo scambio di equivalenti? La risposta affermativa è fondata sulla considerazione seguente. Sappiamo che le motivazioni che stanno alla base dell’agire economico sono di due tipi: estrinseche e intrinseche. Le une hanno natura teleologica – si compie un’azione per conseguire da essa il massimo risultato possibile date le circostanze – e sono espressione di passioni peculiari, quali la passione acquisitiva o quella narcisistica dell’io. Le altre hanno natura non strumentale – si fa qualcosa per il significato o il valore intrinseco di quel che si fa e non solo per il risultato finale – e scaturiscono da una speciale passione, la passione per l’altro, non più visto come strumento dell’affermazione del proprio io. È altresì noto che i due tipi di motivazioni sono variamente presenti (e combinati) nei soggetti imprenditoriali che popolano una economia di mercato. Vi sono, infatti, imprenditori che pongono in cima alla propria struttura di preferenze quella di lavorare in imprese centrate sul principio di reciprocità, alle quali applicano un modo di organizzazione del processo produttivo basato sulla mutua fiducia, sul senso di equità, sul rispetto delle soggettività. E vi sono imprenditori che invece preferiscono organizzare il lavoro in modo anonimo e impersonale e per i quali il rispetto delle norme di legge è un vincolo e non un argomento della loro funzione obiettivo. Per costoro, l’unica forma di socialità perseguita è quella suggerita dal modello della scelta razionale, secondo cui il legame sociale ha ragion d’essere solamente nella misura in cui consente di meglio conseguire gli obiettivi individuali.
Chiaramente, il primo tipo di imprenditore sarà maggiormente attratto, coeteris paribus, dalla forma sociale di impresa; il secondo tipo da quella capitalistica – anche se nella realtà parecchie sono le ibridazioni tra le due forme. Ebbene, un assetto istituzionale che privilegiasse – come avviene in Italia – la forma capitalistica di impresa non solamente sarebbe poco rispettoso delle ragioni della libertà (la libertà di scelta senza il potere di scelta si riduce a vuoto filosofema), ma rinuncerebbe in modo irragionevole a servirsi del mercato per ottenere quei risultati che pure si reputano di centrale rilevanza, quali una più equa distribuzione del reddito, un minore tasso di disoccupazione, una dilatazione degli spazi di libertà dei cittadini e così via. Occorre dunque comprendere che l’oggetto della politica non è tanto quello di predisporre incentivi che spingono agenti autointeressati a gestire in modo coerente i propri piani di azione, quanto quello di creare le condizioni per un allargamento della base di prosocialità presente nei territori regionali. Perché, mai lo si dimentichi, lo sviluppo della reciprocità in una popolazione dipende anche dalle caratteristiche dell’assetto giuridico-istituzionale oltre che dalle scelte di politica economico-finanziaria.
Una precisazione è qui opportuna. L’argomento sopra sviluppato postula, per la sua validità, l’accoglimento della concezione emergentista del capitale civile, non già di quella additivista. Secondo quest’ultima, il capitale civile è una risorsa che si aggiunge alle altre forme di capitale (naturale, umano, fisico, ecc.) offrendo un suo proprio contributo al processo di sviluppo – quanto a dire la funzione aggregata di produzione incorpora un argomento ulteriore. La concezione emergentista, invece, vede nel capitale civile quella forza che, una volta messa in campo, va a modificare, in senso generativo, le relazioni preesistenti tra le altre forme di capitale – va cioè a modificare la forma stessa della funzione aggregata di produzione.
In uno studio recente Giovanni Carrosio e Giorgio Osti (Un’analisi ecologica dell’economia civile del Nord Italia, 2011) costruiscono un indice di economia civile relativo alle 46 province del Nord Italia. Gli indicatori – 15 in tutto – prescelti per misurare la consistenza dell’economia civile sono riferiti a tre dimensioni: le pratiche di responsabilità sociale dell’impresa; il numero e la tipologia di imprenditorialità sociale; la presenza sul territorio di reti istituzionali tra soggetti pubblici e privati. Come si comprende, si tratta di dimensioni che mirano a dare conto della reciprocità praticata all’interno sia delle singole organizzazioni d’impresa sia dei rapporti tra imprese ed enti pubblici e tra soggetti for-profit e non-profit. Obiettivo centrale dell’indagine è quello di misurare quanto i territori provinciali presi in considerazione siano capaci di organizzazione e di gestione di tutte le risorse riconducibili all’economia civile. I risultati ottenuti confermano ampiamente la tesi qui difesa. Le aree con più alti livelli di economia civile sono quelle caratterizzate da una radicata cultura cooperativa e da istituzioni locali capaci di attuare modelli di governance democratica per la gestione dei beni comuni. Ciò si riflette in più elevati tassi di sviluppo, una più alta qualità della vita, una più forte coesione sociale.
Di due altre indagini specifiche sul medesimo tema conviene dire. Gianpietro Cavazza (Analisi dei contesti regionali e orientamenti per le politiche familiari nazionali, in Una bussola per le politiche familiari, 2012) si chiede quanto le politiche regionali, in Italia, siano orientate alla famiglia, considerata come uno dei principali generatori di capitale sociale e dunque di capitale civile. Sulla scorta dell’Indice del grado di familiarità dei territori, l’autore mostra che, delle otto regioni prese in considerazione, solamente Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto si qualificano come territori pro-family, nei quali vengono sistematicamente attuate specifiche politiche familiari. Non così in Campania, Friuli, Lazio, Toscana, Sicilia, regioni nelle quali l’impianto normativo è bensì adeguato (sono state analizzate 371 leggi regionali per un totale di mille servizi) ma le leggi quasi mai vengono attuate appieno.
Pure di grande interesse è la ricerca di L. Bruni e G. Ferri (We are happy to help you to help us, Università di Roma ‘Lumsa’, 2013) che prende le mosse dalla seguente constatazione. Nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012, perché la pubblica felicità è calata di meno nel Nord-Est (−14,6%) che non nel resto d’Italia (−19,2%)? Eppure, il PIL pro capite, nel medesimo periodo, era calato del 2,3% nel Nord-Est e ‘solo’ dello 0,6% nel resto d’Italia. Agevole è la risposta: la felicità è influenzata assai più dalla percezione di sicurezza che non dai livelli di reddito. D’altro canto, la sicurezza dipende dalla percezione che gli individui hanno di essere parte e di poter prendere parte al gioco economico: più alta la partecipazione alla vita economica, più alta la felicità. Da qui discende la seguente catena causale: la presenza di imprese sociali e di cooperative – assunte come proxy del grado di partecipazione dell’individuo al mercato – aumenta la fiducia generalizzata; questa accresce la sicurezza percepita e quest’ultima provoca un innalzamento dell’indice di felicità. Come si può intendere, immediate sono le conseguenze di tale constatazione sul piano delle public policies.
Il saggio di Domenico Cersosimo e Rosanna Nisticò (Un paese diseguale: il divario civile in Italia, «Stato e mercato», 2013, 2, pp. 265-300) fornisce un’accurata analisi dei divari interregionali di civiltà nel nostro Paese, misurati in termini di disponibilità, accessibilità e qualità di servizi civili essenziali (sanità, scuola, sicurezza, giustizia). Gli autori opportunamente rilevano come la bassa qualità dei servizi non sia tanto associata alla carenza della spesa pubblica sociale, come invece si continua a pensare, quanto piuttosto ai modi e alle forme in cui le risorse disponibili vengono spese.
Anziché una conclusione
Al termine del suo soggiorno a Venezia, Johann Wolfgang Goethe scrive, nel 1790, il seguente epigramma:
Questa è l’Italia che lasciai. Sempre polverose le strade, sempre spennato lo straniero, qualunque cosa faccia. Cerchi invano la probità tedesca; qui c’è vita e animazione, non ordine e disciplina. Ciascuno pensa solo a sé e diffida degli altri e i reggitori dello Stato, anche loro, pensano a sé soli (Venezianische Epigramme, nr. 4).
Non pensiamo che il grande poeta tedesco, che ben conosceva l’Italia dal Nord al Sud, abbia visto completamente giusto, e sia stato generoso col nostro Paese. Aveva però colto un tratto non secondario del costume e della condotta del nostro popolo – un tratto che in questo saggio riteniamo di aver messo adeguatamente a fuoco. È proprio alla luce di ciò che oggi ha senso tornare a parlare di economia civile. Perché questa linea di pensiero – una linea squisitamente italiana – consente alla diversità delle culture locali di essere occasione di armonia e non di conflitto. La società industriale ha cercato e realizzato l’omologazione, la standardizzazione, prima dei prodotti e poi dei modelli culturali. La società postindustriale, invece, esalta e favorisce le diversità. Ma, se non incanalate, le diversità si trasformano in inefficienze sistemiche. Legge e contratto non bastano più – anche se ben congegnati – a garantire un ordine sociale in grado di raccogliere le nuove sfide. Quel che occorre è di mettere all’opera le risorse dell’homo reciprocans, perché l’homo oeconomicus, anche se ben intenzionato, non riesce a sciogliere nessuno dei grandi dilemmi sociali della nostra epoca. L’aveva ben compreso, in largo anticipo sui tempi, Genovesi quando, nelle sue Lezioni di economia civile (1765), scrisse «homo homini natura amicus», in chiara opposizione con l’hobbesiano homo homini lupus – espressione quest’ultima originariamente dovuta a Plauto.
Ci piace terminare citando un brano di John Ruskin – un classico della scienza sociale:
In una crisi severa, mentre in ballo ci sono tante vite e molte ricchezze, gli economisti non sono di nessun aiuto. Ridotti praticamente al silenzio: non sanno dare alcuna soluzione scientifica alle difficoltà, nulla che possa convincere a calmare le parti che si oppongono tra loro (Unto this last, 1862; trad. it. Cominciando dagli ultimi, 2014, p. 67).
Forse a questo aveva pensato Vilfredo Pareto quando, in una lettera a Maffeo Pantaloni del 30 aprile 1896, scrisse:
Mi persuado ogni giorno di più che non c’è studio più inutile di quello dell’economia politica. Dimmi un poco: se non si fosse mai studiata quella scienza, saremmo noi in peggior stato di ciò che siamo ora? [...] Tutta la nostra economia politica è proprio un vaniloquio (Corrispondenza Pareto-Pantaleone, 1890-1923, 3 voll., a cura di G. De Rosa, 1° vol., 1962, p. 141).
Certo, se il grande Pareto e soprattutto Pantaloni avessero compreso il messaggio centrale dell’economia civile e si fossero astenuti dall’ostracizzarlo con tutte le loro forze (e con tutto il loro potere accademico), certamente non sarebbero giunti a un tale cinismo e probabilmente il corso delle idee in economia avrebbe preso tutt’altra piega. Con il che la disciplina avrebbe potuto rendere migliore servizio alla causa dello sviluppo economico e del progresso civile del nostro Paese.
Bibliografia
L.J. Hanifan, The community center, Boston 1920.
R. Putnam, Making democracy work. Civic traditions in modern Italy, Princeton 1993 (trad. it. La tradizione civica nelle regioni italiane, Milano 1993).
M. Archer, Realist social theory: the morphogenetic approach, Cambridge 1995.
D. Throsby, Cultural capital, «Journal of cultural economics», 1999, 23, pp. 3-12.
N. Uphoff, Understanding social capital, in Social capital, ed. P. Dasgupta, I. Serageldin, Washington 2000, pp. 215-53.
G. Marocchi, Le traiettorie di sviluppo della cooperazione sociale, in Centro Studi CGM, Beni comuni. Quarto rapporto sulla cooperazione in Italia, Torino 2005.
R. Cartocci, Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia, Bologna 2007.
G. Clark, Farewell to alms, Princeton 2007 (trad. it. Senza pietà. Breve storia economica del mondo, Torino 2009).
F. Sabatini, Capitale sociale, imprese sociali, spesa pubblica e qualità della vita, «Impresa sociale», 2007, aprile-giugno, pp. 190-219.
L. Bruni, R. Sugden, Fraternity: why the market need not be a morally free zone, «Economics and philosophy», 2008, 24, pp. 35-64.
F. Sabatini, Il capitale sociale nelle regioni italiane: un’analisi comparata, «Rivista di politica economica», 2009, 99, pp. 167-220.
F. Amati, M. Verde, Il terzo settore al Sud. Un’analisi quantitativa, in Occhi nuovi da Sud, a cura di P. Fantozzi, M. Musella, Roma 2010.
G. De Blasio, G. Nuzzo, Historical traditions of civicness and local economic development, «Journal of regional science», 2010, 50, pp. 833-57.
E. Felice, T. Menzani, Una bella impresa. L’evoluzione della cooperazione sociale in Confcoooperative e Legacoop, «Storia e futuro», 2011, 25.
L. Guiso, P. Pinotti, Democratization and civic capital in Italy, «Quaderni di storia economica», 2011, 23.
L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales, Civic Capital as the missing link, in Handbook of social economics, ed. J. Benhabib, A. Bisin, M. Jackson, Amsterdam 2011.
G. Iuzzolino, G. Pellegrini, G. Viesti, Convergence among italian regions, 1861-2011, «Quaderni di storia economica», 2011, 22.
P. Sestito, I diversi concetti di capitale sociale, in Il capitale sociale, a cura di G. De Blasio, P. Sestito, Roma 2011, pp. 43-57.
Il Terzo settore nell’Italia unita, a cura di E. Rossi, S. Zamagni, Bologna 2011.
P. Acciari, S. Mocetti, Una mappa delle diseguaglianze del reddito in Italia, «Politica economica», 2012, 3, pp. 307-42.
Federsolidarietà, L’atlante della cooperazione sociale, 2012. http://www.pordenone.confcooperative.it/primo_piano_dettaglio.php?id=260, 28 ott. 2014).
D. Mauriello, C. Carini, Il quadro d’insieme e le tendenze dell’evoluzione recente, in L’impresa sociale in Italia. Pluralità dei modelli e contributo alla ripresa, a cura di P. Venturi, F. Zandonai, Milano 2012.
L. Azzolina, Capitale sociale, spesa pubblica e qualità dei servizi, «Stato e mercato», 2013, 99, pp. 423-54.
C. Di Berardino, A. Sarra, Struttura produttiva, localizzazione geografica, crescita nazionale, «L’industria», 2013, 34, pp. 329-46.
E. Felice, Perché il Sud è rimasto indietro, Bologna 2013.
ISTAT, 9° Censimento dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit. Primi risultati, Roma 2013.
T. Nannicini, A. Stella, G. Tabellini et al., Social capital and political accountability, «American economic journal: Economic policy», 2013, 5, pp. 222-50.
S. Vassallo, Il divario incolmabile, Bologna 2013.S. Zamagni, Impresa responsabile e mercato civile, Bologna 2013.
G. De Blasio, D. Scalise, P. Sestito, Universalism vs. particolarism: a round trip from sociology to economics, Roma 2014.
D. Iacobucci, A. Micozzi, I divari territoriali nella dinamica imprenditoriale in Italia, «L’industria», 2014, 1, pp. 49-68.
L. Mauro, F. Pigliaru, G. Carmeci, Decentralization. Social capital and growth, CRENOS, gen. 2014 (http://www2.dse.unibo.it/dsa/seminari/944/luciano%20mauro.pdf, 28 ott. 2014).
A. Picciotti, A. Bernardoni, M. Cossignani et al., Social cooperatives in Italy: economic antecedents and regional distribution, «Annals of public and cooperative economics», 2014, 85, 2, pp. 213-31.
G. Ponzetto, U. Troiano, Social capital, government expenditures and growth, CREI, Barcelona GSE working paper series, 612, July 2014.