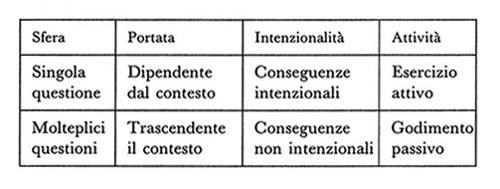Potere
Potere
Introduzione
Il significato più generale del concetto di 'potere' si ritrova nel Sofista di Platone, in cui si afferma che il potere è "la definizione dell'essere", il tratto distintivo dell'esistenza reale: ossia la capacità di "influenzare un altro, o di essere influenzati da un altro" (Sofista, 247e). John Locke adottò quest'uso, riprendendo la distinzione platonica tra potere passivo e potere attivo; "il potere così concepito", scrive Locke, "è duplice, cioè capace di fare o di subire un cambiamento" (Saggio sull'intelletto umano, cap. XXI, § 2). La maggior parte dei filosofi e dei sociologi, tuttavia, ha riferito il concetto di potere esclusivamente alle capacità attive.
Ascrivere un potere a un soggetto, a una persona o a una collettività non significa ascrivere una qualità - né di tipo sensoriale (come aveva intuito Locke), né misteriosa e occulta (come affermava Molière allorché metteva in ridicolo l'idea che l'oppio possieda una virtus dormitiva che spiegherebbe la sua capacità di indurre il sonno). A partire dal filosofo inglese Gilbert Ryle, è diventata prassi comune analizzare tali ascrizioni di poteri in termini di enunciati disposizionali, ossia come combinazioni di enunciati condizionali o ipotetici che specificano cosa si verificherebbe in un determinato insieme di circostanze se tali poteri venissero esercitati. Ma sappiamo quali enunciati condizionali specificano le disposizioni di un dato oggetto (o soggetto) solo perché sappiamo già che esso ha determinati poteri. Sembra pertanto legittimo affermare che "X ha il potere di fare A" significa "X farà o può fare A, nelle condizioni appropriate, in virtù della sua intrinseca natura". In questa prospettiva, ascrivere un potere significa affermare che ciò che X fa o può fare è determinato non semplicemente dagli stimoli cui X può essere soggetto o dalle condizioni estrinseche in cui si trova, ma in qualche misura dalla natura o costituzione intrinseca di X, da cui deriva il suo potere. Quella di potere è quindi "una nozione associata in modo particolare alla capacità di agire, all'avvio di catene di eventi, all'attività". Non si tratta, peraltro, di una nozione antropomorfica, poiché la 'capacità di agire' in questo caso è intesa come definita dalla distinzione tra natura intrinseca e circostanze estrinseche (v. Harré e Madden, 1975, pp. 84-91).Il tema di questo articolo, tuttavia, è il potere sociale, e gli agenti il cui potere costituirà l'oggetto della nostra discussione saranno quindi agenti sociali, sia individui che collettività (gruppi o organizzazioni). I poteri di tali agenti consistono nella capacità di provocare determinati cambiamenti. Ma non tutti i cambiamenti che gli agenti sociali sono in grado di provocare possono essere considerati a buon diritto conseguenze del loro potere. Alcuni di essi saranno troppo banali: la capacità di A di muovere correnti d'aria quando parla non è certo una manifestazione del suo potere. Altri cambiamenti sono in contrasto con i desideri e le aspettative del soggetto. A non verrà definito potente se le sue azioni sovvertono regolarmente le sue intenzioni - anche se il potere a volte può annullare se stesso.
Certi cambiamenti poi sono in contrasto con gli interessi del soggetto. A non sarà considerato potente se le sue azioni vanno regolarmente contro i suoi interessi. Alla luce di quanto detto, sono stati proposti tre modi per delimitare il concetto di potere. In primo luogo, alcuni autori hanno sostenuto che i cambiamenti causati dal potere devono essere rilevanti (v. White, 1972). In secondo luogo, si è affermato a volte che tali cambiamenti devono essere intenzionali; è questa ad esempio la posizione di Bertrand Russell (v., 1938), che definisce il potere come "la produzione di effetti intenzionali" (dimenticando, peraltro, che 'potere' denota una capacità, non il suo esercizio). In terzo luogo, i cambiamenti prodotti dal potere possono essere intesi come cambiamenti che favoriscono gli interessi dei potenti; Hobbes, ad esempio, definisce il potere dell'uomo come il complesso dei "mezzi che ha a sua disposizione per raggiungere qualche futuro scopo che a lui sembra vantaggioso" (Leviatano, cap. X).
Tuttavia, tutte e tre queste limitazioni del concetto sollevano una serie di problemi che analizzeremo più da vicino nelle pagine seguenti. In primo luogo, quali effetti siano o meno 'rilevanti' è una questione di giudizio (il giudizio di chi?). In secondo luogo, l'idea che il potere debba essere intenzionale è contestabile. Non può forse un soggetto avere ed esercitare potere senza cercare deliberatamente di farlo, in modo inconsapevole o di routine, senza rendersi conto degli effetti che può provocare o provoca effettivamente - come quando, ad esempio, attuando le sue decisioni di investimento, toglie o procura lavoro a persone a lui sconosciute? E in che misura deve essere A in persona a produrre i cambiamenti in questione? Come considerare il caso in cui le intenzioni di A siano realizzate attraverso fattori che sfuggono al suo controllo? Che rapporto sussiste tra potere e fortuna?In terzo luogo, l'idea che il potere debba avvantaggiare gli interessi dei potenti richiede un esame più attento della complessa nozione di 'interessi', sulla quale ritorneremo in seguito.
La nozione di potere può anche essere definita e impiegata in riferimento ad agenti collettivi. Hannah Arendt, ad esempio, si richiama a una tradizione e a un lessico "antico e venerando" secondo cui il termine 'potere' "indica la capacità umana non semplicemente di agire, ma di agire di concerto. Il potere non è mai proprietà dell'individuo; esso appartiene a un gruppo e continua ad esistere solo finché il gruppo resta unito.
Quando diciamo che un individuo 'ha potere' ci riferiamo in realtà al fatto che a tale individuo è stata conferita da un certo numero di persone la facoltà di agire in loro nome" (v. Arendt, 1970, p. 44).
Per Platone e Aristotele, secondo Franz Neumann (v., 1964, p. 5) "il potere politico è il potere complessivo della comunità"; Cicerone, dal canto suo, parla di 'potestas in populo'. Hannah Arendt vede esemplificata questa tradizione tra gli Ateniesi, i Romani e i rivoluzionari del XVIII secolo, specialmente in America. Ma anche altri autori parlano del potere in questi termini. Secondo Montesquieu, ad esempio, 'l'état civil' unisce le volontà individuali, ma i poteri individuali (forces particulières) "non possono unirsi se non quando si uniscono tutte le volontà" (L'Esprit des lois, libro I, cap. 3).
Il problema di associare le volontà individuali per ottenere risultati che andrebbero a beneficio della collettività ha assunto un'importanza centrale nelle scienze sociali a partire dallo studio di Mancur Olson (v., 1965). Il problema dell'azione collettiva sorge perché è difficile ottenere che gli individui cooperino per il mutuo vantaggio, quando possono beneficiare degli esiti dell'azione collettiva senza impegnarsi in prima persona (il cosiddetto problema del free rider). L'esempio più noto di tale problema è la generalizzazione del cosiddetto 'dilemma del prigioniero', che rappresenta una situazione in cui è meglio per tutti cooperare, ma è razionale per i singoli individui non farlo. Ad esempio, è meglio per tutti i lavoratori scioperare per ottenere condizioni salariali migliori, ma per ognuno di essi è meglio presentarsi al lavoro; è meglio per tutti i pescatori non praticare la pesca a strascico, ma è meglio per il singolo infrangere la regola; è meglio per tutti non gettare rifiuti nel parco, mentre i singoli individui non hanno alcun incentivo ad astenersi dal farlo. Comportamenti quali votare, denunciare i redditi alle autorità e aderire a un movimento rivoluzionario rispondono alla stessa logica.
Le soluzioni al problema dell'azione collettiva possono essere centralizzate - quando l'obiettivo viene raggiunto dall'esterno attraverso il ricorso alla forza o a incentivi selezionati - oppure decentralizzate - quando una qualche combinazione di interesse personale a lungo termine, altruismo e conformità alle norme sociali può ingenerare un comportamento orientato alla cooperazione. In sintesi il potere, inteso come capacità dell'azione collettiva di ottenere risultati mutuamente vantaggiosi, dipende dalle condizioni alle quali gli individui sono disposti a cooperare.Tuttavia il potere sociale così come lo abbiamo considerato sinora, individuale o collettivo che sia, non corrisponde all'accezione più ristretta in cui il termine 'potere' viene spesso usato nel linguaggio comune e negli scritti dei filosofi, degli storici e degli scienziati sociali. In questa accezione più ristretta, gli effetti prodotti dal potere sono ancora più specifici: si tratta cioè di modifiche indotte in altri agenti sociali che si traducono nel loro conformarsi alla nostra volontà. Il potere, in questa accezione più ristretta, è essenzialmente relazionale e consiste nel potere su altri. Questa distinzione tra l'accezione più ampia del concetto - potere come capacità attiva di produrre effetti - e quella ristretta appena illustrata è stata colta nel modo più perspicuo da Spinoza, allorché distingue tra potentia e potestas. Una cosa ha bisogno "per cominciare ad esistere della stessa potenza [potentia] che per continuare ad esistere" (Tractatus politicus, cap. II, § 2); il termine 'potestas', d'altro canto, viene impiegato per indicare il 'trovarsi in potere di un altro'. Secondo Spinoza, "ciascuno è soggetto a un altro fino a quando è in potestà [potestas] di un altro, e a se stesso in quanto può respingere ogni violenza, punire un danno subito seguendo solo il proprio giudizio e, in maniera generale, quando può vivere a modo suo" (ibid., cap. II, § 9).
Questa distinzione è espressa in tedesco da quella tra Kraft da un lato e Macht e Gewalt dall'altro, laddove sia l'inglese power che l'italiano potere coprono entrambi i significati (anche se in italiano esiste il termine potenza equivalente a potentia), e lo stesso vale per i due termini francesi pouvoir e puissance.Spinoza suggerisce l'esistenza di un'intima connessione tra potere (come potestas) e libertà: il potere, in questa prospettiva, consiste nella capacità degli agenti sociali di indurre gli altri a conformarsi alla propria volontà vincolandone la libertà, impedendo loro di vivere secondo la propria natura e il proprio giudizio. Nei prossimi due capitoli focalizzeremo l'attenzione sul potere inteso in questo senso. Dapprima illustreremo i vari modi in cui il potere così concepito può essere esercitato, per poi considerare le diverse relazioni di potere - sempre inteso in questo senso - che possono intercorrere tra gli agenti. Faremo poi un passo indietro e analizzeremo il concetto di potere in generale, chiedendoci quali interessi e quali assunti si celino dietro i nostri sforzi di stabilire dove risieda e come sia distribuito il potere in una data società o in un dato contesto sociale. Dalle diverse risposte a questo interrogativo scaturiscono differenti concezioni del potere e differenti metodi per analizzarlo. Concluderemo indicando le difficoltà specifiche presentate dallo studio del potere.
Meccanismi del potere
Nell'accezione ristretta della nozione di potere, un agente sociale ha potere su un altro o su altri quando è in grado di assicurarsi la loro obbedienza limitandone la libertà. Ciò può essere ottenuto in vari modi. Un primo modo consiste nell'escludere possibilità alternative, riducendole nel caso limite ad una sola. Tratteremo questo caso nel paragrafo dedicato alla forza. Un secondo modo è quello di modificare la relativa desiderabilità delle alternative che si prospettano agli agenti, assicurandosi il loro conformarsi al nostro volere col porli di fronte a una scelta che preferirebbero non fare. In questo caso si parlerà di coercizione. Un terzo modo, infine, consiste nel manipolare un altro o altri agenti, sia condizionandone le opzioni, sia strutturando le circostanze in cui si trovano ad agire in modo che aderiscano a determinate alleanze o coalizioni, sia ancora inducendoli o persuadendoli a nutrire determinate credenze e desideri. In quest'ultimo caso si ha una forma di influenza, che consiste nel predisporre o condizionare la volontà di un altro o di altri. L'influenza può essere esercitata anche impartendo disposizioni che gli altri accettano come vincolanti, ossia attraverso l'autorità, oppure fornendo ragioni o motivi per agire o non agire in un certo modo, ossia attraverso la persuasione razionale. Prima di passare ad esaminare ciascuno di questi meccanismi, è opportuno ribadire che in questo campo vi è ben poco di incontrovertibile: in particolare, come vedremo, non tutte queste presunte forme di potere sono incontestabilmente limitazioni della libertà, né la riducono allo stesso modo. Un'ulteriore osservazione preliminare si rende necessaria: presenteremo nei prossimi capitoli una serie di distinzioni concettuali servendoci di convenzioni definitorie di alcuni termini del linguaggio ordinario. Nell'uso quotidiano, tuttavia, tali termini hanno un'accezione assai più oscillante e incerta. Nostro scopo non è quello di rappresentare né di riordinare tale uso, bensì di emendarlo per fini di chiarezza concettuale.
Forza
È importante distinguere l'uso diretto della forza o violenza dalla minaccia del ricorso alla stessa. La prima strategia può aver successo (nel raggiungere gli obiettivi di chi la mette in atto), ma può anche significare il fallimento della seconda: B può costringere A a scoprire le carte non cedendo alle sue minacce e inducendolo a ricorrere effettivamente alla forza minacciata. D'altro canto, il ricorso alla forza può rendere più credibile minacce future: ne è un esempio il caso della mafia che uccide un magistrato pour encourager les autres.
Per 'forza' si intende qualsiasi azione materiale diretta contro le persone fisiche o le loro proprietà che, quando riesce, impedisce loro di agire in un determinato modo o le pone nella situazione desiderata, annullandone le resistenze e, in casi estremi, la stessa esistenza. Usare la forza significa in un certo senso trattare le persone come oggetti, non come soggetti, poiché gli scopi voluti sono ottenuti in questo caso nonostante le azioni degli altri, anziché mediante esse. Il ricorso alla forza non assicura che gli altri si conformino alla nostra volontà, bensì elimina la necessità di agire in questo senso.
Già Machiavelli rilevava che la forza, rispetto ad altre forme di potere, è altamente antieconomica. Poiché non ottiene lo scopo facendo sì che gli altri agiscano in risposta alle condizioni cui sono posti di fronte, né influenzandone la volontà, la forza richiede un intervento diretto e incessante e un notevole dispendio di energie e di risorse. D'altro canto, come accennato in precedenza, l'uso strategico della forza può rendere tanto più efficaci altre forme di potere. Di fatto, spesso la forza riesce ad ottenere l'obbedienza in modo indiretto, segnalando la prospettiva di una violenza maggiore, continuata o accresciuta, e in questo caso diventa uno strumento della coercizione o dell'influenza. A seconda dei contesti varierà ovviamente la quantità di forza necessaria per rendere efficace un sistema di coercizione-più-influenza. È stato osservato, ad esempio, che il multiforme sistema di controllo sociale ed economico della mafia negli anni ottanta è costato circa diecimila morti per mano del crimine organizzato nell'Italia meridionale.
Coercizione
La coercizione è spesso considerata la forma standard del potere (nel senso ristretto). Il potere coercitivo consiste nella capacità di ottenere il conformarsi di un altro o di altri alla nostra volontà tramite il ricorso a minacce o a sanzioni negative. Ciò presuppone un conflitto di volontà tra il soggetto che esercita e quello che subisce la coercizione, e la necessità di superare le resistenze di quest'ultimo. È senza dubbio questa concezione del potere che sta alla base della definizione fornita da Harold Lasswell e Abraham Kaplan, secondo i quali sono relazioni di potere quelle in cui "severe sanzioni sono previste e vengono effettivamente applicate per sostenere una politica contro l'opposizione" (v. Lasswell e Kaplan, 1950, pp. 74-75). Più precisamente, la coercizione opera nel modo seguente. Un attore minaccia un altro o altri con sanzioni negative se essi agiranno (o non agiranno) in un determinato modo: la minaccia viene ritenuta concreta, e fa sì che chi subisce la coercizione cerchi di evitarla agendo (o non agendo) nella maniera desiderata da chi la esercita. L'uso della coercizione si basa sul presupposto che gli individui abbiano una certa (limitata) gamma di desideri dati e costanti e di preferenze anch'esse date che determinano l'ordine di priorità dei bisogni, poste certe condizioni e conseguenze attese. (Per 'preferenze' intendiamo qui disposizioni strutturate a scegliere determinati stati di cose piuttosto che altri, che implicano a loro volta disposizioni ad agire, in certe condizioni, in un modo piuttosto che in un altro). A parità di altre condizioni, A preferisce vivere nella sua casa piuttosto che venderla. Se un membro della mafia minaccia di ricorrere alla violenza se A non vende la casa, tale preferenza rimane immutata. Ma se A preferisce evitare il rischio che gli venga fatto del male e quindi decide di vendere la casa, può modificare il proprio obiettivo in questa nuova, mutata situazione, date le conseguenze che ora comporta la scelta di non vendere.
La coercizione presuppone come dati i desideri e le preferenze del soggetto. Può darsi che essa non funzioni: l'attaccamento che A nutre per la propria casa, o il suo coraggio di fronte al pericolo potrebbero indurlo a resistere alle minacce della mafia (ad esempio sfidandole apertamente, o cercando l'aiuto di un mediatore). Ma se la coercizione funziona, lo si deve al fatto che essa modifica l'obiettivo specifico di A e quindi il suo comportamento in una data situazione, non già i suoi desideri e le sue preferenze costanti. Di fatto, per essere efficace, la coercizione si basa su tali desideri e preferenze, in quanto presuppone che nella situazione di minaccia l'alternativa in precedenza preferita, una volta associata alla sanzione negativa, non verrà più perseguita.
Nella coercizione, la volontà del soggetto che la esercita prevale sulla volontà di colui che la subisce: il primo modifica le condizioni in cui possono operare le preferenze del secondo, assegnando nuovi 'prezzi' alle alternative. Naturalmente, una modificazione di questo tipo si verifica anche quando si avanza un'offerta; ma la coercizione, diversamente da quanto accade quando si fa un'offerta, cambia tali condizioni e fornisce una selezione di alternative in contrasto con i desideri del soggetto che la subisce. Chi esercita la coercizione quindi costringe colui che ne è vittima a fare ciò che non vuole fare e quindi ad agire contro la propria volontà. D'altro canto, nella situazione di minaccia, la persona o le persone che subiscono la coercizione, allorché obbediscono, agiscono in conformità ai propri desideri e alle proprie preferenze, e in questo senso agiscono secondo la propria libera volontà.
Di conseguenza, come osservava Georg Simmel (v., 1923³, p. 183), la coercizione implica "la spontaneità e la co-efficienza del soggetto subordinato"; essa "richiede solo un prezzo per la realizzazione della libertà - un prezzo, in verità, che non siamo disposti a pagare". In questo senso, nelle situazioni di potere coercitivo i soggetti che subiscono la coercizione, per quanto la loro libertà risulti diminuita, continuano nondimeno ad agire liberamente. Come ha osservato Wartenberg (v., 1990, p. 100) "Sebbene una situazione di coercizione limiti lo spazio di azione di un agente, tuttavia non lo priva della capacità di scegliere tra le alternative che gli vengono presentate da chi esercita la coercizione".
Un'efficace descrizione dei modi in cui le vittime della coercizione possono diventarne complici è dato da Vaclav Havel ne Il potere dei senza potere (Milano 1991), in cui viene descritta la vita sotto il regime comunista nell'ex Cecoslovacchia. Per quale ragione, si chiede Havel, un fruttivendolo espone tra le sue mercanzie un'insegna in cui si legge "lavoratori del mondo, unitevi!", anche se né lui, né i suoi clienti, né i passanti credono in tale messaggio? La risposta, scrive Havel, è che così facendo "egli dichiara la propria fedeltà (e non può farlo altrimenti se vuole che la sua dichiarazione venga accettata), nel solo modo che il regime è in grado di recepire, ossia accettando il rituale prescritto, accettando le apparenze come realtà, accettando le regole fissate del gioco. Così facendo, tuttavia, diventa egli stesso una pedina del gioco, rendendone possibile la continuazione e l'esistenza stessa".
A differenza della forza, la coercizione richiede che vi sia comunicazione tra gli agenti coinvolti nella relazione di potere. Affinché una minaccia sia credibile, coloro che subiscono la coercizione debbono averla compresa nel momento in cui è stata formulata e credere nella sua sincerità, nella plausibilità dei motivi per cui viene fatta e nella capacità di chi esercita la coercizione di metterla in atto. Ma questa comprensione e queste convinzioni possono rivelarsi erronee, in quanto si basano su una sopravvalutazione o viceversa su una sottovalutazione delle minacce intese. Possono persino rivelarsi illusorie: A potrebbe sbagliarsi nel ritenere che B possa o voglia attuare la sua minaccia, o addirittura nel credere che B lo stia effettivamente minacciando. Come accennato in precedenza, la coercizione è una forma di potere più economica rispetto alla forza. Quando è efficace, è sufficiente prospettare una minaccia per far sì che gli altri si conformino alla nostra volontà, e quando è massimamente efficace, la minaccia non ha nemmeno bisogno di essere formulata, perché tale effetto consegue dalla sua anticipazione attraverso la cosiddetta 'legge delle reazioni anticipate' (v. Friedrich, 1963, cap. 11). In questo caso, la semplice potenzialità della minaccia diventa un condizionamento all'interno di una relazione di dominio esistente: l'attore subordinato (il fruttivendolo, per riprendere l'esempio di Havel) si comporta come se la minaccia fosse stata formulata.
Al pari della forza, tuttavia, anche la coercizione implica un conflitto di volontà, e in due modi. In primo luogo, essa consiste nel prevalere sulla volontà di un altro nel senso sopra indicato, e in secondo luogo, è intrinsecamente incline a ingenerare resistenza. Le forme di potere che ci accingiamo a considerare costituiscono tutte sistemi per prevenire, evitare o vincere conflitti e resistenze.
Manipolazione
Considereremo due tipi di 'manipolazione' - indicando con questo termine semplicemente la capacità di ottenere che un altro o altri si conformino alla nostra volontà mediante l'uso strategico di un'arte o abilità (senza implicare che ciò debba necessariamente tradursi in un danno o in un inganno nei confronti dei soggetti manipolati, né che agire in questo modo sia sempre o nella maggior parte dei casi condannabile).
Il primo tipo di manipolazione si basa, al pari della coercizione, sul fatto che gli agenti hanno desideri fissi e preferenze costanti che strutturano tali desideri. La forma più semplice e ovvia di questo tipo di manipolazione è l'induzione o allettamento, ossia la capacità di raggiungere i propri scopi o di assicurarsi la propria posizione avanzando delle offerte - corrompendo, subornando o cooptando un altro o altri. Come nel caso della coercizione, l'induzione può non andare a buon fine qualora i desideri e le preferenze degli agenti siano diversi da quelli previsti: non è vero che ogni persona ha un prezzo. (Di fatto, a differenza della coercizione, l'induzione può anche agire attraverso la creazione di nuovi desideri e preferenze, piuttosto che attraverso una modificazione delle disposizioni esistenti. In questo caso, l'induzione sarebbe una forma di influenza, che analizzeremo in seguito).
I governanti hanno conosciuto e praticato da tempo immemorabile tali pratiche di manipolazione, trasformando i potenziali co-operatori in collaboratori. Un'altra tecnica analoga è quella sintetizzata nell'antica massima 'divide et impera', che si riferisce a tutti i modi esistenti per prevenire, scoraggiare e distorcere la comunicazione tra attori subordinati o rivali.
La nostra attenzione si focalizzerà in particolare su tre tecniche di manipolazione, prescelte da William H. Riker quali esempi della cosiddetta 'erestetica' - ossia la capacità di un agente di indurre gli altri a coalizzarsi o a stringere alleanze con lui "strutturando il mondo in modo da assicurarsi la vittoria" (v. Riker, 1986, p. IX) - che viene messa in atto tipicamente nelle situazioni di voto. Prevalendo su B in una votazione, A se ne assicura l'obbedienza solo perché B accetta l'esito della votazione. Le tre tecniche che ci accingiamo ad illustrare presuppongono l'esistenza di attori con desideri dati ordinati in base a preferenze date, che si trovano a scegliere tra una serie di alternative comparabili lungo una o più dimensioni, e ricorrendo a una o più procedure decisionali. Sono tutte, in breve, applicazioni della teoria delle decisioni o delle scelte sociali, che descrive e analizza il modo in cui le preferenze individuali si trasformano in decisioni collettive. Tali tecniche possono comunque essere illustrate anche con esempi di tattiche politiche tratti sia dal mondo antico che da quello moderno (v. Riker, 1986).
La prima delle tecniche in questione è costituita dal controllo sull'ordine del giorno: la possibilità di determinare quali questioni debbano essere decise, in che modo e in quale ordine, consente di realizzare ordini del giorno che determinano la vittoria di alternative differenti. Ad esempio, Charles Plott e Michael Levine constatarono che l'aeroclub di cui Levine era membro, dovendo decidere in merito alla composizione della flotta, poteva essere indotto a prendere la decisione voluta da Levine strutturando in un certo modo l'ordine del giorno. Partendo da questo fatto, i due autori hanno cercato di dimostrare, ad un livello più generale ed astratto, che attraverso il controllo sull'ordine del giorno si possono controllare i risultati del processo decisionale, assumendo una data distribuzione di ordinamenti delle preferenze e sulla base di previsioni realistiche sulle probabili strategie di voto degli individui.
Basandosi su una serie di esperimenti condotti su gruppi di studenti (ad ognuno dei quali era stato promesso un determinato schema di ricompense per indurre un particolare ordinamento delle preferenze), Plott e Levine esplorarono ingegnosamente i controfattuali (cosa sarebbe accaduto altrimenti?) applicando differenti ordini del giorno a gruppi di persone con la stessa struttura di preferenze. La loro ricerca dimostra in effetti che tale controllo sull'ordine del giorno è possibile (v. Plott e Levine, 1978).
Riker cita in proposito una vicenda narrata da Plinio il Giovane (Epistolario, libro VIII, lettera XIV), il quale cercò - senza peraltro riuscirvi - di mettere in atto una tecnica di questo tipo. In qualità di pretore, Plinio si trovò ad affrontare il caso di un gruppo di liberti accusati di fronte al Senato di aver ucciso il console Afranio Destro. I senatori avevano tre alternative - proscioglimento (P), condanna all'esilio (E), condanna a morte (M) - ed erano schierati in tre gruppi con i seguenti ordinamenti delle preferenze: favorevoli al proscioglimento PEM 45%; favorevoli all'esilio EPM 35%; favorevoli alla pena di morte MEP 20%. Come si vede, la condanna all'esilio rappresentava il 'vincitore di Condorcet' (l'alternativa che può battere qualsiasi altra in un confronto testa a testa) - con una chiara maggioranza sulle altre due, come rivelerebbe una procedura binaria (due scelte del tipo e/o: 'colpevole o innocente?' e 'esilio o morte?'). Plinio, che era favorevole al proscioglimento, cercò di assicurarsi questo risultato insistendo sull'adozione di una procedura 'ternaria', ossia facendo schierare i senatori in tre gruppi e dichiarando vincitore quello con il maggior numero di voti per la prima preferenza. Se questa strategia avesse funzionato, il controllo sull'ordine del giorno avrebbe determinato il proscioglimento degli imputati.
La seconda tecnica è quella del voto strategico, in cui i votanti si servono della risorsa rappresentata dal proprio voto per sconfiggere un vincitore apparentemente certo (un risultato di 'equilibrio'), oppure per contrastare un atto di controllo sull'ordine del giorno votando in modo 'non miope'. Votare in modo strategico significa abbandonare l'alternativa preferita quando è possibile sconfiggere un avversario e guadagnare qualcosa per sé optando per la seconda scelta del proprio ordinamento delle preferenze. Nel caso citato in precedenza, ad esempio, i senatori favorevoli alla pena di morte passarono dalla parte di quelli favorevoli all'esilio, vanificando in questo modo la manovra di Plinio.
La terza tecnica è quella della manipolazione delle dimensioni o degli aspetti della decisione, che consiste essenzialmente nel modificare i termini della questione sulla quale ci si confronta con l'avversario, alterando così una posizione di equilibrio in cui quest'ultimo ha una effettiva maggioranza. Riker cita in proposito l'esempio di Abraham Lincoln, il quale nel 1858 si trovò ad affrontare Stephen Douglas, il senatore democratico in carica, nella campagna per l'elezione dei candidati all'assemblea legislativa dell'Illinois. Domandando a Douglas se le assemblee legislative territoriali potevano abolire lo schiavismo, Lincoln spostò l'attenzione dalla dimensione economica, sulla quale i democratici potevano contare su una maggioranza consolidata, alla questione dello schiavismo, sulla quale sussisteva invece una frattura tra sudisti e nordisti: se avesse risposto affermativamente, Douglas avrebbe guadagnato l'Illinois ma avrebbe perso ogni speranza per la carica presidenziale.
La manipolazione delle dimensioni, scrive Riker (v., 1986, p. 150), "è lo stratagemma erestetico di gran lunga più praticato, uno stratagemma che i politici adottano costantemente".
Il secondo tipo di manipolazione differisce dal primo nonché dalla coercizione in quanto costituisce una forma di quella che chiameremo influenza: consiste infatti nel predisporre o nel condizionare la volontà degli agenti, o i loro desideri, preferenze e credenze. Se 'erestetica' è il neologismo coniato da Riker per indicare l'antica arte del primo tipo di manipolazione, 'retorica' è la denominazione tradizionale di un'arte non meno antica del secondo tipo. Laddove lo scopo della manipolazione del primo tipo è quello di strutturare le alternative degli agenti lasciando immutate le loro preferenze, l'obiettivo di questo secondo tipo di manipolazione è quello di modificare tali preferenze, ad esempio persuadendo gli attori a pensare e comportarsi in determinati modi anziché in altri.
Il potere manipolatorio del secondo tipo (che è anche la prima forma di influenza che considereremo) può agire come forma di controllo sia di individui che di agenti collettivi. Può essere usato per scoraggiare o prevenire l'azione collettiva, o la formazione collettiva della volontà, impedendo che vengano a crearsi le condizioni esaminate in precedenza che la rendono possibile; ciò può essere fatto in vari modi: incentivando i potenziali cooperatori a privilegiare gli interessi a breve termine anziché quelli a lungo termine, scoraggiando l'altruismo, promuovendo norme che sfavoriscono la cooperazione (come la regola dell'omertà nell'Italia meridionale), oppure propagando o inculcando un atteggiamento fatalistico e pessimistico in merito alla possibilità stessa che l'azione collettiva riesca a raggiungere risultati positivi per gli individui che potrebbero altrimenti essere spinti a parteciparvi.
Ma il potere manipolatorio (come dimostrano gli ultimi esempi menzionati) può essere esercitato anche sui singoli individui influenzandone direttamente la volontà. Ciò può avvenire nel lungo periodo, come nel caso degli effetti nel tempo della socializzazione, oppure 'situazionalmente' - vale a dire, il contesto d'azione del soggetto può determinarne i desideri e le preferenze. In questo caso è la struttura delle alternative ad influenzare le credenze e i desideri del soggetto. La manipolazione può modificare tale struttura, la quale a sua volta può modificare le preferenze. Consideriamo la situazione esemplificata dall'aneddoto della volpe e dell'uva, in cui gli attori modificano le proprie aspirazioni adattandole a ciò che considerano possibile. In casi del genere, essi adattano endogenamente le proprie preferenze alla situazione, attraverso l'accettazione passiva o la rassegnazione, o per ridurre la dissonanza cognitiva. Il potere consiste qui nell'imporre delle restrizioni alle quali gli attori reagiscono endogenamente. In parole più semplici, le persone possono essere assoggettate e persino domate quando sono poste di fronte a ruoli subordinati e a ineguaglianze consolidate, laddove coloro che traggono vantaggio da tali ruoli e ineguaglianze hanno a disposizione vari mezzi per farli apparire naturali, inevitabili o immutabili.
Jon Elster ha messo in discussione l'assunto che "la rassegnazione sia indotta in generale da coloro che ne traggono vantaggio", e che "i governanti abbiano realmente il potere di indurre deliberatamente determinate credenze e desideri nei governati" (v. Elster, 1983, pp. 115-117). Secondo Elster, i desideri e le credenze che sono alla base della rassegnazione sono "essenzialmente effetti collaterali", ossia stati che possono prodursi solo come conseguenze secondarie di azioni intraprese per altri scopi. Si tratta di stati che non possono essere indotti consapevolmente o intenzionalmente, giacché il tentativo stesso di crearli ne impedisce il verificarsi (ibid., cap. II). Esempi al riguardo sono stati individuali quali la spontaneità o il sonno, oppure stati sociali quali i benefici effetti educativi della partecipazione democratica. Per Elster, la rassegnazione di coloro che sono soggetti al potere dei governanti o delle classi dominanti (e cita in proposito il metodismo durante la rivoluzione industriale in Inghilterra) costituisce un esempio di tali "stati che sono essenzialmente effetti collaterali" (ibid., pp. 116-117).
Alla tesi di Elster tuttavia si possono muovere tre obiezioni. In primo luogo, non è lecito assumere che la rassegnazione sia stata indotta dai detentori del potere a meno che non vi siano prove concrete al riguardo. In secondo luogo, non è chiaro perché la rassegnazione debba essere essenzialmente un effetto collaterale, né perché non possa talvolta essere perseguita e prodotta deliberatamente - attraverso l'indottrinamento, o il simbolismo, o il rituale, o inculcando semplicemente la convinzione che non esiste alcuna alternativa allo status quo. In terzo luogo, Elster a sua volta parte dal presupposto che il potere manipolatorio debba essere intenzionale, ma (come abbiamo accennato in precedenza e come vedremo meglio in seguito), il rapporto tra potere e intenzioni costituisce un problema assai complesso e controverso.
Come si è detto, il potere manipolatorio inteso come influenza sulla volontà può operare sia nel lungo termine, attraverso la socializzazione, sia situazionalmente, attraverso il condizionamento delle preferenze. Esso può consistere anche in atti diretti di comunicazione che influenzano le credenze e i desideri degli agenti. Tale influenza può essere 'calda' oppure 'fredda' (o un misto delle due), a seconda che si focalizzi sulle passioni e sulle emozioni oppure sulla consapevolezza e sulla ragione. Approssimativamente, si potrebbe dire che ciò che rende tale persuasione manipolatoria piuttosto che razionale è l'uso strategico dell'arte o della capacità di superare (ma non necessariamente di sovvertire) la 'forza dell'argomento migliore'.
Nell'ambito dell'influenza manipolatoria della varietà 'calda' rientrano tutte le forme di persuasione emozionale di cui i massimi esperti sono i bambini, i pubblicitari e i retori. L'influenza manipolatoria 'fredda' opera invece sulla dimensione cognitiva, influenzando la visione del mondo degli individui. Il modo più semplice di esercitare tale potere consiste nel servirsi del controllo sull'informazione, ad esempio mediante la censura. In forma più sottile, però, le credenze possono essere influenzate attraverso il modo in cui vengono 'strutturate' le questioni e formulati gli argomenti - e in questo campo, ancora una volta, i retori sono i maggiori esperti. L'influenza della varietà 'fredda' è stata studiata in modo approfondito dagli psicologi cognitivisti, in particolare da Amos Tversky e dai suoi collaboratori. La sua presenza è segnalata da una modificazione della desiderabilità delle alternative quando la situazione di scelta è ristrutturata in un modo che, sul piano razionale, non comporta alcuna differenza: ad esempio, dovendo decidere tra il trattamento con i raggi e la chirurgia quale terapia per il cancro ai polmoni, i soggetti (inclusi i medici) effettuano scelte che dipendono dal modo in cui vengono presentate le statistiche - come statistiche sui tassi di mortalità oppure sui tassi di sopravvivenza. Sembra che, tipicamente, la scelta venga effettuata tra descrizioni di alternative piuttosto che tra le alternative stesse. Il potere di strutturazione può avere quindi effetti di notevole portata.
La formulazione di argomenti è l'elemento essenziale dell'arte della retorica e costituisce un altro importante tipo di potere manipolatorio. Si consideri, ad esempio, il recente studio di Albert Hirschman sulla 'retorica della reazione'. Hirschman individua tre 'tesi' o strutture di argomenti avanzati contro le riforme negli ultimi due secoli: contro il principio di eguaglianza davanti alla legge e contro i diritti civili nel XVIII secolo, contro il suffragio universale nel XIX secolo e contro il Welfare State nel XX secolo. La prima tesi è quella dell"effetto perverso', secondo cui "ogni azione che mira a migliorare un qualche aspetto dell'ordine politico, sociale o economico esistente serve solo a peggiorare la situazione che si intende correggere"; la seconda è quella della futilità, secondo cui "i tentativi di trasformare la società risulteranno vani, semplicemente, non sortiranno alcun effetto"; la terza tesi, infine, è quella della messa a repentaglio, secondo cui "i costi del cambiamento o della riforma proposti sono troppo alti, in quanto mettono a repentaglio altri, importanti risultati già conseguiti" (v. Hirschman, 1991, p. 6). Ciò che rende retorici - e quindi manipolatori - questi argomenti (e le controtesi 'progressiste' individuate da Hirschman) è il loro carattere intransigente: la loro scaltra refrattarietà ai dettagli delle situazioni reali che dovrebbero illustrare nonché a "soluzioni di compromesso costruttive" (ibid., p. 169). Essi richiamano inoltre miti potenti (l'hybris-nemesi, la divina Provvidenza, il mito di Edipo), nonché insidiose e influenti formule interpretative. Il potere della retorica consiste nell'influenzare le menti, e quindi le volontà, impiegando risorse di questo genere per rendere convincenti gli argomenti (il che non significa negare che possa trattarsi a volte di argomenti sostenibili razionalmente).
Autorità
Un altro, distinto tipo di influenza, che è una forma di potere sulle credenze o in alternativa sulle azioni di altri, è l'autorità. Laddove la manipolazione implica un'arte o una capacità che trascende e talvolta sovverte i dettami della ragione, l'autorità esclude l'uso della ragione e nello stesso tempo vi fa appello. Da un lato, infatti, essa richiede che il soggetto non eserciti la propria facoltà di giudizio; dall'altro invoca una giustificazione per imporre tale rinuncia. Accettando l'autorità, A accetta come ragione sufficiente per agire in un certo modo o credere in qualcosa il fatto che così gli è stato ordinato da qualcuno cui riconosce il diritto di farlo. Accettare l'autorità significa precisamente astenersi dall'analizzare criticamente ciò che viene imposto di credere o di fare; significa quindi agire o credere non sulla base di una valutazione delle ragioni, bensì sulla base di una ragione di secondo ordine, o meta-ragione, la quale impone di rinunciare all'autonoma valutazione delle ragioni. Analogamente, esercitare l'autorità significa non dover offrire ragioni, ma essere obbediti o creduti perché si ha un diritto riconosciuto ad esserlo. Hobbes coglie questo punto centrale allorché traccia la seguente distinzione tra raccomandazione (consiglio) e autorità (comando): "il consiglio è un precetto in cui la ragione dell'obbedienza deriva dalla cosa stessa che viene consigliata; il comando invece è un precetto in cui la causa della obbedienza è la volontà di chi comanda. Infatti è improprio dire 'io comando', se non quando la volontà si sostituisce alla ragione. Ora, quando si obbedisce alle leggi non in virtù della cosa stessa, ma in ragione della volontà del consigliere, la legge non è un consiglio ma un comando" (De cive, cap. 14, parte I).
L'autorità, dunque, offre una ragione di primo ordine per agire e/o credere e una ragione di secondo ordine per ignorare le ragioni contrastanti. È degno di nota il fatto che l'esercizio dell'autorità non deve essere necessariamente intenzionale: si può accettare come autoritativo ciò che è stato inteso, ad esempio, come un semplice consiglio. Inoltre, cosa debba valere o meno come autoritativo dipende dal punto di vista dal quale si definisce l'autorità. Questa può essere definita in primo luogo dal punto di vista di coloro che la detengono o la esercitano e di coloro che vi sono soggetti o la accettano; in secondo luogo dal punto di vista delle norme prevalenti in una data società - sia leggi ufficiali quali sono interpretate dai magistrati, dai tribunali e dai rappresentanti dello Stato, sia norme non ufficiali che governano le credenze e le pratiche di una società (e che spesso sono in conflitto tra loro); in terzo luogo da un punto di vista impersonale e che si presume 'oggettivo' dal quale può essere giudicata ogni pretesa di autorità. Ognuna di queste prospettive offre una risposta diversa alla domanda: cosa rende autoritativa una proposizione? Il terzo punto di vista fornisce una definizione 'normativa' o non relativistica; l'autorità è legittima se risponde a determinati standard 'razionali'; il primo fa dipendere la risposta dalle credenze e dagli atteggiamenti delle parti coinvolte (autorità de facto); il secondo fa riferimento alle norme prevalenti, indipendentemente dalle credenze e dagli atteggiamenti delle parti interessate (autorità de jure). Quest'ultimo è il punto di vista adottato tipicamente dai sociologi del diritto, come ad esempio Max Weber, secondo cui quali che siano i motivi per cui si obbedisce ad un comando, ciò che conta è il suo fondamento legale.
Poiché l'accettazione dell'autorità esclude un esame dei contenuti di una proposizione, occorre un qualche criterio per identificarne la fonte come autoritativa - un criterio in grado di stabilire chi è legittimato a possedere e a esercitare l'autorità. Hobbes parla in proposito di "segni dai quali si può discernere in quale individuo od assemblea sia posto il potere sovrano e da chi sia detenuto" (Leviatano, cap. XVIII), e Jeremy Bentham di "un segnale comune [...] noto e visibile a tutti" (A fragment on government, a cura di W. Harrison, Oxford 1948, p. 90). È istruttivo considerare la varietà di questi tratti distintivi o segnali nelle diverse epoche storiche e nelle diverse società: l'età; il sesso; lo status legato alla parentela, all'occupazione, alla casta o alla razza; la ricchezza e le proprietà; l'onore e la considerazione di ogni tipo; il valore militare; le pretese religiose, di tipo sia tradizionale che carismatico; le credenziali; il ruolo funzionale; l'ufficio o la carica; la fama stessa di essere potenti. Tale criterio di identificazione per designare la fonte di proposizioni autoritative richiede l'esistenza di 'regole di riconoscimento' accettate che consentano alle parti di distinguere chi è dotato di autorità da chi non lo è. Non si tratta necessariamente di regole formalizzate; potrebbero essere benissimo norme non esplicitate soggette a un'interpretazione altamente personale. Possiamo citare come esempio il seguente passo del Re Lear:"Kent: [...] avete qualcosa nella fisionomia che mi piacerebbe di poter chiamare padron mio.Lear: E che cos'è?Kent: Autorità." (Atto I, scena IV; tr. it., Milano 1992, p. 71). E talvolta l'interpretazione può essere innovativa, persino rivoluzionaria, come nel caso dell'autorità carismatica weberiana.Accettare l'autorità come una ragione per agire o per credere esclude la considerazione di ragioni contrastanti, ma solo di ragioni di un certo tipo. Vi è, di fatto, una considerevole variazione rispetto alla gamma di ragioni che la ragione autoritativa esclude.
Chi è soggetto all'autorità può essere nondimeno autorizzato ad agire in base alla propria coscienza o a determinati interessi (ad esempio in vista della sopravvivenza, come sosteneva Hobbes, o per salvaguardare i propri interessi personali, come sosteneva J.S. Mill), oppure ancora sulla base di un'altra autorità, ad esempio quella del sovrano, quando questi sia presente nell'ambito della giurisdizione di un signore feudale. Nel caso dell'autorità una ragione non prevale su altre ragioni contrastanti perché ha maggior peso: piuttosto, le esclude in virtù della sua natura, non della sua forza. Possono essere escluse anche ragioni molto forti (come quando un soldato mette a rischio la propria vita). Il punto essenziale è che l'autorità esclude l'azione o la credenza basate sulla valutazione delle ragioni. D'altro canto, coloro che accettano l'autorità assumono che vi sia una buona ragione per tale esclusione, e che l'autorità ci guidi nella stessa direzione che si presume indicata dalla ragione, ossia che le proposizioni autoritative contengano, come osserva Carl Friedrich (v., 1958, p. 35), "la potenzialità di un pensiero razionale". O ancora, come scrive Diderot nell'articolo Autorità dell'Encyclopédie, l'autorità è un utile strumento per guidarci verso scopi razionali: la ragione è "una torcia accesa dalla natura e destinata a illuminarci", mentre l'autorità "non è altro che un bastone creato dall'uomo, che ha la virtù di aiutarci, nella nostra debolezza, lungo la strada indicata dalla ragione".
L'autorità può essere esercitata sulla credenza, oppure sull'azione. Tale distinzione viene spesso espressa dalla contrapposizione tra 'essere un'autorità' ed 'avere autorità'. Accettare l'autorità intesa nel primo senso significa accettare come valide o vere certe proposizioni perché la loro fonte è riconosciuta come un'autorità. Rientrano in questa definizione un continuum di casi che vanno dalla cieca fede (ad esempio nei sacerdoti o nei profeti) all'accettazione fondata razionalmente (ad esempio dell'opinione degli esperti).
Nelle epoche e nelle società premoderne l'autorità di questo tipo equivale al possesso di un qualche status, o qualità o pretesa speciali che forniscono un motivo convincente per la fiducia o l'obbedienza: tale status ecc. può derivare da una relazione privilegiata con un atto di fondazione o un principio originario o un'entità sacra, oppure dalla conoscenza di un corpus di verità inaccessibili agli altri. L'autorità è rivendicata sulla base di un sapere o di una rivelazione o di una intuizione o di una conoscenza speciali. Ciò presuppone, ovviamente, l'assunto epistemologico che tale conoscenza sia accessibile. L'autorità vista in questi termini è intrinsecamente inegualitaria, poiché coloro che hanno un accesso privilegiato a tale conoscenza sono per ciò stesso superiori agli altri e hanno diritto alla loro deferenza e alla loro sottomissione.
D'altro canto, nella misura in cui manca l'idea di un accesso privilegiato alla conoscenza di verità (di tipo religioso, morale o scientifico) in virtù di una rivelazione, o di un particolare status, o di una carica, oppure di una qualche capacità naturale, l'autorità può essere accettata semplicemente sulla base di considerazioni pragmatiche di convenienza e di economia degli sforzi. Ci affidiamo all'autorità degli esperti in tutti gli ambiti della vita (così come gli esperti si affidano all'autorità di altri esperti), in parte perché crediamo che il loro sapere sia sperimentato e verificato, in parte perché è accessibile al pubblico controllo.
Diversa dall'autorità sulla credenza è l'autorità sulla condotta. In questo caso l'autorità è vista in termini di decisioni vincolanti che inducono l'obbedienza, la cui fonte si assume sia accettata volontariamente come autoritativa da coloro che vi si sottomettono. L'autorità di questo tipo può essere vista come una soluzione ai problemi dell'azione collettiva. La coordinazione nell'azione collettiva è necessaria, ma potrebbe risultare impossibile da ottenere se ognuno agisce di testa propria. La pretesa all'obbedienza da parte di uno o più individui che hanno autorità non si fonda sulla rivendicazione di una relazione privilegiata con le origini della tradizione o con entità sacre, o con un sapere speciale, bensì sul fatto di essere investiti di autorità attraverso una qualche procedura consensuale o accettabile in vista di uno scopo comune giustificabile razionalmente.
Chi è soggetto a questo tipo di autorità è obbligato per sua volontà (entro certi limiti), qualunque sia la sua valutazione personale in un dato caso, in quanto l'azione collettiva richiede la rinunzia al proprio giudizio individuale. Si noti, tuttavia, che a differenza dell'autorità sulla credenza, che esige necessariamente l'assenso di coloro che vi sono soggetti (ossia: se si crede ad un'opinione sulla base dell'autorità, non si può nello stesso tempo dissentire da essa), l'autorità sulla condotta richiede semplicemente che coloro che vi sono soggetti rinuncino ad agire di testa propria, pur restando liberi di dissentire in privato dai comandi specifici di cui accettano l'autorità.L'autorità accettata volontariamente è dunque tanto un'espressione quanto una restrizione della libertà individuale. Per Hobbes e per Spinoza l'esistenza stessa della società richiede l'accettazione di un'autorità così intesa, onde garantire la necessaria sicurezza della vita sociale; per la tradizione liberale da Locke in poi, invece, i requisiti per la coordinazione sono più specifici, e impongono un sacrificio più limitato del diritto all'autonomia individuale. La costituzione è uno strumento per distribuire poteri, per garantire l'autorità e i diritti e per tutelare la libertà.
Qual è, allora, il rapporto tra autorità e potere, tra libertà e ragione? È forse l'autorità, come suggerito in precedenza, un mezzo, giustificato razionalmente e accettato liberamente, per conseguire i nostri fini, un semplice bastone che ci aiuta lungo la strada mostrata dalla ragione? Dubbi in proposito sono stati avanzati da almeno due direzioni. Quanti pongono in primo piano la difesa dell'autonomia (kantiana) individuale (ma non Kant stesso) vedono un conflitto irriducibile tra l'autorità, il diritto di governare da un lato, e l'autonomia, il rifiuto di essere governati dall'altro.
Nella sua formulazione più estrema (o più coerente) questa posizione si traduce in un anarchismo filosofico il quale, partendo dal presupposto che "tutti hanno il dovere permanente di acquistare il massimo grado possibile di autonomia", arriva alla conclusione che "ogni autorità è egualmente illegittima" e che "non esiste alcuno Stato i cui cittadini abbiano un obbligo morale ad obbedire ai suoi comandi" (v. Wolff, 1970, p. 19). Da un'altra direzione i 'realisti', da Trasimaco agli esponenti neomachiavelliani della teoria elitaria ad altri ancora, hanno obiettato che sia l'autorità sulla credenza sia la presunta accettazione volontaria dell'autorità sulla condotta hanno sempre natura illusoria: ciò che è autoritativo è sempre autoritario, perché le ragioni che ne giustificano l'accettazione e le regole di riconoscimento sono sempre maschere ideologiche, razionalizzazioni, 'derivazioni' o 'formule politiche' dietro cui si cela la force majeure dei governanti. Per Max Weber, il cui pensiero era vicino a questa forma di 'realismo', il riconoscimento volontario dell'autorità come legittima non è che una tra le tante possibilità. "Il comando - scrive Weber - può essere eseguito, a seconda dei casi, in virtù della convinzione personale della sua giustizia, o in virtù di un sentimento di dovere, o per paura, per 'sorda abitudine', per un vantaggio personale" (v. Weber, 1922; tr. it., vol. IV, p. 49). E di fatto, è legittimo chiedersi in che misura quella che appare come autorità legittima non sia in realtà il prodotto di una delle forme di coercizione e/o manipolazione analizzate in precedenza.
Persuasione razionale
A prima vista sembra che la 'persuasione razionale' non debba trovar posto in una tipologia dei meccanismi di potere, poiché se B accetta autonomamente le ragioni di A per credere qualcosa o per agire in un certo modo, sembrerebbe naturale concludere che sono queste ragioni, o forse la loro accettazione da parte di B, a determinare la sua credenza o la sua condotta, e non già il potere di A. In effetti, come abbiamo accennato in precedenza, è proprio in opposizione alla pura forza della ragione o dell'argomentazione che si può identificare il potere manipolatorio come tale (anche se esso può essere utilizzato per ottenere l'accettazione di conclusioni razionalmente fondate). Tuttavia occorre prender nota qui di una significativa corrente di pensiero contemporanea, la quale mette in discussione la nozione stessa di autonomia della ragione e cerca di stabilire vari collegamenti tra il potere da un lato e la conoscenza e la sfera discorsiva dall'altro.Secondo Michel Foucault "l'esercizio del potere è sempre associato ad una certa economia dei discorsi di verità che agiscono attraverso questa associazione e sulla base di essa. Siamo soggetti alla produzione di verità attraverso il potere e non possiamo esercitare potere se non attraverso la produzione di verità" (v. Foucault, 1980).
Il passo diventa un po' meno oscuro se si richiama alla mente l'osservazione di Nietzsche che la verità "è un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane che sono state potenziate poeticamente e retoricamente, che sono state trasformate ed abbellite, e che dopo un lungo uso sembrano a un popolo solide, canoniche e vincolanti" (Cfr. F. Nietzsche, Über Warheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, 1873; tr. it.: Su verità e menzogna in senso extramorale, in Opere complete, a cura di G. Colli e M. Montinari, Milano 1980², vol. II, tomo III, p. 361). Le verità, continua Nietzsche, sono "illusioni": un esercito che occupa le nostre menti, le colonizza addirittura sotto le spoglie dell'obiettività. Il potere così inteso è la capacità di influenzare, persino di 'formare' la concezione del mondo e di se stessi di altri individui.
A ciò Foucault aggiunge l'idea che nell'ambito della moderna "società di normalizzazione" il potere opera come "una fitta griglia di coercizioni disciplinari" le quali comportano "un costante soggiogamento" attraverso "continui e ininterrotti processi che assoggettano i nostri corpi, governano i nostri gesti, dettano i nostri comportamenti, ecc.". In questo modo, secondo Foucault, "i soggetti sono formati gradualmente, progressivamente, realmente e materialmente attraverso una molteplicità di organismi, forze, energie, materiali, desideri, pensieri, ecc.". Le persone diventano così soggetti in un duplice senso: soggetti ad altri "attraverso il controllo e la dipendenza" e "legati alla propria identità mediante la coscienza e l'autoconoscenza". In questo modo, tutti i "micromeccanismi del potere" - quali gli "apparati di sorveglianza, la medicalizzazione della sessualità, della follia, della delinquenza" - strutturano il nostro campo d'azione, rendendoci liberi e schiavi nello stesso tempo. In breve, ogni discorso apparentemente oggettivo è parte integrante di un sistema di assoggettamento; e così i tentativi apparentemente razionali di persuasione non sono che esempi del modo in cui tale sistema opera attraverso il medium della coscienza e dell'autoconoscenza dei soggetti coinvolti. Non ci è chiaro in che misura questa tesi di Foucault abbia pretese di universalità, né, se sia da intendersi come universale, in che modo possa essere asserita senza cadere nell'autocontraddizione, e nemmeno chi o cosa siano le entità che esercitano il potere così concepito. Ma anche assumendo che si tratti di questioni senza risposta, ciò che Foucault - sulle orme di Nietzsche - offre è, al minimo, una formula per avanzare il sospetto che ciò che appare come persuasione razionale sia in realtà una forma di discorso repressivo.
Relazioni di potere
Il potere inteso nell'accezione ristretta è detenuto ed esercitato da alcuni individui su altri, ed è quindi il fondamento di relazioni asimmetriche di cui occorre ora esaminare la natura più da vicino. A questo scopo distingueremo tre tipi di relazioni asimmetriche che possono intercorrere tra gli agenti sociali: ineguaglianza, dominio e oppressione.
Ineguaglianza
Quello di ineguaglianza è un concetto puramente distributivo. Essere interessati all'ineguaglianza significa essere interessati alla distribuzione di vantaggi o benefici di vario tipo nella società. Le ineguaglianze possono riguardare beni materiali, quali la ricchezza e le proprietà, il reddito e l'occupazione, oppure beni astratti quali le opportunità di vita, lo status o il prestigio, oppure beni ancora più astratti quali il benessere, la felicità, le risorse umane o le capacità fondamentali. I sociologi che studiano l'ineguaglianza e la stratificazione sociale possono avere opinioni discordi in merito al metodo più adatto per misurarle, e i filosofi interessati alla giustizia egualitaria possono fornire risposte diverse alla questione: "ineguaglianza rispetto a che cosa?"; e tuttavia, nel focalizzare l'attenzione sull'ineguaglianza essi prendono in considerazione i modelli di distribuzione delle risorse trattandoli come stati finali, e lasciano in ombra i processi decisionali e le strutture istituzionalizzate che li hanno ingenerati. Tali processi e strutture possono avere come base il sistema economico - la divisione del lavoro, i mercati, la riproduzione materiale - che dà luogo a ricompense e posizioni sociali differenziate; oppure gerarchie di sovra- e subordinazione che generano differenze di status e di accesso al potere decisionale; oppure ancora possono essere processi e strutture di natura culturale, che generano esclusione e rifiuto attraverso una discriminazione basata sugli stili di vita e le identità di gruppo. Incentrare l'attenzione sulle ineguaglianze significa prendere in considerazione solo i risultati finali di queste strutture e di questi processi, non i processi e le strutture in se stessi.Si è affermato spesso che il potere è uno dei beni distribuiti in modo ineguale in una società improntata all'ineguaglianza, e talvolta esso è considerato una dimensione separata, se non fondamentale, della stratificazione sociale.
Ad esempio Gerhard Lenski osserva che "se potessimo stabilire lo schema [di distribuzione del potere] in una data società, avremmo stabilito lo schema di distribuzione dei privilegi, e se potessimo scoprire le cause di una data distribuzione del potere, avremmo scoperto anche le cause della distribuzione dei privilegi ad essa associata" (v. Lenski, 1966, p. 45). Weber dal canto suo affermava che "le 'classi', i 'ceti' e i 'partiti' costituiscono precisamente fenomeni di distribuzione della potenza all'interno di una comunità" (v. Weber, 1922; tr. it., vol. IV, p. 28). Tuttavia è fuorviante concepire il potere come una dimensione della stratificazione o base dell'ineguaglianza a sé stante, poiché il potere è inteso qui come capacità di individui e gruppi di ottenere ricompense o risorse materiali e sociali scarse. Il concetto di potere è usato qui nell'accezione non ristretta, più generale (che analizzeremo in seguito): non è che un altro modo per designare l'afflusso di ricompense derivante dalla competizione distributiva. Il potere in questo senso (come capacità di assicurarsi vantaggi maggiori) può o meno implicare il potere nel senso ristretto (come capacità di assicurarsi l'acquiescenza o di mantenere la dipendenza). A volte lo implica - come quando in un determinato settore del mercato del lavoro i lavoratori organizzati limitano le alternative di quelli non organizzati -, spesso però non lo implica. La questione che ci accingiamo a discutere - in che misura l'ineguaglianza sia basata su relazioni di potere inteso nel senso ristretto - è una questione aperta di natura empirica.
Dominio
Chiameremo le relazioni di potere inteso nel senso ristretto 'relazioni di dominio', conformemente alle teorie di Weber per il quale il concetto di 'dominio' (Herrschaft) aveva un'importanza centrale.Weber distingueva tra un "significato più generale" e un significato più ristretto del concetto di Herrschaft. Il primo indica semplicemente tutte le strutture di relazioni di potere; in questo senso, "una posizione usualmente designata come 'dominante' può svilupparsi tanto nelle relazioni sociali di un salotto come sul mercato, dall'alto di una cattedra in un'aula di lezione come in una discussione scientifica e nello sport" (v. Weber, 1922; tr. it., vol. IV, p. 45).
Weber pertanto traccia una distinzione tra il dominio "costituito in virtù di una costellazione di interessi (in particolare in virtù della posizione di monopolio)" e il dominio "costituito in virtù dell'autorità (potere di comando e dovere di obbedienza)" (ibid.). Il dominio nel senso ristretto esclude il primo - ossia il dominio "che sia soltanto potere di mercato, oppure che sia condizionato soltanto dalla costellazione degli interessi" (anche se questo, "proprio a causa della mancanza di regole [può] essere ritenuto molto più oppressivo") - ed è identificato con il "potere autoritario di comando". Più specificamente, per dominio "deve dunque intendersi il fenomeno per cui una volontà manifestata ('comando') del detentore o dei detentori del potere vuole influire sull'agire di altre persone (del 'dominato' o dei 'dominati'), ed influisce effettivamente in modo tale che il loro agire procede, in un grado socialmente rilevante, come se i dominati avessero, per loro stesso volere, assunto il contenuto del comando per massima del loro agire ('obbedienza')" (ibid.; tr. it., vol. IV, pp. 48-49).
Queste distinzioni weberiane si riferiscono a 'tipi ideali'; nella realtà i confini tra di essi sono fluidi: le transizioni sono graduali, poiché "una distinzione precisa è spesso impossibile nella realtà; ma proprio per tale motivo è ancora più necessario disporre di concetti chiari" (ibid.; tr. it., vol. I, p. 209). Pertanto ogni tipo di dominio in virtù di una costellazione di interessi può sempre trasformarsi in un dominio autoritario, come quando i rapporti di dipendenza basati sul mercato sono formalizzati in relazioni di autorità formalmente regolate; ad esempio un vassallo entra liberamente in una relazione feudale con il signore, che di conseguenza acquista autorità su di lui; oppure i contratti sul mercato del lavoro - che dal punto di vista formale sono stipulati tra 'eguali', con l'accettazione formalmente 'libera' delle condizioni proposte - diventano posizioni formalizzate entro gerarchie costituite (pubbliche o private). Inoltre, "anche in ogni relazione autoritaria fondata sul dovere un minimo di interesse personale da parte di colui che obbedisce rimane normalmente come indispensabile molla dell'obbedienza" (ibid.; tr. it., vol. IV, p. 47).
Con il concetto di Herrschaft nel senso ristretto Weber intende identificare relazioni strutturate tra superiori e subordinati in cui, tuttavia, l'obbedienza di fatto può basarsi sui motivi più diversi ("cominciando dalla cieca abitudine fino a considerazioni razionali rispetto allo scopo": ibid.; tr. it., vol. I, p. 207) ed essere ottenuta con una grande varietà di mezzi. Il principale merito dell'approccio weberiano è costituito proprio dall'attenzione per tale varietà, e per aver posto il problema dei vari modi in cui le relazioni di potere vengono instaurate e mantenute.
L'ipotesi generale formulata da Weber è che nessun dominio "può accontentarsi per sua volontà di fondare la propria permanenza su motivi esclusivamente affettivi o razionali rispetto al valore"; ogni sistema di dominio "cerca piuttosto di suscitare e di coltivare la fede nella propria legittimità. A seconda della specie di legittimità cui pretende, è però fondamentalmente diverso anche il tipo dell'obbedienza, dell'apparato amministrativo determinato a sua garanzia, del carattere dell'esercizio del potere - e quindi anche la sua efficacia" (ibid.; tr. it., vol. I, p. 208).
Di qui la decisione di Weber di classificare le forme di dominio a seconda del tipo di pretesa di legittimità, poiché questo a suo avviso varia al variare delle relazioni di potere e delle forme di amministrazione, costituendone il fondamento e la spiegazione. In altre parole, "il carattere sociologico [del dominio] risulterà differente a seconda di certe differenze nei fondamenti generali della validità del potere" (ibid.; tr. it., vol. IV, p. 49).I tre "tipi puri di autorità" - tradizionale, razionale-legale e carismatico - definiscono i fondamenti dell'obbedienza prevalenti nelle strutture di dominio (Herrschaft nel senso ristretto).
Essi non si riferiscono ai motivi dell'obbedienza o alle strutture di potere. Gli individui, secondo Weber, possono obbedire per ipocrisia, per opportunismo, per interesse materiale, per debolezza o impotenza, o perché non vi sono altre alternative. "È decisivo il fatto che la sua propria [di un potere] pretesa di legittimità 'valga' a seconda del tipo in una misura rilevante, garantendo la sua sussistenza e insieme determinando la specie dei mezzi di potere prescelti" (ibid.; tr. it., vol. I, p. 209).
I tipi di autorità si basano su tipi di norme che specificano chi o che cosa debba valere come autoritativo. L'autorità tradizionale, quella razionale-legale e quella carismatica esprimono quindi diversi tipi di ragioni o fondamenti di obbedienza avanzati pubblicamente, ognuno dei quali, secondo Weber, tende a prevalere in determinate condizioni e a sua volta è associato a determinate relazioni di potere e forme di amministrazione. Nella teoria weberiana, in una data associazione politica o in un dato ordinamento istituzionale tenderà a prevalere un determinato tipo di autorità: quella razionale-legale è propria dello Stato moderno e delle forme di organizzazione burocratiche, sia pubbliche che private; quella tradizionale caratterizza le società patriarcali, patrimoniali e feudali, mentre l'autorità carismatica si presenta (per venire successivamente routinizzata) nei periodi di transizione nelle comunità di tutte le epoche storiche, compresa quella moderna. Tuttavia, sebbene in una data struttura di dominio tenda a prevalere un certo tipo di autorità "le forme che si trovano nella realtà storica" risultano dalla "combinazione, mescolanza, parificazione e trasformazione" di questi tipi 'puri' (ibid.; tr. it., vol. IV, p. 57).
Al tipo di dominio basato sull'autorità legittima, proprio dello Stato e di altri 'ordinamenti istituzionali' gerarchici, si può contrapporre (seguendo Weber) il tipo di dominio costituito in virtù di 'costellazioni di interessi', caratteristico dei mercati economici e della divisione del lavoro. A questi due tipi se ne può contrapporre (questa volta discostandoci da Weber) un terzo, che sorge dalle pratiche culturali di mutuo riconoscimento e di esclusione tipiche delle 'comunità'.
Lo stesso Weber affermava che il dominio monopolistico sul mercato rappresenta il "tipo più puro" di dominio costituito in virtù di una costellazione di interessi, il quale include "tutti i rapporti di scambio, anche quelli ideali" (ibid.; tr. it., vol. IV, p. 49). L'elemento essenziale delle relazioni di potere di questo tipo è il controllo delle alternative che si offrono agli agenti in un rapporto di libero scambio a tutti i livelli, da quello strettamente locale a quello mondiale. Il 'dominio monopolistico' comporta quindi sia il potere coercitivo (ricorso a minacce e false minacce) sui potenziali concorrenti, sia l'influenza sui consumatori. Tuttavia è opportuno osservare in proposito che non vi è alcuna ragione per assumere che il monopolio costituisca la forma normale di questo tipo di dominio: in che misura il potere sia disperso o concentrato all'interno dei sistemi economici è una questione empirica aperta. Sotto questo riguardo si tratta di una forma di dominio diversa da quella basata sull'autorità, che presuppone un locus di sovranità.
Ricordiamo la definizione weberiana dello Stato come "comunità umana la quale, nell'ambito di un determinato territorio [...] pretende per sé il monopolio legittimo dell'uso della forza fisica (ibid.; tr. it., vol. IV, p. 479). Nella sociologia weberiana del dominio basato sull'autorità la contrapposizione tra Stato e cittadini, tra 'governanti e governati', tra élite e masse è data per scontata.Il dominio basato sugli interessi nella politica internazionale è stato studiato da Susan Strange (v., 1990), che fa una interessante distinzione tra potere strutturale e potere relazionale. In campo finanziario, secondo questa autrice, gli Stati Uniti hanno avuto nel secondo dopoguerra "il potere strutturale di ampliare o limitare le alternative che si offrivano agli altri paesi". Specialmente per i paesi del Terzo Mondo si è verificata una limitazione delle alternative, determinata dalla ricerca da parte degli Stati Uniti di strategie mirate a una integrazione finanziaria globale, che comportavano liberalizzazione, privatizzazione e deregulation. La conseguenza più significativa è stata un'accelerazione della competizione tra gli Stati per le quote di mercato, che ha determinato un adattamento dei programmi e degli obiettivi politici dei singoli paesi (ad esempio la privatizzazione in blocco delle aziende di Stato). Un'altra conseguenza è stata l'accresciuta vulnerabilità di molti paesi al rallentamento della crescita economica mondiale. Una terza conseguenza è stata la fuga di capitali verso gli Stati Uniti, capitali che sarebbero potuti invece andare ai paesi in via di sviluppo, alleviando il debito del Terzo Mondo. Naturalmente - aggiunge la Strange - questo "potere di sfruttamento" può "ritorcersi contro coloro che lo possiedono risolvendosi in ultimo a loro svantaggio" (p. 267).
La deliberata creazione di una economia mondiale aperta si è tradotta in una involontaria restrizione delle opportunità della classe operaia negli Stati Uniti, e le forze del mercato hanno a loro volta ristretto il campo delle scelte politiche statunitensi. I presidenti e il Congresso degli Stati Uniti, invece, "hanno il potere, se mai qualcuno lo ha, di rovesciare il processo e di spostare nuovamente l'equilibrio del potere dal mercato allo Stato" (p. 266). Il Giappone, per contro, ha cominciato ad esercitare il 'potere relazionale' derivante dalla sua posizione di principale paese creditore, utilizzando cioè "il potere relazionale a doppio taglio di colui che elargisce aiuti nei confronti dei beneficiari". Esso ha così cercato di utilizzare risorse finanziarie "per conquistare una cerchia di alleati ben disposti nei confronti delle imprese giapponesi in competizione per le quote del mercato mondiale", anche se ciò "non sempre assicura da parte loro un comportamento conforme agli interessi giapponesi nazionali o aziendali" (pp. 270-271).
Con la nozione di 'dominio basato sul riconoscimento' ci riferiamo a quelle relazioni di potere che derivano dalla capacità degli agenti sociali di includere o escludere altri da cerchie di riconoscimento stimate, le quali definiscono l'identità di un individuo ai propri occhi e a quelli degli altri. Tali cerchie costituiscono delle 'culture del riconoscimento': esse rappresentano gruppi l'appartenenza ai quali dipende dal mutuo riconoscimento. Le basi di appartenenza a tali gruppi spiegano il motivo per cui i loro membri vi aderiscono; e le ragioni di tale appartenenza costituiscono i motivi di accettazione e di esclusione su cui essi si fondano.
Tra tali ragioni, o condizioni di appartenenza, vi sono fattori casuali quali le origini familiari e l'orientamento sessuale, oppure uno status sociale condiviso o una storia comune, oppure la partecipazione alla cultura del gruppo, e così via. La base di esistenza di questi gruppi varia. Alcuni, come ad esempio i gruppi occupazionali, hanno come base la divisione del lavoro; altri una comune condizione economica svantaggiata; altri ancora, viceversa, il mantenimento di privilegi economici. Certuni, come ad esempio gli Zingari, sono basati sull'esclusione sociale, oppure, come è accaduto spesso per gli Ebrei, su una persecuzione sanzionata politicamente, laddove altri si basano sul mantenimento di privilegi sociali e politici. A volte basi e ragioni di appartenenza coincidono: alcune culture di autoriconoscimento si basano unicamente su modi di vita e pratiche culturali condivise - dai clubs di tifosi del calcio ai gruppi etnici a intere nazioni (come sempre, ovviamente, tutti questi fattori e altri ancora interagiscono). Tali gruppi non sono né associazioni né aggregazioni. L'appartenenza ad essi non dipende né da procedure formali di ammissione né dal semplice possesso di attributi in comune con altri, bensì dal fatto di essere riconosciuti e accettati come membri.
Appartenere a tali gruppi significa essere ammessi nelle loro cerchie di riconoscimento, ed è importante, in quanto è alla base di quella che viene spesso definita 'identità'. L'appartenenza costituisce infatti uno dei principali modi in cui gli individui si identificano reciprocamente, si formano aspettative sulla natura dei propri simili e ne interpretano la condotta; e poiché il modo in cui ci vedono gli altri determina in larga misura il modo in cui vediamo noi stessi, essa influenza fortemente il modo in cui le persone considerano e concepiscono se stesse. Di conseguenza, essere esclusi da una cultura di riconoscimento di alto profilo e tenuta in grande considerazione può compromettere gravemente l'autostima e quindi essere causa di infelicità, specialmente per individui sradicati e disorientati dalle condizioni della moderna vita urbana e dal rapido mutamento economico. In reazione all'esclusione si sviluppano controculture di autoriconoscimento in cui trovano rifugio gli alienati e gli anomici. Il cosiddetto 'fondamentalismo' può essere probabilmente spiegato in parte in questo modo. D'altro canto, non tutti gli individui in un dato contesto sociale desiderano il riconoscimento da parte delle culture dominanti, specialmente quando queste appaiano eccessivamente esigenti e pervasive. Inoltre, nelle moderne società improntate alla mobilità e al pluralismo culturale non tutti desiderano il riconoscimento con lo stesso grado di intensità: per alcuni la possibilità di scegliere tra una pluralità di identità è più importante della certezza dell'appartenenza.Il dominio basato sul riconoscimento può di conseguenza operare in vari modi. Può consistere nel non accordare riconoscimento ai membri di un altro gruppo, che vengono marginalizzati o trattati come esseri di status inferiore.
Si sviluppano così gerarchie di status, che distinguono all'interno di una cultura ciò che è 'normale' da ciò che è 'anormale'. Il dominio basato sul riconoscimento può consistere anche nel rifiuto e nella stigmatizzazione dei membri di questi altri gruppi estranei alla cultura dominante - ad esempio gli immigrati o gli stranieri - che vengono trattati come non persone e, se si trovano in una condizione svantaggiata, oppressi in vari modi sino a diventare vittime, in casi estremi, di operazioni di 'pulizia etnica'. Ma questo tipo di dominio può consistere anche nell'imposizione del riconoscimento a gruppi subordinati attraverso forme di imperialismo culturale, oppure nel tentativo da parte degli 'imprenditori del riconoscimento' di imporre la conformità a individui recalcitranti, per i quali il riconoscimento è in ogni caso meno che desiderabile: coloro che hanno cambiato identità, o non ne hanno una, o ne hanno diverse, o rifiutano qualsiasi identità. Tutte queste forme di dominio possono essere rozze oppure estremamente sottili: possono implicare il ricorso alla coercizione oppure all'influenza; possono basarsi sull'aperta punizione della devianza e sulla manipolazione deliberata, oppure su interazioni, gesti e tipi di discorso informali. A differenza del dominio basato sull'autorità, quello basato sul riconoscimento non è tipicamente localizzato in una singola fonte sovrana. Forse è a questo tipo di dominio che faceva riferimento Foucault allorché affermava che le relazioni di dominio non sono relazioni di sovranità, ma comportano molteplici forme di soggezione, e che il potere non deve essere considerato in termini di dominio consolidato e omogeneo da parte di un individuo, di un gruppo o di una classe su altri, bensì piuttosto lo strumento con il quale gli individui vengono identificati e 'formati' attraverso una rete o griglia di microprocessi di 'normalizzazione'e di 'coercizioni disciplinari'.
Oppressione
Se con 'ineguaglianza' abbiamo designato la distribuzione di vantaggi e svantaggi in una società e con 'dominio' le relazioni di potere di alcuni su altri, indicheremo con 'oppressione' gli effetti negativi o dannosi di tali relazioni di potere su coloro su cui viene esercitato. Più precisamente, tale concetto si riferisce sia agli effetti in questione che alle relazioni di potere che li producono.
Esistono varie forme di oppressione, e dovremmo respingere la tentazione di assimilarle l'una all'altra o di considerarne una più essenziale delle altre e quindi in grado di spiegarle tutte. Ciò che distingue l'oppressione nelle sue varie forme da una semplice condizione svantaggiata è il fatto di derivare, in un modo o nell'altro, dalle relazioni e dai meccanismi di potere illustrati nei capitoli precedenti. Analizzando le varie forme di oppressione, distingueremo diversi tipi di situazioni di svantaggio, ognuna delle quali deriva tipicamente (ma non esclusivamente) da un determinato tipo di relazione di potere.
Consideriamo in primo luogo lo sfruttamento, una relazione di scambio ineguale che si instaura all'interno di strutture coercitive che offrono agli sfruttati relativamente poche alternative. Nella classica versione marxista, lo sfruttamento capitalistico consiste nell'appropriazione da parte dei capitalisti del surplus di valore prodotto dai lavoratori. Apparentemente, lo scambio di forza lavoro contro un salario, in condizioni di scambio libero ed eguale, è uno scambio tra valori equivalenti; secondo Marx però si tratta di apparenze ingannevoli. Infatti il plusvalore è ottenuto grazie al potere degli sfruttatori (sostenuto da quello dello Stato): il lavoro salariato è 'lavoro coatto', estorto sotto quella che Marx definiva la 'cieca compulsione' dei rapporti economici, per cui i lavoratori sono costretti prima a vendere la propria forza lavoro a un capitalista, e poi a svolgere l'attività lavorativa sotto il controllo e la supervisione di quest'ultimo. Il primo tipo di coercizione è compatibile con quella che Marx definiva 'libertà formale' (ad esempio, la libertà di decidere per chi lavorare e a quale prezzo), e si identifica con le costrizioni anonime e impersonali del mercato del lavoro, data la differenza di risorse tra gli agenti di produzione che rende il lavoro salariato l'unica reale alternativa per i lavoratori. Il secondo tipo di coercizione è costituito dal controllo - sostenuto dalle leggi e basato sul possesso dei mezzi di produzione - che il capitalista esercita sul processo lavorativo. E il lavoratore è defraudato di una ricompensa equivalente, poiché secondo la teoria del valore-lavoro la sua forza lavoro ha prodotto un valore supplementare che viene espropriato dal capitalista.
Una definizione più astratta dello sfruttamento (non più basata sulla teoria del valore-lavoro) è stata proposta da C.B. Macpherson (v., 1983, III saggio), che lo concepisce in termini di 'trasferimento di poteri': gli sfruttati esercitano i propri poteri (o 'capacità umane fondamentali') sotto il controllo di altri, in funzione degli scopi di questi ultimi e a loro vantaggio, e quindi accrescendone sistematicamente il potere. Ciò che viene trasferito è il potere messo al servizio di altri, mentre il potere su altri - lo sfruttamento delle abilità altrui, la "capacità di ricavare vantaggi da altri" - che viene con ciò sistematicamente accresciuto è definito da Macpherson 'potere di sfruttamento' (extractive power). Nella tradizione marxista lo sfruttamento era considerato un elemento costitutivo dei rapporti di classe, ma esistono anche forme di sfruttamento basate sulle differenze di sesso e di razza, nella misura in cui la divisione del lavoro - nell'organizzazione familiare e nel mercato del lavoro - assegna posizioni e compiti scarsamente retribuiti e poco gratificanti agli individui che rientrano in determinate categorie. Inoltre, come abbiamo visto a proposito dell'analisi del potere finanziario sviluppata da Susan Strange, lo sfruttamento può anche caratterizzare le relazioni internazionali.A differenza dello sfruttamento, la subordinazione è una conseguenza diretta del dominio basato sull'autorità attraverso strutture di potere articolate gerarchicamente.
Ciò che sperimentano i subordinati è la soggezione (nel senso in cui 'soggetto' si contrappone non ad 'oggetto' bensì a 'cittadino'). Essi sono soggetti ad uno status inferiore - in una gerarchia del prestigio, o del rispetto, o della dignità - e a una relativa deprivazione di potere sotto vari riguardi: non possono sviluppare ed esprimere liberamente i propri poteri (o capacità fondamentali); sono privi di risorse economiche, politiche e culturali; non hanno alcun potere sulle condizioni in cui lavorano e vivono; non hanno accesso al potere decisionale centrale. I subordinati tipicamente occupano posizioni inferiori e svolgono compiti definiti da altri nella divisione del lavoro, ricevono ordini anziché impartirli, sono trattati con disprezzo e mancanza di rispetto in un'ampia gamma di contesti, e sono privi delle risorse, dell'organizzazione, delle capacità e spesso persino della volontà necessarie per superare tutti questi svantaggi. Ai diversi sistemi di subordinazione fanno riscontro altrettante forme di subordinazione. Alcune sono specifiche di determinate istituzioni (come nelle corporazioni e nelle burocrazie), altre sono estese a tutta la società e sono parte integrante della gerarchia di status e del sistema di divisione del lavoro che la caratterizzano. Il più esteso sistema tradizionale di subordinazione sopravvissuto nel mondo moderno è il sistema di casta del subcontinente indiano. D'altro canto, la modernità genera le proprie forme distintive di subordinazione, nonostante l'impegno a lungo termine a realizzare l'ideale di eguaglianza (così come viene definito nella classica formulazione di Tocqueville) e per certi versi a causa di esso. Ad esempio la meritocrazia, nella misura in cui esiste nella pratica, condanna coloro che non riescono a superarne le prove 'oggettive' a un senso di irrimediabile fallimento e di impotenza.
Nelle società occidentali contemporanee la linea di discrimine più netta che separa i subordinati nell'ambito occupazionale è forse quella tra professionisti e lavoratori non qualificati. Inoltre nelle società moderne si prospetta la inquietante minaccia di una nuova crescente forma di subordinazione all'autorità degli specialisti, dei manager e dei burocrati. Questa possibilità è prefigurata nella visione weberiana di una 'nuova servitù' derivante dalla crescente complessità del sistema economico, dalla parziale statalizzazione delle attività economiche e dalla crescita della popolazione, che determinano una quantità di lavoro crescente per i burocrati, una crescente specializzazione delle funzioni, e un predominio del professionismo e della specializzazione nell'amministrazione e nell'educazione (v. Weber, 1922) - una società quindi impregnata dei valori burocratici di ordine e sicurezza e dominata in misura crescente da un'unica gerarchia onnicomprensiva.
La visione di Weber era quella di una irresistibile espansione della burocratizzazione in tutte le relazioni di autorità sia pubbliche che private, e di una crescente importanza degli 'esperti' e della conoscenza specializzata in ogni campo (v. Weber, 1922), una visione che lo induceva a nutrire un moderato pessimismo nei confronti degli 'antiquati ideali' della democrazia (eguaglianza di potere) e della libertà (sviluppo dei poteri individuali). L'unica soluzione che Weber intravvedeva era quella di mantenere viva la risoluta volontà di una nazione di non lasciarsi governare come un gregge (v. Weber, 1922).
Diversa sia dallo sfruttamento che dalla subordinazione è quella forma di oppressione che consiste nel non riconoscimento o nel misconoscimento, la quale, come scrive Charles Taylor, "imprigiona chi ne è vittima in un modo d'essere falso, distorto, riduttivo. Ben più che una semplice mancanza di rispetto, essa può infliggere gravi ferite, suscitando un paralizzante odio verso se stessi" (Multiculturalism and 'the politics of recognition', Princeton 1992, p. 25). Conseguenza ed espressione di questa forma di oppressione è la discriminazione, che consiste nella negazione di vantaggi socialmente apprezzati mediante pratiche basate sul trattamento ingiusto o dannoso riservato a determinati gruppi. Tali pratiche possono consistere in azioni deliberate: ad esempio atti specifici di discriminazione sessista, razzista o di altro tipo - come quando si rifiuta per pregiudizio ad una donna o ad un individuo di razza nera un lavoro, una promozione o un appartamento, oppure si riserva un trattamento di sfavore a una particolare comunità etnica nella distribuzione di fondi pubblici. La discriminazione può anche essere di tipo strutturale o istituzionale, come quando certe organizzazioni utilizzano procedure di selezione in sé neutrali (ad esempio per l'accesso alle facoltà di medicina) che però, di fatto, hanno un impatto discriminatorio su gruppi identificabili.
Il sistema dei test standardizzati, quello dell'assunzione basata su conoscenze personali e quello del pensionamento in base all'anzianità hanno spesso un effetto discriminatorio di questo tipo. Ognuna di queste forme di discriminazione rafforza le altre: le discriminazioni effettuate in passato rendono meno efficaci le procedure di selezione 'obiettive' e neutrali, mentre la discriminazione strutturale conferisce rispettabilità ai comportamenti basati sul pregiudizio.
La discriminazione è quindi una conseguenza, più o meno intenzionale, della negazione del riconoscimento, ossia del rifiuto di accettare come 'normali' persone che, in virtù di una o più caratteristiche distintive, sono emarginate o escluse. (Ovviamente, nelle società differenziate gerarchicamente i discriminati, come ad esempio gli intoccabili, saranno trattati come individui 'normali' che si collocano al gradino più basso della scala sociale). Il danno che subiscono in questo modo le vittime della discriminazione si aggiunge alla negazione dei benefici (il lavoro, una promozione, un appartamento, una sovvenzione, l'ammissione ad una facoltà di medicina) che essa comporta, poiché la ragione di tale negazione è degradante per i discriminati. Essi subiscono l'ulteriore danno dell'esclusione dalla cultura del riconoscimento dominante, che stabilisce ciò che è normale e rispettabile distinguendolo da ciò che è deviante e non rispettabile. O meglio, lo svantaggio materiale creato dalla discriminazione simbolizza il dominio della cultura del riconoscimento che lo determina. È questo il principale motivo per cui al fine di alleviare questo tipo di oppressione è necessario porre rimedio agli svantaggi materiali che essa crea, essendo questo, di norma, l'unico modo appropriato per dimostrare il riconoscimento in precedenza negato.
L'ingiustizia commessa attraverso atti di discriminazione è un'ingiustizia commessa nei confronti di chi ne è vittima; il rimedio appropriato è quindi quello di ridare a costoro ciò che era stato loro ingiustamente negato. Ma l'ingiustizia commessa attraverso la discriminazione strutturale o istituzionale non ha vittime identificabili, essendo un'ingiustizia commessa verso il gruppo nella sua totalità. In questo caso il rimedio adeguato consiste nell'attuazione di politiche analoghe alla cosiddetta affirmative action - il progetto di integrazione interetnica a favore della minoranza nera iniziato negli anni sessanta negli Stati Uniti - che mirano a ridurre nel tempo l'impatto discriminatorio di procedure 'neutrali'.Il dominio basato sul riconoscimento, tuttavia, qualora il riconoscimento sia imposto ai membri di un gruppo mediante quella che, servendoci di una significativa metafora, chiameremo colonizzazione, o quello che viene definito a volte 'imperialismo culturale' (v. Young, 1990), può dar luogo ad un'altra forma di oppressione, che consiste nell'universalizzare elevandole a norma l'esperienza e la cultura di un gruppo o di una nazione dominante e mettendo a tacere la prospettiva degli oppressi, che vengono contemporaneamente stereotipizzati come 'Altro'. Questa forma di oppressione si serve di tutto l'armamentario dei meccanismi del potere, come ebbe ad osservare il poeta nero Aime Cesaire allorché scrisse "parlo di milioni di uomini cui sono stati inculcati ad arte paura, complessi di inferiorità, trepidazione, servilismo, disperazione, umiliazione".
Queste parole, tratte dal Discourse sur le colonialisme, vengono citate da Frantz Fanon all'inizio del suo primo libro Peau noire, masques blancs (Paris, 1959), in cui, come in altre opere successive, vengono esplorate le dimensioni psicologiche, sociali e politiche di questa forma di oppressione, nonché gli stretti rapporti tra linguaggio, personalità, relazioni sessuali ed esperienza politica nel contesto della lotta per l'indipendenza e dell'esperienza postcoloniale in Algeria e in altre parti dell'Africa.La colonizzazione intesa in questo senso, tuttavia, costituisce una forma di oppressione più generale, tipica delle società in cui i gruppi dominanti, che controllano i mezzi di interpretazione e di comunicazione, proiettano la propria esperienza come rappresentativa dell'umanità in quanto tale. I soggetti culturalmente dominati risultano così, paradossalmente, segnalati attraverso stereotipi e nello stesso tempo sottratti alla visibilità.
Definiti dalla cultura dominante, che interiorizzano e nel contempo rifiutano, essi sperimentano una sorta di 'doppia coscienza' che il pensatore nero americano W.E.B. Du Bois ha descritto nel modo seguente: "la sensazione di guardare sempre se stessi attraverso gli occhi di altri, di misurare il proprio animo con il metro di un mondo che li giudica con divertito disprezzo e commiserazione" (The souls of black folk, New York 1969, p. 45). Questa doppia coscienza compare quando modalità introiettate di interpretazione del mondo che svalutano e stereotipizzano i membri di un determinato gruppo vengono messi in discussione da questi ultimi. Ciò porta all'affermazione di culture alternative del riconoscimento e costituisce la base della cosiddetta 'politica della differenza' nelle società multiculturali del mondo contemporaneo.
Relazioni di potere positive
Sinora abbiamo soffermato l'attenzione esclusivamente sulle conseguenze oppressive delle relazioni di potere. Tuttavia detenere ed esercitare potere su altri può anche essere una relazione che ha conseguenze positive per questi ultimi. Rientra tra le relazioni di questo tipo quello che viene spesso etichettato come paternalismo: A agisce paternalisticamente nei confronti di B se e solo se: 1) A intende evitare un danno o procurare un beneficio a B; 2) A agisce in contrasto con i desideri e le preferenze attuali di B e 3) l'azione di A costituisce una limitazione dell'autonomia di B. Pochi sarebbero disposti a negare che varie forme di paternalismo sono legittime quando vengono esercitate nei confronti di minori e di individui incapaci di intendere e di volere o affetti da malattie mentali - ad esempio soggetti gravemente ritardati, psicotici e così via. I problemi sorgono quando il paternalismo si manifesta nei confronti di individui adulti e capaci. Esempi familiari al riguardo sono le leggi che rendono obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza, o che impongono di pagare i contributi sociali per le pensioni, o di attendere un periodo di tempo prestabilito per il matrimonio o il divorzio, la pratica della censura (per quanto limitata) a tutela della morale, le leggi che autorizzano i medici ad eseguire operazioni in contrasto con obiezioni di tipo religioso, o di ingannare i pazienti, o che impongono agli studenti di seguire determinati corsi, ecc.
Sono tutti esempi che dimostrano l'equilibrio che deve essere raggiunto in questi casi tra la tutela e la promozione degli interessi di altri individui e il rispetto della loro autonomia.Una prima questione che si pone in proposito è se e in che misura tali politiche raggiungano effettivamente il loro obiettivo paternalistico di favorire gli interessi altrui; una seconda questione è se e in che misura siano legittime. I liberali orientati verso posizioni liberiste sono scettici per quanto concerne la prima questione empirica, e fortemente antipaternalistici per quanto concerne la seconda negando, con John Stuart Mill, il diritto di obbligare qualcuno a fare o a non fare qualcosa "perché sarebbe meglio per lui comportarsi in questo modo, perché lo renderebbe più felice, perché nell'opinione degli altri sarebbe saggio comportarsi così" (On liberty). Il potere paternalistico - sia quello esercitato dallo Stato sia, per fare un esempio, quello esercitato dai medici - viene considerato una minaccia pervasiva e costante della libertà individuale. Tuttavia la risposta alla prima questione talvolta è positiva, e in tutte le società, anche le più liberali, esiste sempre un minimo (variabile) di leggi e regolamentazioni di questo tipo. Il problema più profondo è se e in che misura tali leggi e regole, che impongono il rispetto di determinati codici di condotta per il bene delle persone piuttosto che per prevenire un danno ad altri individui, siano necessarie perché prosperi una morale liberale.
Se la paternità fornisce la metafora per un tipo di relazioni di potere (a volte) positive, la maternità è stata proposta da varie autrici femministe come una possibile metafora per un altro tipo di relazioni anch'esse positive. Il comportamento materno, si è sostenuto, costituisce un esempio di esercizio del potere al fine di conferire potere ad un altro soggetto, ossia di incrementarne le risorse, le abilità, l'efficacia e la capacità di agire. Si tratta, in breve, di un modello di potere trasformativo, in cui il potere su un altro "provoca la propria stessa obsolescenza conferendo potere al soggetto subordinato" (v. Wartenberg, 1990, p. 184).
Se il paternalismo comporta una restrizione dell'autonomia del soggetto su cui viene esercitato, il 'maternalismo' potrebbe invece contribuire a svilupparla. Questa idea, che risale fondamentalmente all'autrice femminista francese Luce Irigaray, è illustrata nel modo seguente da Nancy Hartsock: "L'esperienza femminile non solo della maternità, ma in senso più ampio l'educazione generale delle fanciulle al ruolo materno, e l'esperienza delle cure materne ricevute da una persona del proprio sesso, è un'esperienza in cui il potere su un altro viene gradualmente trasformato, sia da chi esercita il potere sia da colui sul quale esso viene esercitato, in autonomia e (idealmente) in mutuo rispetto" (v. Hartsock, 1983, p. 257). Senza dubbio ciò significa idealizzare i rapporti della maggior parte delle madri con i figli (e anche con le figlie) trascurando le numerose ambiguità, i trabocchetti, le difficoltà e i condizionamenti sociali e culturali che improntano tali rapporti. Dopotutto, le madri si trovano anch'esse (come i padri) di fronte al compito di preparare i figli ad accettare determinati ruoli sociali e a conformarsi alle relazioni di potere dominanti. Tuttavia, se considerato alla stregua di una metafora, il 'maternalismo' può costituire, come suggerisce Wartenberg, il modello di una gamma di relazioni di potere potenzialmente trasformative - come l'apprendistato, l'insegnamento, la terapia, ecc. - che talvolta possono tradursi in un conferimento di potere ai soggetti subordinati. Wartenberg cita in proposito il Socrate di Platone, apparentemente in una posizione di dominio, che ingenera una feconda incertezza nei suoi giovani interlocutori affinché essi possano meglio raggiungere l'autoconoscenza e l'autodeterminazione.
Tutti questi esempi mostrano come alcune relazioni di potere e di dipendenza possano avere un potenziale di autoannullamento e di trasformazione, e come anche quelle che possono apparire forme di oppressione possano rivelarsi ad un esame più attento il suo contrario.
Il concetto di potere
Abbiamo esaminato sinora i diversi modi in cui il potere può essere esercitato da alcuni agenti sociali su altri, i tipi di relazioni di potere che intercorrono tra tali agenti e i tipici contesti in cui esse si instaurano, nonché i tipici effetti, sia negativi che positivi, che tali relazioni di potere hanno su coloro sui quali esso viene esercitato. L'esercizio del potere, inteso in questo modo, costituisce una forma specifica del potere nel senso generale, o non ristretto, al quale dedicheremo ora la nostra attenzione.
Il termine 'potere' riferito in generale agli agenti sociali denota semplicemente, come abbiamo visto, la capacità di produrre effetti in qualche modo rilevanti, intenzionali e correlati agli interessi degli agenti coinvolti. Come vedremo ora, il potere inteso come capacità degli agenti sociali di produrre effetti può assumere diverse forme.
Consideriamo in primo luogo la sfera del potere, intendendo con ciò il numero di effetti, o di tipi di effetti, che un agente può produrre. Supponiamo che A e B siano entrambi ministri di un governo. A potrebbe riuscire a far approvare un programma politico al quale ha dato il suo pieno sostegno, ma non essere in grado di imporre la propria linea su altre questioni, laddove B potrebbe essere in grado di vincere su parecchie, differenti questioni. Naturalmente, l'individuazione delle 'questioni' può essere controversa, e ovviamente la rilevanza delle questioni rispetto alle quali si è in grado di prevalere è importante (vedi sotto), ma a parità di altre condizioni, quanto più ampia sarà la sfera entro cui A è in grado di produrre effetti significativi, tanto maggiore sarà il suo potere. Il potere su una singola questione può essere estremamente importante (si pensi al potere di Greenpeace), ma un ampliamento della sfera del potere (ancora una volta, a parità di altre condizioni) significa un aumento della capacità di produrre effetti rilevanti.
Questa distinzione può essere illustrata con un'analogia che spesso viene fatta tra potere e denaro. Avere potere su una singola questione equivale a scarsa liquidità - ciò che si può acquistare con esso è estremamente limitato - laddove il potere su una pluralità di questioni è fungibile e può essere 'speso' in parecchi modi diversi.Consideriamo in secondo luogo la portata o raggio d'azione della capacità in questione, intendendo con ciò il tipo di circostanze in cui essa può esplicarsi. Il 'potere' identifica ciò che un agente è in grado di fare esclusivamente nelle condizioni esistenti, oppure in una varietà di circostanze alternative? Nel primo caso, A è potente se può produrre gli effetti desiderati solo quando le circostanze presenti lo mettono in condizione di farlo (ad esempio, una particolare configurazione di preferenze di voto può far sì che sia il voto di A a decidere l'esito della votazione); nel secondo caso, A è potente se può ottenere i risultati voluti in una varietà di possibili circostanze. Il primo tipo di potere identifica ciò che un agente è in grado di fare in un determinato luogo e in un determinato momento, date le condizioni esistenti in quel luogo e in quel momento; il secondo una capacità che un individuo è in grado di dispiegare in un'ampia gamma di contesti (standard).
Peter Morris ricorre in proposito alla distinzione tra ableness e capacity; noi però non seguiremo questa terminologia, ma parleremo di capacità 'dipendente dal contesto', nel primo caso, e di capacità 'trascendente il contesto' nel secondo. Questa distinzione getta una luce interessante sul rapporto tra potere e resistenza - e, più in generale, tra potere e ostacoli di qualsiasi genere. Infatti la capacità che dipende dal contesto hinc et nunc viene massimizzata se la resistenza o gli ostacoli che essa incontra vengono minimizzati; laddove la capacità trascendente il contesto è tanto maggiore, quanto più grande è la resistenza o il numero di ostacoli che si è in grado di superare.In terzo luogo, consideriamo la relazione tra potere e intenzionalità. Alcune capacità sono capacità di ottenere effetti voluti: se A possiede una capacità di questo genere può, con le risorse appropriate e nelle circostanze favorevoli, ottenere l'effetto desiderato (se lo può ottenere solo in quelle circostanze, si tratta di una capacità dipendente dal contesto). Le capacità di questo tipo sono assimilabili logicamente ad abilità (skills): se A possiede una tale capacità, di norma si può contare sul fatto che, se vuole, otterrà l'effetto desiderato. Tuttavia la maggior parte delle nostre azioni innescano innumerevoli catene di conseguenze involontarie, alcune delle quali estremamente significative. Anche queste possono essere incluse nell'ambito delle capacità di chi le produce, per quanto siano impreviste e persino imprevedibili. Un buon esempio al riguardo è costituito da due catene di conseguenze involontarie (ma di grande rilevanza) prodotte dalla guerra delle Falkland, attuata in modo pienamente intenzionale da Margaret Thatcher (guerra che, come dimostrò chiaramente, essa aveva il potere di vincere).
La prima di tali catene di conseguenze sfociò nel ripristino della democrazia in Argentina; la seconda nella rinascita del partito conservatore britannico (che nei sondaggi di opinione aveva toccato il punto più basso della sua popolarità dalla seconda guerra mondiale) e nel trionfo del thatcherismo in Gran Bretagna.
In quarto luogo, consideriamo la distinzione tra potere attivo e potere passivo. Esercitare potere significa compiere azioni. E invero, l'espressione stessa 'esercitare potere' richiama l'idea di attività. Tuttavia le capacità che il concetto di 'potere' denota includono anche quelle che rendono dispensabile il ricorso all'azione. Il potere di A sarà allora tanto maggiore, quanto più egli sarà in grado di raggiungere i risultati appropriati senza essere costretto ad agire, esclusivamente in virtù degli atteggiamenti che gli altri hanno nei suoi confronti, o di una configurazione favorevole di relazioni e di forze sociali che facilitano il raggiungimento di tali risultati. Abbiamo già incontrato il potere delle reazioni anticipate che consente di evitare il ricorso all'aperta coercizione: un chiaro esempio in proposito è l'autocensura praticata da scrittori e giornalisti nei regimi autoritari. Il potere passivo accumulato da tali regimi è, naturalmente, il residuo dell'uso passato di un potere attivo, spesso su vasta scala. Ma non ogni potere passivo deriva direttamente da un potere attivo esercitato in precedenza. Ne è un esempio il potere derivante dallo status che induce deferenza: esso infatti esime quanti possiedono posizioni sociali e privilegi consolidati dalla necessità di agire per conservarli.
La distinzione tra potere attivo e potere passivo può essere pensata in termini di rapporto tra potere e costi. Se il potere diminuisce al crescere dei costi del suo esercizio, e se l'esercizio attivo del potere è considerato esso stesso un costo, allora si può dire che il potere passivo riduce a zero tali costi. La tabella illustra la discussione precedente. Le quattro colonne rappresentano i quattro aspetti considerati, presentati come alternative (sebbene costituiscano di fatto un continuum): ogni elemento della fila superiore rappresenta un'alternativa, ogni elemento della fila inferiore il suo contrario. Il potere di un agente sociale descritto dalla fila superiore (a parità di altre condizioni) aumenta se acquista successivamente la caratteristica descritta in ciascuna casella della fila inferiore. Supponiamo che A sia in grado di prevalere su una data questione nelle presenti circostanze, ottenendo ciò che intendeva ottenere ed esercitando la sua volontà. Il potere di A non sarà forse maggiore nella misura in cui può fare lo stesso rispetto a una pluralità di questioni, in una gamma di circostanze diverse, provocando importanti conseguenze non intenzionali e senza dover muovere un dito?
Abbiamo visto sinora che la capacità cui diamo il nome di potere può avere un'estensione variabile, a seconda del numero di effetti o di tipi di effetti che è in grado di determinare, della gamma di circostanze in cui può esplicarsi e del grado di involontarietà e di passività che comporta il suo manifestarsi. Si noti tuttavia che tutti questi fattori di variabilità valgono per le manifestazioni di potere prese singolarmente: il potere di un dato agente è maggiore se ciascuna di esse risulta accresciuta rispetto a tale agente. Ma oltre che a identificare e a misurare il potere degli agenti sociali, siamo interessati anche a comparare il potere di individui e di collettività, ossia a stabilire in che misura il potere di un soggetto è maggiore di quello di un altro. In alcuni casi, il potere di due agenti può avere la stessa estensione. Per quanto riguarda il potere di un agente A su una data questione, o insieme di questioni, possiamo dire che il potere di un altro agente B su quella questione o insieme di questioni è maggiore se può esplicarsi in una gamma più ampia di circostanze, se produce un numero superiore di conseguenze rilevanti o comporta costi minori per l'agente. In altri casi, la sfera del potere di A può includere quella di B: se la sfera del potere di A è maggiore di quella di B (vale a dire: A è in grado di provocare tutti gli effetti che è in grado di provocare B, e in più altri ancora), allora il potere di A è maggiore di quello di B. Ovviamente, però, nella maggior parte dei casi le comparazioni del potere sono più complesse, perché di solito confrontiamo il potere dei diversi agenti su differenti questioni. Siamo interessati a comparare il potere complessivo dei singoli agenti nei casi in cui la sfera del loro rispettivo potere non coincide e spesso non si sovrappone.
Le comparazioni di questo tipo mettono in luce un altro aspetto in relazione al quale la forma o l'estensione del potere può variare. Infatti, A avrà un potere (complessivo) maggiore di B se è in grado di provocare effetti più 'rilevanti' di quelli che può provocare B. Ma come valutare la rilevanza delle conseguenze? Il criterio più ovvio appare quello dell'impatto che il potere ha sugli interessi degli agenti coinvolti, intendendo per 'interessi' ciò che è importante per uno o più agenti: riferendoci agli interessi di A, ci riferiamo a ciò che è importante per A; riferendoci all''nteresse nazionale', ci riferiamo a ciò che i leaders politici o l'opinione pubblica ritengono importante per una data nazione. Così, nel confrontare il potere degli agenti su ambiti, o insiemi di questioni, differenti, introduciamo inevitabilmente delle valutazioni relative alla misura e al modo in cui il potere di tali agenti favorisce i loro interessi e, cosa ancora più importante, investe gli interessi di altri. Di norma, si presuppone che il potere sia funzionale agli interessi di chi lo detiene (anche se, come dimostra lo studio di Susan Strange sul potere finanziario 'strutturale' degli Stati Uniti, esso può ritorcersi contro i suoi detentori tornando in ultimo a loro svantaggio). Ma a prescindere da questo assunto, è l'impatto del potere sugli interessi di altri a fornire il criterio in base al quale valutarne la relativa estensione.
Così saremmo inclini a ritenere che un giudice di seconda istanza che ha la facoltà di comminare l'ergastolo o la pena di morte ha maggior potere su un imputato di un giudice di prima istanza; che la mafia, nelle aree in cui esercita il suo dominio, ha maggior potere di altri influenti gruppi, organizzazioni e agenzie governative; e che il potere dei magnati nel settore multimediale è maggiore di quello, ad esempio, dei pubblicitari o dei divi del cinema o del rock. Si può dunque affermare che se A è in grado di influenzare gli interessi fondamentali o essenziali di B, il suo potere (in rapporto a B) è maggiore di quello di C, che ha un impatto sugli interessi superficiali di B. Naturalmente, la questione dove risiedano gli interessi delle persone, cosa sia essenziale e cosa invece sia marginale per la loro vita è una questione intrinsecamente controversa.
Qualunque risposta implica necessariamente una presa di posizione nelle attuali controversie morali e politiche. Per questa ragione le comparazioni del potere che comportano una valutazione dell'impatto che esso ha sugli interessi degli agenti non possono mai evitare giudizi morali e politici controvertibili.Gli interessi degli agenti possono essere concepiti in diversi modi. In primo luogo, possono essere identificati direttamente con le preferenze - che, ricordiamo, abbiamo definito come disposizioni costanti a scegliere determinati stati di cose piuttosto che altri (in contrapposizione a bisogni o capricci effimeri). Tali preferenze possono essere 'rivelate' - per usare la terminologia degli economisti - in concrete situazioni di scelta, come accade nel comportamento di mercato. Parleremo in questo caso di preferenze manifeste. Ma possono anche essere nascoste e quindi non rivelate in effettive situazioni di scelta, assumendo la forma di proteste o aspirazioni parzialmente o del tutto inespresse che, a causa dell'orientamento politico dominante o della cultura prevalente restano inascoltate, e a volte non vengono nemmeno formulate. Parleremo in questo caso di preferenze nascoste. L'equiparazione tra interessi e preferenze si fonda sulla concezione benthamiana secondo la quale ognuno è il miglior giudice dei propri interessi: al fine di scoprire dove risiedano gli interessi delle persone, si possono osservare i loro comportamenti di scelta (come nel mercato o nella cabina elettorale), oppure si inferisce, da un'attenta osservazione di ciò che dicono e fanno, come si comporterebbero se potessero scegliere tra alternative attualmente non disponibili.
Un altro modo di concepire gli interessi è quello di considerarli come condizioni necessarie del benessere umano, ossia tutto ciò di cui gli esseri umani in generale hanno bisogno per vivere un'esistenza a loro giudizio soddisfacente, qualunque sia il criterio in base al quale viene espresso tale giudizio. Ci riferiamo qui a ciò che i filosofi politici contemporanei chiamano di volta in volta 'bisogni fondamentali', 'beni primari', 'risorse' e mezzi per realizzare le 'capacità fondamentali': tutte quelle condizioni che consentono agli individui di realizzare i loro scopi e i loro ideali di una vita degna, e senza le quali tale realizzazione risulta frustrata o gravemente ostacolata. Tra questi interessi intesi come condizioni del benessere figurano beni primari quali la salute, un adeguato nutrimento, un minimum di risorse materiali e culturali e di accesso a tali risorse. Alcuni autori, come John Rawls, includono nell'elenco anche le libertà e le opportunità fondamentali e le basi del rispetto di sé -il che solleva la questione della specificità culturale. Quali interessi intesi come condizioni del benessere possono essere considerati universali e quali sono invece propri di una particolare area culturale? In ogni caso, qualunque sia la risposta a questo interrogativo, gli interessi così intesi non dipendono dalle preferenze. La loro qualifica di interessi degli individui non deriva dal fatto di essere desiderati dalle persone; certe condizioni che danneggiano la salute sono contrarie agli interessi (così intesi) degli individui, qualunque siano le loro preferenze e anche se essi cercano attivamente di favorirle.
Un altro modo di intendere gli interessi è quello di considerarli non già come preferenze né come condizioni necessarie per la realizzazione di una vita degna, bensì come consistenti nel 'bene' stesso degli individui, ossia nella realizzazione stessa di una vita degna. Ad esempio, gli interessi di una persona possono rivelarsi negli scopi centrali o negli obiettivi a lungo termine in base ai quali essa configura la propria vita, nelle 'meta-preferenze' o 'valutazioni forti' in base alle quali essa valuta quali desideri e preferenze renderebbero migliore la sua vita, o nell'intera rete di desideri, preferenze e meta-preferenze implicati dalla realizzazione di una vita degna. Da questo punto di vista, gli interessi sono dati dal contenuto di una vita degna. Naturalmente cosa debba essere considerato degno o valido e cosa invece indegno o privo di valore rimane un profondo, essenziale problema etico (così come la questione in che modo si debba rispondere a tale quesito).
Qui intendiamo semplicemente richiamare l'attenzione sul fatto che gli interessi così definiti sono indipendenti dalle preferenze, poiché l'identificazione tra interessi e realizzazione del bene degli individui non esclude la possibilità, anzi presuppone, che essi possano preferire un tipo di vita contrario ai loro interessi.Dunque, la valutazione dell'estensione del potere di un agente è in parte determinata da giudizi di valore. Se A è in grado di influire sugli interessi di altri in misura maggiore di B, comunque si vogliano definire tali interessi, ciò, a parità di altre condizioni, autorizza a concludere che il potere di A è maggiore di quello di B. Ma in che modo A deve influire sugli interessi di altri individui? In modo positivo o negativo? Deve favorirli o danneggiarli? Molti autori che si sono occupati della tematica del potere sembrano sostenere quest'ultima ipotesi, affermando cioè che avere potere significa agire contro gli interessi di altri. Questa posizione potrebbe derivare da un privilegiamento della concezione ristretta del potere (inteso come potere su altri) discussa in precedenza, sebbene, come abbiamo visto, anche il potere definito in questi termini possa avere conseguenze (paternaliste o 'maternaliste') che promuovono gli interessi altrui. Ma non vi è alcun motivo per affermare a priori che i potenti (nel senso ristretto del termine 'potere') minacciano, anziché favorire, gli interessi altrui, sebbene ciò sia spesso vero. (Talvolta, di fatto, l'esercizio del potere può andare a beneficio di tutti, per quanto in misura ineguale). Si può dunque concludere che il potere è sempre a due sensi? Il potere di A è forse maggiore se egli è in grado sia di favorire che di danneggiare gli interessi di B? E quando si cerca di misurare la forza relativa del potere di un agente, a cosa si dovrà attribuire maggiore importanza: alla sua capacità di favorire gli interessi o a quella di danneggiarli? E che ruolo hanno i numeri? Sugli interessi di quante persone dovrà influire A per avere maggior potere? E come confrontare la capacità di influire sugli interessi di molte persone superficialmente con quella di influire sugli interessi di pochi ma in modo profondo? La verità è che il concetto di potere nell'accezione generale non fornisce alcun criterio per rispondere a tali quesiti. Per farlo, è necessario far riferimento all'una o all'altra delle diverse concezioni del potere, alle quali rivolgeremo ora la nostra attenzione.
Diverse concezioni del potere
Nel capitolo precedente abbiamo cercato di definire lo spazio delimitato dal concetto di potere. In pratica, però, sia nella vita quotidiana che nell'ambito delle scienze sociali vengono utilizzate concezioni più specifiche del potere, funzionali al tipo di interesse, che ci spingono a chiederci dove esso risieda e come sia distribuito. Per chiarire le idee delineeremo due di tali concezioni del potere, l'una ristretta, l'altra molto generale, illustrando il modo in cui funzionano e il tipo di interessi che ne determinano l'impiego e i contenuti. Consideriamo in primo luogo la concezione del potere privilegiata dai politologi, per lo più dell'area statunitense, che analizzano la distribuzione del potere al livello delle comunità locali, ad esempio nelle città. Questi autori sono stati fortemente influenzati dal classico studio di Robert Dahl, Who governs? Democracy and power in an American city (1961), una ricerca di impostazione behavioristica sul potere e sul processo decisionale nella città di New Haven negli anni cinquanta. Secondo questa concezione, il potere è relativo a singole decisioni o settori decisionali, e dipende dal contesto locale in cui viene esercitato, sicché la questione che si pone il ricercatore è: quanto potere detengono gli attori rilevanti rispetto ad alcune decisioni o settori decisionali 'chiave' in un dato luogo e in un dato momento, considerando come decisioni 'chiave' o importanti quelle che interessano una parte considerevole della popolazione? (Nel caso della ricerca di Dahl, le questioni 'chiave' erano il risanamento urbano, l'abolizione della segregazione razziale nella scuola e le candidature politiche). Il potere è inteso qui come intenzionale e attivo, in quanto viene misurato studiandone l''esercizio' effettivo - ossia procedendo all'accertamento degli individui che prevalgono nel processo decisionale. Questo è visto come una situazione di conflitto tra interessi, concepiti in termini di preferenze manifeste, rivelate nell'arena decisionale dagli attori schierati a favore delle diverse linee politiche o dai gruppi di interesse: l'esercizio del potere consiste nel prevalere sull'opposizione, ossia nel superare le preferenze contrarie.
Le conclusioni cui giunge gran parte di questa letteratura vengono di solito etichettate come 'pluralistiche': poiché differenti attori e differenti gruppi di interesse prevalgono in differenti ambiti decisionali, non esiste una 'élite dominante' che esercita un potere globale, ma il potere è distribuito pluralisticamente o democraticamente.Opposta a questa concezione del potere è quella secondo cui esso opera al di sotto della superficie osservabile degli interessi-preferenze in conflitto, i quali sarebbero essi stessi formati dal potere. Si tratta di una concezione che, in varie forme, si ritrova in diverse tradizioni di indagine e di pensiero: nelle teorie di ispirazione marxiana sulla coscienza di classe e sull'ideologia - specialmente quelle che si rifanno alla nozione gramsciana di egemonia; nelle indagini di ispirazione freudiana sul ruolo delle pratiche educative nella formazione della personalità e sulle radici culturali della psicopatologia; nelle teorie dell'imperialismo culturale e della 'colonizzazione' menzionate nel capitolo precedente; e infine nel filone di ricerca che ha per oggetto la costituzione della soggettività, la formazione di pratiche discorsive dell'individualità nelle diverse epoche storiche e in differenti contesti culturali, e la 'costruzione' dell'identità e della capacità di agire in rapporto a particolari gruppi - tematiche che sono state al centro del dibattito di storiche e teoriche di orientamento femminista. In questi indirizzi di ricerca una linea di divisione fondamentale è stata quella che ha opposto da un lato i seguaci di Foucault, che considerano questa 'costruzione' un processo onnipresente e unidirezionale che opera attraverso i meccanismi del controllo sociale e discorsivo, e dall'altro gli autori che considerano il processo di costruzione come un progetto contestato che emerge all'interno di relazioni di potere contraddittorie, ambigue e conflittuali. Comunque sia, in tutte queste tradizioni di pensiero il potere è equiparato alla capacità di influenzare le credenze e i desideri degli individui in una pluralità di ambiti e di contesti, attraverso processi che spesso non sono intenzionali e nemmeno compresi, e che potrebbero non richiedere alcuna attività deliberata da parte di chi esercita il potere.
Tuttavia, gli studiosi che concepiscono il potere in questi termini spesso assumono, senza peraltro dichiararlo sempre esplicitamente, che le sue conseguenze siano contrarie agli interessi intesi come condizioni del benessere (l'autonomia razionale, l'autodeterminazione, l'autenticità) delle sue 'vittime'.Incentrando l'attenzione, per il momento, solo su queste due concezioni, è chiaro che alla loro base vi sono motivazioni di ordine sia metodologico che politico. Dahl e i suoi colleghi miravano a sottoporre la cosiddetta 'ipotesi della élite dominante' ad una verifica empirica in termini di comportamento osservabile. Insoddisfatti della genericità delle affermazioni di autori quali C. Wright Mills e Floyd Hunter in merito al potere globale delle élites dominanti, essi intendevano stabilire 'chi governa' accertando chi risulta vincitore in conflitti politici pubblici su decisioni chiave. Ma al di là di questo interesse metodologico, essi intendevano anche verificare la solidità della democrazia americana al livello locale, solidità che essi consideravano in larga misura comprovata dai loro studi, i quali rivelavano una pluralità di 'vincitori'. Per contro, i sostenitori della seconda concezione sono stati in genere critici nei confronti di queste ricerche improntate all''empirismo' e al 'behaviorismo', insistendo sullo iato tra apparenze e realtà che è compito della scienza o dell'interpretazione colmare. Il potere, per questi autori, è al di sotto della superficie, sicché partendo dalle preferenze manifeste e dai conflitti osservabili, o dalla loro assenza, non è possibile arrivare a cogliere la 'reale' struttura del potere che ha la funzione di formare la 'coscienza' o le 'identità'. Tale struttura nascosta viene inoltre equiparata ad una qualche forma di dominio e di oppressione, generatrice di apparenze che ne occultano la natura e i meccanismi di funzionamento.
La prima di queste concezioni è stata oggetto di critiche serrate. Peter Bachrach e Morton S. Baratz hanno osservato che essa mette in luce solo una delle 'due facce del potere'; ne esiste infatti un'altra, che consiste nel potere di determinare quali questioni debbano raggiungere il livello del conflitto pubblico ed entrare nel processo decisionale. Mutuando da E.E. Schattschneider l'espressione "mobilization of bias", essi hanno illustrato alcuni dei modi in cui si può impedire che certe questioni vengano prese in considerazione nel processo decisionale escludendo dall'arena politica le istanze e la protesta di determinati individui e gruppi. Tali istanze sono preferenze nascoste (parzialmente o del tutto inespresse, sub- o prepolitiche) la cui soppressione od esclusione dal processo decisionale viene definita da Bachrach e da Baratz 'processo di non decisione', indicando con ciò che tale potere di esclusione è sia intenzionale che attivo. Ciò che essi proponevano era quindi un'estensione della prima concezione, in grado di abbracciare anche questa seconda faccia o dimensione del potere. Il potere in questa prospettiva è sempre riferito a un contesto specifico e ad ambiti specifici, è intenzionale ed attivo, protegge gli interessi dei potenti agendo contro le preferenze-interessi, manifesti o nascosti, di coloro contro i quali è esercitato e diretto.
Questa concezione venne utilizzata da Matthew Crenson (v., 1971) in uno studio sul controllo dell'inquinamento dell'aria in due città statunitensi, in cui l'autore dimostrò come a Gary, nell'Indiana, la potente industria siderurgica locale fosse riuscita per lungo tempo a sfruttare la propria posizione di monopolio e il proprio prestigio in città per escludere dall'ordine del giorno la questione dell'inquinamento (un raffronto veniva fatto con un'altra città vicina con caratteristiche analoghe, ma in cui non esisteva un potere preponderante di questo genere). Crenson concludeva quindi che un sistema politico può essere pluralistico nel processo decisionale e monolitico o unitario in quello di non decisione.In un precedente lavoro (v. Lukes, 1974) abbiamo cercato di ampliare ulteriormente questa concezione bidimensionale del potere per includervi una 'terza dimensione', sostenendo che il potere è tanto più efficace quanto più chi lo detiene può contare sulla acquiescenza volontaria di coloro sui quali viene esercitato. L'esercizio supremo e più insidioso del potere consiste nell'indurre o nel preservare la conformità delle credenze, dei desideri e delle preferenze degli altri, evitando o eliminando in questo modo la necessità di agire contro le loro preferenze, manifeste o nascoste che siano. In questo caso il potere può agire efficacemente in assenza di conflitti osservabili. Criticando l'impostazione behavioristica delle due concezioni delineate in precedenza, sostenevamo che il comportamento conforme può essere ottenuto senza che i detentori del potere perseguano intenzionalmente questo obiettivo, e senza che debbano intervenire attivamente per raggiungerlo: si tratta di un esito che può verificarsi inconsciamente e impercettibilmente, in modo spontaneo e non intenzionale.
D'altro canto, non abbandonavamo l'idea che il potere è sempre esercitato contro gli interessi degli altri, cosicché anche in questa 'terza dimensione' esso è in contrasto con gli interessi, in questo caso gli 'interessi reali' (riferendoci in particolare all'autonomia), di coloro verso cui è diretto. Questa concezione ha trovato applicazione in un notevole studio sul potere e l'acquiescenza tra i minatori di una valle degli Appalachi condotto da John Gaventa (v., 1980), il quale ha dimostrato come, per lungo tempo, una compagnia mineraria gestita da proprietari assenteisti e un sindacato corrotto fossero riusciti ad inculcare negli abitanti di questa valle un tale senso di impotenza che essi, nonostante le condizioni di estrema miseria e di subordinazione in cui si trovavano, mostravano scarsi segni di resistenza sia aperta che sotterranea.
Questa 'concezione radicale' è stata a sua volta oggetto di numerose critiche. I sostenitori behavioristici della concezione unidimensionale del potere hanno rigettato l'ipotesi che il potere possa manifestarsi senza essere osservabile, ed osservato di fatto sotto forma di comportamento. Come si può concepire il potere come 'non agire'? Come si può studiare ciò che non accade? Altri hanno osservato che di fronte ad un apparente consenso e in assenza di una protesta o di un'opposizione anche nascosta è impossibile stabilire i 'controfattuali rilevanti': come può un osservatore decidere quali siano, tra un numero indefinito di potenziali questioni, quelle cui il potere ha impedito di diventare attuali escludendole dal processo decisionale? E come si può distinguere un consenso 'falso' o manipolato da un consenso autentico? Ulteriori perplessità sono state espresse in merito all'affermazione secondo cui il potere tridimensionale può includere la capacità di provocare conseguenze non intenzionali. Quale deve essere la portata di tali conseguenze, e in che modo la loro inclusione è compatibile con l'asserito legame tra potere e responsabilità? E come può il potere essere passivo? È sufficiente beneficiare dell'acquiescenza degli altri e di una configurazione favorevole di assetti sociali? In che modo si potrà distinguere allora tra potere e fortuna? E come stabilire quali sono gli 'interessi reali' delle persone senza ricadere nel paternalismo o addirittura nell'autoritarismo? E perché si deve necessariamente assumere che il potere va sempre contro gli interessi degli altri? Non potrebbe forse favorirli, e di fatto costituirli?
Sono questi gli interrogativi e le obiezioni suscitati dal tentativo di sviluppare una concezione del potere più ampia di quella ristretta analizzata all'inizio del capitolo. Si tratta però di interrogativi e di obiezioni che possono essere discussi adeguatamente solo se ci poniamo un'altra questione più fondamentale: per quale scopo abbiamo bisogno di una concezione del potere? Quale compito le chiediamo di svolgere? Più precisamente, quali motivazioni si celano dietro il nostro interesse ad accertare dove risieda, quanto sia esteso e come sia distribuito il potere? A tali interrogativi possono essere date diverse risposte che, a loro volta, forniscono ciascuna una base diversa per rispondere alle questioni e alle obiezioni sollevate in precedenza e per risolvere le controversie in merito al modo in cui deve essere concepito il potere.
Problemi posti dallo studio del potere
La risposta più generale alla questione, a quale scopo abbiamo bisogno di una concezione del potere, è che essa ci aiuta a orientarci in un mondo popolato da agenti, sia individuali che collettivi, di cui dobbiamo conoscere i poteri se vogliamo avere una qualche chance di sopravvivere e di prosperare. Disporre di una mappa dei poteri di tali agenti - delle loro potenziali capacità di influire sui nostri interessi - ci consente un certo grado di previsione e di controllo. Senza di essa ci troveremmo in uno stato di natura hobbesiano, vittime ignare di un potere dopo l'altro da cui saremmo liberi solo con la morte.Ma il modo in cui concepiamo tali poteri dipende dai nostri scopi e dalle nostre prospettive. Questi possono essere di natura immediatamente pratica. Se sono un agente della CIA che lavora in un paese straniero, cercherò di reclutare agenti capaci di eseguire compiti specifici in una situazione specifica, e disposti a farlo. Se sono un lobbista che opera a Washington o a Bruxelles, dedicherò la mia attenzione a quelle organizzazioni o a quegli individui che meglio possono tutelare o favorire gli interessi dei miei clienti. Se sono uno studente che frequenta una nuova scuola, vorrò sapere quali studenti più anziani e quali insegnanti evitare.
D'altro canto, si possono avere scopi e prospettive di natura più prettamente politica. Potremmo azzardare l'ipotesi - sebbene a quanto ci risulti non esistano ricerche empiriche che la suffraghino - che le concezioni del potere varino a seconda del grado di prossimità ad esso. Sembra dunque plausibile sostenere che i potenti (perlomeno nelle società democratiche) tendano ad avere una concezione ristretta del proprio potere, considerandolo di ambito e di portata limitati, e legato esclusivamente alle loro intenzioni e alle loro azioni.
I potenti, inoltre, tendono a ritenersi dei benefattori, che tutelano e promuovono gli interessi degli altri anziché danneggiarli. Partendo da una tale concezione, potremmo concludere, i potenti - e chi è loro vicino - troveranno naturale e utile porre l'accento sui limiti e sui condizionamenti cui è soggetto il loro potere, sulla ristrettezza del loro margine d'azione e sul ruolo preponderante del caso e della fortuna. Altrettanto plausibile sembra l'ipotesi inversa, ossia che le persone distanti dal potere e soggette ad esso tenderanno ad averne una concezione ampliata. Costoro saranno più inclini a considerare il potere come esteso ad una pluralità di ambiti e di contesti, ad attribuirgli anche effetti non intenzionali oltreché intenzionali, e a ritenere i potenti responsabili anche di ciò che non impediscono che accada, oltre che di ciò che fanno accadere. Costoro percepiranno gli interessi che il potere danneggia, oltreché quelli che favorisce, e, cercando spiegazioni e forse un rimedio ai mali che li affliggono, riterranno probabilmente i potenti responsabili del loro benessere e della loro felicità. In breve, essi saranno inclini ad avere una concezione allargata di ciò che i potenti sono in grado di fare, e ad avere una visione più strutturale e sistemica del potere.Non intendiamo attribuire validità universale a questa duplice ipotesi.
Non sarebbe difficile trovare esempi contrari, in particolare là dove ideologie fatalistiche riescono a indurre i subordinati ad avere una concezione ristretta del potere. E tuttavia riteniamo che essa abbia il vantaggio di indicare alcuni dei modi (e ne esistono indubbiamente altri) in cui la concezione del potere è una funzione delle relazioni di potere stesse - e può sia derivare da esse che rafforzarle e metterle in discussione.
Il potere, infine, può essere concettualizzato sulla base di scopi e prospettive di tipo accademico o 'scientifico'. In questo caso il problema chiave è se sia possibile arrivare ad una definizione che sia scevra da ogni influenza politica e che consenta di localizzare, misurare e comparare il potere degli agenti sociali in modo 'obiettivo'. Detto in altri termini: esiste un metodo per identificare il potere degli agenti sociali - ossia le loro capacità di influire sugli interessi altrui - in grado di produrre quella che tutte le persone ragionevoli sarebbero concordi nel ritenere la mappa del potere di un dato contesto, o sistema, o società?
Esistono svariati motivi per essere scettici al riguardo. Un primo motivo è dato dai risultati negativi che la ricerca su questo tema ha dato sino ad oggi. Il cosiddetto 'dibattito sul potere' illustrato in precedenza è stato notoriamente incapace, dopo trent'anni di controversie, di approdare ad una qualche definizione concorde. Sotto questo aspetto il dibattito accademico è simile ad altre controversie di questo tipo nella letteratura sul potere. Consideriamo un altro esempio contemporaneo tratto dal campo delle relazioni internazionali. Qui il potere è spesso concepito in termini di risorse o 'capacità', militari, economiche o di entrambi i tipi. A ciò si obietta di solito che sono molti i casi di grandi armate sconfitte da piccoli eserciti più agili e più determinati (ne sono esempi l'invasione tedesca della Francia nel 1940, o la sconfitta degli Stati Uniti in Vietnam), e più in generale, si sottolinea il ruolo cruciale della volontà e dell'abilità. Tuttavia, allorché gli studiosi di economia politica cercano di spiegare il crescente disordine economico internazionale a partire dalla metà degli anni settanta, citano in genere la perdita di potere 'egemonico' da parte degli Stati Uniti, ossia di un potere basato, secondo la definizione di Robert Keohane, sul "controllo delle materie prime, [sul] controllo delle fonti di capitale, [sul] controllo dei mercati, e sul vantaggio concorrenziale nella produzione di beni altamente apprezzati" (v. Keohane, 1984, p. 32). Analogamente, Robert Gilpin vede la presunta perdita di potere degli Stati Uniti in termini di declino delle capacità produttive del paese e della conseguente perdita di mercati rispetto all'Europa e al Giappone, che si traduce in una perdita di volontà e di capacità di guidare il sistema mondiale. Susan Strange e Robert Cox, invece, concepiscono il potere in maniera differente: esso sarebbe basato sulle relazioni transnazionali di accumulazione e sfruttamento, che investono sia il sistema internazionale degli Stati che la struttura produttiva globale, e consisterebbe in una rete di relazioni di dipendenza. Partendo da questo presupposto, Susan Strange conclude che non vi è stata alcuna perdita significativa di potere degli Stati Uniti sulle altre nazioni e sugli operatori di mercato: si tratta infatti di un potere strutturale che non è necessariamente il risultato di politiche deliberate, e pertanto non è definibile in termini di risorse a base geografica che permettono una gestione efficace, la pianificazione dell'attività economica e la formazione di una volontà politica.
Una seconda ragione per nutrire dubbi sulla possibilità di delineare una mappa del potere definitiva risiede in quello che è stato definito "il carattere essenzialmente controverso" del concetto di potere. Se l'analisi condotta sinora è corretta, ogni concettualizzazione del potere implica in parecchi punti giudizi contestabili, alcuni dei quali controversi sul piano morale e politico.
Consideriamo, in primo luogo, il problema dei controfattuali. Nonostante l'obiezione comportamentistica secondo cui le attribuzioni di potere devono essere limitate a ciò che si può osservare, la verità ineludibile è che tutte le attribuzioni di questo tipo implicano enunciati controfattuali. Consideriamo ad esempio l'asserzione di Dahl, secondo cui l'esercizio di potere di A su B cambia il corso d'azione di B: anche in questo caso vale il controfattuale che se non fosse stato per A, B avrebbe agito diversamente. Più in generale, le attribuzioni di potere identificano capacità disposizionali ovvero potenziali, e poiché queste potrebbero non essere esercitate (allo stesso modo in cui un fragile vetro può non rompersi) il potere potrebbe essere interamente controfattuale, rispetto a determinati agenti e all'interno di un contesto o in vari contesti, e inferito dai suoi effetti (ad esempio attraverso reazioni anticipate). Tali attribuzioni di potere saranno sempre invalidabili (come quando i sostenitori di un regime autoritario affermano che il sostegno di cui godono è autentico e non frutto di coercizione o manipolazione).
Consideriamo, in secondo luogo, il problema dell'intenzionalità. L'opinione piuttosto comune secondo cui gli effetti del potere devono essere intenzionali probabilmente ha origine dall'associazione tra potere e responsabilità e dall'idea intuitiva che le conseguenze non intenzionali delle nostre azioni esulino dai nostri poteri. Ma è sufficiente un momento di riflessione per rammentare che nel diritto la responsabilità non è limitata alle azioni intenzionali (ma si estende, ad esempio, anche alla negligenza), e lo stesso vale in altri contesti (di ordine politico, morale, professionale, ecc.). Così ad esempio, i cittadini possono ritenere 'gli uomini di potere' responsabili di effetti non voluti (ed è questa l'opinione di C. Wright Mills), considerando la loro stessa disattenzione per certe conseguenze delle politiche da essi attuate una dimostrazione del loro potere. Ma il punto importante che qui occorre mettere in rilievo è che quando si tratta di decidere in primo luogo se, e in secondo luogo quali, conseguenze non intenzionali debbano essere incluse nell'ambito del potere attribuito ad un soggetto, entrano in gioco giudizi controvertibili che, a loro volta, scaturiscono da giudizi altrettanto controvertibili in merito alle responsabilità dei presunti potenti.In terzo luogo, consideriamo il problema dell'attività e della passività.
Anche in questo caso sussiste una convinzione intuitiva secondo cui avere potere significa agire. Ma esistono due tipi di inattività che contrastano con questa idea. Il primo tipo di inattività, di cui abbiamo già parlato, consiste nel non aver bisogno di agire: vantaggi e privilegi derivano dal semplice fatto di essere in una certa posizione o di avere un determinato status. Ma come distinguere tra le situazioni in cui ciò è dovuto a un particolare sistema o struttura di potere, e quelle in cui è dovuto alla 'fortuna'? A ciò si può rispondere che: 1) le condizioni che generano le ineguaglianze in questione debbono essere 'sistemiche' e 'strutturali', e non già fortuite e imprevedibili, e 2) in merito a tali ineguaglianze deve potersi formulare una valutazione in termini di giustizia e ingiustizia (e quindi si possono pensare assetti sociali alternativi in cui esse siano maggiori o minori); come ha sostenuto F.A. von Hayek, se i processi che ingenerano le ineguaglianze hanno il carattere di processi naturali che sfuggono a un effettivo controllo sociale, allora esse sono attribuibili alla fortuna e non sono né giuste né ingiuste. Ma tutto ciò significa che distinguere tra potere e fortuna implica giudizi controvertibili sui quali non tutte le persone ragionevoli sarebbero d'accordo.
Il secondo tipo di inattività è costituito dall'azione mancata: ciò che Bentham definiva 'azioni negative', e dunque gli atti di omissione contrapposti agli atti di commissione (ad esempio, non cercare di salvare un uomo che annega). Ma in quali casi l'omissione - la mancata prevenzione o limitazione di una determinata conseguenza - è da considerarsi una manifestazione di potere, e in quali invece non lo è? A ciò si può rispondere che una azione negativa è una manifestazione di potere quando: 1) un agente A potrebbe aver compiuto un'azione X; 2) X avrebbe evitato l'effetto Y e 3) A sa, o è ragionevole supporre che avrebbe dovuto sapere, sia 1) che 2). Questa definizione copre tutta una gamma di casi che vanno da quello di una società industriale che non si preoccupa di condurre ricerche sugli effetti dannosi dei suoi prodotti (come l'asbesto o sostanze medicinali nocive), a quello di una società borghese che tollera il lavoro minorile, gli incidenti industriali e altri mali evitabili, così vividamente documentati da Marx ed Engels, a quello infine di uno Stato del Terzo Mondo che non si preoccupa di costituire delle riserve per far fronte ad eventuali carestie.
Alla base delle attribuzioni di potere di questo tipo vi è, ovviamente, l'idea di responsabilità: A è ritenuto responsabile di Y non solo causalmente, ma anche moralmente, legalmente, politicamente, ecc. Il problema della responsabilità solleva quello dei costi e delle condizioni di un'azione efficace. In primo luogo, quali costi comporta, per A e per la società nel suo complesso, prevenire il verificarsi di Y? In secondo luogo, se A è un individuo, può da solo evitare la conseguenza Y, e se è una collettività, è possibile risolvere i problemi dell'azione collettiva? E infine, quale X è rilevante, ossia, dove va ricercata la causa della mancata prevenzione di Y? Le carestie sono imputabili a una mancanza di riserve oppure ad una mancanza di democrazia? In sintesi, se un intervento esterno potesse far cessare una guerra, quali costi avrebbe, da chi dovrebbe essere attuato, e come? Tuttavia, all'interno della classe di azioni negative individuate in base ai criteri sopra enunciati, solo una sottoclasse sarà definibile in modo pertinente in termini di manifestazione di potere. Solo in alcuni casi, infatti, avrà un senso considerare le azioni mancate come manifestazioni di potere. Di solito non ha molta utilità attribuire questo tipo di potere ipotetico, passivo ad attori storici. Quando ciò ha una qualche utilità, questa può essere diretta - come nel caso in cui i cittadini o i critici della società cercano di identificare 'gli uomini di potere', o i movimenti sociali cercano di mobilitarsi contro un determinato gruppo o strato sociale - oppure indiretta, come quando le autrici femministe descrivono esempi storici di patriarcato in termini di struttura di potere. Ma anche in questo caso, nell'attribuzione di potere entrano in gioco giudizi contestabili.
Consideriamo, infine, il problema degli interessi. Come abbiamo visto, definire gli interessi degli individui significa non solo localizzare il potere ma anche effettuare valutazioni comparative della sua estensione, dato che tali valutazioni sono di norma inseparabili da un giudizio in merito alla rilevanza dei suoi effetti. Il problema di stabilire cosa favorisca e cosa invece danneggi gli interessi delle persone è sempre presupposto nelle attribuzioni di potere, e costituisce spesso la materia del contendere nei dibattiti su questo tema. Consideriamo la questione assai controversa del potere della televisione. Se i fornitori dei programmi e della pubblicità televisivi abbiano potere in rapporto agli spettatori e quanto potere abbiano è in parte, ovviamente, una questione empirica, soggetta alla verifica di una ricerca sistematica. Ma si tratta anche, in parte, di un problema concettuale relativo alla definizione degli interessi delle persone. In qualità di consumatori gli individui hanno interessi definibili in termini di preferenze, ma si potrebbe legittimamente sostenere che hanno anche interessi definibili in termini di benessere e di felicità; e non sembra verosimile un consenso ragionevole sull'ordine di priorità da assegnare all'uno e all'altro tipo di interessi, e nemmeno sulla definizione di ciò in cui essi rispettivamente consistono.Partendo da queste considerazioni possiamo trarre una conclusione generale che costituisce una terza ragione per essere scettici sulla possibilità di una convergenza, e cioè che esistono argomenti convincenti in favore dell'una e dell'altra posizione: sia in favore di una concezione ristretta del potere, sia in favore di una concezione ampliata. Nel primo caso si argomenterà che la concezione ristretta ha confini precisi; che è in grado di specificare a quali verifiche empiriche devono essere sottoposte le ipotesi; che evita molte delle difficoltà insite nella concezione ampliata, e che questa risulta in ogni caso superflua poiché i processi e le relazioni che cerca di includere nella categoria del 'potere' possono essere ricompresi in altri concetti. Nel secondo caso si argomenterà che il potere va considerato un fenomeno unitario, del quale la concezione ristretta coglie solo gli aspetti più superficiali; che di fatto, focalizzando l'interesse esclusivamente su questi ultimi non si presta la debita attenzione all'estensione degli effetti del potere; che le difficoltà menzionate non si risolvono ignorandole o trasferendole sotto un altro concetto; e infine, che le forme più sottili e pervasive del potere sono per loro natura le meno accessibili all'osservazione e le più problematiche per la ricerca empirica.Concluderemo il nostro discorso con alcune osservazioni a sostegno di quest'ultima asserzione. Quando cerchiamo di comprendere il potere, il modo in cui lo concepiamo è legato in varie maniere al fenomeno che stiamo cercando di comprendere. Il nostro scopo è quello di darne una rappresentazione adeguata a fini descrittivi ed esplicativi, ma la nostra concezione può essere derivata e condizionata dal fenomeno stesso che stiamo cercando di descrivere e di spiegare. Le nostre idee sul potere possono servire a riprodurre e a rafforzare strutture e relazioni di potere esistenti, oppure a contestarle e a sovvertirle; possono contribuire a mantenerle operanti o possono smascherare i principî che ne regolano il funzionamento, e la cui efficacia è accresciuta proprio dal fatto di essere sottratti alla visibilità. Nella misura in cui quest'ultima ipotesi è vera, un aspetto del potere sarà la sua capacità di autonascondimento, che eluderà ogni metodologia incentrata esclusivamente su ciò che è direttamente o immediatamente osservabile. Se si ammette questa possibilità, a nostro avviso, si avrà una ragione decisiva per adottare una concezione ampliata anziché ristretta del potere.
(V. anche Autorità; Consenso; Eguaglianza; Legittimità).
Bibliografia
Arendt, H., On violence, New York 1970 (tr. it.: Le due facce del potere, Padova 1986).
Bachrach, P., Baratz, M.S., Power and poverty: theory and practice, New York 1970.
Baldwin, D., Paradoxes of power, New York-Oxford 1989.
Barnes, B., The nature of power, Cambridge 1988.
Barry, B. (a cura di), Power and political theory. Some European perspectives, London 1976.
Bell, R., Edwards, D.V., Wagner, R.H., Political power. A reader in theory and research, New York 1969.
Boulding, K.E., Three faces of power, Newbury Park, Cal., 1989.
Bourricaud, F., Esquisse d'une théorie de l'autorité, Paris 1961.
Clegg, S., Frameworks of power, London 1989.
Crenson, M.A., The un-politics of air pollution. A study of non-decisionmaking in the cities, Baltimore, Md., 1971.
Dahl, R.A., Who governs? Democracy and power in an American city, New Haven, Conn.-London 1961.
Debnam, G., The analysis of power. A realist approach, London 1984.
Dowding, K., Rational choice and political power, Aldershot 1991.
Elster, J., Sour grapes. Studies in the subversion of rationality, Paris 1983 (tr. it.: Uva acerba. Versioni non ortodosse della razionalità, Milano 1989).
Foucault, M., Power/knowledge, New York 1980.
Friedrich, C.J., Authority, reason and discretion, in Nomos I: Authority (a cura di C.J. Friedrich), Cambridge, Mass., 1958.
Friedrich, C.J., Man and his government: an empirical theory of politics, New York 1963.
Galbraith, J.K., The anatomy of power, Boston, Mass., 1983.
Gaventa, J., Power and powerlessness. Quiescence and rebellion in an Appalachian valley, Oxford 1980.
Harré, R., Madden, E.H., Casual powers. A theory of natural necessity, Oxford 1975.
Hartsock, N., Money, sex and power. Towards a feminist historical materialism, New York-London 1983.
Hirschman, A.O., The rhetoric of reaction, Cambridge, Mass., 1991 (tr. it.: Retoriche dell'intransigenza: perversità, futilità, messa a repentaglio, Bologna 1991).
Honneth, A., Kritik der Macht. Reflexionstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie, Frankfurt a.M. 1985.
Hunter, F., Community power structure. A study of decision makers, Chapel Hill, N.C., 1953.
Isaac, J.C., Power and marxist theory. A realist view, Ithaca, N.Y.-London 1987.
Keohane, R.O., After hegemony. Co-operation and discord in the world political economy, Princeton, N.J., 1984.
Lasswell, H., Kaplan, A., Power and society. A framework for political inquiry, New Haven, Conn., 1950 (tr. it.: Potere e società. Uno schema concettuale per la ricerca politica, Milano 1969).
Lenski, G., Power and privilege. A theory of social stratification, New York 1966.
Luhmann, N., Macht, Stuttgart 1975 (tr. it.: Potere e complessità sociale, Milano 1979).
Lukes, S., Power: a radical view, London 1974.
Lukes, S. (a cura di), Power, Oxford 1986.
Macpherson, C.B., Democratic theory, Oxford 1983.
Mills, C.W., The power elite, New York 1956 (tr. it.: L'élite del potere, Milano 1959).
Morris, P., Power. A philosophical analysis, Manchester 1987.
Nagel, J.H., The descriptive analysis of power, New Haven, Conn.-London 1975.
Neumann, F., The democratic and the authoritarian State. Essays in political and legal theory (1957), Glencoe, Ill., 1964 (tr. it.: Lo Stato democratico e lo Stato autoritario, Bologna 1984).
Nozick, R., Coercion, in Philosophy, politics and society (a cura di P. Laslett, W.G. Runciman e Q. Skinner), Oxford 1972.
Olson, M., The logic of collective action: public goods and the theory of groups, Cambridge, Mass., 1965 (tr. it.: La logica dell'azione collettiva: i beni pubblici e la teoria dei gruppi, Milano 1983).
Plott, C.R., Levine, M.E., A model of agenda influence on committee decisions, in "American economic review", LXVIII, marzo 1978, pp. 146-160.
Polsby, N.Y., Community power and political theory, New Haven, Conn., 1963.
Popitz, H., Phänomene der Macht, Tübingen 1986.
Riker, W.H., The art of political manipulation, New Haven, Conn.-London 1986.
Rothschild, K.W. (a cura di), Power in economics, Harmondsworth 1971.
Russell, B., Power. A new social analysis, London 1938 (tr. it.: Il potere: una nuova analisi, Milano 1976).
Simmel, G., Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Leipzig 1908, 1923³ (tr. it.: Sociologia, Milano 1989).
Stoppino, M., Potere politico e Stato, Milano 1968.
Stoppino, M., Le forme del potere, Napoli 1974.
Strange, S., Finance, information and power, in "Review of international studies", 1990, XVI, pp. 259-274.
Wartenberg, T.E., The forms of power: from domination to transformation, Philadelphia, N.J., 1990.
Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der Verstehenden Soziologie, Tübingen 1922 (tr. it.: Economia e società, 4 voll., Milano 1995).
Wertheimer, A., Coercion, Princeton, N.J., 1987.
White, D.M., The problem of power, in "British journal of political science", 1972, II, pp. 470-490.
White, D.M., The concept of power, Morristown, N.J., 1976.
Wolff, R.P., In defence of anarchism, New York 1970.
Wrong, D.H., Power. Its forms, bases and uses, Oxford 1979.
Young, I.M., Justice and the politics of difference, Princeton, N.J., 1990.