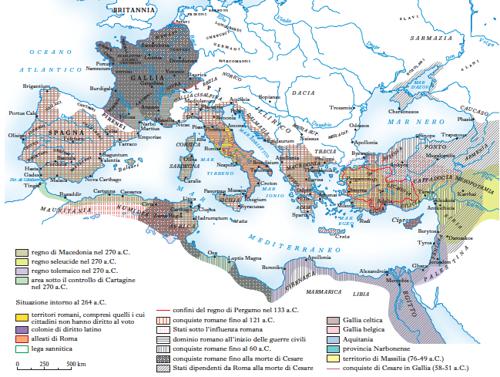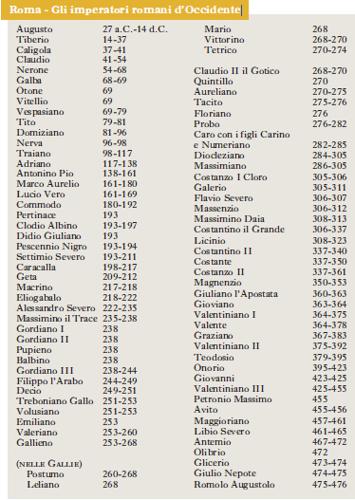Roma
Roma
Città, capitale della Repubblica italiana.
La monarchia
La tradizione annalistica romana faceva risalire la fondazione di R. al 754 o 753 a.C. e la riconnetteva, basandosi su leggende di varia origine (latina, romana, greca), con i troiani provenienti da Ilio sotto la guida di Enea e con i re di Alba, discendenti di Enea. Le testimonianze archeologiche provano che dal sec. 10° al 7° sui colli romani si venne formando una serie di centri e in particolare che sul Palatino, il colle della «città di Romolo», esisteva già nel sec. 8° un centro abitato. Tali comunità dei colli romani, raggiunta col tempo una certa unità politica, parteciparono alle leghe religiose latine: la più antica di cui abbiamo notizia è quella che sul Monte Cavo riuniva una trentina di comunità attorno al santuario di Giove laziale. In un primo tempo, la supremazia fu di Alba; ma in seguito a lotte, sulle quali abbiamo solo notizie leggendarie, Alba fu distrutta e R. divenne la città egemone della Lega latina (secondo la tradizione vulgata, al tempo del re Tullo Ostilio). Di R. nei tempi dell’età regia (date tradizionali: 754 o 753-509), come del resto di tutto il periodo che precede l’incendio gallico (390), non abbiamo informazioni degne di fede, salvo che su singoli momenti. La serie dei «sette re di R.» (Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo) contiene probabilmente degli elementi di verità, ma va tenuto presente che si tratta di una costruzione abbastanza tarda, nella quale, per ragioni di sistemazione cronologica, la successione e il numero e le figure stesse dei re che effettivamente ressero la città subirono probabilmente alterazioni sensibili. Le prime figure di re, come Romolo o Numa Pompilio, hanno carattere leggendario (certamente Romolo); ad altre, come Servio Tullio, furono attribuite grandi innovazioni nell’ordinamento politico e militare e nella sistemazione della città, che sono invece posteriori. In generale, si possono distinguere nell’età regia di R. due fasi: la prima, di dominio dell’elemento latino (ma anche sabino); la seconda, dell’elemento etrusco, che corrisponderebbe ai re Tarquinio Prisco, Servio Tullio (secondo una buona tradizione, in etrusco, Mastarna) e Tarquinio il Superbo. La documentazione archeologica e linguistica, oltre alle notizie sull’espansione etrusca nei secc. 7° e 6° nell’Italia centrale e meridionale, sembra confermare infatti che nel sec. 6° una dinastia etrusca occupò il trono romano. In quest’epoca R. si afferma come vera e propria grande città murata, tra le più notevoli dell’Occidente mediterraneo, e la sua egemonia sui latini si spiega nella cornice del generale periodo di potenza etrusca, terrestre e marittima. La struttura sociale e politica di R. regia era fondata, secondo la tradizione vulgata, sulla tripartizione della città in tribù (Ramnenses, Titienses, Luceres), in curie (dieci per ogni tribù) e in gentes. Le funzioni di queste divisioni e di questi raggruppamenti non sono ben note, anche perché subirono presto notevoli trasformazioni. Sembra che le tribù avessero in origine, nel periodo precedente all’ordinamento centuriato (➔ centuriazione), il compito di fornire la base del reclutamento dell’esercito romano; le curie rappresentavano forse il residuo della primitiva autonomia delle comunità riunitesi a formare Roma. Nelle gentes, elemento fondamentale della struttura sociale romana, si raggruppavano, attorno al comune culto degli antenati, le famiglie ricche di tradizioni e potenza economica (fondamentalmente agraria), che costituivano, mercé la riunione collegiale dei capigente (patres, patrizi), il Senato. Di fronte alle gentes era la plebe: la moltitudine dei romani, privi dei fondamentali privilegi politici, religiosi e sociali, che costituì a lungo l’elemento antagonista del patriziato, cui cercò, attraverso una lotta secolare, di strappare la piena parità nella vita cittadina. Sembra che il predominio patrizio sia stato indebolito dagli ultimi re etruschi, i quali, con il riconoscimento di nuove gentes di origine plebea (donde poi la distinzione di genti maggiori e genti minori), con l’introduzione (che sembra risalire a quest’epoca) dell’ordinamento militare centuriato, e con l’avocare a sé stessi molti poteri e privilegi religiosi e politici, compirono opera in certo senso democratica. Contro questa il patriziato reagì: e nella caduta della monarchia e nel nuovo ordinamento repubblicano, nel quale le rigide distinzioni di classe furono restaurate e la monarchia vitalizia sostituita da una duplice monarchia annuale (➔ console), riservata ai patrizi, si può scorgere appunto la riaffermazione della forza e dei privilegi della classe superiore, contro le nuove gentes di origine plebea e la plebe stessa.
La repubblica. Dalla repubblica patrizia alla repubblica patrizio-plebea
Sotto i re etruschi, R. aveva raggiunto un notevole grado di prosperità e di importanza politica nel Lazio; con il declino della potenza etrusca (battaglia di Cuma; battaglia di Ariccia) e con le vicende che portarono allo stabilimento della repubblica, R. entrò in un periodo di crisi nel quale, all’indebolirsi della potenza esterna, corrispose l’aggravarsi dei contrasti interni. Gli etruschi recarono poi un grave colpo alla città con la spedizione di Porsenna, conclusasi, sembra, con un patto per il quale la repubblica romana si trovava notevolmente limitata nella sua autonomia politica. Le città della Lega latina si sottrassero allora all’egemonia di R.; solo dopo una guerra, assai difficile per R., che era anche stretta a Nord dalla potenza etrusca di Veio, si poté venire a un’alleanza tra i romani e i latini, col cd. (e assai discusso) foedus Cassianum (493, console Spurio Cassio), cui, più tardi secondo la tradizione, aderirono anche gli ernici. Compito della nuova lega era soprattutto la difesa dai volsci e dagli equi; R. in particolare fu invece nel sec. 5° impegnata nella lotta contro Veio. Intanto, nella prima metà di questo secolo, la tradizione, lacunosa, oscura e mista di elementi leggendari, permette di scorgere le linee generali dell’evoluzione costituzionale romana, incentrata nella lotta dei plebei contro i patrizi fondatori dell’ordinamento repubblicano, per la conquista di una legislazione scritta che garantisse l’eguaglianza civile e per lo stabilirsi di garanzie costituzionali contro il prepotere e il privilegio della classe senatoria. Nel sec. 5°, come primo frutto delle lotte della plebe per la conquista della parità sociale e politica, si ebbe l’istituzione del tribunato della plebe; intanto, la lotta della plebe era stata facilitata dalla dissoluzione dell’originaria divisione in tre tribù, sostituita con una nuova divisione, puramente territoriale, dovuta a necessità militari e tributarie. R. città era stata divisa in 4 tribù urbane e il suo contado in 16 tribù rustiche (che nei secoli crebbero fino a 35). Si ebbe poi la legislazione scritta. La tradizione narra che un collegio di dieci magistrati patrizi (decemviri) ebbe l’incarico di codificare le leggi, fino allora tramandate oralmente, patrimonio dell’aristocrazia e del sacerdozio romano, e svolse la sua opera in un anno (451); l’anno seguente, essa fu compiuta da un altro decemvirato, nel quale cinque membri erano plebei. Il frutto di questa codificazione furono dodici tavole di bronzo nelle quali erano incise le leggi (➔ Dodici tavole); questo codice fu considerato sempre la base di tutto il diritto romano. Difficili a intendere sono le tradizioni che parlano di un violento contrasto tra patrizi e plebei attorno al secondo collegio decemvirale; forse la plebe intese, mercé questo collegio, abolire il consolato, che però fu ristabilito. Certamente, nel secolo che seguì, al consolato fu spesso sostituito un collegio di tribuni militum consulari potestate, carica alla quale aveva accesso la plebe; e in contrapposto a quest’affermazione plebea si ebbe l’istituzione della censura patrizia. Intanto, l’am;missione al tribunato consolare portò i plebei a poter rivestire la questura e da questa a entrare nel Senato. Poi una delle leggi Licinie-Sestie (366) stabilì che uno dei due consoli annuali dovesse essere plebeo; successivamente tutte le altre principali cariche, dittatura (356), censura (351), pretura (337), collegi dei pontefici e degli auguri (lex Ogulnia, 300), furono aperte alla plebe. La parificazione dei due ordini fu piena quando le adunanze della plebe (concilia plebis tributa), risalenti almeno all’epoca dell’istituzione delle tribù urbane e rustiche, divennero giuridicamente valide quanto i comizi curiati e centuriati: la lex Publilia del 339 sembra rendesse valide per tutto il popolo romano le deliberazioni dei concilia della plebe, che divennero così giuridicamente perfetti («comizi tributi»), pur essendo necessaria, come appare, la ratifica del Senato. A questa assemblea presero a partecipare anche i patrizi, finché la lex Hortensia (287) la liberò dalla ratifica del Senato. Così la legislazione romana acquistava una nuova sede, i comizi tributi, dove l’iniziativa spettava ai tribuni. Nel frattempo, però, la nuova nobiltà plebea, costituita dagli elementi arricchiti, prese ad accostarsi sempre di più al vecchio patriziato; la trasformazione dei comizi centuriati (dell’esercito in armi) in comizi di cittadini divisi a seconda del censo (che costituiva il fondamento della ripartizione degli oneri militari, i maggiori spettando alle classi alte) portò alla formazione di un’assemblea nella quale le centurie costituite dai cittadini di censo più elevato erano numericamente prevalenti sulle altre: è l’ordinamento centuriato dei cittadini che la tradizione faceva risalire al re Servio Tullio, ma che si ritiene da taluni attuato nel sec. 4°. Si realizzò così tra i due comizi (tributi e centuriati: quelli curiati avevano ormai solo funzioni ridotte) e il Senato un complesso sistema di equilibrio tra le classi, nel quale però la predominanza del vecchio patriziato e, soprattutto, della più recente nobiltà ricca d’origine plebea, si attuava pienamente. La funzione del tribunato della plebe si esaurì col finire delle grandi lotte per la parità giuridica, rimanendo come semplice strumento di controllo, finché i Gracchi, tre secoli dopo, non la riesumarono con fini rivoluzionari.
L’unificazione della Penisola Italiana
Nel sec. 5°, controllati i volsci e gli equi, R. dovette affrontare Veio; e contro quest’ultima fu combattuta una guerra che ebbe varie fasi. Iniziata tra il secondo e il terzo decennio del sec. 5°, vide più volte sconfitti i romani, finché, dopo la vittoria sui fidenati alleati di Veio (435), dopo un lungo assedio (iniziato circa nel 405), la città etrusca cadde (396) per opera del dittatore M. Furio Camillo. Dal suo territorio furono formate quattro nuove tribù rustiche: così R. poté estendere il suo dominio a N. fino ai Monti Cimini, che chiudono il Lazio. Ma la caduta di Veio era stata resa possibile anche dall’indebolimento della potenza etrusca, causato dalla pressione dei celti (galli) che attorno al 400 si erano estesi nella pianura del Po e andavano rafforzandosi in Emilia. Intorno al 390 nuove tribù celtiche attaccarono l’Etruria e mossero rapidamente contro Roma. Sconfitti i romani al fiume Allia, i galli conquistarono la città (salvo la rocca capitolina) e non si ritirarono se non dopo averla devastata e incendiata. La sconfitta di R. provocò il disgregarsi della Lega latina; e solo con sforzo poderoso, cui è legato il nome di Furio Camillo, i romani poterono restaurare la propria egemonia, sottomettere le città etrusche di Cere, Tarquinia, Faleri e costringere i volsci a entrare nella lega, che riorganizzarono, sottomettendola più saldamente. Al termine di questo travagliato periodo, R. estendeva il suo dominio diretto o indiretto, mercé deduzione di colonie o patti di alleanza, dai Monti Cimini a Terracina. Nel 348 un trattato con Cartagine (che era stato preceduto forse da un altro, alla fine del sec. 6°) riconosceva i confini del dominio romano verso S. Intanto, nel corso del sec. 5°, nell’Italia centromeridionale si era andata affermando la potenza dei sanniti, a danno soprattutto delle città italiote della Campania, mentre le altre città più a S dovettero per difendersi unirsi in una Lega italiota che poggiò a lungo sull’aiuto di Siracusa. I sanniti del centro, legati ai frentani, costituirono una forte unità politica, simile nella struttura alla Lega romano-latina; e contro questa R. dovette affrontare una lotta lunga e durissima, che durò, in varie riprese, oltre cinquant’anni. Le notizie su questo importante periodo della storia di R. sono scarse e oscure. Le guerre sannitiche misero a dura prova la compattezza del dominio romano; i sanniti riuscirono a farsi alleati non solo gli etruschi e i galli, ma anche, in certi momenti, popoli alleati di R., o sotto diretto dominio romano, come gli ernici. In seguito alle vicende delle guerre sannitiche, infatti, scoppiò la rivolta dei latini, che terminò con un ulteriore rafforzamento di R. e con la dissoluzione della Lega latina (338), sostituita da una serie di alleanze stipulate direttamente tra R. e le singole città, cui fu vietato di allearsi tra loro. Al termine di queste guerre, dopo una violenta e grave insurrezione dei galli senoni e poi dei galli boi (285-283), vittoriosamente domata, il territorio della repubblica romana misurava almeno 20.000 km2 e quello degli alleati 60.000 km2; gli abitanti, complessivamente, ammontavano a tre milioni. La federazione romano-italica era ormai tra gli Stati mediterranei ed ellenistici superata solo dall’impero di Cartagine e dai regni di Egitto e di Siria. Complesse vicende politiche e militari dell’Italia meridionale portarono frattanto R. a conflitto con Taranto. La città greca si era procurata l’alleanza di Pirro, re d’Epiro, che sbarcò in Italia nella primavera del 280: ne seguì una guerra (➔ Pirro) nella quale R. subì pericolose sconfitte, finché, dopo varie vicende, constatato che non riusciva a piegare la forza militare e politica dei romani, Pirro tornò in Grecia (275). Taranto si arrese nel 272 e dovette entrare nella federazione italica, seguita da Reggio nel 270. Intanto, tra il 272 e il 265, bruzi, lucani, sanniti, piceni, umbri, iapigi furono domati da R. e sistemati nella federazione italica; l’etrusca Volsini fu distrutta. Nei decenni seguenti alla guerra di Pirro, R. aveva così unificato la Penisola Italiana. Il sistema del dominio romano era già allora assai complesso: non esisteva, e non esistette a lungo, una struttura uniforme del dominio, ma questo era fondato su tre tipi fondamentali di rapporti: città con piena cittadinanza (colonie), municipi, città alleate (➔ municipio; federato). In realtà però le sfumature dell’applicazione di questi concetti giuridici erano assai numerose, e non sono ben chiare e note in tutti i loro particolari. I municipi, per es., potevano godere di maggiori o minori diritti, e così le città alleate, le cui autonomie amministrative e politiche variavano molto da caso a caso. Un elemento però stringeva saldamente questo complesso organico, derivato dalla federazione romano-italica ma ormai centrato in R.: il dovere militare, che per tutti i centri del dominio romano era regolato o dalla legge stessa di R. (per le colonie e per i municipi) o dai singoli trattati di alleanza con le città socie, tenute, in diversa misura e modo, a fornire le truppe ausiliarie; in particolare, le città costiere, a fornire navi e ciurme. Il processo di latinizzazione dell’Italia proseguì senza mai arrestarsi; la superiorità militare e politica di R. era rafforzata e giustificata dall’efficacia del suo sistema giuridico che si andava spontaneamente affermando, recando pace e miglioramenti delle condizioni civili.
Le guerre puniche e macedoniche
Dalla metà del sec. 3° alla metà del 2°, R., che aveva già unificato la Penisola Italiana, divenne la prima potenza del mondo antico: in un secolo furono distrutti l’impero cartaginese e annientati, o gravemente minati nella loro potenza, i regni ellenistici. Le forze tradizionali del mondo mediterraneo, cartaginesi e greci, scomparvero e la struttura politica del mondo antico fu interamente rinnovata. Questi grandiosi eventi ebbero naturalmente il risultato di trasformare dall’interno la società e la civiltà romane; a questo periodo di grande espansione seguì infatti un secolo di lotte e di guerre civili, dalle quali il carattere della repubblica patrizio-plebea uscì interamente trasformato, anche prima che il mutamento si manifestasse esteriormente con la fondazione della monarchia di Cesare e del principato di Augusto. Fin dai secc. 7° e 6° Cartagine aveva esteso il suo impero sul Mediterraneo orientale, impero «commerciale», come è stato chiamato, sorto e fondato soprattutto in virtù dei traffici nei quali i fenici, fin da antichissima epoca, detenevano il primato. In Italia la presenza dei cartaginesi si faceva avvertire soprattutto lungo la costa tirrenica, dove il contatto con gli etruschi aveva portato anche ad alleanze militari contro le quali si erano dovute scontrare duramente le città greche. L’urto con R., con la quale Cartagine aveva avuto fino alla metà del sec. 3° rapporti di amicizia, divenne inevitabile dopo che le guerre di Pirro avevano portato R. a unificare la penisola e a raggiungere così la punta estrema della Calabria, venendo perciò a contatto con la Sicilia, della quale Cartagine divideva il dominio con Siracusa e nella quale aveva fortissimi interessi. Lo scoppio nel 264 a.C. della prima guerra punica, col passaggio dell’esercito romano in Sicilia, non a torto è stato considerato il momento decisivo della storia di R.: quello in cui i limiti ancora esistenti alla potenza romana, la sua caratteristica esclusivamente terrestre e i suoi interessi esclusivamente italici, caddero, e le necessità militari e politiche della guerra contro Cartagine, potenza dagli interessi e dall’influenza tanto vasti, dettero allo Stato romano quello straordinario impulso espansivo che ne caratterizzò poi la vita fino all’impero. D’altra parte, l’entrare a contatto con l’impero cartaginese e con le sue alleanze favorì una migliore conoscenza del mondo ellenistico-orientale, non più soltanto sul piano culturale e della civilizzazione, ma anche sul terreno politico. Le vicende della prima guerra punica (264-241), vinta da R., soprattutto per merito della flotta, prima inesistente e creata per l’impossibilità di battere i cartaginesi nelle loro munitissime piazzeforti siciliane senza bloccare i mari, dimostrarono che R. ormai non aveva nel Mediterraneo occidentale rivali con i quali non potesse competere. Con la riduzione a provincia della Sicilia (seguita poi da Sardegna e Corsica), R. stabilì il suo dominio oltremare e aggiunse al suo già complesso sistema di egemonia una nuova creazione, la provincia. Ma Cartagine, le cui risorse economiche e politiche non si erano esaurite con la guerra, cercò di riconquistare in Spagna il primato perduto nel Mediterraneo centrale. E proprio dalla Spagna mosse l’esercito cartaginese di Annibale quando, dopo la rinascita della potenza di Cartagine, R., decisa a tenere fermo il confine dell’Ebro e a non permettere in nessun modo che la città rivale acquistasse ulteriore influenza, accettò il nuovo conflitto. Se la prima guerra punica aveva dimostrato che R. aveva ormai il dominio del mare, la seconda (218-201 a.C.) dimostrò che Cartagine era bensì in grado di battere R. nella guerra terrestre, e quasi di prostrarla, ma che l’organismo politico della federazione romano-italica era assai più forte dell’oligarchia cartaginese e in grado di affrontare una lunga guerra di logoramento, ciò che Cartagine, per ristrettezza di vedute politiche e per mancanza di tradizione militare cittadina (il suo esercito era pressoché interamente mercenario), non poteva fare. La lunga serie di sconfitte che Annibale inflisse a R. portando la guerra nella Penisola Italiana fin sotto le mura della città, che culminò a Canne (216) con la distruzione dell’esercito di due consoli, non riuscì a realizzare il fine che il generale, uomo di grande intelligenza politica, si era proposto, e cioè di sollevare gli alleati e i sudditi italiani di R. contro R., disfacendone la secolare opera di unificazione, nella quale egli vedeva consistere la potenza romana. Alla fine della guerra, che si concluse non in Italia (donde Annibale, ormai isolato e logorato, dovette partire per accorrere a difendere Cartagine dall’esercito di Scipione) ma in Africa, non soltanto R. aveva abbattuto definitivamente la forza politica di Cartagine, ma aveva rinsaldato la sua dominazione, tanto che subito fu in grado, nonostante le condizioni di fortissimo logoramento in cui si trovava, di affrontare i nuovi problemi che la Grecia e l’Oriente le ponevano. Nel corso della guerra, l’aristocrazia romana aveva espresso una grande classe dirigente militare, e in Publio Cornelio Scipione Africano una forte personalità di generale e politico, all’altezza dei grandi compiti che R. doveva affrontare e che egli portò a termine: la vittoria su Annibale e, vari anni dopo, quella sul regno di Siria. Durante la seconda guerra punica, Cartagine si era procurata l’alleanza di Filippo V di Macedonia; le guerre macedoniche e la guerra di Siria (➔ Antioco III il Grande) furono conseguenza di quel primo contatto. In queste guerre, che occuparono il quarantennio successivo alla fine della seconda guerra punica, R. dovette affrontare problemi politici interamente nuovi. L’urto con Cartagine aveva dato a R. il dominio del Mediterraneo occidentale; il mondo greco-orientale rimaneva ancora fuori dalla sua sfera di interessi e le era ancora poco noto. L’intrico delle lotte tra le città greche, il conflitto di interessi tra Macedonia e Siria, l’indebolirsi della potenza dell’Egitto tolemaico dettero modo a R., entrata nel primo conflitto con la Macedonia per limitarne la potenza crescente che faceva temere per i recenti acquisti illirici (R. aveva messo piede sull’altra sponda dell’Adriatico nel corso del sec. 3°), di sviluppare una complessa e non sempre chiara politica di egemonia, valendosi delle vittorie militari per affermarsi come arbitra e pacificatrice della Grecia e dell’Egeo. Qui però il sistema di dominare mercé i trattati di alleanza, e con armi soprattutto diplomatiche e politiche, sembrò fallire. La Grecia aveva troppo forte la tradizione delle libertà cittadine, e troppo alto il senso della propria superiorità culturale, per sottostare al dominio romano. Si può affermare che alla conquista dell’Oriente R. fu tratta da una serie di eventi politici nei quali l’iniziativa fu quasi sempre dalla parte greca o macedone o siriaca; la mancanza di un piano preordinato a lunga scadenza, caratteristica dell’espansione romana in tutta l’età repubblicana, fino a Pompeo e Cesare, si dimostrò chiaramente nel corso delle guerre macedoniche, che ebbero sostanzialmente il carattere di risposta a offese o a pericolose iniziative degli avversari, non senza che i romani cominciassero a trarne qualche vantaggio economico. Il compito che gran parte della classe dirigente romana, o per filellenismo o, al contrario, per diffidenza e avversione alle cose greche, si era proposto, e cioè di dominare la Grecia e il Vicino Oriente senza mescolarvisi direttamente, fallì. Alla fine delle guerre macedoniche (168 a.C.) il dominio romano era direttamente stabilito in Grecia e nell’Egeo e il sistema degli Stati asiatici largamente influenzato dagli interessi romani; dopo l’ultima ribellione della Grecia, domata con grande durezza (146), tutte le leghe di città greche furono disciolte; le comunità che non avevano partecipato alla guerra, mantenute nella condizione di alleate, le altre ridotte a tributarie e sottoposte ai governatori della costituita provincia di Macedonia. Nello stesso anno, dopo un durissimo assedio, la terza guerra punica, voluta soprattutto dai ceti commerciali romani gelosi della rivale che era tornata a fiorire, finì con la distruzione di Cartagine, che scomparve come centro abitato, fino a che Giulio Cesare, dopo cento anni, non vi dedusse una colonia. Venti anni dopo la terza guerra punica, con l’assog;gettamento del regno di Pergamo e la creazione della provincia di Asia (126), il dominio romano comprendeva, oltre l’Italia, la Gallia cisalpina (ampiamente latinizzata e colonizzata nel corso del sec. 2°), l’Istria e la Dalmazia (assoggettate tra il 180 e il 160), sette province: Sicilia, Sardegna-Corsica, Spagna Citeriore e Spagna Ulteriore (risalenti alla seconda guerra punica), Macedonia, Africa e Asia. Il dominio indiretto si estendeva poi, specie in Africa e Asia, a regni alleati e a città libere alleate; i commerci romani arrivavano ormai quasi in tutto il mondo conosciuto e i contatti con la civiltà ellenistica e orientale si facevano sempre più importanti per la vita di R., avviandosi a divenire un elemento fondamentale di quella vasta trasformazione della società e della civiltà romane che già da un secolo si era iniziata. Raggiunta nel sec. 3° la piena parità dei diritti tra plebe e patriziato, si era formata la nuova classe dirigente patrizio-plebea, e questa aveva condotto le grandi guerre dell’unificazione e del dominio esterno. La vastità e durezza di queste e la complessità dei problemi di natura politica, economica, militare, che R. per un secolo aveva dovuto affrontare, avevano prodotto una decadenza sempre più notevole dell’elemento contadino-popolare come forza di governo, espresso nei comizi, a favore del Senato divenuto, per la sua omogeneità e capacità di iniziativa unitaria, il centro indispensabile e onnipotente della repubblica. La seconda guerra punica, in particolare, che portò nelle colonie romane e latine e tra le città alleate la devastazione e lo spopolamento, e che richiese al contadiname romano, nerbo dell’esercito, uno sforzo quasi insostenibile, arrecò un indebolimento grave all’elemento popolare di R., contribuendo, con questo fatto negativo, al prevalere del governo senatorio, già giustificato da ragioni politiche. Non mancarono nel Senato elementi che favorivano una politica democratica, ma il processo generale rimase quello di un sempre maggiore irrigidimento dell’oligarchia nobiliare, che dall’impoverimento delle masse contadine traeva motivo per sempre maggiore arricchimento, con l’acquisto a basso prezzo di terre o con la confisca di beni dei contadini indebitati. Si avviava così la formazione del latifondo, e la situazione sociale tendeva ad aggravarsi per l’aumentare, in seguito alle grandi vittorie, degli schiavi nel lavoro della terra, a danno dei salariati e dei clienti. Il possesso dell’ager publicus, teoricamente aperto a tutti, si limitava sempre di più ai grandi proprietari che avevano la possibilità di sfruttarlo. Nasceva così, e si avviava a divenire questione centrale della storia romana dell’ultima repubblica, la questione agraria. A questa se ne collegava un’altra, anch’essa frutto delle grandi guerre: quella degli alleati italici, che avevano, quanto i romani, pagato col sangue e le ricchezze proprie le vittorie dalle quali era nato il dominio universale romano, ma che non ne potevano essere compensati, perché esclusi dalla cittadinanza romana, titolo indispensabile per partecipare alla distribuzione delle terre e del bottino e alla lucrosa amministrazione delle nuove province. La questione agraria e quella della cittadinanza romana furono ignorate a lungo dall’aristocrazia romana, tutta intenta a sistemare il governo mondiale e a dirimere nel suo interno le dure lotte per il potere. Queste, dalla fine della seconda guerra punica, col predominio degli Scipioni, si andavano svolgendo con alterne fasi, fino a che, per opera soprattutto della minore aristocrazia fondiaria tradizionalista, rappresentata da Marco Porcio Catone, il dominio degli Scipioni non fu annullato. Accanto all’aristocrazia fondiaria, intanto, si veniva formando, frutto anch’essa delle conquiste, la nuova classe del capitale mobiliare, censita come classe dei «cavalieri»: appaltatori, esattori, commercianti (il commercio era vietato ai senatori) e industriali. Questa classe divenne poi, per secoli, la classe dominante e caratteristica della società romana; intanto nella seconda metà del sec. 2°, il suo contrasto con l’aristocrazia tradizionale si andava facendo sempre più forte, tanto che vi fu chi, come Gaio Gracco, poté sfruttarlo ai fini di una rivoluzione in senso democratico.
Dai Gracchi alla fine del regime repubblicano
Nel secolo che va dal tribunato di Tiberio Gracco (133) alla battaglia di Azio (31), con un processo dapprima lento e confuso, poi sempre più rapido ed evidente, le istituzioni, la società e l’ordinamento dello Stato romano mutarono profondamente attraverso guerre civili e durissime lotte politiche. Il problema sociale delle classi rurali, private delle loro terre in seguito alla formazione del latifondo, della plebe romana in costante aumento, della nuova e sempre più potente classe dei cavalieri, la pressione dei soci italici desiderosi dei privilegi connessi con la cittadinanza romana, il problema del rimodernamento e riadeguamento dell’esercito, sono già tutti presenti, più o meno esplicitamente, nelle lotte che si scatenarono attorno alle proposte riformatrici di Tiberio e poi di Gaio Gracco; i motivi che animarono l’azione dei due tribuni non si estinsero con la loro sconfitta politica e personale, ma in diverso modo durarono lungo tutto il sec. 1° a.C., finché trovarono in Cesare chi, raccogliendo in sistema le riforme già attuate e quelle nuove, grandi e numerosissime, da lui stesso concepite, li risolse in modo definitivo. Cesare trasse dalla secolare lotta sociale e politica decisive conseguenze, dalle quali la repubblica romana uscì interamente trasformata, dissolta in una monarchia. Questa, tuttavia, nella definitiva costituzione concepita e attuata da Augusto, assunse caratteri affatto particolari: le forme giuridiche repubblicane non furono distrutte, anzi in certo modo restaurate, sì che il trapasso dalla repubblica all’impero non appare come una vera e propria rottura giuridica, bensì come un mutamento profondo dello spirito della costituzione, frutto della conclusione delle guerre civili e della definitiva pacificazione delle classi sotto l’egemonia personale del principe. Ciò spiega perché, mentre alla coscienza dei contemporanei difensori della repubblica senatoriale, e dei loro discendenti ideali, l’avvento di Cesare e poi del principato di Augusto apparve come una usurpazione violenta e come la fine della libertà repubblicana, in effetti si è potuto parlare di una «diarchia» tra imperatore e Senato, ed è potuto accadere che la nozione giuridica fondamentale della sovranità abbia conservato sempre nell’impero il suo originario carattere popolare (fonte di legittimità del potere imperiale rimase la delega dei poteri da parte del populus, unico sovrano ideale). Tale carattere insieme violento e tradizionalista della rivoluzione romana, quale appare dal punto di vista della sua conclusione, è il frutto della complessità e contraddittorietà della storia della repubblica nel sec. 1° a.C. Durante le aspre lotte per il potere, l’ideale della difesa della tradizione e del buon ordine repubblicano-senatoriale non fu mai dimenticato, e anzi in suo nome si svolsero le maggiori iniziative rivoluzionarie, la dittatura di Silla come quella di Cesare, il quale nella lotta contro Pompeo e il Senato cercò sempre di gettare sugli avversari la colpa d’aver infranto la legittimità repubblicana. Dopo il fallimento di alcuni tentativi della parte più illuminata dell’aristocrazia romana per affrontare il problema agrario, sempre più grave, vinti dalla resistenza della maggioranza della classe patrizia, Tiberio Gracco, tribuno nel 133, iniziò una tenace opera di iniziativa riformatrice, accentrata intorno a una legge agraria che prevedeva la distribuzione di terre sulla base della revisione del regime dell’ager publicus. Per far passare la legge, Tiberio dovette ricorrere all’espediente rivoluzionario di far deporre un tribuno che aveva opposto il veto; il tentativo di essere eletto nuovamente tribuno per il 132 provocò dei disordini nei quali fu ucciso. Tuttavia, la commissione di tre senatori incaricata di provvedere alla distribuzione delle terre pubbliche sulla base della legge di Tiberio entrò in funzione e lavorò negli anni successivi, attraverso difficoltà e limitazioni sempre crescenti, fino al 111, quando fu soppressa. Il lavoro della commissione rimise una grande quantità di cittadini proletari in condizione di essere censiti nelle classi; la piccola proprietà contadina, elemento indispensabile della società romana, si sollevò in parte dal suo stato di decadenza. Nello stesso anno 133, Scipione Emiliano, il rappresentante più insigne dell’aristocrazia romana, attorno al quale si raccoglieva la parte migliore di essa, mise fine all’assedio di Numanzia, durante il quale si era dimostrato lo stato di grave deficienza in cui versava l’esercito, e ridusse alla pace la Penisola Iberica. Tornato a Roma, Scipione condusse una politica moderata, ma non riuscì a impedire che il problema agrario, non risolto dal lavoro lento della commissione senatoriale, tornasse violentemente in primo piano col tribunato di Gaio Gracco (123), fratello minore di Tiberio. Questi, nella ricerca di quell’appoggio economico e politico che era mancato al fratello, cercò alleanze con i cavalieri e con i soci italici, legando la sorte della causa popolare alla contesa tra cavalieri e patrizi e al problema della estensione della cittadinanza romana. Rieletto tribuno nel 122, Gaio Gracco condusse avanti la sua iniziativa che sempre più si faceva rivoluzionaria; l’anno seguen;te, nel violento contrasto con il Senato, fu ucciso. I suoi progetti di estensione della cittadinanza ;romana a tutti gli italici e di deduzione di colonie oltremare fallirono; ma i temi sociali e politici da lui posti non scomparvero con lui. Mentre la lotta politica continuava, ed era in corso un processo di reazione senatoriale, la guerra di Giugurta (111-105 ca.) e il pericolo dell’invasione delle tribù germaniche dei cimbri e dei teutoni costrinsero R. a volgere nuovamente la sua attenzione all’esterno. Ambedue queste guerre furono vinte, ma come generale vincitore emerse Gaio Mario, uno dei due protagonisti della prima guerra civile romana. Per sopperire alle urgenti necessità del momento, Mario ricorse alla leva tumultuosa e all’arruolamento dei proletari, trasformando questo sistema eccezionale in istituto stabile. La riforma mariana dell’esercito ebbe grande influenza sul corso della storia di R.: da quel momento in poi l’esercito, anziché di piccoli contadini proprietari, fu composto soprattutto di nullatenenti arruolati volontariamente, cui l’assegnazione di una terra rappresentava il premio alla fine della campagna. Si venne così creando la figura del generale che lega a sé stesso l’esercito, come colui che si fa garante della futura sorte economica dei soldati. Rafforzato nel potere dalle vittorie e da una serie di consolati, Mario appoggiò la parte democratica: i successivi episodi della proposta di riforma agraria del tribuno Saturnino (100) e della estensione della cittadinanza agli italici di Livio Druso (91) mostrano la sempre più evidente indissolubilità dei problemi agrario e italico. Alla morte violenta di Druso, gli italici si ribellarono a R. e le mossero guerra organizzandosi in una confederazione. L’insurrezione fu domata (90-89) con durissime campagne condotte da Mario e da Silla, generale e uomo politico aristocratico che già si era segnalato nella guerra di Giugurta; ma alla fine agli italici dovette essere concessa la cittadinanza. Nell’89, dunque, tutta la Penisola Italiana era unificata sotto una sola cittadinanza; agli italici, però, non veniva concessa piena equiparazione nei diritti politici. Rimase quindi un elemento di malcontento, sul quale giocò la demagogia dei seguaci di Mario. La reazione senatoriale, guidata da Silla, divenne sempre più forte; in seguito all’esilio di Mario (88), mentre Silla si trovava in Oriente a combattere la prima guerra mitridatica (➔ Mitridate VI Eupatore), si ebbe col consolato di Cinna e il ritorno di Mario una violenta reazione popolare, che portò a gravissime stragi di avversari. Reduce dall’Oriente (83), Silla, in una dura guerra contro i seguaci di Mario (il quale nel frattempo era morto), distrusse la forza politica e militare della parte popolare e, come dittatore (82-79), intraprese una spietata persecuzione degli avversari del Senato e una serie di riforme che rimettevano il potere interamente nelle mani del patriziato, colpendo i cavalieri e togliendo ai popolari il diritto d’iniziativa tribunizia. Silla depose volontariamente il potere, che tornò tutto nelle mani del Senato; un anno dopo (78), morì. L’opposizione popolare risorse: il Senato dovette subito affrontare le conseguenze della guerra civile, in Italia col tentativo di insurrezione democratica di Lepido, in Spagna con la lunga guerra (80-72) contro il mariano Sertorio, che aveva creato un vero e proprio anti-Stato romano. Questa guerra, che fu condotta e vinta da Pompeo, significò l’affermazione personale di questo generale, emerso già durante la guerra civile dell’83-82, politico e comandante di parte senatoria ma dotato di indipendenza e di ambizione, oltre che di grandi doti di capo militare. Rispettoso dell’ordine repubblicano, ma deciso a conquistare un’egemonia di fatto, Pompeo, reduce della Spagna, alleatosi con Crasso, l’uomo più ricco di R. e vincitore della grande rivolta di schiavi che aveva sconvolto la penisola (➔ Spartaco), ottenne con lui il consolato (70) e compì una serie di riforme in senso antisillano, senza ledere il principio dell’autorità senatoria, ma ripristinando il potere dei cavalieri e le antiche prerogative tribunizie, tanto da apparire il naturale mediatore tra l’oligarchia senatoria e le nuove forze della finanza e delle masse popolari. Contro la volontà del Senato, che lo temeva, mercé una rogazione tribunizia, Pompeo ottenne (67) il comando supremo, con poteri militari straordinari, della guerra contro i pirati. Questi, nella generale carenza di un’efficace polizia dei mari, e con la connivenza dei grandi mercanti di schiavi dei quali erano i principali fornitori, avevano in quest’epoca raggiunto una potenza inaudita, costituendo quasi un impero marittimo con le basi in Cilicia e a Creta (con essi aveva trattato, contro R., Sertorio). Condotta vittoriosamente a termine la guerra dei pirati, Pompeo ottenne (lex Manilia, 66) il comando della seconda guerra contro Mitridate, iniziata nel 74 e da Lucullo già quasi portata a termine. Conclusa questa guerra (64), Pompeo dette una nuova sistemazione all’Asia, con l’aggiunta della nuova provincia di Siria. Tornato in Italia al colmo della potenza militare, Pompeo si sottomise all’autorità del Senato e sciolse il suo esercito: le sue mire personali non giungevano all’eversione del potere senatorio. Ma, privatosi della forza militare, egli dovette subire l’umiliazione di non vedere accolte dal Senato le sue richieste di distribuzione di terre ai soldati e di ratifica dell’ordinamento imposto all’Asia. Se questo atteggiamento remissivo nocque per il momento a Pompeo, d’altra parte creò la base del credito che egli desiderava godere presso il Senato, e quando questo in seguito si sentì in pericolo, egli poté apparire come il naturale protettore e salvatore dell’ordine repubblicano. Intanto, nella politica romana, andava emergendo Cesare, di famiglia tra le più nobili, ma più o meno apertamente capo delle forze popolari. La prima grande iniziativa politica di Cesare fu una proposta di legge agraria che, contemplando enormi poteri finanziari e politici per la commissione incaricata di attuarla, e prevedendo l’alienazione di tutti i demani extra-peninsulari, parve rivoluzionaria al Senato: nel 63, anno del suo consolato, Cicerone fece cadere questa proposta e poco dopo, sventando la congiura rivoluzionaria e anarcoide di Catilina, sembrò aver salvato il regime senatoriale. Tuttavia Pompeo, alla ricerca di appoggi su cui fondare la sua egemonia, e Cesare, le cui mire personali si andavano precisando, unitisi con Crasso in un’alleanza personale, il «primo triumvirato» (60), senza base costituzionale, ma di grandissima forza politica, ottennero l’approvazione di una serie di provvedimenti di distribuzione di terra ai veterani di Pompeo (con la costituzione di una commissione di cui fu capo lo stesso Pompeo) e la ratifica dell’ordinamento dell’Asia, conseguendo così una sostanziale vittoria sul Senato. Come stabilito nei loro patti, Cesare ottenne il consolato per l’anno 59 e, con provvedimento del tutto nuovo, il comando militare straordinario per la durata di cinque anni nell’Italia settentrionale e nella Gallia transalpina. Il consolato di Cesare fu caratterizzato dall’attuazione, su vastissima scala, della distribuzione delle terre in Italia, con la quale il problema agrario era avviato a sostanziale risoluzione, perché ne veniva eliminato, mercé la ripartizione dell’ultima e migliore parte del demanio, uno dei principali termini; e da un dettagliato ordinamento dell’amministrazione delle province, il quale, pur non ostacolando la classe dei cavalieri (rappresentata da Crasso) che dalle province traeva grandi proventi, metteva ordine in questo settore che costituiva uno dei più delicati problemi dell’impero romano. Nel periodo che va dalla sistemazione della provincia di Asia dopo l’annessione del regno di Pergamo al consolato di Cesare, R. aveva esteso il suo dominio in Asia, mercé le due guerre mitridatiche, e si era consolidata verso il Settentrione, con la distruzione delle tribù germaniche dei cimbri e dei teutoni, a opera di Mario. Qui però nuovi movimenti dei germani stavano turbando la Gallia e minacciavano indirettamente la provincia della Transalpina e l’Italia settentrionale. Nel farsi assegnare il comando militare di queste regioni, Cesare individuava la direzione in cui le possibilità espansive di R. avevano ora modo di manifestarsi; e col provvedimento che garantiva la durata quinquennale del suo comando stabiliva un precedente di portata rivoluzionaria, assicurandosi una base duratura di potere militare, anche maggiore di quella di cui aveva goduto Pompeo. Negli anni dal 58 al 51, con una serie di campagne che lo portarono ad attraversare il Reno e la Manica Cesare conquistò la Gallia e la ridusse a provincia romana. Le conseguenze della conquista di Cesare furono decisive per la storia di R. e del mondo occidentale; con esse, attraverso l’inclusione della Gallia nel mondo romano, si pose la premessa per lo spostamento verso il Nord del centro dell’impero occidentale che, fatto realtà in tarda età imperiale, si tradusse poi nell’Europa medievale e moderna. Il prestigio politico e militare di Cesare in seguito alle vittorie galliche divenne immediatamente grandissimo e oscurò quello stesso di Pompeo. Negli anni dell’assenza di Cesare, la situazione politica a R. si era evoluta: Crasso e Pompeo si erano allontanati l’uno dall’altro, ma Cesare, riunendoli a convegno a Lucca (56), ricreò la solidarietà del triumvirato, sulla base di una vera e propria spartizione dell’egemonia nell’impero: a Crasso era affidato l’Oriente, con una grande spedizione contro i parti, a Pompeo l’Italia con la Spagna e l’Africa, a Cesare veniva prorogato il comando militare. Pompeo e Cesare ottenevano di nuovo il consolato per l’anno 55. Il fallimento della spedizione di Crasso e la morte di questo (battaglia di Carre, 53) tolsero al triumvirato un importante elemento di equilibrio, e Cesare e Pompeo si trovarono l’uno di fronte all’altro. R. era travagliata da torbidi quali non si erano mai visti prima: Cicerone e Catone erano stati allontanati dall’Italia, dove Clodio conduceva con bande armate una campagna di violenze anti-senatoriali. Dopo l’uccisione di questo a opera dell’aristocratico Milone, Pompeo fu finalmente invitato dal Senato a ristabilire l’ordine ed eletto console unico per l’anno in corso. Questa data segna il riavvicinamento decisivo tra Pompeo e il Senato e l’inizio della definitiva rottura con Cesare. Nei due anni successivi, attraverso una lunga serie di intrighi e tentativi di compromesso, il conflitto esplose: il Senato ordinò a Cesare di lasciare le sue truppe, ma questi pose la condizione che Pompeo lo imitasse. Il Senato non accettò; dichiarato nemico della patria, Cesare marciò verso R. con una sola legione (49) e in breve tempo, con una rapida e audacissima campagna, costrinse Pompeo e gran parte del Senato ad abbandonare l’Italia per proseguire la guerra nella Penisola Balcanica, poggiando sull’Oriente e mobilitando le forze fedeli in Spagna e in Africa. Nel breve periodo di tempo trascorso a R., Cesare dette inizio alla sua opera di riformatore dell’ordinamento repubblicano; ma, soprattutto, preparò la guerra. Dopo una spedizione in Spagna, passò in Illiria, e nell’agosto del 48 ebbe luogo a Farsalo, in Tessaglia, lo scontro con Pompeo. Questi, vinto da Cesare, si rifugiò in Egitto, dove fu ucciso dal re Tolomeo. Liquidate in una serie di campagne in Asia (47), in Africa (46), dove morì Catone, e in Spagna (45) le forze dei pompeiani, Cesare tornò a R., dove si dette con tutte le sue energie a preparare il nuovo assetto dello Stato romano, portando alle loro logiche conseguenze i risultati di novant’anni di lotte politiche, le più aspre che R. avesse mai conosciuto, e di guerre civili. Il potere personale assunto da Cesare ebbe indubbiamente i caratteri sostanziali di una monarchia: egli si pose alla testa dello Stato come dittatore a vita e imperator. Mentre compiva una serie di concessioni ai poteri tradizionali del Senato e dei comizi, riserbava per sé una fondamentale serie di privilegi nella nomina delle cariche, nella proposta delle leggi e nella facoltà di riformare l’amministrazione nei più vari campi, il che gli conferiva in realtà un potere assoluto. Di questi poteri straordinari si avvalse soprattutto per riordinare l’amministrazione delle province, sulle quali stabilì un severo controllo, eliminando abusi e unificando i sistemi di governo, e per stabilire numerose colonie militari, sia nelle province, specie in Gallia, sia in Italia, procedendo a unificarne gli ordinamenti e a sistemarne le amministrazioni. A R., il Senato si ridusse a poco più che a un consiglio, perdendo di fatto, se non di diritto, il suo potere di governo; in esso Cesare introdusse un gran numero di nuovi senatori di censo equestre e molti di origine provinciale, specie gallici e spagnoli, al fine di unificare al massimo le classi e le regioni dell’impero, diminuendo i privilegi dell’Italia e di Roma. La concezione dell’impero di Cesare andava così contro gli interessi e le tradizioni egemoniche romane e italiche; la sua concezione della monarchia, benché con certi caratteri formali si rifacesse all’antica monarchia romana, era sostanzialmente di tipo ellenistico, universalistica e cosmopolitica. Se egli intendesse realmente assumere il titolo di re, inviso ai romani, è dubbio; certamente, però, un simile disegno gli fu attribuito dai nemici politici, e l’accusa di tirannide coalizzò contro di lui gli elementi più rigidamente repubblicani. Mentre si accingeva a partire per una grande spedizione in Oriente, Cesare cadde vittima di una congiura e fu ucciso il 15 marzo del 44. La tradizione antica considera Cesare come il primo imperatore; tuttavia, la sua politica di livellamento di R. con le province, la sua concezione assolutistica del potere e l’estrema spregiudicatezza nel trattare l’ordinamento formale-giuridico della repubblica lo avvicinano più ai tardi imperatori che a quelli che, a cominciare da Augusto, ressero l’impero di R. nei secc. 1° e 2° d.C. Immerso per tutta la vita nella lotta politica e nella guerra civile, Cesare fu naturalmente portato a trascurare quanto di vitale e di reale esisteva nelle istituzioni di quell’ordinamento, e specialmente nel Senato, che gli si erano sempre opposte, e delle quali conosceva tutte le debolezze e l’incapacità di governo di fronte alla responsabilità dell’impero mondiale. Egli pensò di poter riassumere in sé stesso tutti gli elementi vitali di R. e di potere accelerare i tempi di una rivoluzione che in realtà non era ancora del tutto matura. La sua stessa opera di rivoluzionario ridette vigore agli avversari; mentre aveva potuto trasformare per sempre l’ordinamento repubblicano, non poteva egli stesso consumare tutta la carica di contraddizioni e di contrasti che la rivoluzione conteneva. Dopo la morte di Cesare, queste contraddizioni devastarono ancora per quindici anni l’Italia e l’impero; il Senato compiva l’ultimo sforzo per riconquistare l’egemonia, ma, privo ormai di forza autonoma, seguì la via, che il contrasto tra Pompeo e Cesare aveva tracciato, di farsi proteggere da un capo militare, mettendosi in realtà nelle sue mani. La pacificazione definitiva fu possibile solo quando Augusto, rimasto unico vincitore della guerra civile, investito dei pieni poteri dal Senato, attuò con esso quei compromessi, soprattutto costituzionali, che ne resero possibile la sopravvivenza in condizione subordinata.
L’impero
Alla morte di Cesare seguirono gravissimi torbidi in R., che sboccarono in una guerra civile in cui nuovamente, come in quella tra Cesare e Pompeo, tutto l’impero fu coinvolto. Più propriamente, si trattò di due guerre civili, l’una naturale conseguenza dell’assassinio del dittatore, nella quale ancora una volta il Senato si divise tra i cesariani e i repubblicani, l’altra, maturata dal profondo contrasto tra Ottaviano e Antonio, che era poi contrasto tra due modi di intendere l’eredità di Cesare, nella quale il Senato si schierò in maggioranza accanto a Ottaviano, insediato a R., contro Antonio, stabilito in Oriente. L’eredità politica del dittatore fu immediatamente raccolta dal suo luogotenente Antonio mentre R. era in fermento, divisa tra la parte senatoriale che vedeva nei tirannicidi Bruto e Cassio i liberatori della repubblica, ma non osava interamente scoprirsi temendo il popolo, e i cesariani che non intendevano con la morte del loro capo considerare perduta la causa della loro rivoluzione. Ma la posizione di successore di Cesare fu ben presto contestata ad Antonio da Ottaviano, il futuro Augusto, il figlio adottivo ed erede universale di Cesare, giovanissimo ma già capace della più spregiudicata politica. Tra i due si realizzò un compromesso: una serie di iniziative militari in Italia (44-43), condotte da Antonio, distrusse la forza di Bruto e Cassio in Italia, costringendoli in Oriente, dove già si erano messi personalmente in salvo poco dopo le idi di marzo. Cicerone assunse su di sé il peso di una tenace battaglia politica contro Antonio; ma la costituzione del 2° triumvirato tra Antonio, Ottaviano e Lepido (43), che a differenza del primo fu ratificato dal Senato e assunse vera e propria figura giuridica di magistratura (triumviratus rei publicae constituendae), investendo i tre del compito supremo di riordinare lo Stato, segnò la fine di ogni equivoco: cesariani e repubblicani furono decisamente gli uni di fronte agli altri, e mentre i triumviri scatenavano una dura persecuzione contro i repubblicani – in essa perdette la vita Cicerone – ricorrendo come Silla (e diversamente da Cesare) alle proscrizioni, i repubblicani preparavano in Oriente la guerra. Cassio in Siria e nell’Asia Minore meridionale, Bruto in Macedonia, Tracia e nella provincia di Asia, presero in mano tutte le truppe che vi si trovavano, spremendo le popolazioni per ottenere il denaro necessario al mantenimento delle 13 legioni che riuscirono a costituire e la numerosa flotta, che li appoggiava. A Filippi (autunno del 42) l’esercito di Cassio e Bruto si scontrò con quello, di pari forza, di Ottaviano e Antonio: la vittoria dei triumviri fu completa; i tirannicidi vi caddero, i triumviri rimasero arbitri dell’impero. Mentre Antonio si accingeva al compito di procurare denaro e forze in Oriente, Ottaviano in Italia dovette domare una grave insurrezione di popolazioni italiche angariate dai mercenari dell’esercito triumvirale (guerra di Perugia, 41-40); a capo di questo si era posto Lucio Antonio, fratello del triumviro, che intendeva così combattere, in favore del fratello, il già evidente strapotere di Ottaviano in Italia. Questo primo grave screzio tra i due triumviri, nel quale si inseriva il pericolo incombente della grande flotta repubblicana, comandata dal figlio di Pompeo, Sesto Pompeo, si appianò temporaneamente con l’incontro di Brindisi (estate del 40), dove Antonio e Ottaviano si accordarono per mettere fine alla guerra navale, sulla base di una spartizione dell’impero: a Ottaviano sarebbe toccato il compito di riordinare l’Occidente, ad Antonio l’Oriente, a Lepido l’Africa. Dopo tre anni di dura guerra, la flotta di Sesto Pompeo fu distrutta (battaglia di Nauloco, 36); e contemporaneamente Lepido, fallito un suo tentativo di strappare il premio e il merito della vittoria a Ottaviano, fu da questo esautorato e privato dell’Africa. Antonio, in Oriente, stretto un intimo rapporto con la regina d’Egitto Cleopatra, attendeva con scarsa energia al riordinamento di questa parte dell’impero, senza opporre una vera resistenza alla ripresa imperiosa e violenta della potenza del regno dei parti, che già dal 40 metteva in pericolo grave tutta l’Asia romana. Solo nel 36 egli prese l’offensiva, con un grande disegno strategico ricalcato sulle orme della marcia di Alessandro Magno; ma ottenne soltanto un successo parziale, riuscendo a conquistare l’Armenia dopo aver dovuto rinunciare a stabilire il suo potere fino al Mar Caspio. Antonio tuttavia poté celebrare il suo trionfo contro i parti: e scelse come sede della cerimonia non R., bensì Alessandria. Questo fatto, la cui eco sfavorevole in R. fu abilmente sfruttata dall’attivissima propaganda di Ottaviano, già rivelava quale direzione avesse preso la politica di Antonio, dominato dal fascino di Cleopatra e dal ricordo della politica orientalizzante di Cesare, che però, a differenza del suo assai meno geniale luogotenente, l’aveva concepita movendo dall’Occidente, in funzione cioè sempre dell’unità dell’impero. Ma Antonio andò oltre: Cleopatra e Cesarione, un figlio che la regina aveva avuto da Cesare, furono da lui proclamati sovrani d’Egitto, col titolo tipicamente orientale di re dei re, e a questo regno furono assegnati Cirene, la Siria e parti dell’Asia Minore. Una grande parte dell’impero andava così perduta per R.: Ottaviano doveva e poteva ora presentarsi come il vendicatore delle conquiste repubblicane e il garante dell’unità tradizionale dell’impero, centrata in Italia e a Roma. La politica interna di Ottaviano fu poi sempre dominata dal concetto, maturato nel contrasto con Antonio, del tradizionale predominio italico e romano tra tutti i popoli dell’impero, in antagonismo con le tendenze orientalizzanti e cosmopolitiche. Il potere dei triumviri, già una volta rinnovato, veniva a scadere nel 32: contro un tentativo di Antonio di esautorarlo, Ottaviano preparò la guerra, a nome della repubblica, ufficialmente dichiarata solo contro Cleopatra, evitando così formalmente l’odioso nome di guerra civile. La battaglia di Azio (2 sett. del 31) oppose due grandi eserciti e due grandi flotte. La vittoria di Ottaviano fu completa; passato in Egitto, nell’agosto del 30 otteneva un nuovo successo in uno scontro di cavalleria alle porte di Alessandria; Antonio e Cleopatra si suicidarono. L’Egitto fu ridotto a provincia, con uno status particolare; nel 29 Ottaviano tornò a R. e, celebrato il trionfo, chiuse le porte del tempio di Giano, a significare che l’era delle guerre era finita. Subito intraprese la sua opera di assestamento dell’impero e dello Stato romano, con la quale si considera chiusa la storia repubblicana e iniziata l’età imperiale: d’ora in poi lo Stato romano avrà infatti come centro la figura di un monarca e non più l’assemblea del Senato e i comizi popolari.
Augusto
Il compito cui Ottaviano, poi Augusto, attese anzitutto nei primi anni del suo lungo principato (29 a.C-14 d.C.) fu quello di stabilire legalmente le basi del suo potere, senza alterare i lineamenti fondamentali della Costituzione repubblicana, tanto da apparire conservatore e restauratore nel momento stesso in cui, in realtà, rinnovava la struttura dello Stato. Principi fondamentali della sua abile condotta furono quelli di non creare alcuna vera nuova magistratura, ma di potenziare il carattere di quelle tradizionali per quanto si riferiva alla sua persona. L’imperio proconsolare perpetuo gli attribuì il comando di tutti gli eserciti dell’impero (al consolato egli rinunciò presto); la potestà tribunicia, conferitagli a vita, rese sacrosanta la sua persona e gli attribuì poteri straordinari nel Senato e nell’assemblea popolare; il pontificato massimo e l’augurato lo investirono del diritto di regolare e sorvegliare la religione di R., compito di grande importanza, perché il consolidamento della religione tradizionale era momento fondamentale della sua opera di restauratore del buon ordine dello Stato. Tutte queste cariche, cui egli giunse ottenendole di volta in volta dal Senato con apparenza di libera iniziativa, non si cumularono a costituire una nuova figura di magistrato, ma coesistettero in lui così da farne in tutte le principali funzioni di governo l’uomo investito di massima autorità. I titoli di imperatore e Augusto, assunti come nomi, simboleggiarono il carattere militare e sacrosanto del nuovo Cesare. Questa configurazione del principato augusteo si mantenne formalmente identica nei suoi successori, per almeno due secoli, fino a che, dopo la lunga crisi del sec. 3°, con Diocleziano, si prese atto della lenta evoluzione che aveva reso sempre più vuote le forme repubblicane, e alla figura del principe si sostituì apertamente quella del monarca assoluto, il dominus. Altro principio fondamentale del governo di Augusto fu che l’organizzazione dell’impero doveva essere fondata sulle idee romano-nazionali: al cosmopolitismo mai precisato di Cesare, e al chiaro indirizzo orientalizzante di Antonio, Augusto contrappose la persistenza del principio che aveva dominato la storia repubblicana, secondo il quale nell’ambito dell’impero il primato politico, civile, militare ed economico doveva essere riservato alla stirpe latina, a R. e all’Italia. Il privilegio della cittadinanza romana, esteso ma sempre relativamente ristretto, rimase il fondamento dello Stato; i provinciali mantennero il loro ruolo di sudditi, viventi sotto la pace e il buon governo romano. Le ricchezze dell’impero affluivano a R., e l’Italia era libera dai gravami tributari principali. Tuttavia, proprio in funzione di questo predominio romano nell’impero, Augusto sentì che la prima necessità era di instaurare il buon governo e una retta amministrazione provinciale. Perciò, con una serie di riforme egli sottrasse all’avidità delle promagistrature il controllo amministrativo delle province, affiancando ai promagistrati delle province senatorie un procuratore addetto all’esazione delle imposte e ai demani, e istituendo il principio delle cariche remunerate creò un sistema di funzionari, semplice ed efficiente burocrazia responsabile verso il principe. Accanto all’antica cassa dello Stato, l’erario, egli istituì la cassa imperiale, il fisco, e abolì il sistema degli appalti, disciplinando per questa via l’esazione delle imposte. Aprì inoltre la carriera amministrativa ai liberti, che d’ora in poi acquisteranno maggior peso nella vita economica dell’impero. Alle classi senatoriale ed equestre dette modo di partecipare stabilmente al governo imperiale, mercé l’istituzione dei legati e dei prefetti, preposti i primi all’amministrazione delle province imperiali, i secondi alle forze di polizia, all’approvvigionamento di R., alla guardia pretoriana. Di fronte a questo sistema di funzionari con competenze fisse e ordinati per gradi, le vecchie promagistrature repubblicane passarono in seconda linea. Con tali riforme, delle quali curò i minimi particolari, e con il dare tutta la sua opera alla sorveglianza e alla direzione degli affari, Augusto assicurò un ordinamento stabile ed efficiente, offrendo ai provinciali e a tutto l’impero l’autorità e la garanzia di un governo giusto e pacifico. Il problema dei confini e della politica estera imperiale attendeva anch’esso una impostazione durevole e comprensiva. Augusto ne ebbe cura particolare e sistemò in forma a lungo valida i confini dell’impero, che le conquiste dell’ultimo secolo, da Pompeo a Cesare e ad Antonio, avevano notevolmente ampliato. Egli si propose di risollevare la vita delle province, e per garantire la pace a ciò necessaria si dovevano anzitutto rettificare i confini ovunque le esigenze di difesa lo rendessero necessario: in questo senso, di difesa e stabilità, furono sentite e perciò vanno interpretate le nuove conquiste da Augusto concepite e attuate. L’occupazione e pacificazione della Spagna fu completata; la regione alpina interamente conquistata, la Pannonia e la Mesia incorporate, raggiungendo così il Danubio; Galazia e Giudea furono fatte rientrare nel regime provinciale; lo Stato vassallo di Mauretania ricostituito, e riordinati quello del Bosforo Cimmerio e l’Armenia; con il regno partico fu raggiunto un accordo. Il piano di avanzare il confine germanico fino all’Elba fallì; tuttavia, le linee del Reno e del Danubio furono congiunte, ad assicurare un confine continuo ed efficiente, fortemente munito. Nell’ordinamento ricevuto da Augusto, l’impero risultò diviso nelle seguenti province: tre in Spagna: Lusitania, Tarraconense, Betica; quattro nella Gallia: Aquitania, Lugdunense, Belgica, Narbonense; poi Sicilia, Macedonia, Acaia, Cipro e Cirene, Sardegna, Rezia, Norico, Pannonia, Dalmazia, Mesia, Asia, Bitinia, Galazia, Pamfilia, Siria, Africa e Numidia. Molte regioni conservarono lo stato di regni o territori vassalli o comunque riconoscenti il predominio di R., come Tracia, Licia e Rodi, Cappadocia, Ponto, Paflagonia, Piccola Armenia, Commagene, Palmira, Emesa, Mauretania. La Giudea, conservando la sua autonomia, ricevette un procuratore, forse dipendente dal legato di Siria, e tale era il suo stato quando a Nazareth nacque Gesù. Uno status a parte ebbe l’Egitto, dipendente personalmente dall’imperatore, che qui succedeva ai faraoni e ai re della dinastia macedone: dall’Egitto proveniva gran parte delle entrate del fisco e del patrimonio personale di Augusto e dei suoi successori. Grandi cure rivolse Augusto all’Italia, e in particolare a R., della quale curò la divisione in regioni e la riorganizzazione di tutti i servizi amministrativi e annonari. Aspetto peculiare e innovatore dell’ordinamento augusteo fu la distinzione fondamentale tra province governate dal Senato con il tradizionale sistema della promagistratura (controllate però in più modi, nelle cose militari e fiscali, dal principe) e province governate dall’imperatore col sistema dei legati: e queste erano tutte quelle nelle quali le necessità di difesa rendevano indispensabile la permanenza di un esercito, che, in virtù del proconsolato perpetuo, dipendeva personalmente da Augusto. Le province imperiali costituivano la maggior parte dell’impero e si accrebbero con le conquiste e le annessioni compiute dai suoi successori, che mantennero fermo il principio di considerare imperiali tutte le nuove acquisizioni romane. In tal modo, i confini vitali dell’impero, protetti da un cordone rado ma continuo di legioni (25 ai tempi di Augusto), un vero e proprio esercito stanziale permanente, erano sotto la responsabilità diretta dell’imperatore, che sull’esercito fondava il suo effettivo potere. Riforme amministrative e militari, ordinamento del dominio di R., politica religiosa e culturale tesa a rinsaldare la tradizione romana (da Augusto prende nome la più splendida età della letteratura latina, quella di Orazio, di Virgilio, di Livio) rappresentano la creazione di Augusto: da essa, in continuità di problemi, dipendono i secoli seguenti della storia di R., che, pur nelle contraddizioni e nel variare dei tempi, può essere considerata almeno fino alla morte di Marco Aurelio (180) come una unità.
Da Augusto a Settimio Severo
Già l’immediato successore di Augusto, Tiberio (14-37), nonostante il suo rispetto per le prerogative del Senato, dovette scontare la circostanza che l’equilibrio tra Senato e principato, tra ordinamento tradizionale e innovazione rivoluzionaria, realizzato nel lungo principato di Augusto, era in realtà strettamente legato alla personalità di questo e al fatto che nel dominio dell’uomo Augusto si era conclusa la pace civile di Roma. Grande imperatore, ottimo politico e amministratore, Tiberio passò nella tradizione storica e culturale romana, quasi tutta elaborata nell’ambiente dell’aristocrazia senatoria, come un tiranno, almeno negli ultimi anni di vita; e in effetti dovette ricorrere, per dominare le forze ostili del Senato, geloso non solo delle sue prerogative, ma tendente a riconquistare la perduta egemonia, a mezzi di repressione anche violenti. Fedele alle direttive di Augusto, come in genere tutti gli imperatori fino a Traiano, Tiberio si attenne al principio che la fase delle vere e proprie conquiste era finita e che le guerre esterne valevano solo per correggere e rafforzare le linee difensive dell’impero. E in realtà l’organizzazione finanziaria e quella militare dell’impero di R., in stretto nesso tra di loro, erano tali da limitare al massimo la possibilità della costituzione di grandi eserciti offensivi. Il numero delle legioni dell’esercito permanente romano si accrebbe lentamente durante la storia imperiale, ma il carattere fondamentalmente confinario e stanziale del loro impiego si conservò sempre fino a tarda epoca, quando le invasioni barbariche resero necessaria la costituzione di un esercito mobile accanto a quello stabile dei confini. Fino a Traiano, le campagne condotte dagli imperatori o dai loro generali rimasero sempre limitate, tranne quella che portò Claudio alla conquista della Britannia (iniziata nel 43 d.C.). Nonostante il fatto che gran parte della spesa pubblica andasse all’esercito e che la carriera militare rimanesse quella che qualificava al massimo gli individui, l’impero romano dei primi secoli fu essenzialmente pacifico; poche centinaia di migliaia di soldati romani e alleati erano sparsi alla periferia del grandissimo territorio imperiale. Questo è uno dei significati più evidenti della «pace romana»; i cittadini d’Italia e delle province vivevano quasi senza avvertire l’elemento militare su cui si fondava la loro sicurezza. La lotta civile, del tutto scomparsa con la fine delle guerre del sec. 1° a.C., si ridusse in gran parte a cospirazioni nell’ambito dell’aristocrazia senatoriale romana. Gli eserciti provinciali parteciparono ai momenti di crisi, quando la successione degli imperatori, mai regolata giuridicamente, si svolse attraverso lotte anche assai cruente (come quelle che videro affermarsi Vespasiano); soprattutto in quanto i loro generali, con le vittorie riportate sui nemici esterni, assumevano il prestigio che poteva farli aspirare alla corona imperiale; ma in genere il fenomeno tipico dell’ultimo secolo della repubblica, cioè il dominio assoluto dell’elemento militare nella determinazione del potere civile, non si verificò più. Le province, l’Italia e R., amministrate da una burocrazia e da una classe dirigente civile, poterono riprendersi dalla decadenza economica e dal grave stato di collasso cui le guerre intestine dell’ultima repubblica le avevano condotte. Il problema centrale della vita politica dell’impero era il rapporto tra l’aristocrazia e l’imperatore: l’elezione dell’imperatore rimase sempre formalmente al Senato, perché anche quando fu designato dall’esercito o dalla guardia personale (i pretoriani), la ratifica del Senato, con il rinnovo nella persona del nuovo capo di tutte le cariche e le potestà che ne determinavano il potere, rimase l’elemento formalmente decisivo. Dopo Tiberio e il breve regno del successore Caligola (37-41), Claudio (41-54), eletto dai pretoriani, riprese la politica di espansione, conquistando la Britannia, e di rafforzamento dei poteri amministrativi della corte imperiale, affidandoli nelle mani di potenti liberti, fatto che eccitò ulteriormente la gelosia tanto dell’aristocrazia senatoria, quanto della classe equestre. Il regno di Claudio è perciò assai malfamato nella tradizione letteraria romana, ma fu in realtà uno dei pochi nei quali si sia rivelata una intenzione cosciente, se non sempre una adeguata capacità, di governare l’impero in base a principi non arbitrari e non dispotici. Claudio curò il retto funzionamento della giustizia e concepì l’impero come una grande unità da curare e sorvegliare in tutte le sue parti; egli era imbevuto di cultura storica e da questa traeva ideali di grandezza e di missione imperiale pacificatrice e giustiziera. Il successore Nerone (54-68), dopo un esordio dominato dall’influenza di Seneca, nel cui pensiero al principato fondato sull’equilibrio tra Senato e imperatore si sostituì l’idea del principe assoluto e illuminato, sapiente legislatore e moralizzatore supremo, di impronta stoica, finì invece miseramente, e la condotta priva di ogni discernimento politico e morale del giovane imperatore condusse a una serie di cospirazioni senatorie, duramente represse, e infine alla rivolta degli eserciti. Il regno di Nerone è però significativo perché in esso tornò a manifestarsi una tendenza fondamentale della concezione imperiale, sia pure in forma immatura e grottesca: la tendenza ellenizzante, nella quale all’assolutismo derivato dalle filosofie sorte nel mondo ellenistico si associava una spiccata preferenza per la parte orientale dell’impero, contrapposta per cultura, tradizione e tipo di vita economica e sociale all’Italia e all’Occidente – Gallia e Spagna e Africa –, le regioni dove il romanesimo augusteo si era più profondamente radicato. La tendenza ellenizzante, nella quale alla religione tradizionale e ai costumi civili e politici romani si contrapponevano i nuovi culti provenienti dall’Oriente asiatico e il costume fastoso delle corti persiane ed ellenistiche, prevalse poi, con significato ben diversamente positivo, nell’impero di Adriano. Affermatosi contro tre imperatori (Galba, Otone, Vitellio) che tra il 68 e il 69 si erano eliminati, successivamente, a vicenda, Vespasiano (69-79) ristabilì l’ordine e dette inizio a un riassestamento delle finanze e dell’amministrazione, fortemente scosse dalla disastrosa politica di Nerone e dalla guerra per la successione. Con un’energica politica fiscale e di restrizione delle spese, riducendo gli effettivi dell’esercito, Vespasiano riuscì a risollevare l’economia dell’impero e, seguendo la sua naturale inclinazione di italico, riprese il motivo augusteo del rafforzamento dell’egemonia italica. Ad Augusto egli si richiamò esplicitamente come ispiratore della sua concezione del principato; e tuttavia anch’egli dovette scontrarsi duramente col Senato. Una innovazione di notevole portata storica egli introdusse nell’esercito: da quel momento in avanti i cittadini della Penisola Italiana non costituivano più il grosso dell’esercito, che invece era arruolato, prevalentemente o quasi esclusivamente, tra i provinciali. Con questo provvedimento Vespasiano cercava di risolvere il problema dello spopolamento dell’Italia, assicurando alle sue terre le braccia necessarie, e d’altra parte contribuiva ad accelerare il processo di universalizzazione della romanità, che nell’esercito aveva sempre trovato una delle sue vie principali. Dopo il breve regno di Tito (79-81), Domiziano (81-96), il secondo successore di Vespasiano, temperamento di autocrate, rovesciò la sua politica augustea, e col cerimoniale, con la metodica esclusione del Senato dalla partecipazione all’amministrazione, con la creazione di un perfezionato sistema di polizia segreta, ottenne di rafforzare l’opposizione aristocratica, che si rivolse finalmente contro di lui, favorita anche da poco dignitosi compromessi cui Domiziano ricorse per ottenere la pace con popoli confinanti. Questo imperatore, ucciso da una cospirazione cui parteciparono insieme Senato e pretoriani, divenne il simbolo della tirannide fosca e prevaricatrice di tutte le leggi e costumi romani. In realtà, sia il principe sia il Senato si dibattevano, sempre più impotenti l’uno di fronte all’altro, nel tentativo torbido e inconsapevole di trovare un modus vivendi che garantisse la supremazia di uno dei due contendenti. La vittoria, come naturale ormai, toccò di fatto al principe: i successori di Domiziano, gli Antonini, la più splendida serie di governanti di cui abbia goduto l’impero romano, affermarono definitivamente il primato imperiale; ma poterono farlo perché seppero, in modo nuovo, ritrovare le basi di un compromesso con il Senato. Alla morte di Domiziano, il pericolo di una guerra civile fu scongiurato con l’innalzare al trono il vecchio autorevole senatore Nerva (96-98), accetto anche ai pretoriani. Nerva poté garantire al figlio adottivo Traiano (98-117) la possibilità di realizzare il suo disegno di restaurare l’autorità del Senato senza diminuire quella del principe, anzi rafforzando questa con quella. Traiano volle considerarsi primo tra i pari, ma al tempo stesso, riprendendo rigorosamente la politica di conquista, mobilitò attorno a sé le migliori energie del Senato e delle classi dirigenti romane. Nel periodo di Traiano e dei successori Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, si realizzò pienamente quella collaborazione tra i poteri che sola poteva garantire il fiorire della vita civile ed economica dell’impero. Il processo di rafforzamento del potere amministrativo della corte imperiale e della burocrazia, sempre più indipendente dal Senato, continuò, specie a opera di Adriano; caratteristica di questo periodo, considerato sempre dalla tradizione posteriore come il punto felice per eccellenza della storia imperiale, è la dedizione delle classi dirigenti romane e provinciali al servizio dello Stato, raccolte intorno al principe, egli stesso tutto impegnato nei suoi compiti di governante e supremo, saggio reggitore delle sorti comuni. Traiano, con due fortunate campagne (101-102; 105-107), portò il confine romano oltre il Danubio, creando la nuova provincia di Dacia, e in Asia riprese i disegni di Antonio, infliggendo dure sconfitte ai parti (campagna del 113-117) e creando le nuove province di Arabia Petrea, di Armenia e di Mesopotamia. Tuttavia, lo sforzo finanziario e militare che questi nuovi acquisti avrebbero richiesto per essere mantenuti era troppo grave anche per un impero ben amministrato e in fase di notevole sviluppo economico come quello che Traiano, morendo, lasciava al figlio adottivo Adriano. Questi (117-138) abbandonò le nuove province d’Asia, tranne la Mesopotamia superiore, e dedicò tutta la sua vita a un’opera instancabile a favore del benessere dell’impero. Adriano, uomo di raffinata cultura ellenizzante, trascorse gran parte del suo regno a viaggiare in tutte le regioni del dominio romano, lasciando ovunque, in opere pubbliche e in provvedimenti amministrativi, traccia del suo passaggio; fondò numerose città, e dovunque creò templi, strade, acquedotti, mercati: Atene, da lui prediletta, rifiorì. Dietro il suo esempio, in un clima di slancio filantropico, nella coscienza di una imperitura durevolezza dell’edificio civile imperiale, i ricchi privati, con lasciti e donativi alle loro città, ne innalzavano le ricchezze e lo splendore. Il lungo periodo di tranquillità, celebrato già dai contemporanei come il più splendido della storia di R., vide come mai prima fiorire i commerci e le industrie nella pace sociale. Il «vallo di Adriano» definì le frontiere britanniche dell’impero; una grave rivolta giudaica in Palestina fu domata personalmente da Adriano (132-135). Il lungo regno di Antonino Pio (138-161), tutto dedito alla saggia ordinaria amministrazione e al riassetto e consolidamento delle frontiere, rappresentò il culmine del felice periodo degli Antonini. Ma durante il regno di Marco Aurelio (161-180), uomo di grande cultura, che del suo potere imperiale si era fatto una missione assoluta con l’animo sereno e severo del filosofo stoico, si affacciò per la prima volta, dopo secoli, il pericolo barbarico. Marcomanni e parti assalirono i confini del Danubio e della Mesopotamia. L’impero, travagliato da carestie e da una tremenda pestilenza che ridusse grandemente il numero degli abitanti e rese necessario, per la prima volta, l’arruolamento di notevoli contingenti di mercenari barbarici, resse bene il colpo, sotto la guida di Marco Aurelio, e inizialmente del fratello Lucio Vero a lui associato nell’impero (pace con i parti, 165; vittoria sui marcomanni, 175); ma alla morte dell’imperatore, con la successione del figlio Commodo (180-192), da lui voluta contro l’abitudine invalsa dell’adozione del migliore tra i generali e i senatori, il felice periodo della storia di R. ebbe termine. Commodo si comportò come un tiranno e nuovamente, come già ai tempi di Domiziano, tutto il sistema politico imperiale entrò in crisi. E, come Domiziano, Commodo finì ucciso. Dopo il breve regno di Pertinace, la nuova guerra civile, che vide in competizione quattro aspiranti al trono (Didio Giuliano, Settimio Severo, Clodio Albino, Pescennio Nigro) portati dagli eserciti delle varie parti dell’impero, finì con la vittoria di Settimio Severo (193-211), duro soldato di origine africana, lontano per temperamento e cultura da quel clima di civile, elevato incontro tra romanità ed ellenismo, che aveva caratterizzato l’età degli Antonini. Con il sec. 3° d.C., passato nella tradizione come il secolo dell’anarchia, R. entrò nella più grave crisi mai vissuta, e ne riemerse solo con Diocleziano; questi trasse le conseguenze politiche della lunga e tormentata vicenda, riformando interamente la struttura dell’impero e la concezione del principato. Dalla fine del sec. 2°, l’eredità politica e morale di Augusto cessa di operare come forza direttrice centrale della storia romana, e dal caos morale, politico ed economico emerge il nuovo impero, assoluto, centralizzato, divinizzato.
Il cristianesimo
Mentre l’edificio dell’impero romano entrava nella sua grande crisi, il cristianesimo, nato da due secoli, si affermava sempre di più come la religione più diffusa nel mondo conosciuto. L’esistenza di una comunità cristiana a R., o più esattamente di una reazione suscitata in seno alla fiorente comunità ebraica di R. dalla propaganda cristiana, è attestata con certezza negli anni Quaranta: Svetonio infatti, nella vita di Claudio, scrive che questo imperatore Iudaeos, impulsore Chresto, assidue tumultuantes Roma expulit («cacciò da Roma i Giudei che continuamente tumultuavano su istigazione di Cresto»), testimonianza confermata dagli Atti degli Apostoli (18,2). Può dunque dirsi con certezza che il messaggio cristiano giunse presto a R., trovando il suo primo centro di diffusione in ambito giudaico. Un’ulteriore testimonianza, di primaria importanza nella comunità romana, è costituita dall’epistola di Paolo ai romani, scritta attorno al 57-58; più tardi, fu lo stesso apostolo che giunse prigioniero a R. (cfr. Atti 28, 11-29) e vi diffuse il verbo cristiano con notevole successo, a giudicare da quel che egli dice nell’epistola ai filippesi, scritta nel periodo di cattività romana, tra il 63 e il 64. Giungiamo così all’anno (64) dell’incendio di R., che provocò la nota persecuzione neroniana contro i cristiani accusati di aver appiccato il fuoco. Alla fine del sec. 1°, ci si presenta un nuovo documento, di grande significato, nella comunità cristiana di R.; è la Prima Clementis ove si è anche voluto riconoscere il primo cenno al martirio di Pietro e Paolo a Roma. Da questo momento la tradizione della morte di Pietro a R., la cui antichità è confermata anche dagli scavi sul colle Vaticano, si andò incrementando, mentre la comunità romana, nel corso del sec. 2°, viene assumendo una propria fisionomia, ricollegando le sue origini alla predicazione degli apostoli. Nella seconda metà del secolo, da Aniceto a Vittore a Callisto, vescovi di R., si venne accentuando l’importanza della comunità, ormai sempre più latinizzata. Il sec. 3° segna il formarsi di una sua precisa e preminente posizione, cui le altre comunità, soprattutto quelle che da R. derivano la loro fondazione e le comunità dell’Africa romana, guardano con particolare rispetto. Lo Stato romano si era manifestato dapprima in linea di massima tollerante verso la nuova «setta». Tuttavia il contrasto, già esploso in singoli episodi di persecuzione, non poteva tardare ad aggravarsi. Il Dio dei cristiani era altrettanto esclusivo verso i suoi fedeli quanto il Dio degli ebrei, ma il cristianesimo aveva capacità e volontà di proselitismo enormemente superiori a quelle del giudaismo. D’altra parte la fine tragica delle due grandi rivolte ebraiche, domate l’una da Vespasiano e Tito, con la distruzione di Gerusalemme, e l’altra da Adriano, aveva contribuito a creare attorno alla religione israelitica e alla cristiana, a lungo non ben distinte agli occhi dei romani, l’aureola delle religioni dei ribelli per eccellenza, mentre favorendo la diaspora giudaica aumentava la diffusione anche dei centri di propagazione del cristianesimo. La nuova religione, che interdiceva il culto dell’imperatore, uno dei fondamenti dell’impero, spingeva il cittadino ad appartarsi dalla vita sociale e pubblica, rispondendo all’esigenza d’interiorità che si andava diffondendo in tutte le classi. Al tempo stesso, le comunità che sempre più si stringevano a costituire la Chiesa rappresentavano un elemento di aggregazione sociale completamente estraneo allo Stato e tendenzialmente indifferente alle sue sorti; la stessa vita economica era influenzata dai principi della carità e del mutuo soccorso che animavano i nuclei cristiani. La nuova religione si distingueva da quelle orientali per il suo carattere assolutamente universalistico, per la semplicità dei suoi riti, per la mancanza di quelle rigide gerarchie di iniziazione che tendevano a mantenere quelle religioni ristrette e prive di vera forza espansiva. Il messaggio dei Vangeli poteva essere inteso dal senatore di cultura greca come dal legionario appena civilizzato, senza che la diversità delle risonanze culturali deformasse il nucleo fondamentale della religione, i suoi momenti eticamente e socialmente più vitali, la morale della carità, dell’amore universale, della parità degli esseri umani, della speranza nel regno futuro. In sostanza, il cristianesimo non era nella sua essenza portato a costituire una forza eversiva della società e dello Stato, finché il cristiano poteva e doveva dare allo Stato e alla società (una volta assolto il debito verso Dio e rispettato il principio che l’adorazione è dovuta a lui solo, ciò che per la tolleranza romana era nella maggior parte dei casi possibile) tutto sé stesso, come buon cittadino o militare; ma creava una riserva spirituale di fronte allo Stato, relativizzandone il rapporto con l’uomo. Dove lo Stato tentasse di prevaricare e chiedere al cristiano più di quel che questo poteva dare, la relatività del rapporto si manifestava, e il cittadino scompariva davanti al credente. Il cristianesimo, e la sua Chiesa, rappresentava insomma una potenziale minaccia per l’impero non in quanto originariamente prescrivesse alcunché contro lo Stato, ma in quanto per i suoi valori etico-religiosi creava la possibilità di una vita al di fuori di esso. Certamente, col tempo maturarono l’orgoglio e il senso di superiorità morale sul mondo profano, che appariva sempre più smarrito e incapace di rinnovarsi. Gli uomini di cultura pagani e i più avvertiti politici e imperatori sentirono che la nuova religione, che non si manifestava come una moda passeggera, rappresentava nel cuore dell’ordinamento civile, nel compatto mondo spirituale greco-romano, una dimensione nuova, una linea di evasione. La larga diffusione delle religioni orientali (in partic. quella del mitraismo, d’origine persiana), dei culti misterici, delle sette orfico-pitagoriche e, presso i più colti, della filosofia platonizzante (sempre più tendente verso la religione) creava d’altra parte una sorta di antagonismo contro i cristiani, che mostravano per queste religioni e filosofie altrettanto disprezzo quanto per gli dei tradizionali del paganesimo greco-romano. Se queste religioni potevano adattarsi a vivere nell’ordinamento di R., perché il cristianesimo manteneva una così profonda riserva? La stessa umanità dei costumi e della mentalità, che nella società civile romana del 1° e 2° sec. aveva raggiunto un alto livello, lo stesso affermarsi di posizioni come quella di Seneca (della cui morale i cristiani stessi sentirono il profondo valore), piuttosto che avvicinare i mitigati spiriti pagani allo spirito cristiano rendevano più evidente il contrasto tra i due mondi, fra i quali l’abisso scavato dalla positività della fede nella rivelazione si manifestava invalicabile da ogni affinità meramente morale. Il «ciceroniano» e il «cristiano», che potevano anche essere vicini nel modo di vivere, erano in realtà ai poli estremi: rappresentavano due mondi opposti, l’uno fondato nel rispetto cosciente di una secolare tradizione di cultura e di vita etica, l’altro nella cosciente e ferrea adesione a una fede obiettiva. Donde una incomprensione profonda per il cristianesimo anche da parte di coloro che erano disposti a condividere certi insegnamenti morali di dolcezza e mitezza: la cultura greco-romana ripugnava a fondare tutta la vita spirituale su un fatto tanto irrazionale come la fede in un Uomo-Dio, e non poteva riconoscere nella oscura nascita, nella breve vita terrena e morte di Gesù di Nazareth un evento che capovolgesse interamente la storia umana, un fatto assolutamente e trascendentalmente condizionante per l’uomo. Il disagio del contatto con questo nuovo «popolo eletto», che non si identificava con alcuna stirpe nota di abitanti dell’impero, che si insinuava dovunque e non poteva essere stretto da presso, e che se stretto da presso sfuggiva con la morte all’impero della legge e della tradizione di R., con un popolo che si lasciava separare dalla comunità dello Stato senza provare per la morte civile quell’orrore che contraddistingueva l’uomo antico, tutto sociale e avvezzo a ritrovare nel rapporto con i propri simili associati nello Stato la propria più intima essenza; il disagio di avvertire in questi pur buoni cittadini un totale disprezzo per i valori fondamentali dell’etica pagana, come la gloria, la fama, la virtù, la saggezza, la conoscenza della filosofia e della scienza, la bellezza della poesia e delle arti; il concreto affermarsi in forme autonome dei gruppi umani raccolti nelle comunità e nelle chiese, centri d’interessi sociali e di vita economica: questi e altri motivi vennero creando lentamente le condizioni di quelle persecuzioni anticristiane volute da molti imperatori e perseguite talora con tenacia e crudeltà quali mai lo Stato romano aveva posto in tali iniziative. Ma a differenza del culto dionisiaco, duramente colpito nel sec. 2° a.C. per il suo carattere anarchico e moralmente ripugnante ai romani dell’età di Catone, o del culto druidico, la cui estirpazione coincideva con lo spegnimento delle ultime forze di resistenza celtiche, o del giudaismo ribelle degli zeloti, il cristianesimo non poté essere colpito a morte dai provvedimenti persecutori; lo impedivano il suo carattere universalistico, l’impossibilità di localizzarlo geograficamente e socialmente, la sua tenace resistenza che assumeva tutte le forme, dalla volontà eroica del martirio alla remissività dei molti che sembravano disposti al compromesso. Nell’ampiezza del suo raggio, il cristianesimo abbracciava spiriti forti e integralmente dediti alla difesa della fede, così come spiriti pronti a cedere, capaci di sottostare per poi risollevarsi quando la tempesta fosse passata. La Chiesa risorgeva dopo le persecuzioni per virtù della feconda testimonianza dei martiri, ma di fatto anche per la sopravvivenza di coloro i quali avevano, pure nel piegarsi, mantenuto una forte riserva interiore. Ogni persecuzione risollevava tra i cristiani la polemica tra chi non aveva ceduto e chi si era piegato e da tali contrasti, ben presto assurti a grandezza dottrinale, nascevano l’esperienza politica della Chiesa cristiana, la sempre maggiore consapevolezza delle proprie inesauribili risorse, la sempre più chiara visione dei punti deboli del paganesimo e dell’impero, la sempre più complessa coscienza del problema dei rapporti con lo Stato. E mentre la Chiesa nonostante tutto si ampliava e progrediva continuamente, lo Stato si rendeva sempre meglio conto di quale forza potesse rappresentare, nei momenti di crisi, l’appoggio della Chiesa cristiana; e, mentre nel seno della Chiesa maturavano i grandi contrasti dottrinali e morali, le eresie e le interpretazioni diverse che la dividevano spesso con violenza, lo Stato si rendeva sempre più conto di non poter rimanere indifferente di fronte a tali contrasti, che segnavano ormai la vita dell’impero con conseguenze politiche e sociali obiettive. È significativo il fatto che il primo imperatore romano che riconobbe al cristianesimo la liceità e poi, in un certo senso, la supremazia fra tutte le religioni, Costantino, avesse cominciato con l’utilizzare la forza della nuova fede ai fini della propria lotta per il potere, e rivendicasse poi per l’autorità imperiale il diritto di arbitrare i contrasti in seno alla Chiesa e di partecipare così in qualche modo alla sua vita.
Da Settimio Severo a Diocleziano
Il secolo che va da Settimio Severo a Diocleziano vide esplodere il fenomeno della pressione barbarica sui confini dell’impero, in special modo su quelli romani (da parte dei germani) e su quelli orientali (ad opera dei parti). Oltre che dalle minacce esterne, però, lo Stato romano era tormentato da un profondo travaglio interno, causato dai problemi di governo centrale, dalla crisi sociale (incentrata sulla decadenza delle classi dirigenti tradizionali: i grandi proprietari dell’aristocrazia senatoriale romana e i curiali, cioè gli amministratori che detenevano il governo dei centri provinciali dell’impero) e dalla crisi economica (con il grave fenomeno della progressiva e inarrestabile svalutazione della moneta). Di fronte al continuo pericolo delle invasioni, al dilatarsi del gravame fiscale, imposto dalle crescenti necessità dell’esercito, le classi inferiori soggiacquero al dominio dei funzionari imperiali e dei grandi proprietari, decadendo a condizioni praticamente servili, ciò che creava spesso disordini e ribellioni: tale fu la rivolta dei bagaudi (bande di predoni formate da gente di campagna), da cui per lungo tempo furono afflitte le Gallie. La società si andava cristallizzando in caste: da una parte gli honestiores, detentori del potere, anche se tormentati dall’incertezza sociale ed economica, dall’altra gli humiliores, asserviti e senza difesa alcuna da parte dello Stato che poteva pensare soltanto a spremere tutto il denaro possibile dalla terra e a portar via il maggior numero possibile di soldati. Intanto, il processo di esautorazione della classe senatoria si accentuava, a vantaggio del potere militare e della burocrazia imperiale; l’imperatore Gallieno, decretando l’impossibilità per i senatori di assumere comandi militari, infliggeva un colpo decisivo al Senato e poneva le basi giuridiche per quella distinzione tra amministrazione civile e militare che Diocleziano avrebbe reso definitiva. La monarchia assunse dunque un carattere nettamente militare; i tentativi ripetuti del Senato di eleggere imperatori di origine senatoriale fallirono tutti in breve tempo, mentre l’esercito, ormai interamente provinciale e spesso addirittura barbarico, affermava la sua potenza eleggendo imperatori i propri comandanti tra i quali alcuni, come Massimino il Trace (235-238) e Caro (282-285), non rispettarono neppure la formalità della ratifica senatoria della propria elezione. Sotto Settimio Severo vi fu ancora un periodo di relativa pace; ma già con il figlio Caracalla (che fu associato al trono nel 198 e regnò da solo dal 211 al 217) e con i suoi successori Eliogabalo (218-222) e Alessandro Severo (222-235) la violenza della lotta si manifestò pienamente, e questi, come quasi tutti i loro successori, finirono uccisi in cospirazioni o nelle battaglie tra gli eserciti romani in lotta per il predominio. Per la prima volta si videro imperatori, come Decio (249-251), cadere uccisi dai barbari; o prigionieri, come Valeriano (253-260) lo fu di Shapur, imperatore dei parti. La potenza militare e politica dei parti conobbe una grande ascesa, per opera della nuova dinastia persiana dei Sasanidi, che si ispirava agli ideali dell’antico impero persiano di Ciro e Dario. A metà del secolo si formò un impero nell’impero nelle Gallie, in Spagna e in Britannia, con l’imperatore Postumo e i suoi successori, che durò oltre dieci anni (260-274); il confine orientale dovette essere tenuto mercé l’aiuto del nuovo Stato di Palmira, che assunse un’autorità quasi completa con Zenobia e Odenato, finché Aureliano (270-275) non lo distrusse, restaurando il dominio di Roma.
Da Diocleziano alla caduta dell’impero d’Occidente
Gli ultimi due secoli di storia dell’impero romano furono assorbiti da nuovi grandi problemi, che riassumono il senso della decadenza del grande organismo politico romano e della nascita del nuovo mondo: la civiltà dell’Alto Medioevo in Occidente, l’impero bizantino in Oriente. Se ne possono isolare tre, tenendo presenti il loro nesso intimo e la necessaria schematicità di una simile enumerazione: la trasformazione dell’impero pagano in impero cristiano (con la elevazione di R. a centro della cattolicità); la resistenza alle invasioni dei barbari del Nord e dell’Oriente; la trasformazione della compagine amministrativa dell’impero, in base all’importanza progressivamente assunta dalla distinzione tra parte occidentale e parte orientale, all’affermarsi definitivo della monarchia assoluta e della struttura gerarchica piramidale della amministrazione civile (corrispondente a un irrigidimento della società in caste e in gruppi sociali chiusi). La storia romana dei secc. 4° e 5°, con lo scatenarsi della grande migrazione dei popoli barbarici, vede sempre più intrecciarsi le guerre civili con le guerre esterne; il fenomeno dell’imbarbarimento dell’esercito si accentua, e accanto a esso, determinante per i futuri sviluppi della storia occidentale, lo stanziarsi nei confini dell’impero di tribù barbariche, dietro accordi con le autorità romane, che in tal modo cercavano di rafforzare i confini, comperando a prezzo della terra e dell’autorità una stabilità relativa. Cessate dopo Diocleziano le persecuzioni, il rapporto con la Chiesa cristiana divenne problema politico, del quale Costantino si fece primo e geniale interprete, risolvendolo nel senso di riconoscere alla Chiesa quel posto nella società romana che ormai le era proprio, e con ciò preparando la progressiva assimilazione di autorità ecclesiastica e autorità civile, che alla lunga, di fronte al crollo dello Stato romano, si realizzò in Occidente con la pratica assunzione di responsabilità civili e politiche da parte della Chiesa di R., e in Oriente col cesaropapismo e la subordinazione della gerarchia ecclesiastica all’autorità imperiale, essa stessa suprema autorità ecclesiastica. Così l’impero si trovò coinvolto in problemi religiosi, e le questioni teologiche, come anche quelle relative all’autorità delle Chiese (Roma contro Alessandria o Antiochia, o Costantinopoli ecc.), divennero materia su cui gli imperatori si dovettero pronunciare, decidendo così della supremazia di questa o quella corrente o Chiesa cristiana. Il primato di R. come centro del cattolicesimo divenne però presto indiscusso per quanto riguardava l’Occidente; più problematico fu invece in Oriente, che però riconobbe sempre, almeno in teoria, la supremazia del pontefice romano. Nei grandi movimenti barbarici s’inserì il processo di cristianizzazione: a mano a mano che entravano in contatto diretto con la civiltà romana, le genti barbare si convertivano al cristianesimo. Contemporaneamente al rivolgimento portato dalle invasioni barbariche e dalla progressiva cristianizzazione del mondo conosciuto nacquero o si consolidarono forme di vita sociale che già preludono al Medioevo, come l’insediamento stabile dei contadini sulla terra (servitù della gleba), il declino (almeno parziale e in certi momenti più che in altri) delle basi monetarie dell’economia, la decadenza e lenta scomparsa di molti antichi centri cittadini, sostituiti da più povere forme di comunità agrarie, il rafforzamento del senso gerarchico della società, il cui vertice è l’imperatore (dominus), ormai del tutto irraggiungibile e quasi divinizzato, laddove però il moltiplicarsi della massa burocratica complica, frantuma e rende anarchica la vita sociale ai livelli inferiori. L’incertezza dei confini, accentuatasi nel corso del tempo, e l’esposizione sempre più grave al rischio delle incursioni barbariche accrescono la gravità di certi fenomeni di rivolta e trasformazione sociale, come la fuga e la ribellione dei servi, solidarizzanti con i barbari. Inoltre, spesso, anche le classi alte provinciali (e nel nuovo ordinamento dioclezianeo anche l’Italia fu provincia), su cui gravavano insopportabili gli obblighi fiscali, preferivano alla più ordinata ma spesso inumana amministrazione imperiale il compromesso coi barbari. Così, nonostante che la differenza tra barbari e romani rimanesse molto sentita, a marcare un livello di civiltà assai diverso, ci fu un nesso profondo tra l’aspetto violento ed esteriormente vistoso della decadenza dell’impero per opera delle armi germaniche e l’aspetto più silenzioso e celato della trasformazione sociale e del mutamento degli spiriti: a tal punto che è forse vano voler cercare in quale di questi due aspetti sia la vera «causa» della fine di quel mondo antico, che la volontà politica e la civiltà di R. avevano costruito. E in realtà, il processo fu lungo, ricco di ritorni e di varietà di aspetti locali, diversamente graduato nei suoi momenti sociali, economici, politici, militari, demografici, culturali: come mostra, tra l’altro, il fatto che vi sono forti divergenze tra gli storici circa il momento in cui si può parlare di vero e proprio inizio del Medioevo, a seconda della prospettiva in cui ci si pone e dell’importanza attribuita a questo o quel momento della vita storica (per esempio la vita economica, o l’organizzazione amministrativa e politica, o la consapevolezza degli ideali culturali e religiosi). Fu un processo tanto complesso da non poter essere racchiuso in una formula sola, né spiegato con una «causa». Certo è che tra il mondo romano dell’età di Diocleziano e quello dell’età, poniamo, di Valentiniano III v’è una differenza sostanziale: il primo è ancora, nonostante la gravissima crisi militare, politica e sociale in atto nel sec. 3°, un ente che, anche se assai diverso e per molti aspetti «decadente» rispetto alle età auree di Augusto o di Adriano, ha in sé la capacità di riorganizzarsi saldamente, di riprendere l’iniziativa e di rinascere a nuova vita; il secondo, invece, è ormai chiaramente un organismo, almeno nella sua parte occidentale, del tutto trasformato. Dalla morte di Aureliano (275) all’avvento di Diocleziano (284) la crisi interna dell’impero matura decisamente attraverso nuove guerre civili ed esterne, fino a trovare nella capacità politica e nell’ampia visione dei problemi amministrativi e organizzativi di Diocleziano una soluzione che, grazie alla trasformazione profonda delle strutture, sanziona la fine del vecchio impero ma, al tempo stesso, lo rinnova e gli conferisce un vigore nuovo. Il grande problema era di vedere se ciò dovesse avvenire con o contro il cristianesimo: la risposta fu inizialmente nel senso di un accentuarsi della reazione pagana, con la quale Diocleziano coronava il suo sforzo di restaurare l’impero; ma successivamente, e definitivamente (salvo l’episodio di Giuliano), la Chiesa cristiana venne accolta come momento fondamentale della vita della società antica. Già con Gallieno e Aureliano si era andati incontro al cristianesimo, e la stessa politica della Chiesa si faceva sempre più consapevole del fatto che il quadro naturale del suo sviluppo storico dovesse arrivare a coincidere con l’impero universale romano. Pochi imperatori incarnarono come Diocleziano (284-305) una tanto rigida volontà di ordine e di stabilità. Le sue riforme furono realizzate gradualmente tra mille difficoltà esterne e interne in cui si dibatteva l’impero; tuttavia la coerenza del suo spirito conferì un’unità di fatto anche là dove non v’era probabilmente unità di intenzioni. Ciò può dirsi del sistema della «tetrarchia», per il quale il supremo titolo imperiale si trovò diviso tra due Augusti e, a loro subordinati, tra due Cesari, destinati a raccoglierne la successione; il sistema fu realizzato in vari momenti e si affermò poi con la norma dell’abdicazione a data fissa degli Augusti e la successione dei Cesari. Il sistema tetrarchico però non risolse, come era nelle intenzioni di Diocleziano, il problema delle lotte per il potere al vertice dell’impero; tuttavia disciplinò in qualche misura il sistema d’elezione degli imperatori e sancì il principio della possibile collegialità della carica suprema, legata alla distinzione tra pars orientis e pars occidentis, sanzionata poi definitivamente e consapevolmente da Teodosio nelle persone dei figli Arcadio e Onorio. Le guerre continue e i pericoli enormi in cui s’era trovato l’impero a causa della contemporanea aggressione barbarica a confini fra di loro lontanissimi avevano reso evidente la necessità che l’autorità imperiale si spostasse dal centro alla periferia: e Diocleziano, che pur ebbe vivissimo il senso della romanità e latinità, fu il primo imperatore che abbandonò R. come propria stabile sede, eleggendo la preferita Nicomedia. Del resto città come Treviri o Milano cominciavano già ad assumere un ruolo sempre più importante, come capitali di fatto dell’impero, le cui esigenze di difesa dimostravano che R. non era più la sede naturale del potere centrale, come lo era stata all’epoca della grande pace e dell’egemonia imperiale. Il principio della capillarità, esteso da Diocleziano a tutta l’amministrazione dell’impero, portò con sé di necessità l’aumento del numero delle province; attraverso il raggruppamento di queste in diocesi e delle diocesi in prefetture, si realizzò una struttura amministrativa e militare a un tempo, rigidamente piramidale, al cui vertice stava la rinnovata suprema potestà imperiale, cui ormai simbologia e prassi di corte riconoscono ufficialmente un carattere del tutto assoluto e super-umano. Nelle persone dei due Augusti si incarnano le divinità che presiedono alla vita dell’impero: così l’Augusto Diocleziano è Giovio e l’Augusto Massimiano (286-305) è Erculio. La riforma dell’esercito tenne a distinguere sempre meglio le truppe stabili di frontiera (limitanei) dai corpi mobili a disposizione degli Augusti e dei Cesari, riserve interne destinate a intervenire ai confini (comitatus o comitatenses). La capillarità della divisione amministrativa era dovuta a ragioni di difesa, ma anche di economia. Di quell’economia che ormai da un secolo era in piena crisi, con la svalutazione quasi totale della moneta (nonostante i ripetuti tentativi degli imperatori di salvarla) e il ritorno sempre più frequente allo scambio in natura, con il conseguente rallentamento e decadimento di tutta la vita economica dell’impero. Diocleziano tentò di risollevare la situazione attraverso una serie di provvedimenti di largo respiro, anche se in realtà assai scarsi di risultati duraturi; sempre pressanti erano infatti le esigenze del fisco che gravava inesorabilmente sulle classi più produttive. Così l’Editto dei prezzi (301) fu un fallito tentativo di calmierare tutti i prezzi dell’impero. Ma soprattutto decisiva per la storia della società antica fu la tendenza, sempre più forte, a irrigidire in maniera definitiva, decretando l’obbligo dell’ereditarietà delle professioni e legando alla terra i contadini (servitù della gleba), la struttura sociale esistente per impedire la disgregazione. Ciò che in parte riuscì; ma l’immobilità così imposta alla società aggravò ulteriormente il già evidente stato di incapacità d’iniziativa economica delle classi medie e umili. Intanto, dalle persecuzioni di Diocleziano il cristianesimo uscì più forte. Il problema della tolleranza si impose indilazionabile ai successori del grande imperatore dalmata, i quali nella disputa per il potere finirono anche per appoggiarsi alla forza sociale e ormai chiaramente politica della Chiesa, che polarizzava attorno a sé una somma enorme di interessi spirituali e mondani. La guerra tra Licinio (308-323) e Massimino Daia (308-313) può dirsi ancora una guerra tra cristianesimo e paganesimo; non altrettanto può dirsi invece del definitivo scontro fra Costantino e Massenzio (306-312), il quale ultimo non era certo da meno del primo per quanto riguarda la tolleranza verso i cristiani. Al vincitore Costantino (306-337) spettò il compito di ristabilire l’unità politica dell’impero, entrata fortemente in crisi in seguito alla fine dell’equilibrio tetrarchico, non più sostenuto dal vecchio Diocleziano, che pur dopo l’abdicazione aveva mantenuto intatta la propria autorità morale di grande governante, e di dar luogo a una nuova unità spirituale, nel nome del riconoscimento ufficiale del primato di fatto della religione cristiana nell’impero. Con l’Editto di Milano (313), con il riconoscimento dei diritti e privilegi delle Chiese, con la convocazione del Concilio di Arles (314) e del grande Concilio di Nicea (325) da lui stesso presieduto, Costantino, che aderì al cristianesimo solo in punto di morte, può dirsi il fondatore del nuovo impero cristiano. E proprio con lui si apre il grande problema della reciproca determinazione dei rapporti tra Chiesa e impero, da Costantino risolti con formule sottili, ma sostanzialmente nel senso del futuro cesaropapismo, quella concezione del supremo potere religioso dell’imperatore, che dominerà poi tutta la storia dell’impero d’Oriente. Al perfezionamento dell’ordinamento dioclezianeo, Costantino aggiunse il nuovo riassetto dell’amministrazione centrale, moltiplicando gli uffici di corte e circoscrivendo talune prerogative dei più alti funzionari. Questi furono il quaestor sacri palatii, il magister officiorum, il comes sacrarum largitionum, il comes rerum privatarum, cui erano affiancati altri comites. Accanto a essi sedeva il consiglio privato del principe (consistorium), mentre alle forze armate provvedevano il magister peditum e il magister equitum. Dai comitatenses furono distinti i palatini, guardia del palazzo imperiale. L’economia dell’impero fu risollevata con il solido aureo, moneta che si sostenne assai bene. Funzioni giudiziarie furono attribuite agli ecclesiastici; l’edificio politico-giuridico dell’antica R. era ormai completamente trasformato. Per la storia di R. come città e centro politico e spirituale, il regno di Costantino ebbe importanza decisiva: venendo incontro alle effettive necessità strategiche ed economiche dell’organismo dell’impero, Costantino trasportò ufficialmente la sede imperiale da R. a Bisanzio, là dove Europa e Asia, Mar Nero e Mediterraneo si incontravano. Costantinopoli, la nuova R., ebbe dell’antica tutti i regali attributi: primo fra tutti, un nuovo Senato, che però ebbe formalmente dignità inferiore rispetto al vecchio Senato romano. Da quel momento, nonostante che mai la priorità di R. tra le città dell’impero, e su Costantinopoli, venisse disconosciuta, il destino della città, fino allora almeno formalmente centro del suo impero, assunse un nuovo corso. L’accen;tuazione progressiva della contrapposizione di fatto, e poi anche di diritto, tra Oriente e Occidente (come tra patriarca di Bisanzio e pontefice di R.) determinò la decadenza rapida di quel carattere ecumenico di R., che ne faceva una città unica al mondo. Pur conservando i titoli gloriosi del suo passato, R. decade sempre più chiaramente come centro politico, per risorgere solo con il papato medievale, quando ormai la grandezza di R. imperiale fu sostituita dall’unicità di R. città santa del mondo cristiano. E a questa decadenza politica, specie dopo le agitate e tragiche vicende del sec. 5°, nel corso del quale la città, inviolata dal tempo dell’incendio gallico (inizi del sec. 4° a.C.), fu più volte saccheggiata dai barbari goti (sacco di Roma di Alarico, 410) e vandali (sacco di Genserico, 455), fecero naturalmente riscontro la decadenza economica, demografica, urbanistica e la trasformazione progressiva della sua storica fisionomia di città antica nella nuova fisionomia della città alto-medievale fatta di castelli e di fortificazioni, sorte attorno alle case dei potenti e ai santi luoghi di culto. Alla morte di Costantino l’impero fu nuovamente turbato da lotte per la successione; poi Costanzo II (337-361) riunì tutto il governo nelle proprie mani e chiamò a farne parte il cugino Giuliano. Morto Costanzo, Giuliano (360-363) assunse l’impero: aveva trascorso l’adolescenza e la prima giovinezza dedito agli studi filosofici, ma si rivelò un buon generale e difese validamente il confine renano. Era un pagano illuminato e convinto che una restaurazione pagana avrebbe giovato all’impero; la sua spiritualità elevata e profonda ne fa la maggiore figura di quest’epoca, tormentata e profondamente travagliata da immensi problemi. Nella restaurazione pagana, Giuliano vedeva anche il modo di sottrarre l’impero alle violente lotte dottrinali che già affliggevano la Chiesa cristiana. Fu detto Apostata, ma non perseguitò i cristiani, limitandosi a restaurare la parità del culto pagano con quello cristiano, preferendo i filosofi e i letterati pagani ai teologi cristiani. La sua fine prematura, durante una campagna contro i persiani, fu rimpianta da quanti apprezzavano la sana amministrazione e la politica finanziaria cui egli aveva già dato inizio. Il neopaganesimo di Giuliano non lasciò tracce profonde tra i popoli dell’impero: l’antica religione era definitivamente caduta. Valentiniano I (364-375) e il fratello Valente (364-378), rispettivamente in Occidente e in Oriente, ritornarono a una politica filocristiana e tentarono di sollevare in qualche modo lo stato di estrema depressione delle classi inferiori istituendo le cariche di defensores plebis. Ma Valente fu il primo degli imperatori il cui esercito fu distrutto dai barbari, ed egli stesso ucciso (battaglia di Adrianopoli, 378): le orde gotiche, sospinte dagli unni, si dimostrarono militarmente più potenti dell’esercito invitto di Roma. Il figlio e successore di Valentiniano I, Graziano (367-383), si associò nell’impero un valoroso generale, Teodosio, il quale, dopo una complicata vicenda (che vide deposto Graziano da Massimo, questo eliminato da Teodosio, il giovane Valentiniano II posto sotto tutela del barbaro Arbogaste, e da lui sostituito con Eugenio), eliminò Arbogaste ed Eugenio e rimase solo imperatore. Teodosio (379-395) cercò di risolvere il problema dei barbari goti stanziandoli entro i confini dell’impero, come federati, e arruolandoli nell’esercito. Così l’imbarbarimento progressivo dell’impero assunse un nuovo aspetto, quello decisivo: la penetrazione legittima dei popoli germanici al di qua dei confini e il loro impadronirsi delle leve di comando militari. Le capacità personali di Teodosio gli permisero di controllare gli eventi e di imporre una unità di indirizzo politico e religioso (egli fu antipagano e antiariano) all’impero, compromessa però già dai figli Arcadio, cui toccò la parte orientale, e Onorio (395-423), cui andò quella occidentale. Dai due figli di Teodosio discende la divisione dell’impero, che di fatto non sarà mai più unificato, anche se con Giustiniano i diritti e la potenza dell’impero d’Oriente tornarono a farsi sentire in tutto il Mediterraneo. In Occidente prevalsero i capi e gli eserciti barbarici. Onorio fu sotto la tutela di Stilicone, grande e ambizioso generale, che difese l’Italia dai goti ed esercitò di fatto il potere imperiale. Finché visse Stilicone, R. fu difesa; ma nel 410 i goti di Alarico la presero di forza e la saccheggiarono. Morto Alarico, i goti continuarono a spostarsi attraverso l’Occidente, finché si stanziarono, come federati, in Aquitania. Dopo Onorio, il trono fu alla fine assicurato a Valentiniano III (425-455); intanto, l’im;pero era sempre più devastato dai barbari. Ezio, capo delle forze occidentali, sconfisse gli unni di Attila, la cui minaccia continuò comunque a gravare ancora sull’Italia. I vandali, guidati da Genserico, invadevano la Spagna e di qui passavano in Africa, dove fondavano un regno. Dall’Africa venne la spedizione vandalica che saccheggiò per la seconda volta R. (455), arrecando danni enormi, mentre il bottino prelevato da Alarico era stato relativamente modesto. I vandali d’Africa contestavano ormai il dominio del Mediterraneo alla flotta romana. La fine di Ezio e Valentiniano III vide il precipitare rapido della situazione dell’impero occidentale: passarono fugacemente sul trono (455-474) una serie di imperatori (Petronio, Avito, Maggioriano, Libio Severo, Antemio, Olibrio, Glicerio), tutti nominali, giacché il potere era esercitato di fatto dai generali barbarici. Il generale Oreste deponeva nel 475 Giulio Nepote, candidato sostenuto dall’impero d’Oriente, sostituendogli il proprio figlio Romolo, detto Augustolo. Nel settembre del 476 un altro generale, il barbaro Odoacre, fu acclamato re dalle milizie barbariche dell’impero che si trovavano in Italia; deposto Romolo, Odoacre ritenne inutile nominare un nuovo imperatore, e non accettò l’invito di Zenone, imperatore d’Oriente, a ristabilire sul trono Nepote. Rinviate a Costantinopoli le insegne imperiali, Odoacre ricevette il titolo di patrizio romano: e come tale, e come re degli ex federati barbarici, governò l’Italia. L’impero romano sussisteva ancora; formalmente, mancando l’Augusto d’Occidente, l’impero tornava nelle mani dell’Augusto d’Oriente. Ma gli imperatori d’Oriente non potevano ora, né volevano, affrontare, come poi fece Giustiniano, l’impresa di concretizzare di fatto la loro autorità puramente nominale. Dal 476, perciò, si fa finire tradizionalmente la storia romana. In realtà, la funzione di R. era esaurita da tempo, mentre si preparava la rinascita del prestigio della città non più come dominatrice delle genti, ma come centro della Chiesa universale cristiana. La compagine dell’impero occidentale, sommersa dai popoli germanici, era dissolta; la storia di R. era finita. D’ora in poi, i limiti della storia di R. ritornano quelli che erano stati novecento anni prima, i limiti di una città. Questa città era stata, però, la capitale dell’impero di Cesare, di Augusto, di Traiano, di Adriano; in essa erano le rovine dei Fori, la sede del Senato e, a ravvivare in un senso completamente nuovo questi ricordi, le tombe degli Apostoli e la cattedra di s. Pietro. Ciò spiega perché, nel Medioevo, il rinato impero occidentale, a partire da Carlomagno nell’800, considerò sempre R. la città detentrice dei diritti imperiali, e gli imperatori si dovettero sempre fare incoronare in Roma.
Medioevo
Come si è detto precedentemente, ben prima della deposizione di Romolo Augustolo (476) R. aveva perduto il suo antico splendore. I visigoti di Alarico nel 410, i vandali nel 455 e Ricimero nel 472, nella sua lotta con Antemio, avevano inferto profonde ferite ai suoi edifici monumentali; gli abitanti, in continua diminuzione, dalla periferia si andavano raccogliendo nel centro dell’Urbe; le massime magistrature imperiali si erano trasferite altrove, in luoghi più muniti e meno esposti alle minacce dei barbari, a Milano e infine a Ravenna; lo stesso Senato, perduto ogni potere politico e divenuto un semplice organo amministrativo, si rivelava sempre più impotente ad assicurare, insieme con la prefettura, le elementari necessità della vita civile ed economica locale. Ma al progressivo decadimento della R. imperiale si accompagnava il progressivo potenziamento della R. cristiana. Il primitivo cristianesimo usciva dalla clandestinità e con la sua impetuosa avanzata dava la sua impronta, anche topografica, alla città. La potenza non più soltanto religiosa ma decisamente politica del papato è rivelata dall’importanza che assume per R. e per tutta l’Italia l’elezione del nuovo pontefice. Forze e interessi contrapposti si scatenano in violenti e furibondi conflitti, che dal terreno politico ed economico scivolano spesso anche sul piano religioso, provocando lunghe e implacabili controversie dogmatiche e disciplinari: il già cospicuo patrimonio della Chiesa fa della nomina del pontefice una questione connessa alla piena disponibilità dei beni ecclesiastici. Le crisi occasionate da tali elezioni degenerano spesso nello scisma, come appunto quello laurenziano alla cui composizione dovette intervenire da Ravenna il re gotico Teodorico. La feroce guerra gotico-bizantina fu particolarmente disastrosa per R. che a varie riprese fu conquistata e perduta, alternativamente, dai due contendenti: gli assedi, i saccheggi e i massacri, la distruzione sistematica degli acquedotti provocarono un’ulteriore diminuzione della popolazione, tutta raccolta ormai nella pianura alle pendici dei quattro colli digradanti sul Foro. Il Laterano e il Vaticano si protendevano come baluardi ai due estremi, veri centri morali della vita dell’Urbe, anche durante la dominazione bizantina. Allora chiese e località ebbero un’onomastica orientaleggiante. Anche la classe dirigente fu di estrazione bizantina, e di origine orientale e siriaca furono per qualche tempo i papi. Ma, pur in presenza di un duca bizantino, R. andò sempre più assumendo il carattere di città sacra e il papato divenne la suprema autorità cittadina. Tra la fine del sec. 6° e i primi anni del 7° tutta la scena di R. è dominata dalla grande figura del papa Gregorio Magno. Con inesauribile energia egli provvide alle necessità civili e militari della città; con accorgimento e finissimo senso politico, intralciando magari i piani bizantini, ma senza mai mettersi apertamente in urto, realizzò un più tollerabile e umano modus vivendi con i nuovi invasori, i longobardi. A spezzare gli ultimi e formali legami tra R. e Bisanzio venne, nella seconda metà del sec. 7°, lo scisma monotelita. Con la nomina di Gregorio II (715) terminava la serie dei papi orientali, piuttosto ligi alla volontà imperiale. Ma la rottura definitiva avvenne sotto l’imperatore Leone III l’Isaurico, in seguito al suo editto fiscale e alle sue direttive iconoclastiche del 726. Sull’esempio del papa, tutta l’Italia bizantina si sollevò contro il potere imperiale, mentre a R. il rappresentante dell’esarca di Ravenna, il duca Pietro, fedele all’Isaurico, venne accecato, e al suo posto fu eletto il patrizio e duca Stefano, che esprimeva la riscossa locale contro Bisanzio. Si costituì così un governo autonomo, che, oltre alla città, amministrava anche l’intero ducato, corrispondente più o meno all’antica prefettura, e però sempre subordinato alle necessità politiche e religiose del pontefice. Ma alla soggezione bizantina subentrò la minaccia dei longobardi guidati da Liutprando, il quale aveva subito cercato di sfruttare a proprio vantaggio la crisi. Con continui accordi e patteggiamenti, ora appoggiandosi ai bizantini, ora ai duchi longobardi di Spoleto e di Benevento, sempre ribelli al loro sovrano, il papa cercò di salvare il ducato romano, orientandosi infine, quando l’esarcato cadde nelle mani di Astolfo, nel 751, verso i franchi. La popolazione romana, ridottasi a poche decine di migliaia di persone, era organizzata militarmente nelle scholae, una per ognuna delle dodici regioni amministrative in cui la città era suddivisa; a queste andavano aggiunte le formazioni costituite dai diversi gruppi etnici che vivevano nella città: greci, sassoni, frisi, franchi, longobardi, ecc. Ma questi reparti militari erano insufficienti contro un deciso attacco longobardo. Al pericolo esterno va aggiunto quello interno, rappresentato dall’aristocrazia. Venuta meno infatti l’influenza bizantina e compenetrandosi sempre più strettamente potere politico e potere religioso nelle mani del papa, le più potenti famiglie romane tesero a fare del pontificato un proprio riservato ed esclusivo dominio. Il titolo di patrizio, prima rivestito dagli esarchi e poi passato all’ultimo duca, Stefano, comportava un diritto quasi automatico d’intervento nelle faccende religiose e amministrative della città. Il conferimento del patriziato a Pipino, re dei franchi, in seguito al nuovo orientamento politico della Chiesa, offendeva perciò l’aristocrazia, che si vedeva esclusa in tal modo da ogni ingerenza nella direzione della città. Torbidi e tumulti scoppiarono entro le mura di R. tra le fazioni in lotta. Finalmente con Adriano I si giunse all’eliminazione del pericolo longobardo, grazie all’energico appoggio del re franco Carlo: tutte le risorse, materiali e di uomini, furono impiegate al rafforzamento delle mura e del sistema difensivo di R. e fu organizzata una più efficiente milizia, la familia Sancti Petri. La conferma da parte di Carlo della celebre Promissio Carisiaca e la concessione di parte della Sabina e di altri territori sottratti all’Esarcato di Ravenna costituirono un ulteriore potenziamento dell’autorità papale e un ampliamento della sua giurisdizione territoriale. Ma il successore, Leone III (795), fu ancora umiliato da una rivolta dell’aristocrazia, e reintegrato solo a opera di Carlo, intervenuto con la sua forza. Tuttavia le lotte accanite e feroci tra le opposte fazioni non cessarono, provocando ancora gli interventi dei re e imperatori carolingi. La Constitutio Romana dell’824 imposta da Lotario, per esempio, prevedeva che l’elezione papale passasse attraverso la ratifica imperiale, mentre tutta l’amministrazione della città era affidata, direttamente o indirettamente, ai missi permanenti dell’imperatore. La rapida decadenza dei carolingi e la loro impotenza a fronteggiare il pericolo musulmano, la dissoluzione dell’impero nell’anarchia e il conseguente assurgere a grande potenza dei signori di Spoleto e di Tuscia, gravitanti decisamente verso R. e il ducato, crearono nuove situazioni. L’espansione saracena nel Mediterraneo minacciò anche R., sollecitando le energie locali a una più efficace difesa, specialmente dopo lo sbarco dei saraceni alle foci del Tevere (23 agosto 846), il saccheggio di S. Pietro e di S. Paolo e la sconfitta delle milizie cittadine. Ma la violenza e l’anarchia penetrarono anche nell’organismo stesso della Chiesa, tanto più facilmente quanto più questa aveva assunto funzioni e responsabilità politiche. R. si trovò allora esposta all’ingombrante tutela del potente duca di Spoleto, che per un certo tempo poté disporre a suo talento del pontificato, divenendo arbitro incontrastato della città e del ducato e spezzando ogni tentativo di resistenza con efferata ferocia: il macabro processo e lo scempio cui fu sottoposto il cadavere di papa Formoso (897) sono rimasti tristemente celebri. A datare dai primi del 900, in seguito al declinare dell’influenza dei duchi di Spoleto, tutto il potere di R. si concentrò nelle mani dell’onnipotente Teofilatto, titolare del più alto ufficio dell’amministrazione pontificia (vestararius) e comandante supremo delle milizie (magister militum): alleato con il ducato di Spoleto, snidò gli arabi trincerati sul Garigliano, e R. fu così per sempre liberata dall’incubo dei saraceni (915). Alla morte di Teofilatto il potere fu ereditato e fermamente mantenuto, contro ogni tentativo della gerarchia ecclesiastica, dalla figlia di lui Marozia, che si appoggiò agli spoletini e al marchesato di Toscana. Quando Marozia sposò re Ugo di Provenza, il figlio Alberico (sostenuto dalla nobiltà romana gelosa della sua indipendenza) con il titolo di princeps Romanorum stabilì e resse fino alla morte (954) il suo principato personale, nel quale vaghe reminiscenze classiche si confondevano con propositi di riforma religiosa. Un suo figlio, al quale fu dato il nome augurale di Ottaviano, assunse a sedici anni il pontificato col nome di Giovanni XII. Ma ricostituitosi con Ottone I il Sacro romano impero, la politica ecclesiastica del nuovo imperatore e la sua volontà di controllare il pontefice provocarono la perdita dell’autonomia romana, e il papato stesso passò sotto il controllo imperiale. E tuttavia l’aristo;crazia romana non disarmò: per cinquant’anni, sotto la direzione della potentissima famiglia dei Crescenzi, tentò di riprendere il dominio della città, chiudendo però in questo modo il papato nell’ambito familiare e cittadino. La lotta, alternata a momentanee tregue, divampò sempre più accanita, nonostante le sconfitte e le condanne subite dai Crescenzi, finché la morte non troncò il sogno romano-cristiano di Ottone III, la restauratio Imperii. Dai Crescenzi il potere passò (1012), non certo pacificamente, alla famiglia dei Tuscolo, che lo tennero per un trentennio, più o meno ligi agli imperatori franconi, e sempre fra contrasti con le famiglie rivali. Il movimento riformatore, che affermava l’indipen;denza della Chiesa dall’impero, ebbe profonde ripercussioni nell’ambiente romano, portando alla ribalta politica nuovi ceti e nuovi casati, quali i Frangipane e i Pierleoni. Le vecchie casate nobiliari per tradizione e per interesse rimasero invece fedeli all’impero. Le vicende e gli sviluppi della lotta delle investiture ebbero grande risonanza in R., non solo per le consuete complicazioni che apportarono agli schieramenti delle forze locali, ma anche per le conseguenze militari, causa di distruzioni irreparabili. Enrico IV assediò a varie riprese, nel maggio 1081 e nel marzo 1082, la città; riuscì anche (luglio 1083) a impadronirsi, con un colpo di mano, della Città leonina, costringendo il papa Gregorio VII a riparare in Castel Sant’Angelo; piegò con la forza e con la corruzione al suo volere la cittadinanza, facendosi conferire il titolo di patrizio, ma dovette poi fuggire (1084) all’appressarsi di un esercito normanno guidato da Roberto il Guiscardo che, espugnata con la forza la città, la sottopose a un feroce e rovinoso saccheggio. Il popolo esasperato si ribellò contro i normanni, ma fu domato con eccidi in massa e deportazioni. R. rimase divisa e in preda all’alterno potere delle fazioni familiari, i Frangipane e i Pierleoni, che negli strascichi della lotta delle investiture si combattevano fra loro. Si ebbero anche brevi tentativi di reggimento comunale, ma il popolo, anche quando momentaneamente apparve protagonista sulla scena politica, fu sempre manovrato da qualche grande. Soltanto nel 1144 esso riuscì a farsi valere e, sorretto dall’infiammata parola di Arnaldo da Brescia, poté dar vita a un effettivo ma effimero governo comunale (connesso con la cosiddetta renovatio senatus quale istituzione democratica in cui si assommavano tutti i poteri, ottobre 1144), escludendo il dominio papale. Mancava infatti, nella R. medievale, quella rigogliosa attività commerciale e artigianale che alimentò altrove e sostenne il reggimento comunale. Le scarse attività artigianali erano situate, insieme al piccolo e minuto commercio, nei quartieri più popolari, lungo le rive del fiume, tra l’estrema Marmorata e il pons Iudaeorum, nell’ambito delle regioni di Ripa, Sant’Angelo e Campitelli. La costituzione comunale poté reggersi finché durò l’antagonismo tra Chiesa e impero; poi, nel 1155, Arnaldo da Brescia fu sacrificato e abbandonato al suo destino, e, pur di conservare una qualche autonomia nell’amministrazione civile, il comune fece atto di sottomissione al papato. L’accordo stipulato nel 1188 con papa Clemente III sanzionò una certa distinzione tra potere civile e potestà religiosa, con il riconoscimento legale del Senato, sia pure sottoposto a investitura da parte del pontefice. Ma la carica di senatore fu presto disputata con i soliti metodi violenti dagli esponenti delle grandi casate gentilizie. Fino alla ripresa del conflitto con l’impero, al tempo di Federico II, la Chiesa riuscì però a controllare energicamente il governo di R. (Innocenzo III avocò a sé la designazione del senatore). Soltanto negli anni fra il 1231 e il 1234 si ebbe, per iniziativa soprattutto di Luca Savelli, un’energica affermazione dell’autorità civile sul potere ecclesiastico, per cui si vollero rivedere i privilegi giudiziari e tributari del clero. Ma troppo stretti e complessi erano gli interessi morali e materiali che legavano la cittadinanza romana e specialmente l’aristocrazia alla Santa Sede, perché si potesse proseguire in questa direzione. Anche il regime comunale, nonostante il tentativo compiuto in tal senso dal bolognese Brancaleone degli Andalò dopo il 1250, era sempre bloccato dalla rinnovata e più fitta rete di poteri signorili che si distese in tutto il distretto romano in seguito all’alleanza papale-angioina. Né miglior successo poteva sortire il tentativo di governo signorile su base popolare. La rete degli interessi costituiti delle grandi casate (in questo periodo emergono gli Orsini e i Colonna) rappresentava un ostacolo insuperabile al consolidamento sia del comune sia della signoria. Tuttavia, tra la seconda metà del sec. 13° e lo scorcio del 14°, al centro della storia di R. troviamo sempre il comune che, nonostante la limitatezza e precarietà dei suoi poteri, le sue incoerenze e incertezze, esplica la sua attività soprattutto nell’espansione territoriale contro comuni minori e signori feudali e si sforza di limitare la stessa sovranità della Chiesa. La dignità senatoriale, che significava il possesso di R., fu contesa non solo dagli ottimati locali, ma anche da sovrani e principi stranieri, da Manfredi, Riccardo di Cornovaglia, Carlo d’Angiò, il quale, pur contro la volontà del pontefice, la tenne per più di un decennio. Infine, a incominciare da Niccolò III, un Orsini, tutte le cariche pubbliche furono conferite, sia pure a titolo personale, allo stesso papa e quindi praticamente alle grandi famiglie baronali, i cui membri si avvicendavano sul trono di s. Pietro. Il comune rimase saldamente nelle mani delle famiglie cardinalizie e papali, Orsini, Colonna, Savelli, Annibaldi, Caetani. Con papa Bonifacio VIII, R., centro del grandioso giubileo del 1300, ebbe un periodo particolare di rigoglio artistico e culturale, fra l’altro con la fondazione dell’università (1303). Ma il trasferimento della corte papale ad Avignone precipitò alcuni anni dopo R. in una crisi molto grave anche sul piano economico, andando a colpire quei ceti le cui attività gravitavano intorno alla Curia. Mentre Orsini e Colonna si contesero con alterna fortuna il dominio, la discesa di Enrico VII nel 1312 e la breve signoria di Roberto d’Angiò esasperarono ma non mutarono la situazione. Su questo sfondo si svolse l’investitura imperiale offerta a Ludovico il Bavaro dal popolo romano raccolto in Campidoglio. Diffuso e quasi unanime era il desiderio che il papa ritornasse da Avignone nella sua legittima sede romana. Un’ambasceria fu inviata nel 1342 al nuovo papa Clemente VI per invitarlo a tornare a Roma, rimettendo nelle sue mani tutte le cariche cittadine, e per sollecitarlo a indire un nuovo giubileo per il 1350. In tale clima di disagio economico e di stanchezza maturò e si bruciò rapidamente il tentativo di Cola di Rienzo di restaurare un «buon ordine» nella città nel quadro utopistico di un impero rinnovato. Costretto a fuggire nel 1347 per il mancato appoggio di alcuni comuni italiani, per la freddezza dimostrata dal papa e per le rivolte baronali, Cola di Rienzo fece un breve ritorno nel 1354 come senatore; ma, avendo perso di nuovo il favore del popolo, fu ucciso durante un tumulto popolare, anche con il concorso della nobiltà. R. attraversò così nel periodo del papato avignonese una fase di grave decadenza che, negli anni successivi alla cacciata di Cola di Rienzo, si accentuò ulteriormente in conseguenza della peste del 1348, del terremoto del 1349 e delle razzie operate dai mercenari di Gualtiero di Urslingen, cui si sommarono le già esistenti guerre tra fazioni e il banditismo nelle campagne. Una breve parentesi di relativa calma si aprì con l’invio del cardinale Egidio de Albornoz, come legato per l’Italia e vicario generale nei domini della Chiesa, per riorganizzare lo Stato pontificio, allora in piena dissoluzione, e per ripristinare i rapporti con il comune romano. Il cardinale, servendosi per un breve periodo di Cola di Rienzo (1354), che avrebbe dovuto spianare la strada, riuscì nel suo intento facendo alcune concessioni alle aspirazioni comunali, come l’istituzione di un consiglio di popolani affiancato al senatore. In questo periodo fu riformata anche la milizia cittadina, furono affiancati ai conservatori due banderesi, capi della milizia; nel 1363 fu promulgato uno statuto, dal carattere dichiaratamente ostile verso i magnati, che non prevedeva, tra l’altro, alcun rapporto con la Curia avignonese. L’emanazione da parte del cardinale Albornoz delle costituzioni egidiane, destinate a regolare i rapporti fra governo pontificio e poteri locali e a definire i criteri istituzionali posti alla base dell’organismo di governo con a capo il papa, sembrò preludere, con l’insieme dei provvedimenti adottati nei confronti del comune romano, a un periodo di stabilità governativa, e quindi di pace, per la città. Ma, nonostante ciò, la grave crisi aperta dallo spostamento del papato ad Avignone non si risolse. Dopo la fugace apparizione di papa Urbano V nel 1367, finalmente nel 1377 Gregorio XI si decise ad abbandonare la sede avignonese, quando la situazione si fece grave anche per la guerra degli Otto santi sferrata dai fiorentini contro il Patrimonio. Alla morte di Gregorio XI (1378), il popolo romano, temendo un ritorno della curia ad Avignone, con tumulti e violenze impose al conclave riunito l’elezione di un papa romano. Con l’elezione di Urbano VI e l’immediata replica dei cardinali francesi che, riuniti a Fondi, elessero papa Clemente VII, si aprì il grande scisma d’Occidente, destinato a dividere l’unità spirituale cristiana in due obbedienze, facenti capo o al papato avignonese o a quello romano. In tale contesto le rivolte (già scoppiate dopo la riorganizzazione effettuata da Albornoz e a fatica sedate a suo tempo dal cardinale Roberto di Ginevra, il futuro antipapa Clemente VII) esplosero e dilagarono nuovamente in tutto il territorio pontificio. Il successore di Urbano VI, Bonifacio IX, papa nel 1389, ereditò uno Stato in guerra, una cancelleria decimata, un archivio disperso e le finanze esauste; il Lazio con i suoi porti era sotto l’obbedienza avignonese; i bretoni, mercenari al comando di Bernardone di Senes, erano a N di R.; a S, i Caetani che avevano favorito l’elezione di Clemente VII; a Marino, gli avignonesi, vicini quindi alla stessa Roma. In questo clima s’inserirono le continue agitazioni del comune romano. Così Bonifacio IX, dopo essersi assicurato la pace con Onorato Caetani attraverso una serie di tregue annuali, accordò al comune un vitalizio, sostenuto con grandi difficoltà dal clero romano, in cambio del reciproco aiuto. Il comune, fin qui libero dalle ingerenze dirette del clero e della nobiltà, tentò di mantenere le stesse libertà. Tuttavia già dal 1391, la minaccia del papa, allora ad Assisi, di non fare ritorno in R., comportò una ridefinizione degli statuti del 1363, con particolare riferimento alle competenze relative alla giustizia e alle tasse. Ma le tensioni fra comune e pontefice non cessarono, dal momento che lo stesso comune romano, rivendicando ancora l’autonomia dal governo papale, pretese di estendere la propria sovranità sulla Campagna (Campania nel lat. medievale). L’accanirsi delle lotte tra le due fazioni che si alternavano alla guida del comune, facenti capo ai Colonna (i «popolani») e agli Orsini (i «nobili»), entrambe avverse al papa, portò rapidamente alla capitolazione del comune stesso; quando, nel giugno del 1398, i partiti videro la città minacciata dal condottiero Paolo Orsini di Firenze, consegnarono il pieno dominio di R. nelle mani di Bonifacio IX. I nobili fecero allora un estremo tentativo di restaurare il governo dei banderesi, ma fallirono e i capi della congiura furono esiliati o giustiziati. Bonifacio IX abolì l’ufficio dei banderesi, liberò il Senato dalle imposizioni codificate negli statuti, volle subordinata direttamente al papa la nomina, in una lista unitaria, degli ufficiali del comune e vincolò le spese straordinarie per R. alla controfirma del camerario apostolico per l’autorizzazione. Con questi provvedimenti le libertà del comune romano vennero definitivamente abbattute. Ancora nel 1404, alla morte di Bonifacio IX, il comune si sollevò e i Colonna e gli Orsini tornarono nuovamente a scontrarsi per le vie di Roma. Il nuovo papa, Innocenzo VII, ricorse all’aiuto del re di Napoli, Ladislao di Durazzo, già impegnato dal precedente pontefice nelle campagne vincenti contro i Caetani e i Colonna. Ladislao occupò la città, dove, fino alla sua morte (1414), instaurò un clima di dura repressione sul comune e sulla popolazione, sottoposta, fra l’altro, a frequenti tasse ed esazioni. Scomparso Ladislao, nei quattro anni che durò il Conciclio di Costanza, R. fu ancora una volta teatro di violenze e torbidi, contesa, fra gli altri, da Braccio da Montone e da Attendolo Sforza. Soltanto nel 1420 Martino V, un Colonna, eletto papa nel Concilio di Costanza, riuscì, con l’aiuto di A. Sforza, a rientrare nella città e a sottoporla al suo potere.
Rinascimento
Con il pontificato di Martino V, la cui elezione nel 1417 pose fine al grande scisma, si aprì per R. un lungo periodo di pace. Questo papa, pur continuando la politica di limitazione delle libertà municipali, avviò il processo di ripresa economica, amministrativa e culturale della città – al quale contribuì anche il ritorno della corte pontificia a R. –, destinato a trasformare la città medievale in una capitale rinascimentale degna di un principato con a capo, sovrano assoluto, il pontefice, anche se non mancarono episodi di rivolta e di rivendicazione delle libertà cittadine. Martino V distribuì ai membri della sua famiglia, a titolo di feudo, ampie estensioni territoriali all’interno dello Stato pontificio. Con i papi nepotisti successivi, questa tradizione continuò, dando luogo da una parte alla formazione di ricchezze private immense, dall’altra perpetuando le lotte fra quelle potenti famiglie che si sarebbero alternate alla guida sia del comune sia dello Stato pontificio. In tale contesto si inseriscono i tumulti e i disordini che si verificarono a R. subito dopo la morte di Martino V (1431), sotto il successore Eugenio IV. Questi, per affrontare il problema del controllo di R., attaccò direttamente i potenti Colonna e i loro alleati. Ma il papa, indebolito dal contrasto con il Concilio di Basilea e dalle minacce espansionistiche provenienti sia da Napoli sia da parte di Francesco Sforza, dovette affrontare anche le rivolte cittadine fomentate dai Colonna, che insorsero e crearono difficoltà al nuovo pontefice. Così risorse il comune (1434) che, sotto la guida di Niccolò Fortebracci (nominato gran gonfaloniere), costrinse Eugenio IV a fuggire da Roma. Presto il comune si dovette piegare sotto la forza del vescovo di Recanati Giovanni Vitelleschi, che rese possibile il ritorno del papa a R. e sottomise i Colonna e i loro alleati. Ma già nel 1453 Stefano Porcari tentò nuovamente di spingere la popolazione a rivendicare i diritti civili soppressi: la congiura questa volta fallì per il mancato appoggio della stessa popolazione, resa indifferente ed estranea al governo della città ormai in mano a potenti casati nobiliari. Disordini continuarono a manifestarsi anche in seguito, nonostante gli interventi di papi come Paolo II (che nel 1469 emanò nuovi statuti a tutela di residue autonomie della magistratura comunale) o Giulio II (con le sue iniziative, sempre nell’ambito della giustizia), che restituirono un maggior rigore amministrativo e qualche autonomia al comune. Tuttavia, a eccezione di queste turbolenze, connesse spesso a crisi politiche esterne, più vaste e frequenti nella seconda metà del Quattrocento, in occasione della guerra di Ferrante d’Aragona e Renato d’Angiò, della guerra di Ferrara e della congiura dei baroni, la vita politica si svolse a R. sotto il dominio quasi assoluto del papato. La corte e la curia subirono una forte espansione ed ebbe inizio l’uso di mettere all’incanto gli uffici sia laici sia religiosi. Il nepotismo e la mondanizzazione della Chiesa contribuirono in maniera determinante a porre R. sotto il dominio assoluto del papato. Famiglie come Sforza, Della Rovere, Borgia, Orsini, attraverso la curia, controllarono gli uffici municipali, le finanze, gli statuti della città. Tuttavia, in questo clima, parallelamente al dilagare di forme di potere assoluto, R. visse un periodo di profondo rinnovamento culturale. Papi come Niccolò V, Pio II, Sisto IV, Paolo II, impressero una forte spinta alla città, che divenne così la capitale del Rinascimento italiano. Qui operarono personalità come P. Bracciolini, F. Filelfo, il cardinale Bessarione, L. B. Alberti, Michelangelo, Raffaello. La ristrutturazione della città, iniziata con la riorganizzazione della magistratura dei magistri viarum (1425) da Martino V, proseguì attraverso Eugenio IV fino a Niccolò V (1447-55). Con la riedizione degli statuti del 1452 si ebbe un primo sforzo di risistemazione viaria e urbanistica di R., che avrebbe contemplato, fra l’altro, la demolizione dell’antico Borgo da sostituire con una nuova piccola città sulla destra del Tevere, tripartita da vie confluenti su S. Pietro (progetto in parte realizzato nel 1936 con il collegamento diretto tra Castel Sant’Angelo e piazza San Pietro). Niccolò V volle creare una biblioteca pubblica (istituita poi ufficialmente da Sisto IV con una bolla del 15 giugno 1475). Fu introdotta la stampa con i due prototipografi tedeschi K. Sweynheim e A. Pannartz, trasferitisi a R. da Subiaco nel 1467. Si sperimentarono nuove e complesse forme di scrittura monumentale epigrafica, celebrativa di questi pontefici rinascimentali e adattata di volta in volta alle esigenze delle ingenti trasformazioni edilizie della città. Nel 1526, a preludio quasi del sacco che avrebbero effettuato gli imperiali l’anno successivo, i Colonna penetrarono nella città, sottoponendo così R. a rinnovate violenze dopo i tumulti repressi da Giulio II nel 1512. Il 6 maggio 1527 R. fu invasa dai lanzichenecchi luterani e dagli spagnoli di Carlo V che devastarono la città lasciando ingenti danni materiali e infliggendo al mondo cristiano, già scosso dalla Riforma, un profondo e ulteriore trauma. A partire dalla seconda metà del Cinquecento, quasi insensibilmente nel mondo delle arti, con più evidenza nella cultura letteraria, nel costume, nella politica, incominciarono a penetrare nella vita romana gli ideali e le preoccupazioni della Controriforma. Il Concilio di Trento, l’istituzione della Compagnia di Gesù, l’Inquisizione romana posero un freno allo splendore rinascimentale e gli stessi pontefici condussero una vita più raccolta, una politica meno avventurosa, imposta quest’ultima dalla mutata situazione europea. Soltanto Paolo IV, un Carafa, riprese per qualche tempo e senza successo un atteggiamento più combattivo anche nei confronti dell’impero. I papi della seconda metà del sec. 16° furono indotti dalle rimostranze e dalle agitazioni popolari ad attenuare il gravame fiscale, recuperando i mezzi finanziari con una più saggia e oculata politica fiscale e amministrativa. L’atmosfera della Controriforma impose un pesante conformismo, un irrigidimento del principio di autorità, specie in campo religioso; in compenso assunsero aspetto sfarzoso e spettacolare le cerimonie del culto, processioni e altre pratiche liturgiche, dirette ad appagare, insieme con l’edificazione religiosa, anche il gusto per la moltitudine.
Seicento e Settecento
Accanto ai fasti della nobiltà, la presenza numerosa di una folla povera e affamata determinò una serie di misure di emergenza per far fronte ai frequenti disordini, spesso connessi al rincaro dei prezzi (pane compreso), e al brigantaggio che infestava le campagne. Sul volgere del sec. 16° si andò così rafforzando la tendenza ad accentrare il potere anche in relazione alle amministrazioni periferiche, opera già iniziata da Sisto V. Clemente VIII proseguì in tale direzione e con la bolla Pro commissa nobis (1592) riformò l’organizzazione comunale e i rapporti di questa con il potere centrale, istituendo, per l’applicazione della bolla, la Congregazione del Buon Governo. Il rafforzamento del potere centrale avvenne anche attraverso una politica antisignorile che portò da una parte alla creazione (per risanare le finanze locali) di una congregazione cui fu affidato il compito di rendere esecutive le sentenze pronunciate contro i baroni insolventi, persino con la vendita all’incanto dei beni da loro posseduti; dall’altra garantendo l’ordine pubblico attraverso provvedimenti, come i processi volti a punire i delitti comuni, in particolare quelli legati alla nobiltà (come il celebre processo dei Cenci), o destinati a reprimere i duelli e gli eccessi durante il carnevale o a costringere le prostitute a risiedere in un quartiere particolare della città. Il risanamento delle finanze fu tentato anche attraverso il ricorso sempre più frequente all’indebitamento pubblico (furono creati ben 14 nuovi Monti oltre ai 7 già esistenti) e all’incremento del gravame fiscale: nonostante tali provvedimenti, la crisi non fu risolta. Con Alessandro VII Chigi la grave situazione finanziaria venutasi a creare agli inizi del sec. 17° – con la decadenza dell’agricoltura (e quindi le carenze nell’approvvigionamento della città), con il debito pubblico accentuato per la dispendiosa politica economica dei Barberini (operata da Urbano VIII e dai cardinali Antonio e Francesco Barberini, i cui profitti furono oggetto di un’inchiesta, aperta da Innocenzo X, sull’amministrazione delle finanze durante il papato dello stesso Urbano VIII e la guerra di Castro), e non bilanciato dal diminuito reddito pubblico – si aggravò; venne così effettuata un’importante riforma finanziaria che vide, tra l’altro, la riduzione degli interessi legati ai luoghi di monte. Questo tentativo di risanamento tuttavia non ebbe successo, essendo inghiottite le entrate dalla poderosa attività edilizia di Alessandro VII e dalle spese di amministrazione. Accanto al tentativo di risanare il debito pubblico si manifestò, all’interno del governo civile di R., l’intervento della curia. L’antico Senato fu ridotto a una istituzione puramente formale e finì col divenire di pertinenza definitiva del sovrano pontefice anche la nomina dei senatori (dal 1646). Il vicecamerlengo della Chiesa detenne nello stesso tempo anche le funzioni di governatore: a lui fecero capo gli uffici relativi all’amministrazione, al fisco, all’ordine pubblico e alla giustizia sia civile sia penale. In tale contesto le grandi famiglie nobiliari furono destinate a perdere il ruolo di protagoniste assolute della vita politica romana per ridursi a funzioni di semplice rappresentanza; fatte salve quelle che ebbero modo di conservare, o di incrementare, i privilegi loro conferiti dai pontefici per il mai estinto nepotismo, che trovò con Alessandro VIII rinnovato vigore. Ma accanto al forte nepotismo, tutelato da quest’ultimo pontefice, furono operate numerose riforme finanziarie in favore della popolazione; in particolare fu alleggerito il gravame fiscale con la liberalizzazione del commercio dei grani e l’abolizione della gabella della carne. Avviato lo Stato della Chiesa verso la decadenza, tagliato fuori per la sua neutralità dai grandi eventi politici europei e italiani, sempre più in tono minore si svolgeva la vita nella R. del Settecento; oggetto di distaccata curiosità, non argomento di lotta, furono per lo più le grandi controversie tra gesuiti e giansenisti, contro i quali ultimi, come anche contro i Franchi muratori, si scagliò la condanna papale. Sullo scorcio del secolo Pio VI sembrò voler rinnovare, col suo mecenatismo, i fasti del Rinascimento e del barocco, riprendendo l’attività costruttiva per la trasformazione urbanistica di R.: fu l’ultimo guizzo, che si spense nella bufera rivoluzionaria, preannunciata dai molti preti e nobili emigrati che portarono a R. le notizie sugli eventi di Francia. Ma anche a R., come nei maggiori centri dell’Italia e dell’Europa, insieme con gli emigrati erano attivi e sempre più audaci, con il progressivo affermarsi delle armate rivoluzionarie, propagandisti ed emissari giacobini, i quali, sotto la copertura delle logge massoniche o con la protezione dell’ambasciata francese, diffondevano le idee rivoluzionarie tra i giovani e la borghesia. Già al principio del 1793, in un tumulto popolare, trovò la morte il diplomatico francese N.-J.-H. de Basseville, che aveva ostentato emblemi rivoluzionari; l’episodio determinò, da parte della Francia, la rottura delle relazioni diplomatiche con lo Stato pontificio, primo di una serie di eventi che si concluse con la proclamazione della Repubblica romana.
La Repubblica romana del 1798-99
Dopo la proclamazione della Repubblica ad Ancona, e i moti di Senigallia e Pesaro, l’uccisione a R. dell’addetto militare francese Léonard Duphot (28 dic. 1797) fu il pretesto per un intervento militare francese. Occupata R. dal generale L.-A. Berthier, i patrioti romani con rogito notarile, il 15 febbr. 1798, proclamarono decaduto il governo temporale: cinque giorni dopo il papa fu espulso e si rifugiò in Toscana. Un’insurrezione di alcuni rioni, reazione popolare al disagio economico, fu subito domata (25 febbr.), con conseguente fucilazione degli insorti in piazza del Popolo e consegna delle armi da parte della popolazione. Il 20 marzo, in piazza S. Pietro, fu solennemente consacrata la Costituzione, modellata su quella francese del 1795, della Repubblica romana, che assorbì anche l’Anconitano. Furono nominati un tribunato e un Senato e il governo fu formalmente affidato a un consolato di 5 membri e ad alcuni ministri, ma il governo effettivo rimase in mano dei francesi. Le proposte dei patrioti romani di ridistribuire la terra nelle campagne per costituire una piccola proprietà contadina non ebbero seguito e dure furono le repressioni, soprattutto contro i contadini, ribelli ai pesanti tributi. Una spedizione di Ferdinando IV di Napoli, che riuscì a occupare R., fu subito seguita dal ritorno del generale J-É. Championnet e la Repubblica fu restaurata (14 dicembre). Ma le vittorie della coalizione austro-russa, la fine della Repubblica napoletana, le continue insurrezioni contadine, lo scarsissimo seguito a R. dei pochi giacobini, avversati per le malversazioni operate dai francesi (che nel luglio 1799 avevano sospeso le assemblee e il consolato, nominato un comitato provvisorio di governo alle loro dirette dipendenze e proclamato lo stato d’assedio), affrettarono la catastrofe. Il 29 settembre 1799 il generale P. Garnier cedeva Civitavecchia agli inglesi e R. alle truppe napoletane, che il 30 settembre occupavano la città, abbandonata, per la via dell’esilio, dai suoi governanti; Ancona cadde il 13 novembre. Si concluse così l’esperienza repubblicana che, se pur limitata e imposta dalle armi francesi, aveva scosso ed eccitato un ambiente indifferente, preparandolo a nuove responsabilità politiche.
Dalla fine del Settecento al 1849
La Rivoluzione francese e le vicende napoleoniche avevano strappato R. alla sua vita sonnolenta. Caduta l’effimera Repubblica romana, il nuovo papa Pio VII assicurò un certo ordine nella città sconvolta dall’ondata giacobina, per merito soprattutto dell’energico e abile cardinale E. Consalvi. Ma nel 1809 i francesi erano nuovamente padroni di R. e il papa iniziava il suo quinquennale esilio in Francia. Nonostante l’impegno riformatore dei francesi (in campo amministrativo, economico, sanitario, ecc.), i romani non dimostrarono mai eccessiva simpatia per il nuovo regime: non mancarono, anzi, specialmente nelle campagne, resistenze aperte e rivolte. Dopo la caduta di Napoleone, fallito un tentativo di G. Murat d’impadronirsi della città (1815), si ebbe il ritorno di Pio VII e l’inizio della restaurazione, che, blanda inizialmente sotto l’illuminata direzione di Consalvi, andò facendosi sempre più rigida e gretta con il sopravvento degli «zelanti» e, specialmente, con la successione al trono pontificio (1823) di Leone XII. Ma tra il popolo penetravano le prime idee di libertà e la Carboneria apriva le sue «vendite». Nel 1825, proprio tra le celebrazioni del giubileo, il patibolo fece le sue prime vittime (Angelo Targhini e Leonida Montanari). La tempesta, preannunciata dai processi del cardinale A. Rivarola in Romagna e dalle prime esecuzioni capitali romane, esplose nei primi anni del pontificato di Gregorio XVI (1831-46), il quale dovette fronteggiare la rivoluzione scoppiata nelle province settentrionali e subire per sei anni l’occupazione di quelle stesse province da parte delle forze francesi e austriache. Ma le idee carbonare e mazziniane, dopo aver conquistato alcuni strati della borghesia e aver fatto adepti nelle famiglie patrizie, cominciavano a diffondersi anche fra il popolo. A Grego;rio XVI successe Pio IX (1846). L’ideologia enunciata da V. Gioberti nel Primato morale e civile degli Italiani, conciliando abilmente le aspirazioni patriottiche e liberali con i sentimenti cattolici, era penetrata anche in R. e vi aveva suscitato, come nel resto d’Italia, un vero e proprio movimento di opinione pubblica, che dall’alto, con coloriture e cariche diverse, s’irradiava negli strati più popolari. L’entusiasmo per Pio IX, con tutti gli equivoci e le illusioni che vi erano legati, travolse la R. papale. Nell’osanna al pontefice si confondevano insieme con le aspirazioni alla libertà e alla partecipazione statale anche le aspirazioni a un’esistenza meno miserabile. Ma il problema d’inserire i laici nel governo pontificio si rivelò estremamente arduo: da secoli lo Stato pontificio era in mano della gerarchia ecclesiastica e le esigenze religiose soffocavano le necessità civili. Attirato dal mito neoguelfo, Pio IX si avviò sulla strada della riforma: sotto la spinta delle agitazioni popolari permise la costituzione di un ministero al quale, pur sotto la direzione nominale di un cardinale, parteciparono i laici; seguì l’istituzione di una Consulta di Stato, nominata dalle amministrazioni provinciali; una modesta libertà di stampa e la guardia civica completarono le riforme romane, le quali suscitarono grandi fermenti nel popolo, non tanto per ciò che direttamente concedevano, quanto per ciò che lasciavano presagire. La concessione della Costituzione (marzo 1848) pose in piena luce le contraddizioni tra il principio teocratico e il regime costituzionale. Il concistoro dei cardinali si sovrapponeva alle due camere rappresentative, alle quali era sottratta la competenza delle questioni ecclesiastiche e delle cosiddette materie miste: anche la politica estera e gran parte delle finanze, in quanto attinenti all’organismo universale della Chiesa, erano sottratte al Parlamento. L’allocuzione del 29 apr. 1848, in cui Pio IX, in riferimento all’Austria, affermò di non poter fare guerra a un popolo cristiano, rivelò l’insostenibilità di una Chiesa cattolica al rimorchio delle forze liberali. I ministri laici che si alternarono alla direzione del governo, da M. Minghetti a T. Mamiani, a Edoardo Fabbri, a P. Rossi, naufragarono fra gli scogli degli intrighi dei reazionari da una parte e l’opposizione sempre più violenta e incontenibile delle forze democratiche, desiderose ormai di concessioni sostanziali. La fuga del papa a Gaeta dopo l’assassinio di P. Rossi (nov. 1848), fu seguita a R. da un periodo convulso e caotico, cui pose termine soltanto la proclamazione, nel febbr. 1849, della Repubblica romana, che ebbe vita più effimera della prima repubblica del 1798-99.
La Repubblica romana del 1849
Rifugiatosi Pio IX a Gaeta (29 nov. 1848), la giunta provvisoria di governo convocò un’Assemblea costituente che, dichiarato decaduto il governo temporale, proclamò la repubblica (9 febbr. 1849). Nominato un comitato esecutivo, formato da C. Armellini, M. Montecchi e A. Saliceti, si dette avvio a una vasta opera di riforme: furono aboliti i tribunali eccezionali, quello del Sant’Uffizio, la censura sulla stampa e la giurisdizione dei vescovi sulle scuole e sulle università, mentre con un decreto del 21 febbr. si stabilì che tutti i beni ecclesiastici divenissero proprietà nazionale. Giunte le notizie della sconfitta di Novara e della repressione dell’insurrezione genovese, l’Assemblea costituente concentrò le energie nella difesa militare della repubblica, minacciata dalle truppe francesi, austriache, spagnole e napoletane, pronte a intervenire per restaurare il potere temporale del papa. Fu nominato un triumvirato formato da G. Mazzini (arrivato nel marzo in città), C. Armellini e A. Saffi (19 marzo), cui vennero conferiti poteri illimitati, e fu mobilitata la guardia nazionale. Uno dei principali provvedimenti presi dal nuovo governo fu l’approvazione della legge agraria, che stabiliva la ripartizione tra i contadini delle terre espropriate al clero. Il 5 aprile un corpo di spedizione francese guidato dal generale N.-C.-V. Oudinot sbarcò a Civitavecchia e il 30 aprile attaccò la capitale. Intanto gli austriaci occupavano Bologna, le Legazioni, Ancona e le Marche, mentre gli spagnoli sbarcavano a Fiumicino. Fallite le trattative affidate a F.-M. de Lesseps, i francesi ripresero le operazioni militari, rendendo vana l’eroica difesa della popolazione e dei volontari, accorsi da ogni parte d’Italia. Il 3 luglio l’Assemblea costituente decise la resa ma, come testimonianza dei propri ideali democratici, proclamò ugualmente la Costituzione. Essa sanciva il principio della sovranità popolare, dell’uguaglianza, della libertà e della fraternità, risultando la più avanzata, in senso democratico, di tutte le Costituzioni italiane del Risorgimento. Il 31 luglio un triumvirato nominato da Pio IX composto dai cardinali G. della Genga, L. Vannicelli e L. Altieri, assunse il governo della città e iniziò l’opera di restaurazione del potere papale.
La fine dello Stato pontificio
La Repubblica romana era stata travolta dalle forze dell’Europa cattolica, che aveva accolto sollecitamente l’appello del papa esule, che rientrò a R. il 12 aprile 1850. Ma anche il destino dello Stato pontificio era segnato. La crisi era maturata e il popolo romano, pur in sordina, incoraggiato dal successo delle armi piemontesi nella seconda guerra d’indipendenza, si andava orientando verso la soluzione unitaria, sotto l’egida sabauda; le riforme tardive introdotte dal pontefice, gli spettacoli offerti al popolo, la costruzione della prima linea ferroviaria non riuscirono ad arrestare questo processo. I patrioti, monarchici e repubblicani, pur talvolta contrastandosi, operarono con efficacia, indebolendo il governo pontificio e creando incidenti e attentati. Uno di questi, l’esplosione della caserma Serristori, nel 1867, offrì il pretesto all’azione garibaldina di Mentana e preluse alle accoglienze trionfali fatte ai soldati italiani nel 1870. Negli ultimi anni dello Stato della Chiesa, continuò, tuttavia, una vivace vita intellettuale e mondana, racchiusa nei palazzi delle grandi famiglie patrizie, i Doria, i Borghese, i Torlonia, i Caetani. Anche il fervore edilizio ebbe una ripresa con Pio IX; ma lo stato d’incertezza politica e le difficoltà economiche non consentivano più opere grandiose. Anche il numero degli abitanti, nelle sue oscillazioni, rifletté il corso degli avvenimenti e dei perturbamenti politici del periodo: dai 150.000 circa alla fine del Settecento, dopo un sensibile abbassamento durante la dominazione napoleonica, andò aumentando gradatamente, specie sotto il pontificato di Pio IX, fino a superare i 200.000 ab. nel 1870.
Roma capitale d’Italia
La presa di R. aprì un nuovo periodo della vita della città, ormai centro politico e amministrativo del Paese. A poco a poco nuovi edifici pubblici e studiati adattamenti di quelli antichi accolsero la sempre più vasta macchina burocratica e politica del regno d’Italia. Anche se la capitale non conobbe una radicale trasformazione del suo assetto economico e sociale, rimanendo per tutta l’età liberale essenzialmente estranea al processo di industrializzazione, si verificò, proprio in virtù della sua nuova funzione, un crescente sviluppo urbano, che assunse presto quel carattere, mantenuto nel corso degli anni, di progressiva mescolanza dei più vari apporti regionali. Per farvi fronte, durante l’amministrazione Nathan (1907-13), furono avviate numerose iniziative nel campo dell’edilizia, volte alla pianificazione dell’assetto territoriale, mentre una particolare attenzione fu rivolta ai problemi della sanità e dell’istruzione. Durante il fascismo (con decreto del 28 ott. 1925), fu istituito un ente di diritto pubblico che unificava le funzioni allora svolte in altre città dal comune e dalla prefettura, composto da un triumvirato (governatore, vicegovernatore, segretario generale, nominati dal re su proposta dei ministri degli Interni e delle Corporazioni) e da una consulta di dodici membri che forniva parere obbligatorio sul bilancio, l’applicazione dei tributi, i piani regolatori edilizi, l’assunzione diretta di servizi pubblici. Al governatore erano anche trasferite alcune competenze statali, soprattutto in campo sanitario. Un nuovo piano regolatore entrò in vigore nel 1931, prevedendo ampi e audaci sventramenti nel centro storico e la nascita di una serie di borgate popolari decentrate. L’impostazione ideologica di fondo non mancò di riflettersi sulle soluzioni concrete date ai problemi urbanistici e demografici; ispirandosi contemporaneamente al mito della R. antica e al fasto monumentale della R. dei papi, il regime compì le sue opere più rappresentative con la sistemazione della zona dei Fori imperiali e con l’apertura, meno felice, della via della Conciliazione. Lo sviluppo edilizio fu progettato in direzione del mare, mentre era avviata, alla vigilia del secondo conflitto mondiale, la sistemazione di una vasta zona destinata a ospitare l’esposizione universale prevista per il 1942 e a trasformarsi poi in quartiere moderno. Coinvolta nelle iniziative del regime e teatro delle sue manifestazioni più appariscenti, la cittadinanza seguì l’evoluzione della politica nazionale, staccandosi gradualmente dalla classe dirigente fascista, fino a dare un contributo, sia pure circoscritto a gruppi numericamente esigui, alla lotta contro le truppe tedesche nell’autunno del 1943. Ancora centro di vita politica durante i quarantacinque giorni del governo Badoglio, R. fu abbandonata dalla corte e dal governo subito dopo la comunicazione (8 sett. 1943) della firma dell’armistizio con gli anglo-americani. Sottoscritte la sera del 10 sett. 1943 le clausole della tregua a Frascati, R. fu costituita città aperta sotto il comando del generale Calvi di Bergolo; ma presto essa cadde sotto il dominio diretto dei tedeschi (comandante prima il generale Stahel, poi il generale Maeltzer), i quali se ne servirono come retrovia del fronte germanico, che si andava stabilizzando sulla linea «Gustav» e a Cassino. Fu allora organizzata una intensa attività clandestina antifascista, che, nelle condizioni sempre più difficili della popolazione e nel moltiplicarsi delle deportazioni, specialmente di ebrei, seppe affrontare arresti e torture (operate dai tedeschi nella loro sede di via Tasso, da formazioni aderenti alla Repubblica di Salò in una pensione di via Romagna). L’eccidio di 33 soldati tedeschi in via Rasella (23 marzo 1944) fu seguito da una rappresaglia che costò la vita, nell’eccidio delle Fosse ardeatine, a 335 cittadini, in larga parte israeliti. La liberazione di R. per opera degli anglo-americani avvenne il 4 giugno 1944. Sottoposta per breve tempo ad amministrazione militare alleata, R. tornò a essere (15 agosto) sede del governo monarchico e nel 1946 accolse la Costituente italiana.