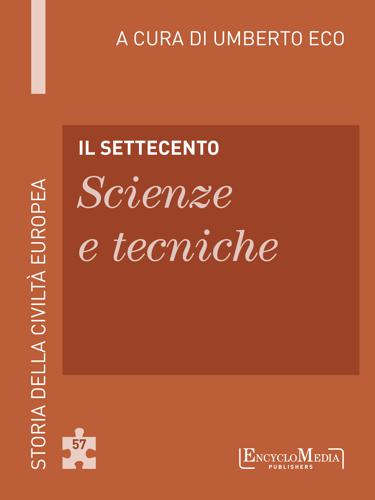Scienza, Stato e rivoluzione
Il contributo è tratto da Storia della civiltà europea a cura di Umberto Eco, edizione in 75 ebook
Accanto ai meriti tradizionalmente riconosciuti alle accademie scientifiche dell’Illuminismo – la libertà e la secolarizzazione del sapere, l’impulso e la centralizzazione delle ricerche, la circolazione e la discussione dei risultati – la storiografia recente riconosce un aspetto più profondo: il fatto che le accademie fungano da laboratori sociali, adottando forme di organizzazione e programmi di ricerca funzionali alle politiche dei rispettivi stati.
La Royal Society e l’Académie des Sciences
La Royal Society di Londra continua a essere un’accademia reale solo di nome. La sua natura di associazione autofinanziata, la sua autonomia dallo Stato e dalla Chiesa, la sua vocazione sperimentale e il suo newtonianesimo apologetico sono caratteristiche privilegiate ereditate dall’ideologia liberale anglicana che essa mantiene in seno al sistema sociale inglese uscito vittorioso dalla Gloriosa rivoluzione.
Di tutt’altra natura è l’Académie des Sciences di Parigi. Questa creazione di Colbert, destinata a diventare la culla del meccanicismo materialista, vede ancora più rafforzata la sua integrazione allo Stato assolutista con il nuovo regolamento del 1716 che ne aumenta numero dei membri, risorse e prerogative. A numero chiuso, cooptati dai propri pari, stipendiati dalla Corona, gli scienziati dell’Académie formano un’aristocrazia intellettuale in seno alla società a caste dell’ancien régime . In cambio del prestigio e dell’autonomia che riceve dallo Stato, l’Académie assolve compiti di giurisdizione e di consulenza tecnologica: giudica e perfeziona le invenzioni degli artigiani, raccoglie modelli di macchine, offre lumi alle tecniche delle manifatture reali, ai lavori di cartografia o di costruzione di canali del regno.
Rispetto a queste corvées di carattere utilitario, l’Académie privilegia le matematiche, la meccanica celeste e razionale, tanto che durante la Rivoluzione gli artigiani rimprovereranno i suoi géomètres di aver trascurato le invenzioni e le tecniche per un programma di sofisticata matematizzazione del sistema newtoniano conforme alla loro idea aristocratica della scienza.
Ma intanto sono quei géomètres, come d’Alembert e Condorcet, a prodigarsi nei progetti del ministero Turgot. E tutti i sovrani illuminati del continente emulano Parigi trasformando cenacoli scientifici locali come l’Académie des Curieux di Bruxelles o il Collegium Curiosorum di Stoccolma in cosmopolite accademie reali che si contendono l’un l’altra gli scienziati. Federico II, non riuscendo a convincere d’Alembert a presiedere la sua accademia, chiama a Berlino Maupertuis, Euler e Lagrange, mentre Caterina II ottiene Euler e Daniel Bernoulli per quella di San Pietroburgo.
Rivoluzione e accademie
A misurare la superiorità scientifica della Francia non è però l’Académie da sola, bensì la rete di luoghi di ricerca e di scuole ingegneristiche creata dall’ancien régime in funzione dei bisogni dell’amministrazione di uno Stato centralista: dall’Osservatorio reale di Parigi (1672) al Jardin des Plantes (Orto botanico) di Buffon (1739), dall’École des Ponts et Chaussées di Perronet (1739), all’École du Génie di Mézières (1749) e all’Ecole des Mines, istituita a Parigi nel 1783 sul modello della Bergakademie di Friburgo.
Questo patrimonio di istituzioni e questa politica in favore della scienza sono ereditati dalla Rivoluzione che nazionalizza le scuole di specializzazione ingegneristica e potenzia, rinnovandoli, sia i laboratori e le raccolte naturalistiche del Jardin des Plantes, che diviene Muséum National d’Histoire Naturelle, sia le collezioni di macchine di Vaucanson, che formano il nucleo attorno a cui la Rivoluzione crea il Conservatoire National des Arts et Métiers di Parigi come centro di divulgazione e formazione tecnologiche.
Al pari delle altre accademie monarchiche, l’Académie Royale des Sciences è invece soppressa durante il Terrore, quando nel Comitato di salute pubblica siedono però scienziati come Berthollet, Chaptal e Monge.
Se l’Académie risorgerà sotto il Direttorio, riorganizzata come Prima classe dell’Institut National des Sciences et des Arts, la riforma del sistema delle misure e la “mobilitazione degli scienziati” nella produzione di armi ed esplosivi per la guerra nazionale esaltano il valore sociale della scienza. Dell’organizzazione scientifica dell’ancien régime , però, la politica della scienza della Rivoluzione mantiene i criteri centralisti ed elitari. Per la formazione delle élite amministrative e universitarie dello Stato democratico la Convenzione fonda ex novo a Parigi nel 1794 sia l’École Polytechnique, che dà a tutti i futuri ingegneri dello Stato un’avanzata formazione matematica sia l’École Normale, destinata alla preparazione degli insegnanti scientifici e umanistici di tutto il Paese. E a queste istituzioni di alto profilo scientifico e sociale si accede non più per diritto di sangue o censo, ma in base al principio meritocratico del naturale talento dell’individuo.