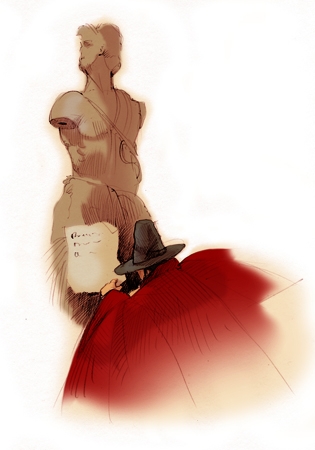epigramma
epigramma
Pochi versi per fulminare il lettore
Iscrizione originariamente destinata alle lapidi, l'epigramma diventa nell'antica Grecia un vero e proprio genere letterario in cui si cimentano i poeti più famosi, e la sua storia arriva fino alle letterature contemporanee. Caratterizzato dalla breve estensione e dall'efficacia, soprattutto nella parte finale, l'epigramma accoglie svariati contenuti in toni seri o divertenti: dall'amore alla politica, dalla riflessione sul destino umano alla satira della società. Essere 'epigrammatico' significa ancora oggi distinguersi per brevità e arguzia
Breve e incisivo
Tra i generi letterari della poesia l'epigramma, insieme all'epica, è quello che può vantare la storia più lunga (quasi tremila anni!) e che ha avuto notevole fortuna in molte epoche. Come si spiega questa fortuna? Epigramma è innanzitutto un componimento breve e ben definito. Proprio perché il poeta ha a disposizione pochi versi, deve esprimere ciò che ha da dire in modo veloce e nitido, deve mirare, cioè, a colpire il lettore con poche frasi. L'estensione limitata e l'efficacia della comunicazione sono le due caratteristiche principali dei componimenti che chiamiamo epigrammi, in ogni epoca e in ogni cultura.
La brevità, come sua conseguenza, ha portato spesso gli autori di epigrammi, già nell'antichità, a concentrare il loro pensiero in modo sempre più asciutto, fino ad arrivare a vere e proprie sentenze lapidarie, argute e fulminanti. I Latini dicevano appunto che l'epigramma doveva avere "un fulmine alla fine". La sentenza finale, spesso, illumina il significato di tutto il componimento, rivelando il pensiero profondo dell'autore o mettendo a fuoco una situazione paradossale e inaspettata, sia comica sia tragica. L'ultimo o gli ultimi due versi di un epigramma, che in genere tende a non superare i sei versi, sono insomma la parte più incisiva e significativa del componimento, nonché la più curata dall'autore (figure retoriche, proverbi, giochi di parole o altro).
Tutti i colori della vita
Di che cosa si parla nell'epigramma? In altri generi letterari il contenuto è spesso già fissato dalla tradizione, quasi obbligato. L'epigramma, invece, proprio per la sua brevità, si è prestato nei secoli ad accogliere i contenuti più diversi, i temi più disparati. Vicende personali e riflessioni generali sull'uomo, amore e morte, momenti della vita quotidiana e argomenti politici o religiosi: di tutto si può parlare nell'epigramma. Come i contenuti, anche i toni sono vari: serio o comico, aggressivo o delicato, solenne o satirico. L'epigramma esprime, insomma, tutti i colori della vita umana.
Per le sue caratteristiche è il genere letterario più adatto a delineare in pochi tratti una situazione o una vicenda che susciti una riflessione, o a ritrarre un personaggio particolare.
Per la sua grande capacità di comunicazione l'epigramma invita spesso a una replica, suscita il desiderio della risposta. Così, nell'antichità come ai nostri tempi, i poeti hanno spesso dialogato tra loro attraverso epigrammi: quasi un botta e risposta sullo stesso tema in cui intervengono, a volte, anche più autori.
La lunga storia dell'epigramma
Quando nasce l'epigramma? Come per altri generi della letteratura occidentale, le radici vanno cercate nell'antica Grecia. Il termine, in greco, significa "ciò che è scritto sopra": con epigramma si indicano, infatti, originariamente, le parole incise sulla lapide di un defunto o su un oggetto o una tavoletta deposti in un santuario a ringraziamento degli dei. L'epigramma, dunque, nasce per scopi pratici e precisi, e nasce non per invenzione di un poeta, ma per opera di tantissimi anonimi compositori di versi. Ben presto, tuttavia, anche i poeti più famosi iniziano a scrivere epigrammi, prima per occasioni concrete come elogi di caduti in battaglie importanti o episodi di vita pubblica da ricordare alla comunità cittadina, poi anche su temi personali, d'amore o di costume: nasce così il genere letterario.
In Grecia
L'epigramma diviene un vero e proprio genere letterario durante l'età ellenistica (ellenismo) un periodo in cui il gusto dei poeti privilegia componimenti brevi ma efficaci sui temi della vita umana, piuttosto che lunghi poemi o opere teatrali di contenuto mitologico. Tutti gli autori scrivono epigrammi, e molti li raccolgono in libri a volte antologici, dove a un epigramma su un certo tema ne segue un altro, sullo stesso argomento, di un secondo autore, e poi un altro e un altro ancora. È come se ogni poeta entrasse in gara con chi lo ha preceduto, per mostrare le sue capacità sullo stesso tema trattato da altri.
I contenuti privilegiati sono l'amore e la riflessione sulla morte, la devozione religiosa e la descrizione della natura. Non mancano, però, altri motivi legati ancora a una funzione pratica dell'epigramma, come ci ha rivelato un antico libro recentemente scoperto: gli autori, anche importanti, scrivevano epigrammi per accompagnare i doni scambiati tra fidanzati o gli oroscopi richiesti agli indovini, per descrivere opere d'arte, per festeggiare una vittoria nelle gare sportive.
Come un tempo, poi, i poeti continuano a comporre iscrizioni in versi per defunti di ogni livello sociale, dal potente sovrano all'umile filatrice di lana, e persino per piccoli animali ai quali è dedicata una tomba. Notevole, infine, l'impiego dell'epigramma per argomenti di critica letteraria o di polemica tra poeti, nonché per la satira di filosofi o di particolari figure sociali come medici e indovini.
L'epigramma ellenistico greco conta numerosissimi autori. Callimaco è il principe dell'epigramma: con le sue riflessioni sempre distaccate e con il gusto di una leggera ironia affronta in toni sereni i temi dell'amore e della morte. Leonida di Taranto rappresenta il mondo degli umili con amare riflessioni, Teocrito di Siracusa le atmosfere spensierate della campagna e dei paesaggi solari.
Gli autori greci continuano a scrivere epigrammi per centinaia di anni, fino all'età cristiana e bizantina. Un importantissimo manoscritto medievale ci ha conservato ben migliaia di epigrammi, di moltissimi autori: è la cosiddetta Antologia palatina, modello di tutti i successivi epigrammisti.
A Roma
Anche nel mondo romano, da originaria iscrizione sepolcrale, l'epigramma diviene genere letterario molto apprezzato. Negli epigrammi di Catullo, eleganti e colti, il tema dominante è la burrascosa vicenda d'amore fra il poeta e la sua donna. Ma Catullo sa essere anche aggressivo e satirico: contro i potenti e i maleducati, contro chi non rispetta l'amicizia.
Il poeta che più di ogni altro ha lasciato il suo nome legato al genere epigrammatico è Marziale, originario della Spagna e vissuto nel 1° secolo d.C. Nei suoi quindici libri di epigrammi sono trattati i temi più disparati, con una onnipresente ironia, spesso dissacrante. Vizi e comportamenti umani, ma anche difetti fisici, diventano il bersaglio del poeta che, in pochi versi, di volta in volta, delinea una galleria impressionante di personaggi negativi della società romana del tempo: schiavi arricchiti e arroganti, medici ignoranti, maghi ciarlatani, prostitute volgari. Marziale mette in ridicolo tutti e porta alla perfezione formale quel meccanismo per cui è alla fine del componimento, spesso proprio nell'ultimo verso, che si colloca la battuta ironica e aggressiva, persino velenosa. Marziale, tuttavia, conosce anche toni malinconici: per esempio quando parla di sé stesso e della sua difficile condizione di vita.
L'epigramma moderno
Sull'onda di un ritrovato studio dell'antichità e del gusto classicista, l'epigramma viene riscoperto nel Rinascimento europeo. Prima in latino, poi nelle lingue nazionali, molti poeti rinnovano la tradizione dell'epigramma classico, adattandolo ai versi moderni. La brevità, l'incisività, il meccanismo dell'arguzia finale rimangono però fondamentali. Canonici sono ancora i temi e alcuni personaggi tipici presi di mira.
Nel Seicento barocco si predilige la ricerca di una battuta finale che stupisca e sorprenda il lettore. Nell'Ottocento si scrivono soprattutto epigrammi polemici e aggressivi. In Italia è l'età delle guerre d'indipendenza, e argomento primario divengono i temi politici: così per Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni e Giacomo Leopardi.
Famosi gli epigrammi rivolti contro il potere temporale dei papi, che anonimi patrioti affiggono a Roma di nascosto, sotto la statua del cosiddetto Pasquino (le 'pasquinate', di tradizione già cinquecentesca).
Nel Novecento l'epigramma è il principale strumento dei poeti per l'attacco personale a critici severi o ad altri poeti: Eugenio Montale è il più bersagliato, Giorgio Bassani il più graffiante, Pier Paolo Pasolini il più indignato.