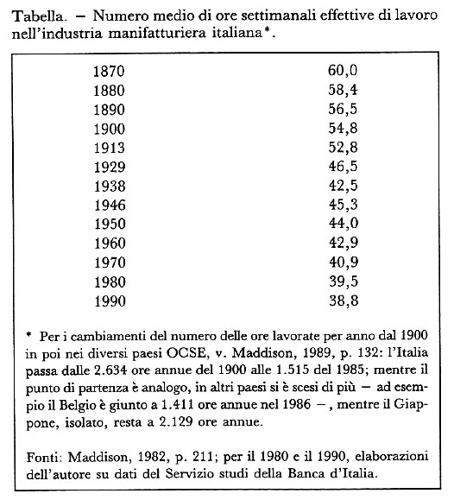Lavoro
LAVORO
Economia
di Alessandro Roncaglia
Introduzione
È necessario innanzitutto precisare che ci occuperemo del lavoro solo dal punto di vista della teoria economica. Si tratta di una semplificazione drastica, che comunque lascia un campo vastissimo di problemi e teorie da passare in rassegna. La considerazione dei problemi relativi al lavoro accompagna infatti il cammino della riflessione sui temi economici per secoli, fin dagli albori di quella che solo a partire da un'epoca relativamente recente (XVII secolo circa) può essere considerata fra le scienze sociali, l'economia politica. Né possiamo limitarci a considerare le teorie oggi prevalenti, sia perché spesso alcune tesi degli economisti del passato, pur cadute in un relativo oblio, sono di un'attualità e un'importanza sorprendenti, sia perché le teorie contemporanee incorporano concetti - a cominciare da quello stesso di lavoro - ricchi di contenuti acquisiti nel corso del tempo. Per vari aspetti, comunque, sarà possibile rinviare ad altri articoli che approfondiscono temi specifici o collaterali.
Il lavoro come sacrificio e come fonte di ricompensa
Il tema del lavoro come condanna - e come condanna che riguarda l'intero arco della vita terrena dell'uomo - è affiancato, nella tradizione biblica, dal tema del frutto del lavoro come ricompensa. Da un lato: "Il suolo sarà maledetto per causa tua; ne mangerai il frutto con affanno, tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli [...] mangerai il pane col sudore della tua fronte finché ritornerai alla terra da cui sei stato tratto; perché tu sei polvere e in polvere ritornerai" (Genesi, 3, 17-19). Dall'altro lato: "L'anima del pigro desidera e non ha nulla, ma l'anima dei diligenti sarà soddisfatta appieno" (Proverbi, 13, 4).
Questi due temi costituiscono, in un certo senso, lo sfondo di ogni riflessione economica, fino ai giorni nostri. Adam Smith (v., 1776) parla del lavoro come toil and trouble, fatica e fastidio; la tradizione marginalista, a partire da William Jevons (v., 1871), considera il lavoro come 'disutilità' che si contrappone all'utilità del prodotto. Quanto al tema della giustizia distributiva, secondo il quale ciascuno dovrebbe ricevere una quota del prodotto sociale proporzionale al suo contributo lavorativo, esso non solo accompagna il dibattito medievale sul 'giusto prezzo' (che corrisponde al costo di produzione, spesso ridotto al solo lavoro) e sull'usura (che è condannata proprio perché chi presta denaro non compie un'attività lavorativa), ma è percepibile anche dietro la teoria del valore-lavoro degli economisti classici, come dietro la teoria marginalista per la quale in concorrenza ognuno riceve un reddito proporzionale al proprio contributo al processo produttivo.Tuttavia le cose non sono così semplici. La condanna dell'umanità al lavoro e la giustizia distributiva non sono principî assoluti o, forse meglio, pur essendo tali in un certo ambito, coesistono con principî di segno opposto relativi all'organizzazione della società.
Per tutta la storia conosciuta, le élites sono sfuggite, in misura notevole se non del tutto, alla condanna al lavoro. Anzi, la libertà dalla schiavitù del lavoro era considerata elemento essenziale di superiorità rispetto alla gente comune. Questo atteggiamento è chiarissimo nell'ostilità verso qualsiasi attività economica, e in particolare verso il lavoro manuale, da parte dei nobili anche impoveriti nella fase di transizione verso il capitalismo.Solo agli occhi dei pensatori utopisti e rivoluzionari ("il mondo capovolto" di cui parla C. Hill: v., 1975) la divisione dell'umanità tra lavoratori e signori esenti dal lavoro va superata, perché il lavoro necessario per la sopravvivenza della società va diviso fra tutti. Questa, anzi, è la caratteristica comune di tutte le utopie socialiste degli ultimi secoli, da Thomas More (v., 1516) e Tommaso Campanella (v., 1602) a Lafargue (v., 1883), fino a Ernesto Rossi (v., 1946). Passando in rassegna le proposte di società ideali e i connessi movimenti riformatori, Spini (v., 1992) ne sottolinea i legami con i filoni più eretici del protestantesimo. In fondo, lo stesso protestantesimo si qualifica almeno originariamente come eretico, fra l'altro, proprio per l'attribuzione di un valore positivo al lavoro, in quanto l'elevazione sociale che esso consente su questa terra corrisponderebbe alla manifestazione della benevolenza divina. Com'è noto, Weber (v., 1904-1905) sostiene che questa convinzione ebbe importanza centrale per l'affermazione del capitalismo.Il significato attribuito al concetto di lavoro si interseca qui con il tema della divisione del lavoro: un altro tema ricorrente nella riflessione economica, che riguarda contemporaneamente l'assetto politico e la stratificazione sociale, il cambiamento tecnologico, lo sviluppo della produzione e la distribuzione del reddito. Su questi temi ci soffermeremo più avanti, dopo avere brevemente considerato l'organizzazione del lavoro nelle società precapitalistiche.
Il lavoro nelle società precapitalistiche
Nelle società schiavistiche dell'antica Grecia e dell'antica Roma, com'è noto, l'obbligo al lavoro riguardava la grande maggioranza della popolazione; inoltre, si trattava di una condanna a una vita non solo di fatiche, ma anche di stenti. Del prodotto sociale toccava agli schiavi e agli strati più bassi della popolazione solo quanto bastava per mantenerli in vita e in condizioni di continuare a lavorare; in caso di carestia, comunque, gli schiavi erano i primi a morire. Non che questo rendesse agiata, secondo gli standard moderni, la vita dei 'cittadini': quelli che, a leggere la letteratura dell'epoca, sembrano i soli sulla scena. Una stratificazione sociale rigida, generalmente basata sulle qualità mostrate in fanciullezza, è indicata come norma ottimale anche in opere quale la Repubblica di Platone.
Poco migliore di quella degli schiavi è la vita dei servi della gleba nelle società feudali del Medioevo. Legati alla terra per obbligo di nascita, sono se non altro liberi di organizzare il proprio lavoro - pur se, ancora una volta, la scarsa produttività dell'agricoltura e il peso dei tributi da corrispondere, a beneficio di nobiltà e clero, anche sotto forma di lavoro (le corvées), li costringono a una vita di stenti e di fatiche. Nella società feudale la vita economica è organizzata essenzialmente sulla base di relazioni ripetitive di tipo tradizionale, e solo limitatamente è centrata sul mercato (v. Kula, 1962). Il rapporto tra signori feudali e servi della gleba non corrisponde a quello tra proprietario terriero e bracciante agricolo: il signore feudale esercita contemporaneamente la sovranità politica e il controllo economico sulle terre del suo feudo; i servi della gleba, oltre a una parte del raccolto ottenuto sulle terre tradizionalmente affidate alla loro cura (le terre servili), debbono al padrone anche prestazioni lavorative sulle terre dominiche, il cui raccolto va interamente al signore. Le difficoltà dei trasporti ostacolano i commerci a lunga distanza di merci base; i commerci sono essenzialmente limitati a beni di lusso, come le spezie, i metalli preziosi, i merletti. Così il territorio è suddiviso in un gran numero di unità produttive abbastanza autosufficienti (il castello con le terre circostanti). Solo in minima parte i beni necessari alla sussistenza - alcuni tipi di cereali, tessuti, ecc. - sono oggetto di scambi contro denaro, in genere in mercati che si svolgono a intervalli regolari nei centri abitati principali, nei quali viene offerto il prodotto in sovrappiù rispetto al normale autoconsumo dei produttori. Anche l'attività lavorativa è prevalentemente regolata dalla tradizione: in una fase in cui la stragrande maggioranza della popolazione è dedita all'agricoltura, vengono comunemente scambiati contro denaro solo i servizi di un numero estremamente limitato di artigiani o professionisti.
Capitalismo e divisione del lavoro
Lo sviluppo graduale dei commerci e delle città dal Trecento al Cinque-Seicento avvia una trasformazione radicale della struttura sociale, sulle cui caratteristiche non ci soffermiamo (v. Cipolla, 1976). Quel che importa sottolineare qui è il cambiamento drastico che subisce l'attività lavorativa con lo sviluppo della divisione del lavoro non solo tra processi produttivi diversi, ma anche e soprattutto all'interno di ciascun processo produttivo.Come si è già accennato, il tema della divisione del lavoro è ricorrente negli scritti su questioni economiche fin dall'antichità. Tuttavia, la sua trattazione subisce modifiche importanti, come riflesso delle modifiche della divisione del lavoro nella realtà, negli scritti di autori come William Petty (1623-1687) o Adam Smith.Innanzitutto, gli scrittori dell'antichità classica sottolineano come effetto della divisione del lavoro il miglioramento qualitativo del prodotto: un aspetto evidente se, ad esempio, confrontiamo la qualità dei mobili o dei vestiti rozzamente prodotti per il proprio consumo dalla famiglia agricola a lato del proprio consueto lavoro, con i prodotti del sarto o del falegname che hanno imparato il mestiere in anni di apprendistato. Viceversa, Petty (v., 1899) - e, dopo di lui, tutti gli studiosi della divisione del lavoro manifatturiero, quando sorgono gli opifici e poi le fabbriche in cui viene sfruttata la forza meccanica della macchina a vapore - sottolineano l'aspetto quantitativo: l'effetto principale del progresso nella divisione del lavoro consiste nell'aumento della produttività, cioè della produzione media per lavoratore, e quindi nella riduzione dei costi medi unitari.In secondo luogo, la divisione del lavoro passa da oggetto di osservazioni casuali a elemento centrale della teorizzazione sul funzionamento dell'economia e più in generale della società umana.
Così Adam Smith (v., 1776) concentra l'attenzione su due fattori che determinano la ricchezza delle nazioni (sostanzialmente identificata con il reddito pro capite, cioè con il reddito nazionale di un paese diviso per il numero dei suoi abitanti): la produttività di ciascun lavoratore e la quota dei lavoratori produttivi sul totale della popolazione. Dietro il primo di questi fattori, l'elemento cruciale è costituito dalla divisione del lavoro, a sua volta legata all'allargamento dei mercati. Inoltre, per Smith, come più tardi per autori quali Marx (v., 1867-1894) e Weber (v., 1922), la divisione del lavoro è anello di congiunzione decisivo tra struttura economica e struttura sociale. Gli aspetti economici si collegano così a quelli politici, e financo ai principî morali.Soffermiamoci su quest'aspetto. Smith insiste sul fatto che la ripartizione dei lavoratori tra i vari tipi di lavoro non avviene in base a qualità originarie dei lavoratori stessi: è il mestiere che plasma, col tempo, la natura del lavoratore. La stratificazione sociale legata alla divisione del lavoro, perciò, non deriva da differenze innate di capacità: non può quindi essere considerata un fenomeno 'naturale'. Val la pena di sottolineare la differenza tra questa posizione e quella comune a un critico conservatore contemporaneo di Smith come Pownall (v., 1776) e alla teoria marginalista della distribuzione (e dei differenziali salariali), basata sulla dotazione originaria di risorse e capacità di ciascun individuo.Smith considera invece 'originaria' o 'naturale' la tendenza degli esseri umani a entrare in rapporto gli uni con gli altri, e quindi a costituire una società, al cui interno possono svilupparsi forme di cooperazione come quelle insite nella divisione del lavoro. La teoria economica, secondo Smith, ha per l'appunto il compito di studiare il funzionamento di una società basata sulla divisione del lavoro, e in cui quindi ciascun lavoratore collabora per ottenere un prodotto di cui può non avere direttamente bisogno, mentre deve procurarsi mezzi di produzione e di sussistenza da altri.Più in generale, Smith vede la divisione del lavoro come fonte di conseguenze positive e negative allo stesso tempo: positive, dal punto di vista della crescita della produttività e quindi del benessere economico generale; negative per il carattere limitante della divisione del lavoro, che condanna "la grande maggioranza della popolazione" a un'attività monotona di scarso interesse con il concreto rischio di un "abbrutimento". Secondo alcuni commentatori, Smith precorre l'idea marxiana dell'alienazione derivante dalla costrizione al lavoro diviso (in un'economia capitalistica, per il lavoratore sono 'altro da sé' sia il prodotto del suo lavoro sia i mezzi di produzione impiegati, entrambi di proprietà del capitalista, sia il processo produttivo, di cui a causa della divisione del lavoro controlla solo una parte: v. Marx, 1844). Tuttavia, a differenza di Smith, Marx ritiene possibile il superamento del lavoro costrittivo, al termine di un processo in cui lo sviluppo delle forze produttive porta al regno della libertà, dove "tutte le sorgenti delle ricchezze collettive scorrono in abbondanza" (v. Marx, 1875; tr. it., p. 39). Smith invece cerca di fare i conti con una realtà destinata a permanere ricca di luci e di ombre, proponendo di favorire la divisione del lavoro, in quanto decisiva per lo sviluppo economico, ma allo stesso tempo di combatterne gli effetti negativi (attraverso, fra l'altro, un intervento pubblico che garantisca a tutti l'istruzione di base).
Sul legame tra divisione del lavoro e sviluppo economico si soffermano vari economisti. Fra questi, Charles Babbage (v., 1832) pone in luce due aspetti. Da un lato egli illustra come la scomposizione di un'attività lavorativa complessa riduca i costi di produzione in quanto permette di utilizzare lavoratori meno qualificati, e quindi pagati meno (il cosiddetto primo principio di Babbage). Infatti è sufficiente che ciascun lavoratore sia dotato solo di una parte delle qualifiche necessarie a compiere l'intero complesso delle operazioni lavorative di un determinato ciclo produttivo. Dall'altro lato - il secondo principio di Babbage - egli sostiene che lo sviluppo della divisione del lavoro, portando a scomporre ogni operazione lavorativa nei suoi costituenti elementari, favorirebbe la sostituzione delle macchine agli uomini, riservando a essi le attività più nobili e complesse di organizzazione del processo produttivo e ricerca dello sviluppo tecnologico. Questi due aspetti compariranno in varie forme nel successivo dibattito fra la tesi - assai diffusa tra i marxisti - della tendenza a una proletarizzazione e depauperizzazione del lavoratore e la contrapposta tesi del crescente contenuto professionale delle attività lavorative. Su questi temi, comunque, torneremo più avanti.
Lavoro produttivo e improduttivo
Come abbiamo accennato sopra, accanto alla produttività del lavoro l'altro fattore della ricchezza delle nazioni identificato da Smith è costituito dalla quota dei lavoratori produttivi sul totale della popolazione. Per Smith era importante sottolineare la centralità di questo fattore: sia per ribadire il ruolo positivo del lavoro nella società (in contrapposizione, molto probabilmente, all'atteggiamento diffuso nei paesi cattolici dell'epoca di considerare il lavoro un marchio di inferiorità sociale), sia perché, almeno nella sua fase iniziale, il sistema capitalistico coesisteva con forti residui del sistema feudale - dalle corti ai monasteri - che a parere di Smith costituivano uno spreco di risorse e quindi un ostacolo allo sviluppo economico. Non si trattava di un tema nuovo, naturalmente: già molti scrittori utopisti (e alcuni non utopisti, come Petty) avevano ricordato il peso per la società costituito da quella parte della popolazione che non collabora alla produzione. Campanella ad esempio, scrivendo nel 1602 rileva che a Napoli lavoravano solo 50.000 persone su 300.000 abitanti.Lo stesso tema della distinzione tra lavoro produttivo e improduttivo era già stato dibattuto a lungo prima di Smith. In genere, è considerato produttivo il lavoro che contribuisce alla ricchezza sociale. Tuttavia, possiamo intendere questa in due accezioni (v. Perrotta, 1988): come insieme di valori d'uso e come valore di scambio, cioè come potere d'acquisto. Per i 'bullionisti' del Cinquecento, che identificavano nell'oro e nell'argento la ricchezza, è produttivo il lavoro che fa affluire metalli preziosi nel paese. Tra gli scrittori del Seicento - i cosiddetti mercantilisti - domina invece la prima accezione. In un autore come Petty abbiamo una gerarchia di attività produttive apparentemente collegata al contributo che ciascuna può fornire al processo di accumulazione, ovvero al grado di durevolezza del prodotto. Per i fisiocrati francesi, a metà del Settecento, è produttivo il solo settore agricolo, perché mette capo a un sovrappiù, mentre il settore manifatturiero è considerato sterile, in quanto il prodotto semplicemente incorpora il valore dei mezzi di produzione impiegati (compresi i mezzi di sussistenza dei lavoratori).
In Smith non abbiamo una definizione univoca: il lavoro produttivo è identificato con quello che mette capo a beni materiali, o con quello che dà luogo a un profitto, mentre i lavori improduttivi - che possono essere utili o inutili, ma Smith non approfondisce questa distinzione - abbracciano sostanzialmente il settore dei servizi. Possiamo forse interpretare la posizione di Smith come centrata sull'identificazione del lavoro produttivo con quello svolto all'interno del nucleo capitalistico dell'economia, all'epoca ancora minoritario ma già chiaramente base della forza economica del paese.In opposizione a Smith, e senza comprenderne le motivazioni di fondo, con Jean-Baptiste Say (v., 1803) si iniziò a considerare produttivo qualsiasi lavoro utile, anche se diretto a fornire servizi, cioè 'beni immateriali'. Questa impostazione è rimasta dominante anche con l'affermazione della teoria marginalista del valore, che fonda la determinazione del valore di scambio sul valore d'uso, cioè sull'utilità dei vari beni o servizi. Tuttavia, con la ripresa dell'impostazione degli economisti classici ad opera di Piero Sraffa (v., 1960), alcuni aspetti almeno della distinzione tra lavoro produttivo e improduttivo sono tornati ad attirare l'attenzione degli economisti. È ipotizzabile, in particolare, un collegamento tra questa distinzione e la maggiore o minore funzionalità allo sviluppo economico delle diverse attività lavorative.
La teoria classica del valore-lavoro e la teoria marginalista del lavoro come fattore di produzione
Con la divisione del lavoro tra unità produttive diverse (e, all'interno di ciascuna di queste, tra compiti diversi affidati ai vari lavoratori) sorge la necessità di una rete di scambi. Infatti, ogni unità produttiva ottiene un bene (o un gruppo di beni) specifico al termine del processo produttivo, mentre per produrre ha bisogno di altri beni come mezzi di produzione (materie prime, macchinari, semilavorati) e mezzi di sussistenza per i lavoratori impiegati nel processo produttivo. Come si è accennato, nel Medioevo l'economia era basata su una serie di unità locali in misura notevole autosufficienti. Gli scambi riguardavano principalmente i beni di lusso, e solo in misura marginale (rispetto alla dimensione dell'autoconsumo da parte degli stessi produttori) quelli necessari alla vita normale dei lavoratori agricoli, che costituivano la grande maggioranza della popolazione. Scambi di bestiame e di attrezzi agricoli, oltre che di prodotti dell'artigianato e di specifici prodotti agricoli, si verificavano in occasione delle fiere, raduni di breve durata di mercanti e acquirenti. I prezzi che si formavano nelle fiere (come i prezzi delle merci trasportate per nave nei porti di sbarco) dipendevano in modo cruciale dal rapporto occasionale, variabile nel tempo e da luogo a luogo, tra la quantità di merci offerta in vendita e il potere d'acquisto dei compratori.
In un certo senso, le teorie neoclassiche del prezzo basato sull'equilibrio tra domanda e offerta, corrispondono alla struttura economica tipica di una società feudale. Tuttavia tra gli scrittori dell'epoca non troviamo teorie di questo tipo, in quanto l'andamento degli scambi e dei prezzi non presenta quelle regolarità che sono il presupposto necessario perché sorga il problema di determinare i valori 'normali' delle variabili. Le riflessioni sui fenomeni economici riguardano piuttosto il problema del 'giusto prezzo', ovvero del comportamento che i mercanti dovevano tenere per non macchiarsi dei peccati di frode e violenza: un problema normativo, quindi, non interpretativo.Il 'giusto prezzo', in altri termini, era quel prezzo al quale era moralmente lecito per il mercante vendere le proprie merci. Alcuni commentatori dell'epoca identificano molto semplicemente tale prezzo con quello liberamente accettato dai partecipanti all'accordo di scambio. Altri, ritenendo mercanti e acquirenti non dotati di eguale potere contrattuale, propongono un prezzo tale da permettere il recupero dei costi di produzione. Altri ancora, semplificando questa tesi tramite una riduzione dei costi di produzione ai soli costi di lavoro, collegano i prezzi alla quantità relativa di lavoro necessaria alla produzione delle varie merci. Abbiamo così una rudimentale teoria del valore-lavoro, normativa più che descrittiva.
La teoria del valore-lavoro riaffiora in William Petty, come semplificazione di una teoria dei prezzi basata sull'elemento oggettivo della difficoltà di produzione piuttosto che su quello soggettivo delle preferenze di venditori e acquirenti (v. Roncaglia, 1977). Adam Smith limita l'applicazione della teoria del valore-lavoro contenuto (cioè direttamente o indirettamente necessario alla produzione di una merce) a uno stadio primitivo della società. In tale situazione, infatti, non si è ancora verificata la suddivisione in classi sociali tra proprietari terrieri, capitalisti (cioè proprietari dei mezzi di produzione) e lavoratori: ogni lavoratore produce da sé i suoi mezzi di produzione (l'arco per il cacciatore, l'amo e l'esca per il pescatore), mentre la popolazione è sufficientemente scarsa perché la terra su cui cacciare o pescare sia disponibile per tutti. Per le società sviluppate Smith propone una teoria del valore-lavoro comandato, secondo la quale il valore di ogni merce è misurato dalla quantità di lavoro che essa può acquistare (ed è quindi pari al prezzo della merce diviso per il salario). Questa teoria, ovviamente, presuppone che siano noti sia il prezzo della merce sia il salario, e non costituisce quindi un tentativo di spiegare il prezzo della merce stessa, ma semplicemente un tentativo di misurarlo.
L'utilizzo del lavoro in questo senso, come misura del valore dei beni, costituisce un criterio semplice e di significato intuitivo per confrontare il valore di una stessa merce in paesi o in tempi diversi: se ad esempio dico che una bicicletta vale venti ore di lavoro in Italia (cioè che per comprarla occorre venti volte il salario orario medio) mentre in Cina, o nell'Italia di un secolo fa, valeva duecento ore di lavoro, mi esprimo in termini sicuramente più significativi che se confrontassi grandezze eterogenee come lire di oggi con lire di ieri, o lire con moneta cinese. Il lavoro comandato, quindi, conserva tutt'oggi un ruolo nell'analisi comparata dei sistemi economici e negli studi dello sviluppo economico.
David Ricardo (v., 1817) e, sulla sua scia, Karl Marx (v., 1867-1894) ripropongono la teoria del valore-lavoro contenuto anche per le società capitalistiche: non solo come spiegazione - che essi stessi ammettono essere imperfetta - di come vengono determinati i prezzi relativi, ma anche, specie nel caso di Marx, come espressione del 'valore assoluto' delle merci (Marx parla del lavoro come della 'sostanza' del valore: v. Lippi, 1976). Sia le difficoltà analitiche incontrate dalla teoria del valore-lavoro, sia le implicazioni rivoluzionarie che ne avevano tratto Marx e, prima di lui, i socialisti ricardiani (come ad esempio Hodgskin: v., 1825), favoriscono comunque l'abbandono dell'impostazione degli economisti classici e l'affermazione della teoria del valore marginalista, basata sul confronto fra preferenze dei soggetti economici e dotazioni originarie di risorse.
Nell'ambito della teoria marginalista tradizionale del valore e della distribuzione, che a partire dalla fine dell'Ottocento e fino ai giorni nostri domina incontrastata nei manuali di economia, il lavoro è uno dei 'fattori di produzione'. Come per gli altri fattori di produzione - terra e capitale -, e come per ogni altro bene, il prezzo del lavoro corrisponde all'equilibrio tra quantità domandata e quantità offerta. La domanda di lavoro da parte delle imprese dipende dal contributo del lavoro al processo produttivo; in base al postulato della produttività marginale decrescente, l'utilizzo di dosi addizionali di lavoro assieme a una dotazione invariata di capitale e terra genera aumenti di prodotto man mano più piccoli. Poiché l'imprenditore in concorrenza è disposto a impiegare dosi aggiuntive di lavoro fin quando il costo - il salario - è inferiore al ricavo - il valore del prodotto addizionale -, la domanda di lavoro è funzione decrescente del salario reale. L'offerta di lavoro da parte del lavoratore, viceversa, è funzione crescente del salario reale: il lavoro è un sacrificio, e in base al principio della penosità marginale crescente ogni lavoratore percepisce come un sacrificio sempre più pesante ogni dose successiva di lavoro prestato, e richiede perciò un compenso crescente per fornire dosi man mano maggiori di lavoro.
(Sottolineiamo qui la differenza tra il concetto di produttività media, o produttività tout court, che è quella di cui parla Smith nello spiegare la ricchezza delle nazioni e sulla quale in genere concentrano l'attenzione gli economisti classici, e il concetto di produttività marginale, utilizzato dalla teoria marginalista. La produttività media ha un immediato riscontro empirico, corrispondendo al rapporto tra produzione complessiva e numero di lavoratori o ore di lavoro impiegate nella produzione; la produttività marginale, invece, indica le variazioni puramente virtuali di prodotto corrispondenti a variazioni ipotetiche di un fattore di produzione, ferme restando la tecnologia e le quantità utilizzate degli altri fattori di produzione. La produttività del lavoro, intesa come produttività media per ora lavorata, tende a crescere nel tempo in seguito al progresso tecnico che si traduce in nuove macchine, e quindi a un ritmo che dipende dall'ammontare degli investimenti, in particolare di quelli in macchinari, che sono stimolati da un aumento dei salari più rapido di quello delle macchine, ma anche in seguito a piccoli miglioramenti introdotti nel processo produttivo in base all'esperienza - il cosiddetto learning by doing).
Il mercato del lavoro
Il modello che abbiamo appena descritto - la teoria marginalista del lavoro come fattore di produzione - costituisce ovviamente solo una base semplificata sulla quale è possibile innestare l'esame di aspetti più specifici, tramite complicazioni successive.
In primo luogo, per quanto riguarda l'offerta di lavoro occorre ricordare l'influenza di fattori demografici e sociali. Tramite i tassi di natalità e mortalità, l'emigrazione e l'immigrazione, questi fattori determinano l'andamento della popolazione di un paese, e in particolare della popolazione in età lavorativa. Gli stessi limiti dell'età lavorativa dipendono da consuetudini sociali (come i tassi di scolarità), norme (come le leggi sul lavoro minorile), istituzioni (come il sistema pensionistico). Solo una parte della popolazione in età lavorativa, comunque, fa parte della popolazione attiva (persone che lavorano o che sono alla ricerca di un lavoro). Il cosiddetto tasso di attività (o tasso di partecipazione), cioè il rapporto tra popolazione attiva e popolazione complessiva, che nei paesi sviluppati è in genere compreso fra il 39 e il 45%, dipende anch'esso da fattori sociali ed economici. Per individuarli, conviene calcolare i tassi di attività specifici, per sesso e classi di età: ad esempio, per le donne comprese tra i 30 e i 39 anni, il rapporto tra occupate o in cerca di lavoro e totale delle donne in quella classe di età. Confrontando i tassi di attività specifici tra paesi diversi o, per uno stesso paese, tra periodi di tempo diversi, si scopre che proprio i tassi di attività femminile contribuiscono in misura determinante a spiegare le differenze nel tasso di attività generale. Queste differenze dipendono, ovviamente, da consuetudini sociali, in particolare relative alla posizione della donna nella società, ma anche da fattori economici quali l'andamento della domanda di lavoro e il tipo di lavoro offerto: quando la disoccupazione è elevata, molti potenziali lavoratori, e soprattutto molte potenziali lavoratrici, rinunciano ai tentativi di trovare lavoro ed escono dalla popolazione attiva. Se ricordiamo quanto diceva Smith a proposito della ricchezza delle nazioni, che dipende sia dalla produttività del lavoro sia dalla quota dei lavoratori produttivi sul totale della popolazione, possiamo comprendere l'importanza del tasso di attività e degli elementi che lo determinano per il tenore di vita di un paese.In secondo luogo, è chiaro che nel modello marginalista base illustrato sopra la disoccupazione risulta nulla se il libero gioco della domanda e dell'offerta è in grado di determinare un salario reale che le renda eguali. L'esistenza della disoccupazione come dato di fatto comune a tutte le economie capitalistiche richiede quindi spiegazioni specifiche (o critiche al modello teorico, come quelle di Keynes, che qui non possiamo considerare; per Keynes, l'occupazione dipende sostanzialmente dalla domanda di lavoro, e quindi dalle decisioni degli imprenditori su quanto e come produrre).
Le spiegazioni della disoccupazione nell'ambito della tradizione marginalista si richiamano, per un aspetto o per l'altro, alle deviazioni del mercato del lavoro dall'ideale della concorrenza perfetta. Ad esempio, il salario può risultare troppo elevato rispetto al livello di equilibrio che assicurerebbe la piena occupazione, a causa del potere contrattuale dei sindacati o a causa di limiti nell'informazione disponibile o di difficoltà nel controllare l'efficienza dei lavoratori. Ancora, le informazioni disponibili sul mercato del lavoro possono essere insufficienti e generare decisioni errate (ad esempio, nella scelta delle qualifiche: troppi laureati in lettere e troppo pochi ingegneri). Infine, l'aggiustamento ai cambiamenti che si verificano nella realtà (ad esempio, le migrazioni dalle aree e dai settori in declino a quelli in crescita) può risultare incompleto o troppo lento; è necessario tempo anche per la ricerca della prima occupazione o per la ricerca di un'occupazione migliore da parte di chi ha lasciato per insoddisfazione il suo posto di lavoro, e che per il momento risulta disoccupato. Istituzioni quali gli uffici di collocamento o le agenzie del lavoro hanno un ruolo importante nel far fronte ad alcuni di questi problemi, che hanno comunque un loro peso anche nell'opinione di quanti non accettano la teoria marginalista. La segmentazione del mercato del lavoro in mercati specifici - differenziati per territorio, per settori di attività e soprattutto per qualifiche - è l'estensione più ovvia e immediata della teoria di base. I differenziali salariali - territoriali, settoriali e di qualifica - vengono comunque a dipendere dal gioco della domanda e dell'offerta su ciascun mercato specifico. In particolare, i differenziali per qualifica debbono compensare le spese sostenute dal lavoratore qualificato per l'investimento addizionale in costi di formazione rispetto al lavoratore comune (v. Blaug, 1972). Lungo queste linee può essere analizzata anche la distinzione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo: nel secondo caso, oltre a un differenziale retributivo corrispondente alle eventuali differenze di qualifica, il reddito incorporerà anche la retribuzione del capitale utilizzato e del rischio. Quest'ultimo elemento - gli investimenti in 'capitale umano', cioè le spese sostenute sia dallo Stato sia dal singolo perché il lavoratore acquisisca una maggiore capacità professionale e quindi migliori prospettive di guadagno - ha assunto notevole rilievo nella moderna teoria dello sviluppo economico. Infatti la maggiore qualificazione della forza lavoro viene comunemente valutata come uno dei principali fattori di sviluppo economico oltre che come uno dei principali fattori di competitività internazionale (v., ad esempio, Reich, 1991).
La considerazione delle differenze di qualifica tra lavoratori porta a rappresentare la classe lavoratrice come un insieme non omogeneo al suo interno. La semplice dicotomia tra lavoro comune e lavoro qualificato o tra lavoro semplice e lavoro complesso (dove l'accento viene posto nel primo caso sulla formazione e la capacità professionale del lavoratore, e nel secondo caso sulle caratteristiche di maggiore o minore complessità del processo lavorativo) viene sostituita da un'articolazione in ceti, prestando attenzione anche a elementi quali differenze di posizione sociale (potere e prestigio oltre che reddito). Si riconosce così che i differenziali salariali non rispondono a puri criteri di mercato ma incorporano un importante elemento di tradizione sociale.
Per analogia possiamo ricordare qui anche i differenziali salariali per sesso: le differenze tra uomini e donne, che si sono ridotte nel tempo ma sono tutt'altro che scomparse, riguardano sia i livelli retributivi per eguali qualifiche e grado, sia la difficoltà di fare carriera a parità di livello d'istruzione. In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, sono rilevanti e oggetto di un'ampia messe di studi anche i differenziali retributivi etnici.Ricordiamo infine che mentre in vari paesi arretrati è importante la piccola proprietà contadina, nei paesi capitalistici avanzati è tutt'altro che trascurabile la quota dei lavoratori autonomi nella popolazione attiva (piccoli commercianti, artigiani, liberi professionisti). Di fronte a questa molteplicità di elementi di differenziazione tra lavoratori, anche le moderne analisi della struttura sociale considerano generalmente inappropriata la visione dicotomica della società (proletari e capitalisti) tipica della tradizione marxista più ortodossa. Poiché le differenze di collocazione nel mondo del lavoro - come nel caso della distinzione tra lavoratori dipendenti e autonomi - influiscono sulla 'visione del mondo' e quindi sull'orientamento politico, pur non determinandolo in modo rigido, la stratificazione per ceti sociali e la sua evoluzione nel corso del tempo costituiscono fattori essenziali nello studio delle vicende politiche (v. Sylos Labini, 1974).
Settori economici e orari di lavoro nello sviluppo del capitalismo
Solo quando si considera il mondo del lavoro nella sua articolazione diviene possibile cogliere l'enorme ampiezza dei cambiamenti intervenuti in esso nel corso degli ultimi decenni, e delle differenze tuttora esistenti tra paesi diversi.Se consideriamo le cose secondo una prospettiva di più lungo periodo, i cambiamenti sono tali da implicare una modifica delle stesse categorie utilizzate per l'analisi. All'inizio del Settecento, le statistiche elaborate dagli aritmetici politici (Gregory King, Charles Davenant) classificavano reddito e lavoratori non in base al settore di attività ma in base a ripartizioni territoriali: una visione che riflette la frammentazione dell'economia nazionale in unità locali non necessariamente autosufficienti ma assai meno legate fra loro di quanto avvenga oggi. Solo in seguito si afferma la suddivisione per settori economici. Anche in questo caso, però, le categorie comunemente utilizzate nel recente passato - agricoltura, industria, servizi - tendono oggi a essere sostituite da nuove categorie, con la distinzione tra servizi destinati e non destinati al mercato (o tra servizi pubblici e privati), mentre sempre meno peso viene attribuito alla distinzione tra agricoltura e industria.La ragione di queste tendenze recenti può essere compresa se guardiamo alle modifiche intervenute negli ultimi decenni nelle quote dei lavoratori impiegate rispettivamente nell'agricoltura, nell'industria e nei servizi. Quella che Colin Clark (v., 1951²) ha battezzato, alquanto impropriamente, 'legge di Petty', prevede che nel tempo la quota del lavoro occupata nell'agricoltura tenda a diminuire, e che crescano quelle occupate nell'industria e nei servizi. Se consideriamo i dati più recenti, vediamo che nei paesi più sviluppati il peso degli occupati in agricoltura è ormai drasticamente ridotto, mentre la quota degli occupati nell'industria, dopo essere cresciuta per vari decenni fino a raggiungere quasi il 50% dei lavoratori, ha iniziato a ridimensionarsi a vantaggio della quota degli occupati nei servizi, pubblici e privati, che in molti paesi cosiddetti 'postindustriali' ha ormai superato il 60%.
Lo stesso fenomeno può essere colto da un altro punto di vista, confrontando la struttura dell'occupazione in paesi a livelli diversi di sviluppo. L'agricoltura ha un ruolo ancora dominante nei paesi a più basso reddito, mentre nei cosiddetti paesi di nuova industrializzazione diminuisce la quota degli occupati in agricoltura e aumenta quella degli occupati nei servizi e soprattutto nell'industria; quest'ultima quota è superiore a quella che riscontriamo nei paesi postindustriali, dove è nettamente dominante l'occupazione nei servizi. Rispetto al profilo dell'evoluzione storica, il confronto tra paesi a diversi livelli di sviluppo mostra oggi una quota relativamente maggiore di occupati nei servizi - specie nei servizi pubblici - nei paesi a basso e medio reddito.
Per quanto riguarda le prospettive per il futuro, non sembra opportuno ricorrere a estrapolazioni delle tendenze più recenti, come fanno molti 'futurologi' che prevedono una continua crescita del settore dei servizi. Questa è dipesa, nella fase più recente, da tre circostanze che non è detto persistano in futuro. Il primo elemento è costituito dalla crescente quota di domanda dei consumatori finali rivolta ai servizi - in particolare per il tempo libero, per l'istruzione, per cure mediche - , considerati 'beni superiori', cioè beni non di prima necessità, la cui domanda cresce d'importanza al crescere del reddito. In secondo luogo abbiamo l''esternalizzazione' di molti servizi per la produzione, cioè il ricorso da parte delle imprese a fornitori esterni per servizi legali, di contabilità, di ricerche di mercato e simili, in precedenza svolti all'interno delle stesse imprese manifatturiere. In terzo luogo ricordiamo la minore crescita della produttività nel settore dei servizi rispetto a quella verificatasi nell'agricoltura e nell'industria manifatturiera.
È plausibile che il primo dei tre elementi appena indicati persista almeno nel futuro prossimo. Anche per il secondo elemento è possibile che non sia stata ancora raggiunta la soglia di saturazione, di fronte alle crescenti esigenze di flessibilità delle imprese. Per il terzo elemento, tuttavia, le cose potrebbero cambiare notevolmente, se l'impatto della microelettronica riguarderà il settore dei servizi più che gli altri settori. Inoltre, l'espansione del settore pubblico collegata alla crescita dei servizi destinati al mercato sembra aver raggiunto un limite difficilmente valicabile in vari paesi a causa delle reazioni sempre più vive a un'elevata pressione fiscale. Un rallentamento della crescita dei servizi (in Italia nel 1994 per la prima volta questo settore ha conosciuto un calo in assoluto nel numero degli occupati) può dar luogo non semplicemente a nuove tendenze nella struttura settoriale dell'occupazione, ma a un crescente problema di disoccupazione tecnologica. Di fronte a questo problema, uno degli sbocchi più frequentemente proposti richiama una delle principali tendenze di lungo e lunghissimo periodo che caratterizzano il mondo del lavoro, quella alla riduzione degli orari di lavoro (giornalieri, settimanali, annui e riferiti all'intero arco di vita attiva del lavoratore: v. tabella).
Occorre sottolineare, comunque, che la tendenza di lungo periodo a una riduzione delle ore lavorate si afferma su una base di oscillazioni collegate all'andamento della congiuntura economica. In particolare, gli orari lavorativi di fatto seguono un andamento grosso modo prociclico (cioè crescono nelle fasi di espansione dell'economia e diminuiscono nelle fasi di rallentamento congiunturale), mentre gli orari contrattuali si mostrano sensibili soprattutto ai problemi di competitività internazionale dei singoli paesi. Infatti un paese non può perseguire isolatamente una politica di riduzione degli orari di lavoro senza correre il rischio di peggiorare la propria competitività internazionale, e quindi di aggravare anziché ridurre la propria disoccupazione. A parità di lavoratori occupati, l'aumento della produttività oraria si deve tradurre in maggiore produzione o in minori orari di lavoro. Nel corso dell'ultimo secolo, la riduzione degli orari di lavoro ha assorbito una quota degli aumenti di produttività oraria pari grosso modo a un terzo, mentre due terzi si sono tradotti in aumento della produzione pro capite.
Di fronte a questa situazione, i sostenitori di una società più attenta alla salvaguardia dell'ambiente, e quindi meno orientata verso la produzione materiale, ritengono che sarebbe necessario uno sforzo coordinato per modificare quelle proporzioni, perseguendo una drastica riduzione del tempo dedicato al lavoro a favore di quello dedicato alla cultura e ad attività libere. In questo senso, le più recenti tendenze dell'ecologismo più radicale si ricollegano a quei filoni del socialismo utopistico, ai quali si è accennato sopra, che auspicano riforme della società dirette ad assicurare una radicale riduzione del lavoro complessivo richiesto per il funzionamento della società accompagnata da una sua più equa riallocazione. Quest'ultimo problema concerne in particolare i lavori meno gradevoli, ma pur sempre necessari; per quanto riguarda quei servizi personali la cui prestazione può avere valore in sé - ad esempio, l'assistenza agli anziani e ai malati - è possibile favorire il ricorso al volontariato; per altre attività lavorative che non hanno questo tipo di gratificazione - ad esempio, la raccolta delle immondizie - è stato proposto il ricorso a un 'esercito del lavoro', in modo che ogni cittadino dedichi una parte limitata della sua vita a prestazioni di questo tipo, senza che nessuno sia condannato a esse per tutta la durata della propria vita attiva; questa proposta dunque ha finalità diverse da quella, analoga ma diretta principalmente a combattere la disoccupazione, di affidare a disoccupati, per periodi di tempo limitati, l'esecuzione di lavori socialmente utili in cambio di un salario minimo.
Evoluzione della struttura economica e della stratificazione sociale: verso il superamento del lavoro costrittivo?
L'immagine del lavoro ereditata dai testi ottocenteschi o della prima metà di questo secolo (e da film come Tempi moderni di Chaplin) e collegata all'immagine dell'operaio comune utilizzato alla catena di montaggio appare non totalmente superata - specie se guardiamo ai paesi in via di sviluppo, nei quali vengono decentrate le attività produttive a minore contenuto professionale - ma poco adeguata a cogliere le tendenze in atto nella fase più recente, specie nei paesi postindustriali. In questa fase ha ripreso vigore la crescita delle piccole e medie imprese, dotate di una maggiore flessibilità, spesso organizzate in 'distretti industriali'; in parallelo, si è avuto uno spostamento d'importanza dalle tecnologie basate sulla divisione scientifica del lavoro (Taylor) e sulle catene di montaggio a tecnologie più flessibili permesse dallo sviluppo della microelettronica e basate sulle macchine a controllo numerico. Inoltre, l'alternanza tra il primo e il secondo principio di Babbage - un frazionamento delle attività lavorative diretto a ridurne il contenuto di professionalità e quindi a ridurre il costo del lavoro, e la sostituzione con macchine delle attività più semplici - genera sia una tendenza di lungo periodo all'arricchimento delle capacità professionali (e soprattutto dell'istruzione di base) richieste ai lavoratori, sia una crescente varietà di mestieri e professioni. Se a questa tendenza si unisce quella alla diffusione dell'azionariato popolare (in vari paesi, in particolare negli Stati Uniti e in Germania, tramite un ruolo centrale dei fondi pensionistici), possiamo cogliere una situazione in cui la dicotomia di classe tra lavoratori e capitalisti perde importanza rispetto alla stratificazione per ceti sociali. In questa stessa direzione potrebbe operare una maggiore diffusione del cooperativismo nella produzione, già proposta nell'Ottocento da un filone del 'socialismo ricardiano' (Robert Owen, William Thompson) e da John Stuart Mill, le cui idee furono praticamente sommerse dall'ostilità delle ideologie marxiste e comuniste, che privilegiavano invece la proprietà pubblica dei mezzi di produzione. Fra l'altro, la diffusione del cooperativismo potrebbe essere favorita dal crescente contenuto professionale delle attività lavorative e quindi dalle crescenti difficoltà di controllare l'adeguatezza delle prestazioni dei lavoratori dipendenti.Il progresso tecnico apre dunque spazi notevoli: riduzione degli orari di lavoro, arricchimento professionale di molte attività lavorative, miglioramenti nell'ambiente di lavoro.
Allo stesso tempo pone problemi difficili: disoccupazione tecnologica, differenziazioni sociali, effetti sull'ambiente. In questo contesto, l'analisi delle tendenze in atto nel mondo del lavoro non può essere disgiunta dallo studio di proposte d'intervento. Fra queste, quelle forse più interessanti, non solo in via diretta ma anche per cogliere meglio le potenzialità della situazione in cui viviamo, sono le più radicali e solo apparentemente più utopistiche. Infatti, può apparire decisamente irrealistica la prospettiva suggerita da Marx di una liberazione completa dal lavoro costrittivo; ma assai meno irrealizzabili, almeno in linea di principio, appaiono le proposte di inserire sulla tendenza secolare alla riduzione del tempo dedicato al lavoro nell'arco della vita umana riforme anche radicali - come la promozione di lavori non produttivi di merci o servizi vendibili ma socialmente utili o l'istituzione di un 'esercito del lavoro' sulle linee sopra indicate - per ripartire in modo più equo sull'intera popolazione il carico ineliminabile del lavoro costrittivo e ridurre il peso delle differenziazioni sociali. Come si vede, comunque, il tema del lavoro è indissolubilmente legato a quello degli assetti della società: le trasformazioni in corso nel campo del lavoro, ricordate sopra, non potranno non avere effetti profondi sull'organizzazione delle società umane e sulla nostra vita. (V. anche Capitalismo; Disoccupazione; Divisione del lavoro; Economia; Economia e politica del lavoro; Macchine; Occupazione; Salari e stipendi; Tecnica e tecnologia; Valore, teorie del).
Bibliografia
Babbage, C., On the economy of machinery and manufacturing (1832), New York 1963.
Blaug, M., An introduction to the economics of education, Harmondsworth 1972.
Campanella, T., La città del Sole (1602), Milano 1963.
Cipolla, C.M., Before the industrial revolution, London 1976.
Clark, C., The conditions of economic progress, London 1940, 1951².
Hill, C., The world turned upside down, Harmondsworth 1975 (tr. it.: Il mondo alla rovescia. Idee e movimenti rivoluzionari nell'Inghilterra del '600, Torino 1981).
Hodgskin, T., Labour defended against the claims of capital; or, the unproductiveness of capital proved with reference to the present combinations amongst journeymen, by a labourer, London 1825 (tr. it.: Difesa del lavoro contro le pretese del capitale ovvero dimostrazione dell'improduttività del capitale, in Socialisti ricardiani, a cura di A. Ginzburg, Milano 1976, pp. 91-133).
Jevons, W.S., The theory of political economy, London 1871 (tr. it.: La teoria dell'economia politica, Torino 1947).
Kranzberg, M., Gies, J., By the sweat of thy brow, New York 1975 (tr. it.: Breve storia del lavoro, Milano 1976).
Kula, W., Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, Warszawa 1962 (tr. it.: Teoria economica del sistema feudale, Torino 1970).
Lafargue, P., Droit à la paresse, Paris 1883 (tr. it.: Il diritto all'ozio, Milano 1971).
Lippi, M., Marx. Il valore come costo sociale reale, Milano 1976.
Maddison, A., Phases of capitalist development, Oxford 1982 (tr. it.: Le fasi di sviluppo del capitalismo, Milano 1987).
Maddison, A., The world economy in the 20th century, Paris 1989.
Marx, K., Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844 (1844), in Historisch-Kritische Gesamtausgabe, serie I, vol. III, Berlin 1932 (tr. it.: Manoscritti economico-filosofici del 1844, Torino 1975).
Marx, K., Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, 3 voll., Hamburg 1867-1894 (tr. it.: Il capitale. Critica dell'economia politica, 3 voll., Roma 1970).
Marx, K., Kritik des Gothaer Programms (1875), in "Die neue Zeit", 1890-1891, IX, n. 18 (tr. it.: Critica al programma di Gotha, Roma 1968).
More, T., Utopia, Lovanio 1516 (tr. it.: Utopia, a cura di L. Firpo, Torino 1971).
Perrotta, C., Produzione e lavoro produttivo nel mercantilismo e nell'illuminismo, Galatina 1988.
Petty, W., Economic writings (1899) (a cura di C. Hull), 2 voll., New York 1964.
Pownall, T., A letter from Governor Pownall to Adam Smith, L.L.D. F.R.S., being an examination of several points of doctrine, laid down in his 'Inquiry in to the nature and causes of the wealth of nations' (1776), in A. Smith, Correspondence (a cura di E.C. Mossner e I.S. Ross), Oxford 1977, pp. 337-376.
Reich, R., The work of nations, New York 1991 (tr. it.: L'economia delle nazioni, Milano 1993).
Ricardo, D., On the principles of political economy and taxation (1817), in The works and correspondence of David Ricardo (ed. critica a cura di P. Sraffa e M. Dobb), vol. I, Cambridge 1951 (tr. it.: Sui principî dell'economia politica e della tassazione, Milano 1976).
Roncaglia, A., Petty. La nascita dell'economia politica, Milano 1977.
Rossi, E., Abolire la miseria (1946), Roma-Bari 1977.
Say, J.-B., Traité d'économie politique, 2 voll., Paris 1803 (tr. it.: Trattato d'economia politica, Torino 1854).
Smith, A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776), in The works and correspondence of Adam Smith (ed. critica a cura di R.H. Campbell, A.S. Skinner e W.B. Todd), vol. II, Oxford 1976 (tr. it.: Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni, Milano 1973).
Spini, G., Le origini del socialismo, Torino 1992.
Sraffa, P., Production of commodities by means of commodities, Cambridge 1960 (tr. it.: Produzione di merci a mezzo di merci, Torino 1960).
Sylos Labini, P., Saggio sulle classi sociali, Roma-Bari 1974.
Weber, M., Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904-1905), in Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, vol. I, Tübingen 1920 (tr. it.: L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, in Sociologia della religione, a cura di P. Rossi, vol. I, Milano 1982, pp. 17-194).
Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922 (tr. it.: Economia e società, 2 voll., Milano 1961, 1974³).
Sociologia
di Marino Regini
1. Introduzione
Il lavoro è un'attività sociale complessa, a cui gli studiosi di scienze sociali hanno guardato in modi differenti e con differenti interessi, a seconda delle preoccupazioni che prevalevano nei diversi periodi storici. Negli ultimi vent'anni, ad esempio, vi è stato uno spostamento significativo dell'attenzione dai problemi della qualità a quelli della quantità di lavoro. Se fra gli anni cinquanta e settanta la preoccupazione dominante era infatti quella della 'umanizzazione' del lavoro - una preoccupazione giustificata dai metodi di lavorazione prevalenti e da una visione pessimistica degli effetti del progresso tecnico - negli anni ottanta, entrato in crisi il modello del Welfare State keynesiano che garantiva pieno impiego e sicurezza sociale, l'attenzione si è spostata verso i problemi della disoccupazione e delle conseguenti opportunità di redistribuire il lavoro, di accorciarne i tempi, e così via.
Ma ciò non significa che la riflessione sulla natura e sul futuro del lavoro sia diventata obsoleta. Anzi, proprio il dibattito su occupazione e disoccupazione ha indotto a riprendere quella riflessione, che ha toccato tre aspetti principali. Il primo, solo apparentemente definitorio, riguarda la stessa nozione di lavoro e ciò che essa ricomprende. Lavoro è sinonimo di occupazione, o è una categoria in cui rientrano anche altri tipi di rapporto sociale (v. Pahl, 1988)? È facile, ma tutto sommato poco significativo, osservare che, in realtà, anche quelli che vengono definiti come disoccupati e inoccupati spesso lavorano nell'economia nascosta e in quella irregolare. Più importante è notare che, se si adotta una definizione di lavoro, in contrapposizione a quella di tempo libero, troppo ricalcata su quella di occupazione - cioè come 'qualcosa che dobbiamo fare, che preferiremmo non fare, e per cui veniamo pagati' (v. Grint, 1991, p. 11) - si rischia di non considerare come attività lavorativa né il lavoro domestico né le molte forme di lavoro volontario. Decidere che cosa è lavoro e che cosa non lo è dipende insomma dalla definizione sociale, storicamente variabile, delle diverse attività umane; e in particolare dipende dal grado di egemonia che alcune forme di lavoro esercitano nei diversi periodi storici.
Il secondo aspetto della riflessione sul lavoro riguarda la sua natura, e quindi la valutazione sociale che di esso viene data. Partendo ancora una volta dai problemi della disoccupazione, si può notare che il lavoro che si cerca o che viene a mancare ha al tempo stesso la natura di labor - che nel significato latino comprende le nozioni di fatica, pena, sacrificio - e di opera, cioè di attività che strutturano la vita e che forniscono identità sociale (v. Touraine, 1986, p. 195). I due aspetti sono presenti in misura variabile nei diversi tipi di lavoro, che tuttavia ha sempre, inevitabilmente, una natura ambigua e contraddittoria. Da un lato è il simbolo della punizione per il peccato originale e della costrizione presente nella condizione umana: 'si lavora perché si deve'. In quanto tale implica non solo fatica e sacrificio, ma per lo più anche subordinazione ed eteronomia. Dall'altro, è un mezzo con cui l'individuo può dimostrare a se stesso e agli altri quanto vale: 'si lavora per affermare le proprie capacità'. Dunque il lavoro è uno strumento non solo di reddito, ma anche di status, di autorealizzazione, di identità sociale; tanto che "chi non ha un lavoro, molto spesso trae la propria autoconsiderazione o il prestigio sociale da altri a lui prossimi, come i genitori, il coniuge, i quali hanno un'occupazione" (v. Dahrendorf, 1988, p. 114). L'enfasi posta dagli scienziati sociali sull'uno o sull'altro di questi caratteri del lavoro dipende, come vedremo, non solo da convinzioni metascientifiche, ma anche dalla diversa lettura dei processi di mutamento che lo hanno interessato. Le trasformazioni del lavoro hanno per effetto di potenziare il primo o il secondo di questi caratteri contraddittori? E l'idea di una nuova società deve contenere in sé quella di una liberazione dal lavoro - attraverso una drastica riduzione dell'orario e un'ampia ripartizione sociale delle attività faticose e alienanti in nessun modo eliminabili - o di una liberazione nel lavoro, valorizzando cioè sempre di più le componenti di autonomia, responsabilità e autorealizzazione che dipendono dal modo di disegnare i lavori (v. Gorz, 1988)?
Infine, il terzo aspetto della riflessione riguarda il futuro del lavoro e della sua centralità sociale nei paesi industriali avanzati. La contrazione dell'occupazione dipendente e la riduzione dell'attività lavorativa stabile nell'esperienza di vita degli individui hanno l'effetto di ridimensionare la centralità sociale del lavoro, e addirittura portano alla 'fine della società del lavoro' (v. Dahrendorf, 1980; v. Offe, 1983), o implicano semplicemente una maggiore diversificazione delle esperienze lavorative, cioè il passaggio 'dal mondo del lavoro a quello dei lavori' (v. Accornero, 1992)?
La riflessione su questi diversi aspetti del lavoro ha posto fine a una lunga e curiosa disattenzione della teoria sociale e politica contemporanea nei confronti di questo fenomeno centrale della vita umana (v. Gallino, 1988, p. 138). Se nell'International encyclopaedia of social sciences addirittura non si trova una voce Work (ma solo quelle affini di Workers, Labor force e Occupations and careers), il dibattito fra gli studiosi di scienze sociali si è invece acceso più di recente sui temi sopra indicati inerenti ai confini, alla natura, e al futuro del lavoro.L'emergere di questo dibattito è rivelatore di profondi mutamenti avvenuti nella forma 'tipica' del lavoro come lo abbiamo conosciuto in questo secolo, cioè il lavoro dipendente (o lavoro salariato) e gerarchicamente subordinato, svolto normalmente a tempo pieno all'interno di un'organizzazione. È la contrazione e al tempo stesso la trasformazione di questo tipo storicamente determinato di lavoro che legittima gli interrogativi più astratti su che cosa rientri nella definizione di lavoro e su quali siano le tendenze prevedibili.Nei prossimi paragrafi, dunque, dovremo analizzare brevemente le caratteristiche del lavoro dipendente (v. § 1a) e gerarchicamente subordinato (v. § 1b), per poi valutare la portata dei suoi mutamenti e delle possibili alternative (v. § 1c). Questi temi verranno poi ripresi per esteso nei capitoli successivi.
Lavoro dipendente e non
L'occupazione alle dipendenze, o lavoro salariato, non è che una delle forme possibili di lavoro, anche se è quella che ha dominato la vita economica e il pensiero sociale dopo l'affermazione del capitalismo. Il concetto del posto di lavoro fisso come fonte pressoché esclusiva del reddito personale è emerso per la prima volta nell'Ottocento. Benché un mercato del lavoro sia esistito in molti paesi europei per diversi secoli, infatti, un'occupazione regolare a tempo pieno non era la norma, e il reddito ricavato dal lavoro salariato costituiva solo una componente non essenziale al mantenimento dell'individuo e della famiglia (v. Pahl, 1988, p. 12). Nonostante la specificità storica della nozione di occupazione dipendente e il periodo relativamente breve in cui si è affermata, ben presto essa viene a coincidere, nell'analisi sociale non meno che nel senso comune, con quella di lavoro tout court. Il manuale americano più usato negli anni cinquanta, ad esempio, definisce il lavoro come "occupazione permanente nella produzione di beni e servizi in cambio di una retribuzione" (v. Dubin, 1958).
È difficile sostenere che questa forma di lavoro non conservi anche oggi la sua centralità; essa ha tuttavia subito trasformazioni rilevanti, e soprattutto una notevole contrazione. L'aumento della disoccupazione cui si è accennato sopra non ne è che una delle cause. Le altre vanno ricercate nell'estensione e nel prolungamento del sistema di istruzione e di quello pensionistico, che hanno sottratto al mercato del lavoro quote crescenti di popolazione in età giovanile e in età anziana, nonché nella generalizzata riduzione dell'orario di lavoro.In diversi paesi, a questa contrazione del lavoro dipendente ha fatto invece riscontro una crescita del lavoro professionale e autonomo (artigiani, commercianti, lavoratori free-lance). E, soprattutto, non vi sono segnali che sia in calo il lavoro domestico, svolto in modo preponderante dalle donne, benché in molti paesi l'organizzazione familiare del lavoro abbia subito mutamenti rilevanti.
Il lavoro gerarchicamente subordinato
Anche la forma di lavoro gerarchicamente subordinato e svolto all'interno di un'organizzazione, che implica la disponibilità temporale piena del lavoratore a prestazioni standardizzate piuttosto che l'offerta di una prestazione specifica, è una costruzione sociale relativamente recente, esito di un duplice processo (v. Chiesi, 1990).Il processo più noto e ampiamente richiamato è quello che, nel corso di questo secolo, ha portato alla costituzione della grande impresa - un'impresa che produce in grande serie beni standard, mediante l'uso di macchine e di una forza lavoro che svolge compiti routinizzati. L'esigenza fondamentale che si poneva rispetto a quest'ultima era quella del controllo e della standardizzazione della prestazione, e a tale esigenza hanno a lungo risposto l'innovazione tecnologica nella fabbrica e negli uffici, e i metodi di organizzazione del lavoro, o 'concetti di produzione' prevalenti (v. Kern e Schumann, 1984).
Nei paesi industriali avanzati, un secondo processo si è poi affiancato al primo nel sancire la centralità del lavoro gerarchicamente subordinato e nell'assicurare il conseguimento di una standardizzazione, uniformità e 'rigidità' della prestazione lavorativa. Si tratta del costituirsi di sistemi di relazioni industriali volti alla tutela contrattuale di un tale rapporto di lavoro, e quindi alla sua stabilizzazione. Se l'organizzazione della grande fabbrica o dell'ufficio tradizionale era di fatto un sistema di regole relativamente uniformi, i sistemi di relazioni industriali che le corrispondevano consistevano in pratica nella contrattazione di queste regole secondo criteri altrettanto uniformi e standardizzati (v. Regini, 1991, pp. 149-150).Anche il lavoro gerarchicamente subordinato e svolto a tempo pieno in un'organizzazione, tuttavia, ha subito profonde trasformazioni e si è quantitativamente ridimensionato. Sono invece fortemente cresciute forme ibride fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, ovvero forme di lavoro atipico.
Il futuro del lavoro tra vecchio e nuovo
Dunque, le trasformazioni del lavoro - quelle recenti e quelle prevedibili - appaiono importanti, ma né dirompenti né univoche. La forma 'tipica' del lavoro dipendente e gerarchicamente subordinato conserva ancora un predominio economico e sociale rilevante. Accanto a questa forma tipica, altri generi di lavoro riconquistano un'attenzione a lungo perduta o negata - è il caso del lavoro autonomo e di quello domestico - o si presentano come novità alla ricerca di un consolidamento - è il caso dei vari lavori atipici.Anche le conseguenze dei processi di mutamento appaiono spesso ambigue e contraddittorie. È così, ad esempio, per quanto riguarda la duplice natura del lavoro. Con un trend iniziato da alcuni decenni, e che ha conosciuto una forte accelerazione nell'ultimo, il grado di fatica, di sacrificio, di costrizione è fortemente diminuito per quasi tutte le mansioni (v. Bonazzi, 1993) - anche se ciò ha reso per certi versi ancor più evidente il limite contro cui tale diminuzione si scontra, rappresentato dal permanere degli aspetti di subordinazione e di eteronomia nella maggior parte dei lavori. Tuttavia, alla diminuzione della componente di labor non ha fatto sempre riscontro un aumento di quella di opera, se non per alcune categorie professionali. Le possibilità di autorealizzazione attraverso il lavoro sono un aspetto intorno al quale si ricreano nuovi dualismi, fra gruppi occupazionali che ricavano dal lavoro soddisfazione e prestigio sociale e altri gruppi che continuano a scorgervi soltanto sacrificio e costrizione, sia pure attenuati. Mentre i secondi cercano di circoscrivere nel tempo e nell'esperienza di vita l'attività lavorativa, i primi si identificano sempre di più in tale attività. "Nulla caratterizza meglio le posizioni superiori del fatto che i loro appartenenti si lamentano di continuo d'aver troppo lavoro da svolgere [...]. Il grande consumo di lavoro è diventato il moderno equivalente del grande consumo di agiatezza" (v. Dahrendorf, 1988, p. 120).
2. Il lavoro nelle economie capitalistiche
È nelle economie capitalistiche che si sviluppa la forma del lavoro dipendente o lavoro salariato, regolata da un mercato anomalo qual è il mercato del lavoro e, successivamente, anche da istituzioni politiche e associative, mediante la legislazione, la contrattazione collettiva, le politiche del lavoro. Nel corso di questo secolo, tale forma di lavoro assume quelli che oggi consideriamo i suoi caratteri standard, e che recentemente sono stati sottoposti a trasformazioni più o meno accentuate. Anche nelle economie capitalistiche, tuttavia, rimangono in vita forme di lavoro non salariato, alcune delle quali hanno di recente riguadagnato un'attenzione da tempo perduta.
I mercati del lavoro e le altre istituzioni regolative
Un mercato è un meccanismo regolativo che consente la formazione del prezzo di un bene attraverso contrattazioni formalmente libere fra chi domanda e chi offre il bene stesso. Quando il bene scambiato è quella merce decisamente anomala costituita dal lavoro umano, si parla di mercato del lavoro. In realtà, vi sono diversi mercati per diversi tipi di lavoro. La domanda di lavoro è fortemente differenziata in base alle competenze richieste (se un'impresa ha bisogno di un ingegnere non assume ovviamente un cameriere) e in base ad altre caratteristiche. Ma anche l'offerta (cioè l'insieme delle persone disponibili a ricoprire un posto di lavoro) è diversificata per livello di istruzione, qualifica, esperienza lavorativa, nonché per età, sesso, provenienza etnica, ecc. Proprio perché le caratteristiche della domanda e dell'offerta di lavoro sono così eterogenee, sarebbe costosissimo e inefficiente, se non impossibile, utilizzare metodi amministrativi per coprire i posti di lavoro disponibili in un'economia sviluppata. Il mercato del lavoro si è invece rivelato uno strumento semplice e relativamente efficiente per fissare i livelli retributivi relativi (quindi i differenziali salariali) per le diverse figure professionali, imprese, aree geografiche e settori industriali. Tuttavia, esso presenta anche molti limiti e problemi di funzionamento, e i suoi esiti suscitano forti opposizioni, così che, storicamente, ha dovuto essere affiancato e in parte sostituito da altre istituzioni regolative. In primo luogo, vi sono aspetti del lavoro che il mercato non può regolare.
A differenza dei livelli retributivi, le condizioni in cui viene effettuata la prestazione lavorativa, o condizioni di lavoro - quali i ritmi di lavoro, le condizioni ambientali, o il grado di coinvolgimento nelle decisioni - vengono variamente regolate dalla gerarchia aziendale, dalla legislazione o dalla contrattazione collettiva. Così pure, non è il mercato del lavoro che può determinare interamente il livello desiderabile di occupazione complessiva (o di domanda di lavoro aggregata), o quello di garanzia del reddito per chi esca temporaneamente o permanentemente dal mercato del lavoro stesso. A ciò provvedono solitamente, in varia misura, le politiche statali, o la concertazione fra gli interessi organizzati. In secondo luogo, il ricorso al mercato può rivelarsi in vari casi meno efficiente dell'uso di meccanismi organizzativi. È questa, ad esempio, la ragione per la quale, per ricoprire posizioni relativamente qualificate, si sono diffusi quelli che gli economisti americani Doeringer e Piore (v., 1971) hanno chiamato 'mercati del lavoro interni', in contrapposizione a quelli 'esterni'. In molte imprese, soprattutto dove la produzione è altamente specifica e dove l'esperienza lavorativa e l'identificazione dei lavoratori con l'impresa stessa sono beni preziosi, le posizioni superiori vengono infatti ricoperte mediante promozione interna - cioè mediante meccanismi organizzativi - anziché mediante ricorso al mercato 'esterno'.Infine, lo scambio che ha luogo nel mercato del lavoro è uno scambio diseguale.
Benché la retribuzione e i termini del rapporto di lavoro vengano stabiliti attraverso una contrattazione formalmente libera, infatti, il potere di mercato - e quindi contrattuale - del datore di lavoro è di solito enormemente superiore a quello del lavoratore. Tranne che per figure professionali di difficile reperibilità, la domanda di lavoro è normalmente inferiore all'offerta e non ha le caratteristiche di urgenza e talvolta di drammaticità di quest'ultima. In tutti i paesi, la legislazione è intervenuta in diversa misura a temperare questa disuguaglianza presente nei mercati del lavoro, ponendo limiti alla facoltà delle imprese di licenziare, favorendo l'assunzione dei più deboli tra quanti si offrono su tale mercato, e così via. In tutti i paesi, inoltre, l'azione collettiva dei lavoratori, che ha portato alla formazione di sindacati, ha contribuito a trasformare lo 'scambio atomistico' che avviene nel mercato del lavoro in 'contrattazione collettiva' e talvolta in 'scambio politico' (v. Pizzorno, 1977), alterando così profondamente la natura di tale mercato.Nelle economie capitalistiche contemporanee, dunque, il mercato del lavoro è ancora il meccanismo principale per fare incontrare la domanda e l'offerta e per consentire che il lavoro si svolga nella forma tipica dell'occupazione dipendente. Ma gli altri meccanismi regolativi - dalle gerarchie aziendali allo Stato, alla contrattazione collettiva - hanno assunto un ruolo fondamentale sia nel fornire all'occupazione dipendente quei caratteri che consideriamo 'tipici' (quali il contratto a tempo indeterminato e con orario standard), sia nell'assecondarne i principali mutamenti.
Tendenze alla flessibilità
Se la forma di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato è una costruzione sociale relativamente recente, ancor più recenti sono alcune tendenze al suo parziale ridimensionamento.In primo luogo, è l'aspetto del tempo pieno ad avere subito una ridefinizione. Già le prime lotte sindacali per la riduzione della giornata di lavoro e la legislazione sulla sua durata avevano messo in evidenza che il significato di tale termine è socialmente variabile e va perciò giuridicamente definito. Tuttavia, nonostante la drastica riduzione della giornata e della settimana lavorative dagli inizi del capitalismo a oggi, l'idea che il lavoro dipendente non potesse che assorbire la gran parte della vita attiva di una persona era rimasta sostanzialmente immutata fino al secondo dopoguerra. È solo con la crescita del benessere nelle società industriali avanzate, e in particolar modo con il forte aumento del tasso di attività femminile (che in alcuni settori porta a una vera e propria femminilizzazione della forza lavoro), che si diffondono forme di lavoro a tempo parziale, organizzate secondo diverse modalità. Su diciannove paesi dell'area OECD, nel 1979 soltanto tre avevano una percentuale di occupati part-time superiore al 20% degli occupati totali; ma nel 1990 questi paesi erano divenuti sette (v. OECD, 1991, p. 46).
In secondo luogo, l'idea del lavoro a tempo indeterminato in cui si svolgono stabilmente le stesse mansioni per una retribuzione anch'essa prefissata - idea che si era affermata in questo secolo come esito della contrattazione sindacale non meno che dell'intervento statale - viene anch'essa messa in discussione negli anni ottanta. In questo decennio, l'esigenza delle imprese di rispondere in modo più agile e tempestivo alle turbolenze dei mercati porta ovunque a richieste di 'flessibilizzazione' del rapporto di lavoro. Queste richieste sono in taluni casi - particolarmente nei paesi anglosassoni - assecondate da propositi politici di deregulation; in altri paesi - ad esempio in Germania e in Italia - vengono di fatto contrattate con i sindacati (v. Regini, 1991).
Il primo obiettivo delle imprese è quello di ottenere maggiore flessibilità in entrata e in uscita dal mercato del lavoro (si parlerà allora di flessibilità numerica o esterna), contravvenendo così al carattere di sostanziale stabilità - difficoltà di licenziamento, divieto di assunzioni a tempo determinato - che i posti di lavoro erano venuti assumendo negli anni sessanta e settanta nelle economie industriali avanzate. Mentre la flessibilità esterna o numerica ha giocato un ruolo chiave nella ristrutturazione industriale dei tardi anni settanta e primi anni ottanta, un'importanza sempre maggiore è stata in seguito assunta dalla flessibilità interna o funzionale - cioè la possibilità di impiegare un lavoratore in mansioni diverse - e da quella temporale - vale a dire la possibilità di modulare il tempo effettivo di lavoro sulle esigenze della produzione. Molte delle imprese che avevano cercato in un primo momento un tipo di riaggiustamento basato su una contrazione dell'organico, infatti, non hanno tardato a scoprire che la riorganizzazione delle mansioni, lo sviluppo professionale della forza lavoro e l'elasticità dell'orario potevano costituire fattori di competitività ancora più importanti.Infine, l'egemonia del lavoro dipendente a tempo indeterminato è messa in discussione dalla crescita - che negli ultimi vent'anni ha interessato in varia misura tutti i paesi industrialmente avanzati - del numero e dell'importanza dei lavoratori con uno status incerto nel mercato del lavoro. Gli esempi sono svariati: dai lavoratori dipendenti che svolgono anche un lavoro in proprio, talvolta preparandosi a diventare piccoli imprenditori, a quanti sono usciti dal mercato del lavoro regolare con un pensionamento anticipato che poi lavorano nell'economia informale, a coloro che svolgono un lavoro free-lance, spesso intrattenendo un rapporto continuativo e di fatto stabile con un'impresa.
Il lavoro fuori dal mercato capitalistico
Come si è più volte accennato, anche in un'economia capitalistica non tutto il lavoro assume la forma standard del lavoro dipendente e retribuito. Tre altri tipi principali di lavoro hanno mantenuto una rilevanza quantitativa durante tutto lo sviluppo capitalistico, benché offuscati dall'egemonia della forma standard, e mostrano oggi una ripresa di importanza economica o sociale. Si tratta del lavoro autonomo e professionale, del lavoro domestico e di quello volontario.Le professioni liberali sono naturalmente una forma di occupazione antica, per le cui caratteristiche particolari esse vengono solitamente trattate sotto una categoria diversa - definita appunto 'professione' - da quella di lavoro. Altre figure sociali (artigiani, commercianti, ecc.) svolgono invece un'attività lavorativa normalmente in forma self-employed, cioè indipendente. Sia le interpretazioni evoluzioniste dell'analisi di Karl Marx, sia le teorie della modernizzazione industriale (v. Kerr e altri, 1960) hanno fatto a lungo considerare queste figure sociali come un residuo precapitalistico o preindustriale, quindi destinato a una inevitabile perdita di importanza, se non all'estinzione. In diversi paesi industrialmente avanzati, invece, la quota dei lavoratori autonomi sul totale della forza lavoro è andata aumentando a partire dagli anni settanta (v. OECD, 1986), in conseguenza sia del formarsi di nuove figure professionali e imprenditoriali create dallo sviluppo economico, sia di politiche di sostegno pubblico volte a ottenere consenso (v. Berger e Piore, 1980).
Il lavoro domestico è stato tradizionalmente svolto dalle donne che - ancor oggi si usa dire - 'non lavorano', cioè che non hanno un'occupazione dipendente. Se il linguaggio comune è rivelatore del perché questa categoria di lavoro sia stata a lungo esclusa dal concetto di lavoro più in generale, l'arbitrarietà di questa esclusione emerge non appena si consideri che le stesse attività di cui consiste il lavoro domestico possono costituire parte del lavoro salariato nell'economia formale. Ciò vale non solo per le attività svolte nell'abitazione in senso stretto, ma anche per molte altre al di fuori di essa, quali il giardinaggio, la manutenzione dell'auto o l'accompagnare i figli a scuola. D'altro canto, le possibilità per le donne di presentarsi sul mercato del lavoro sono state limitate e determinate dalle loro attività domestiche, dando luogo a modelli occupazionali basati sulle distinzioni di sesso. Per diverse ragioni, è dunque difficile non considerare il lavoro dipendente e quello domestico come strettamente connessi fra loro (v. Grint, 1991).Infine, il lavoro volontario è diventato più importante con la moltiplicazione dei servizi sociali connessi all'espansione del Welfare State e della cittadinanza sociale. La crisi fiscale dello Stato e la caduta di qualità dei servizi sociali che ne è seguita ha in molti paesi dato nuovo impulso al volontariato - chiamato spesso anche 'terzo settore' - quale alternativa alle deficienze dello Stato, del mercato e della famiglia nel fornire prestazioni sociali.
3. Il lavoro nell'impresa
La grande impresa e l'amministrazione pubblica sono i due contesti organizzativi nei quali il lavoro salariato ha assunto le caratteristiche tipiche della sua forma standard: non già lavoro svolto autonomamente per quanto riguarda gli strumenti e le procedure lavorative - come nel caso degli artigiani o dei professionisti - ma lavoro 'gerarchicamente subordinato'.
È nell'impresa industriale che le grandi problematiche poste da questo tipo di lavoro si sono originariamente sviluppate. Ed è alla grande impresa industriale che si è rivolta in via prioritaria l'attenzione delle scienze sociali interessate al tema del lavoro e dei suoi effetti sulle persone. Dal vecchio dibattito sulle conseguenze del mutamento tecnologico - intorno a cui si sono sviluppate gran parte della sociologia industriale e della psicologia del lavoro - e sull'umanizzazione del lavoro in una fase di parcellizzazione elevata delle mansioni, si è passati più di recente alle discussioni sul superamento dell'organizzazione del lavoro taylor-fordista, sulla sua portata e sui nuovi modelli emergenti.
Contemporaneamente al superamento del fordismo, tuttavia, due forme di lavoro al di fuori del tipo standard hanno acquistato rilevanza sociale: si tratta del lavoro nel settore dei servizi - che come vedremo racchiude in sé tipi di prestazione fortemente differenziati dal punto di vista qualitativo - e di quella costellazione di forme di lavoro che si usa ormai definire 'atipico'.
Il taylor-fordismo e le conseguenze del mutamento tecnologico
Negli anni cinquanta e sessanta le scienze sociali scoprirono i problemi del 'macchinismo' prima e dell'automazione poi, e delle profonde conseguenze che essi provocavano sul lavoro in termini di parcellizzazione delle mansioni (v. Friedmann, 1946) e di alienazione (v. Blauner, 1964). Gli studiosi si divisero fra chi vedeva il macchinismo come una tendenza secolare a dequalificare il lavoro umano e chi invece, con una visione dialettica presa in prestito dal marxismo, lo considerava come una semplice fase in procinto di essere superata da quella dell'automazione, che avrebbe portato a una ricomposizione e riqualificazione del lavoro (v. Touraine, 1955; v. Mallet, 1963). La sociologia del lavoro francese, in particolare, sviluppò un ampio filone di analisi intorno a tali questioni (v. Friedmann e Naville, 1961). E negli anni settanta questo dibattito fra pessimisti e ottimisti riprese, particolarmente influenzato da lavori come quello di Braverman (v., 1974), che vedeva nella razionalizzazione capitalistica un processo inevitabilmente destinato a 'degradare' il lavoro professionalmente, a renderlo più pesante e a peggiorare le condizioni lavorative.Questi orientamenti dell'analisi sociologica del lavoro derivavano dal fatto che, fino alla metà degli anni settanta, la produzione industriale nei paesi capitalistici sviluppati si era andata organizzando secondo i principî fordisti (v. Piore e Sabel, 1984; v. Boyer e Wolleb, 1986), collegati a una organizzazione del lavoro di ispirazione taylorista che implicava appunto parcellizzazione delle mansioni e dequalificazione. A cavallo del secolo, l'ingegnere americano Frederick W. Taylor sostenne infatti che vi era one best way di organizzare il lavoro in fabbrica: osservare attentamente come veniva eseguita ciascuna mansione, scomporla nei suoi movimenti elementari, misurare i tempi necessari a eseguirli, e ridefinire poi la mansione stessa in modo rigido e standardizzato, senza alcuna autonomia per gli esecutori (v. Taylor, 1911).
Ciò naturalmente implicava una netta separazione fra concezione ed esecuzione del lavoro, che costituiva del resto il principio guida della produzione di massa. L'efficienza della produzione di massa dipende infatti dalle economie di scala; e per ottenere economie di scala, come sappiamo da Adam Smith, è necessario suddividere il lavoro in una serie di operazioni altamente parcellizzate, alcune delle quali possono venire meccanizzate, precisamente per il fatto che sono state semplificate, mentre le altre possono venire eseguite da lavoratori non specializzati, per la stessa ragione (v. Smith, 1776). Questa divisione del lavoro richiedeva un complesso sistema di controlli. I capi controllavano che gli operai si attenessero alle norme; una divisione incaricata del controllo di qualità verificava i risultati ottenuti dai capi; e un settore 'aggiustaggio' a valle delle linee di montaggio riparava i difetti che erano sfuggiti ai continui controlli. Essendo le mansioni così parcellizzate, non vi era motivo di acquisire un'ampia qualificazione sul lavoro o vaste conoscenze di base. La maggior parte degli operai - e dei managers - perciò imparava sul lavoro. Gli operai percorrevano una carriera di mansioni semiqualificate, ciascuna delle quali richiedeva una certa familiarità con la mansione precedente (v. Regini e Sabel, 1989).Naturalmente, si tratta di una descrizione idealtipica. Il taylor-fordismo si diffuse in modo diseguale nei paesi industriali, e con ritardo notevole in alcuni di questi (v. Boyer e Wolleb, 1986). Ma il 'caso da manuale' tratteggiato sopra chiarisce perché le preoccupazioni diffuse fino a tutti gli anni settanta fossero quelle di una umanizzazione del lavoro - o, a seconda dell'ideologia prevalente, di una organizzazione del lavoro non capitalistica.
La riorganizzazione post-fordista del lavoro
Molti studi in diversi paesi ci hanno mostrato come, negli anni settanta e ottanta, si sia passati dal predominio dell'impresa taylor-fordista a una crescente diversificazione dei modi di organizzare l'impresa, la produzione e il lavoro (v. Piore e Sabel, 1984; v. Kern e Schumann, 1984; v. Boyer e Wolleb, 1986). Se si prescinde per il momento da tali differenze (per le quali v. § 3c), si può parlare in generale dell'emergere di un sistema post-fordista e post-taylorista, basato sulla necessità di rispondere in modo flessibile, tempestivo e differenziato alla crescente instabilità dei mercati. Dai tardi anni settanta in poi, la frammentazione dei mercati di massa e le continue oscillazioni nel livello e nella composizione della domanda appaiono infatti come fenomeni generali, quasi universali. E questa accresciuta instabilità dei mercati ha costretto le imprese a mettere in discussione il principio guida della produzione di massa, cioè la separazione fra concezione ed esecuzione.
Le conseguenze sul lavoro nell'impresa sono, almeno potenzialmente, di enorme portata. La piena utilizzazione delle capacità dei lavoratori non viene, infatti, più ostacolata dal dogma taylor-fordista. La ricerca di maggiore efficienza può cessare di fondarsi sull'esasperata suddivisione delle operazioni e sulla rigida frammentazione dei compiti, per puntare invece sullo strumento opposto, vale a dire l'integrazione delle mansioni e l'ampliamento della sfera di responsabilità del lavoratore (v. Kern, 1992, p. 64). Nei nuovi sistemi di produzione flessibile, insomma, operai altamente qualificati dovrebbero sostituire gli operai a bassa o media qualificazione.In effetti, alcune ricerche hanno documentato che si sta invertendo la precedente tendenza a separare nettamente i compiti di esecuzione da quelli di concezione; che per molti lavoratori aumenta il contenuto professionale delle mansioni; che mutano sia il controllo sul lavoro, sia le funzioni della gerarchia e delle regole che intorno a questo problema erano state create. Con una sintesi efficace, anche se certamente ottimistica, si può dire che nei 'nuovi concetti di produzione' l'intelligenza umana viene vista come una risorsa da utilizzare al meglio nel luogo di lavoro anziché come un vincolo intorno al quale costruire un sistema di regole che la disciplini (v. Kern e Schumann, 1984).
Secondo altre ricerche, vi è una crescita dell'astrazione e della 'complessificazione' del lavoro. Astrazione nel senso che il lavoro consiste sempre più nella capacità di interpretare dati più o meno formalizzati proposti dai dispositivi di controllo degli automatismi; complessificazione in quanto aumenta la parte di attività cerebrale e mentale, che si traduce ad esempio nello sforzo di sottoporre a un controllo quasi permanente i vari circuiti e collegamenti fra macchine, a scopo di regolazione o di diagnosi (v. Coriat, 1990, p. 219). Ma gli effetti dei sistemi post-fordisti sul lavoro non sono soltanto, e neppure principalmente, relativi alla qualificazione tecnica richiesta. È soprattutto la dipendenza gerarchica e organizzativa dei lavoratori - che era imposta dal taylor-fordismo - a diminuire, mentre aumentano nettamente le loro possibilità di coinvolgimento, partecipazione e controllo (v. Accornero, 1992, p. 99). Molti lavoratori vengono così a condividere in qualche misura l'orizzonte degli obiettivi aziendali, a differenza di quanto accadeva in precedenza, quando tali obiettivi venivano passivamente accettati o, occasionalmente, messi in discussione (v. Burawoy, 1979).
Tra forza lavoro e risorse umane
Le tendenze di mutamento sopra delineate rappresentano generalizzazioni assai ampie, utili principalmente a confrontare le caratteristiche che il lavoro industriale può assumere nella nuova fase con quelle tipiche del periodo taylor-fordista. Ma il quadro che emerge dalla crisi del fordismo è assai più variegato e incerto. I modelli organizzativo-produttivi secondo cui si è andata riorganizzando la grande impresa industriale negli anni ottanta sono diversi, e a ciascuno di essi corrisponde un diverso ruolo assegnato al lavoro.
Un primo modello è quello che è stato chiamato 'produzione diversificata di qualità' (v. Streeck, 1992); esso è proprio di imprese che puntano a competere sulla qualità dei prodotti più che sul prezzo. In questo modello un ruolo cruciale è svolto dalla elevata e ampia qualificazione della forza lavoro a tutti i livelli, dalla sua capacità di integrare diversi compiti nonché di cambiare e imparare rapidamente nuove mansioni, e dal suo coinvolgimento negli obiettivi aziendali di miglioramento costante e di innovazione incrementale. Da ciò consegue l'utilizzo di una quota molto ampia di forza lavoro con una formazione professionale - sia di base sia specifica per l'azienda - estesa, con capacità sociali quali iniziativa, attitudine al problem solving e alla collaborazione con gli altri, e con una buona dose di identificazione con la cultura aziendale. Un secondo modello, che può essere definito 'produzione di massa flessibile' (v. Boyer, 1988), è invece basato sulla produzione di massa di una varietà di beni (anziché di beni standard come nel fordismo classico), per rispondere alla variabilità della domanda senza rinunciare a contenere i prezzi. L'automazione programmabile, che consente di produrre in massa un'ampia gamma di prodotti, riduce drasticamente sia la domanda di figure professionali a bassa qualificazione (operai di produzione e impiegati amministrativi), sia l'utilizzo delle competenze tecniche del personale mediamente qualificato, al quale vengono soprattutto richieste adattabilità al mutamento e cooperazione. La domanda di qualificazioni elevate si concentra invece su alcuni gruppi cruciali, come i quadri, i tecnici e il personale dell'area commerciale. Ne deriva una netta segmentazione fra personale ad alta qualificazione, appartenente a questi gruppi professionali, e personale a medio-bassa qualificazione, con competenze obsolete.Infine, un terzo modello è quello giapponese del just-in-time e della lean production, o 'toyotismo', che basa la propria competitività in parte sul prezzo dei prodotti, in parte sulla loro qualità (v. Dore, 1987; v. Bonazzi, 1993). Rispetto al fordismo tradizionale, esso comporta una assai più ampia valorizzazione delle risorse umane. Resta la divisione fra funzioni di progettazione e funzioni esecutive, ma assai più attenuata. Vi è uno sforzo collettivo teso a favorire e utilizzare conoscenze diffuse piuttosto che alla loro concentrazione nell'ambito di una ristretta élite, una maggiore attenzione allo sviluppo delle risorse umane complessive, e un minore distacco fra il mondo della scuola e quello del lavoro. Il lavoro di squadra e i circoli della qualità, che insieme all'automazione programmabile e ai macchinari polivalenti sono caratteristiche tipiche dell'organizzazione della produzione di tipo giapponese, rappresentano sia schemi organizzativi sia una politica di coinvolgimento pieno dei lavoratori nell'impresa. Questo modello si basa infatti su un elevato grado di consenso e di partecipazione dei lavoratori anche ai livelli più bassi, e su una condivisione di fatto degli obiettivi aziendali. A tale coinvolgimento fa peraltro da supporto una struttura fortemente dualistica del mercato del lavoro, che prevede, per l'ampia quota di lavoratori occupati nelle grandi imprese, la stabilità dell'occupazione sotto forma dell'impiego a vita, mentre ne scarica i costi sul resto della forza lavoro che opera nel mercato secondario.
Il dualismo fra i lavoratori che sono fortemente beneficiati dai nuovi modi di organizzare il lavoro e quelli che da tali benefici restano esclusi non è del resto limitato al caso giapponese. Anzi, l'impresa flessibile - a qualunque dei modelli indicati appartenga - è fortemente caratterizzata da un nucleo centrale di lavoratori polivalenti e da una periferia di subfornitori, lavoratori a domicilio e categorie varie di lavoro temporaneo (v. Pahl, 1988, p. 171). E anche all'interno dei dipendenti stabili, vi è chi individua alcuni gruppi che vengono valorizzati dai mutamenti in corso, altri che vengono esclusi, e altri ancora che vengono destabilizzati (v. Coriat, 1990); sembra pertanto che un effetto diretto delle nuove strategie post-fordiste possa essere proprio quello della segmentazione. Non è dunque un caso che, anche nelle nuove concezioni manageriali, una parte dei lavoratori venga considerata come 'risorse umane', mentre un'altra parte rimane semplice 'forza lavoro'.
Le attività terziarie e le forme di lavoro atipico
La 'scoperta' della crescente importanza e al tempo stesso delle peculiarità del lavoro nei servizi è una conseguenza indiretta del dibattito sulla società postindustriale, che ha avuto largo spazio nelle scienze sociali particolarmente negli anni settanta (v. Bell, 1973). In un primo momento, l'attenzione degli osservatori si è concentrata sugli aspetti quantitativi della trasformazione sociale in corso: in particolare, sul fenomeno comune a tutti i paesi avanzati di un costante declino dell'occupazione industriale e di una crescita dei posti di lavoro nel settore terziario. In seguito ci si è resi conto anche delle intrinseche differenze di attività che consistono nell'offrire servizi anziché produrre beni. Quando si tratta, in particolare, di offrire servizi alla persona, si verifica spesso una certa intermittenza delle prestazioni, una flessibilizzazione dell'orario rispetto a quello standard, un proliferare delle richieste di tempo parziale, e così via.
Poiché tali fenomeni hanno marginalmente interessato anche il settore industriale, forte è stata la tentazione di individuare una tendenza alla 'terziarizzazione' del lavoro tout court, cioè alla generalizzazione di tratti tipici del lavoro nei servizi a tutte le attività che si svolgono nella società postindustriale. Ma si tratta di scenari assai semplicistici, derivanti da una visione unilineare del mutamento, che hanno presto lasciato il campo a un quadro molto più articolato e sfumato, che emerge in particolare dal confronto fra le diverse traiettorie di sviluppo seguite dai paesi industriali avanzati. Le ricerche di Esping-Andersen (v., 1990, pp. 191 ss.), ad esempio, mostrano come tre paesi industrialmente avanzati quali gli Stati Uniti, la Germania e la Svezia presentino non solo livelli di terziarizzazione differenti, ma anche strutture occupazionali assai diverse, con differenti proporzioni di lavori qualificati e lavori dequalificati.
Lavoro terziario non è, infatti, sinonimo di lavoro più ricco e gratificante, come spesso si sostiene. Se il cosiddetto terziario avanzato - cioè le attività di servizio all'impresa quali marketing, pubblicità, consulenza fiscale, ecc., tradizionalmente svolte dentro l'impresa stessa e poi largamente esternalizzate a causa della crescente specializzazione - ha visto in effetti lo sviluppo di nuove professioni altamente qualificate, ciò non si è invece verificato che in piccola parte nelle attività di servizio alla persona. Che il contesto lavorativo sia una grande organizzazione pubblica, come un ospedale o una piccola impresa privata, come un bar o un servizio di recapito postale celere, l'universo emergente dei lavori in questo campo vede una netta prevalenza di quelli dequalificati, cioè del cosiddetto terziario manuale (v. Esping-Andersen, 1990).
Se non vi è stata, dunque, una terziarizzazione del lavoro, si è invece avuta una generale crescita delle forme di lavoro 'atipico', sia pure con alcune differenze nei vari paesi. Per lavori atipici si intendono generalmente quelle attività che mancano di uno o più requisiti del lavoro subordinato standard (v. Chiesi, 1990). Si tratta dunque di una nozione residuale; come nel caso della società 'postindustriale' o dell'organizzazione produttiva 'post-fordista', la mancanza di un termine appropriato indica la relativa incertezza sulla reale natura del fenomeno. È facile cogliere che cosa lo distingue dalle realtà tradizionali a cui lo si contrappone, ma meno facile identificarne in positivo gli elementi costitutivi. Esempi di queste forme di attività atipiche sono il lavoro free-lance (o prestazione senza vincolo di subordinazione), il lavoro a domicilio, i rapporti a termine, quelli stagionali, quelli retribuiti a risultato, i casi di secondo lavoro. Rilevanti sono anche i casi ibridi fra lavoro dipendente e attività professionale (come quelli di chi svolge una professione alle dipendenze di una organizzazione pubblica o privata) e fra lavoro subordinato e attività imprenditoriale (come nei contratti di franchising o per molti subfornitori strettamente legati a un'impresa più grande). Come è stato osservato (v. Accornero, 1992, p. 101), in questo caso la natura residuale del termine corrisponde bene alla tradizionale marginalità di queste attività rispetto al mondo del lavoro ufficiale. Stati e sindacati, legislazione e contrattazione, hanno a lungo perseguito l'obiettivo di una uniformazione sociale e di una stabilizzazione del lavoro; e in questa ottica le forme diverse dal lavoro subordinato standard venivano mal tollerate. Ma, a partire dagli anni ottanta, l'imperativo aziendale della flessibilità e la diversificazione degli stili individuali di vita hanno contribuito ad aumentarne la legittimità sociale, e ne hanno quindi consentito una notevole espansione.
4. La centralità sociale del lavoro e le sue trasformazioni
I mutamenti che hanno determinato le nuove caratteristiche del lavoro fin qui discusse hanno dato vita, negli ultimi quindici anni, a un acceso dibattito fra gli studiosi di scienze sociali sul futuro del lavoro stesso.Un interrogativo emerge con forza quando si discute sul futuro del lavoro: nella nuova società (postindustriale, postmoderna, neoindustriale, o comunque la si voglia definire) che si va delineando, il lavoro continuerà ad avere quella centralità che indubbiamente ha avuto nella fase della società industriale? Continuerà a strutturare le condizioni e il tempo di vita della gente, a costituire la base della stratificazione sociale, a influenzare profondamente il sistema dei valori sociali? La centralità sociale del lavoro è un fenomeno moderno, legato all'affermarsi del mercato e all'idea che le chances di reddito e di vita degli individui dipendano dal suo operare. Per gli antichi Greci, ad esempio, il lavoro non era affatto un valore, ma era anzi il segno di una condizione sociale inferiore, mentre l'opposto era per le attività del tempo libero. È solo da quando, per reclutare i potenziali lavoratori, ci si deve affidare al 'libero' scambio sul mercato del lavoro anziché a strumenti coercitivi o alla tradizione, che un'ideologia del lavoro - tesa a nobilitare anche le attività più faticose, sporche e abbrutenti - si sviluppa in Europa, come complemento dell'etica protestante.
Tuttavia questa centralità - che si è tradotta nel progressivo affermarsi di una vera e propria 'società del lavoro' - è messa oggi in discussione da una importante scuola di pensiero (v. Dahrendorf, 1980; v. Offe, 1983; v. Handy, 1984; v. Gorz, 1988). Secondo Dahrendorf - che è stato l'iniziatore di questo dibattito e probabilmente il più importante degli autori che vi hanno partecipato - il fattore cruciale di questa perdita di centralità va individuato nel fatto che il lavoro, in conseguenza dei processi di riduzione degli orari, di allungamento del periodo scolare o formativo, di anticipazione del pensionamento, e di estensione e organizzazione del tempo libero, ha assunto un ruolo meno importante nella vita umana (v. Dahrendorf, 1988). Il lavoro inteso come occupazione retribuita è diventato socialmente scarso, e da ciò - richiamandosi a Hannah Arendt (v., 1958) - si fa discendere un passaggio dal regno del 'lavoro' eteronomo a quello dell''attività' autonoma, intesa come ciò che facciamo come risultato delle nostre intenzioni, desideri e interessi (v. Dahrendorf, 1988, p. 113).
Questa impostazione utopica è fortemente criticata da altri autori, alcuni dei quali giungono ad affermare l'opposto: cioè che "il lavoro sta diventando la questione personale, sociale e politica cruciale degli ultimi anni di questo secolo" (v. Pahl, 1988, p. 1). A ben vedere, la ragione della diatriba sta precisamente nelle diverse nozioni di lavoro, e nei modi di considerarne le trasformazioni, che abbiamo discusso in questo articolo. Se si considera solo quella forma tipica costituita dall'occupazione dipendente (per lo più maschile e manifatturiera) in contesti organizzati, allora non vi sono dubbi sulla sua notevole contrazione e quindi sulla crisi della società del lavoro. Ma l'analisi precedente ha mostrato che emergono nuovi modi di lavorare e che il lavoro si trasforma e assume nuove caratteristiche e nuovi significati, senza per questo ridurre il suo ruolo complessivo nella società e nella vita degli individui. Dunque, la centralità sociale del lavoro stesso non appare intaccata. Da un punto di vista generale, si può rilevare come il sistema dei valori sociali resti ancora largamente centrato sul lavoro. La crisi della sua forma tipica, e la conseguente diversificazione delle esperienze lavorative, ha fatto definitivamente tramontare le vecchie subculture fortemente omogenee e ha contribuito ad articolare il tessuto sociale e il quadro dei valori che lo reggono; ma non sembra aver diminuito il ruolo del lavoro come fonte di identità, di socialità e di orientamento politico-culturale - oltre che di stratificazione sociale, come continuano a documentare anche le ricerche più recenti. Dal punto di vista soggettivo di chi lavora, le molte ricerche esistenti sugli atteggiamenti verso il lavoro sembrano indicare, da un lato, un diffuso rifiuto a farne la principale fonte di senso e di strutturazione della propria vita, ma, dall'altro lato, il permanere del suo ruolo come strumento di valutazione di sé e di autostima sociale. Ciò che è più importante notare, tuttavia (v. Littler, 1985, p. 278), è che il significato attribuito al lavoro varia profondamente per uomini e donne, per i lavoratori occidentali e per quelli asiatici, e così via. Il che rende ancora più azzardata qualunque generalizzazione sulla centralità futura del lavoro nell'esperienza soggettiva. (V. anche Automazione; Dirigenti; Disoccupazione; Divisione del lavoro; Impiegati e funzionari; Occupazione; Operai; Organizzazione; Taylorismo).
Bibliografia
Accornero, A., Are we going towards a society of 'activity' or 'work'?, in "Labour", 1992, VI, 3, pp. 89-107.
Arendt, H., The human condition, Chicago 1958 (tr. it.: Vita activa. La condizione umana, Milano 1988).
Bell, D., The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting, New York 1973.
Berger, S., Piore, M.J., Dualism and discontinuity in industrial societies, Cambridge 1980 (tr. it.: Dualismo economico e politica nelle società industriali, Bologna 1982).
Blauner, R., Alienation and freedom. The factory worker and his industry, Chicago 1964 (tr. it.: Alienazione e libertà, Milano 1971).
Bonazzi, G., Il tubo di cristallo. Modello giapponese e fabbrica integrata alla Fiat Auto, Bologna 1993.
Boyer, R., Alla ricerca di alternative al fordismo: gli anni ottanta, in "Stato e mercato", 1988, XXIV, pp. 387-423.
Boyer, R., Wolleb, E. (a cura di), La flexibilité du travail en Europe, Paris 1986 (tr. it.: La flessibilità del lavoro in Europa. Uno studio comparativo delle trasformazioni, Milano 1987).
Braverman, H., Labor and monopoly capital: the degradation of work in the twentieth century, New York-London 1974 (tr. it.: Lavoro e capitale monopolistico: la degradazione del lavoro nel XX secolo, Torino 1978).
Burawoy, M., Manufacturing consent. Changes in the labor process under monopoly capitalism, Chicago 1979.
Chiesi, A., Un quadro di riferimento concettuale, in "Democrazia e diritto", 1990, XXX, 1, pp. 13-30.
Coriat, B., L'atelier et le robot. Essai sur le fordisme et la production de masse à l'âge de l'électronique, Paris 1990.
Dahrendorf, R., Im Entschwinden der Arbeitsgesellschaft: Wandlungen der sozialen Konstruktion des menschlichen Lebens, in "Merkur", 1980, XXXIV, pp. 749-760.
Dahrendorf, R., Dalla società del lavoro alla società dell'attività, in Impresa e lavoro in trasformazione (a cura di P. Ceri), Bologna 1988, pp. 113-123.
Doeringer, P.B., Piore, M.J., Internal labor markets and manpower analysis, Lexington, Mass., 1971.
Dore, R., Taking Japan seriously: a Confucian perspective on leading economic issues, Stanford, Cal., 1987 (tr. it.: Bisogna prendere il Giappone sul serio: saggio sulla varietà dei capitalismi, Bologna 1990).
Dubin, R., The world of work, Englewood Cliffs, N.J., 1958.
Esping-Andersen, G., The three worlds of welfare capitalism, Cambridge 1990.
Friedmann, G., Problèmes humains du machinisme industriel (1946), ed. riveduta e ampliata, Paris 1963² (tr. it.: Problemi umani del macchinismo industriale, Torino 1971).
Friedmann, G., Naville, P., Traité de sociologie du travail, Paris 1961 (tr. it.: Trattato di sociologia del lavoro, 2 voll., Milano 1963).
Gallino, L., Neo-industria e lavoro allo stato fluido, in Impresa e lavoro in trasformazione (a cura di P. Ceri), Bologna 1988, pp. 125-139.
Gorz, A., Métamorphoses du travail, Paris 1988 (tr. it.: Metamorfosi del lavoro. Critica della ragione economica, Torino 1992).
Grint, K., The sociology of work, Cambridge 1991.
Handy, C., The future of work, Oxford 1984.
Kern, H., Cambiamenti nel lavoro e nell'organizzazione delle imprese, in Il futuro della società e del lavoro (a cura della Fondazione Feltrinelli), Milano 1992, pp. 63-72.
Kern, H., Schumann, M., Das Ende der Arbeitsteilung? Rationalisierung in der industriellen Produktion, München 1984 (tr. it.: La fine della divisione del lavoro?, Torino 1991).
Kerr, C., Dunlop, J., Harbison, F., Myers, C., Industrialism and industrial man, Cambridge, Mass., 1960 (tr. it.: L'industrialismo e l'uomo dell'industria, Milano 1976).
Littler, C., The experience of work, Aldershot 1985.
Mallet, S., La nouvelle classe ouvrière, Paris 1963 (tr. it.: La nuova classe operaia, Torino 1967).
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), Self-employment in OECD countries, in OECD employment outlook, Paris 1986.
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), OECD employment outlook, Paris 1991.
Offe, C., Arbeit als soziologische Schlüsselkategorie?, in Krise der Arbeitsgesellschaft? (a cura di J. Matthes), Frankfurt a.M. 1983, pp. 38-65 (tr. it.: Lavoro come categoria sociologica centrale, in "Sociologia del lavoro", 1986, XXVIII, pp. 17-46).
Pahl, R. (a cura di), On work. Historical, comparative and theoretical approaches, Oxford 1988.
Piore, M.J., Sabel, C.F., The second industrial divide: possibilities for prosperity, New York 1984 (tr. it.: Le due vie dello sviluppo industriale. Produzione di massa e produzione flessibile, Milano 1987).
Pizzorno, A., Scambio politico e identità collettiva nel conflitto di classe, in Conflitti in Europa. Lotte di classe, sindacati e Stato dopo il '68 (a cura di C. Crouch e A. Pizzorno), Milano 1977, pp. 407-433.
Regini, M., Confini mobili. La costruzione dell'economia fra politica e società, Bologna 1991.
Regini, M., Sabel, C.F. (a cura di), Strategie di riaggiustamento industriale, Bologna 1989.
Smith, A., An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776), edizione critica a cura di E. Cannan, London 1904 (tr. it.: La ricchezza delle nazioni, Torino 1948).
Streeck, W., Social institutions and economic performance, London 1992.
Taylor, F.W., The principles of scientific management (1911), New York-London 1947 (tr. it.: L'organizzazione scientifica del lavoro, Milano 1967).
Touraine, A., L'évolution du travail ouvrier aux Usines Renault, Paris 1955 (tr. it.: L'evoluzione del lavoro operaio alla Renault, Torino 1974).
Touraine, A., Lavoro e società, in "Sociologia del lavoro", 1986, XXIX, pp. 193-199.
Diritto
di Giuseppe Pera
1. Concetti generali
Il diritto del lavoro, genericamente inteso, presenta ripartizioni interne. In primo luogo il diritto sindacale, cioè quanto attiene alla posizione giuridica delle associazioni professionali, alla contrattazione collettiva, ai mezzi di autotutela (sciopero e serrata). In secondo luogo il diritto del lavoro in senso stretto, cioè il rapporto tra le parti del contratto di lavoro, datore di lavoro e lavoratore. In terzo luogo almeno la previdenza sociale (v. cap. 13). Il diritto del lavoro, quindi, comprende tutto quanto attiene, in senso strumentale-istituzionale o di regolamentazione dei rapporti, alla condizione del lavoro e alla sua tutela nell'esperienza giuridica. Si può anche dire che esso riguarda, in senso lato, i diritti che derivano dal fatto di lavorare alle dipendenze e a favore di un terzo; ivi compresa la libertà di attivarsi per la tutela mediante la coalizione di quanti si ritengono accomunati dal medesimo interesse. Si tratta di un diritto sviluppatosi all'incirca nella seconda metà dell'Ottocento e giunto a maturazione nell'ultimo cinquantennio; esso fa corpo con le vicende politico-sociali verificatesi dopo la Rivoluzione francese e non è possibile 'depurarlo' dalle esigenze emerse nel corpo sociale durante tale periodo.
2. La rivoluzione industriale
La rivoluzione industriale, sviluppatasi dapprima in Inghilterra verso la metà del Settecento e poi, con notevoli scarti nel tempo, in diversi altri paesi, ha costituito sul piano sociale l'humus in cui sono nate e si sono precisate le esigenze e le forze motrici di questo settore del diritto rispetto a quello tradizionale borghese. Per cercare di capire questa evoluzione non se ne possono trascurare le origini, anche se poi, nella sua fase matura, questo diritto si è andato estendendo oltre l'industria, in tutti i settori dell'economia e anche, talora, oltre l'ambito del lavoro subordinato in senso stretto. Ad esempio oggi il diritto italiano considera, almeno in parte e solo a certi fini, anche il lavoro cosiddetto 'parasubordinato', cioè le forme di collaborazione, di per sé autonoma, prevalentemente personale, allorquando essa sia continuativa e coordinata dal committente (Codice di procedura civile, art. 409 n. 3).
3. La questione operaia
Durante la rivoluzione industriale, nelle manifatture e poi nelle fabbriche, andò sorgendo una nuova classe sociale, quella degli operai o proletariato, formata da persone strappate ai lavori agricoli o artigianali, il cui unico bene era la propria forza lavoro in senso materiale, posta al servizio dell'imprenditore (ma quando ciò non era possibile si determinava il dramma della disoccupazione) e da questi comandata (il datore di lavoro aveva il potere giuridico di comandare in ordine alla prestazione e alla disciplina nel luogo di lavoro, e poteva altresì sanzionare in via disciplinare le eventuali disobbedienze). La rivoluzione industriale, con la sua produzione di massa, cancellò pressoché interamente i vecchi mestieri e indusse le classi dirigenti a eliminare le vecchie forme assistenziali di soccorso al pauperismo. Si formò così una vasta 'armata di riserva' di manodopera disponibile alla quale era sempre possibile attingere, secondo la ferrea legge del rapporto tra domanda e offerta di lavoro nel mercato, con salari fissati al minimo indispensabile per la sopravvivenza. In tal modo, come notò Marx, la condizione dell'operaio moderno risultò per un certo aspetto peggiorata rispetto a quella dello schiavo dell'antichità o del servo della gleba. Il padrone doveva comunque alimentare lo schiavo affinché questo suo bene si conservasse, mentre l'imprenditore poteva, senza problemi, liberarsi del lavoratore di cui non aveva più bisogno, licenziandolo. Si ebbe così la cosiddetta 'dittatura contrattuale' dei datori di lavoro. Secondo le categorie del diritto borghese, il vincolo che legava datore e lavoratore era, formalmente, un 'libero' contratto, stipulato con il consenso del collaboratore. Ma, in concreto, le condizioni di questo contratto erano fissate dalla parte datoriale e l'operaio doveva accettarle o rinunciare al lavoro riducendosi alla disoccupazione e alla fame. Ancora oggi, del resto, le condizioni di lavoro, di norma, sono dettate unilateralmente dalla parte datoriale, in un contratto d'adesione; ma vi sono precisi limiti al potere datoriale fissati dalla legge e dalla contrattazione sindacale. Come talora è stato detto, si è almeno passati dalla monarchia assoluta a quella 'costituzionale'. Si deve poi ricordare che, per molto tempo, i lavoratori come classe furono svantaggiati anche sul piano politico. Nei regimi costituzionali a 'democrazia censitaria' il voto era limitato per ragioni di cultura e di censo (e di norma la cultura era legata al censo). In Italia, ad esempio, il suffragio universale maschile si ebbe solo nel 1913 (quello femminile nel 1946). Tutto giocava contro le classi lavoratrici, anche sul piano processuale: per il Codice Napoleonico, nel dubbio, il giudice doveva credere al padrone e non attribuire attendibilità al lavoratore.Non vi era nulla di artificiale in questa concezione, dato che essa scaturiva dalle teorie rigide del primo liberismo, secondo le quali la legge della società era quella della concorrenza degli egoismi individuali e il potere doveva essere riservato a quanti avessero vinto nella dura lotta per l'esistenza.
4. Il sindacalismo
La risposta naturale a tale situazione fu lo sviluppo delle organizzazioni sindacali, dapprima in forma di coalizioni temporanee, sorte per conflitti specifici, e poi in forma di associazioni stabili. In linea generale, il sindacato è il raggruppamento di quanti nel mondo del lavoro (lavoratori e datori) ritengono di essere accomunati da un identico interesse nei confronti della controparte, secondo lo schieramento di classe.In termini più specifici, il sindacalismo dei lavoratori nasce dalla consapevolezza dell'impotenza individuale di fronte al padrone; da qui l'imperativo di raccogliersi in un 'fascio' e di costringere gli imprenditori a trattare con l'entità collettiva. Ne deriva il contratto collettivo, cioè la regolamentazione, tra padronato e sindacato, delle condizioni di lavoro, al fine di determinare i diritti rispettivi delle parti del contratto individuale di lavoro (parte normativa) nonché i salari (i primi contratti ebbero a oggetto esclusivo la determinazione della tariffa salariale, per cui si chiamarono 'concordati di tariffa'). Lo strumento per piegare il padronato alla trattativa è lo sciopero, cioè l'astensione generale dal lavoro. Sindacato, contratto collettivo, sciopero sono i tre pilastri dell'azione dei lavoratori. Di fronte al sindacato c'è in un primo momento la singola impresa, che può ben essere parte della contrattazione (contratto collettivo aziendale); ma anche le imprese formano col tempo le loro organizzazioni sindacali: si tratta, in questo caso, di un sindacalismo di risposta a quello dei lavoratori. Dopo di che tra il sindacalismo dell'una e dell'altra sponda si stabiliscono persistenti relazioni conflittuali, nel giuoco al compromesso periodico. Si hanno, così, le relazioni industriali (espressione d'origine anglosassone); ma è meglio parlare, data la diffusione del fenomeno oltre i confini dell'industria, di relazioni sindacali.
Il sindacalismo presenta una grande varietà di strutture organizzative. In tutti i paesi, nelle prime esperienze, il sindacato fu in prevalenza di mestiere, cioè un raggruppamento di lavoratori accomunati dalla stessa qualifica professionale specifica (ad esempio i carpentieri), che operava in qualsivoglia settore dell'attività economica. Nella prima fase, per quanti avevano una qualificazione professionale precisa, fu facile organizzarsi, mentre restava esclusa la gran massa della manodopera non qualificata. Tali organizzazioni esprimevano i mestieri dell'epoca preindustriale e pertanto in ogni tipo d'industria l'imprenditorialità aveva a che fare con più organizzazioni sindacali: si componeva il conflitto con un certo sindacato e subito dopo ne sorgeva un altro con un diverso sindacato, con inevitabili complicazioni.
In una fase successiva (allorché si organizzò anche la manodopera generica) in tutti i paesi si passò a un diverso modello, ancor oggi prevalente, quello del sindacato d'industria, che raggruppa tutti i lavoratori di ogni tipo di professionalità e livello secondo i diversi settori: ad esempio metalmeccanico, tessile, ecc. Quando oggi, con formula abbreviata, parliamo di sindacato 'dei chimici' alludiamo non solo ai lavoratori che hanno competenza specifica per la chimica, ma a tutti i dipendenti dell'industria chimica: i chimici, ma anche gli impiegati amministrativi, i custodi, tutti coloro che lavorano in questo tipo d'impresa, dal più basso al più alto livello, con l'esclusione dei dirigenti, che hanno una loro specifica organizzazione sindacale. Lo stesso avviene, in Italia, per la nuova categoria dei quadri, riconosciuta con una legge del 1985. Altre organizzazioni di mestiere sono sorte ultimamente per specifiche professionalità, in dissenso con il sindacalismo tradizionale onnicomprensivo, accusato di praticare una politica egualitaria; questo è avvenuto, ad esempio, nel caso dei macchinisti delle ferrovie. Per altro verso il sindacato è una organizzazione complessa. In Italia e in Francia sussistono varie confederazioni (o centrali) divise, almeno originariamente, secondo la diversa ispirazione ideologica e, talora, anche partitica. La confederazione è un'associazione complessa, una associazione di associazioni; in essa confluiscono i diversi sindacati di categoria, ognuno dei quali ha le sue strutture territorialmente decentrate: sindacati provinciali, comunali, ecc. A livello periferico esistono orizzontalmente istanze di collegamento tra le organizzazioni periferiche dei diversi sindacati, in funzione di servizi comuni (immobili, impiegati, ecc.). In Italia, tradizionalmente, queste istanze di collegamento sono rappresentate dalle camere del lavoro. Le diverse istanze sindacali sono, ai vari livelli, agenti contrattuali, parti stipulanti della contrattazione collettiva. In Italia le confederazioni stipulano talora, per questioni generalissime che interessano tutto il mondo del lavoro (ad esempio in tema di scala mobile dei salari, v. cap. 16, o per le rappresentanze sindacali a livello d'impresa), accordi interconfederali. Agenti contrattuali massimi sono i sindacati nazionali di categoria, che stipulano, appunto, il contratto collettivo nazionale, una sorta di piccolo codice a portata normativa, con la regolamentazione delle condizioni di lavoro. Possono esservi, inoltre, contratti provinciali e, soprattutto, contratti aziendali, con delicati problemi in ordine ai rapporti tra i contratti di diverso livello. Tutto questo è costitutivo della normativa dei rapporti di lavoro; del resto, il Codice civile afferma, in linea generale, che il contratto ha forza di legge tra le parti.
5. Il sindacalismo e la legge
Quale sia in concreto la situazione del sindacalismo risulta dalla diversa qualificazione dello sciopero nei vari ordinamenti. Secondo una fortunata formula di Calamandrei, storicamente lo sciopero è stato variamente qualificato o come reato o come libertà o come diritto.Alle origini il regime fu ovunque di repressione legale; nel pieno della Rivoluzione francese la legge Le Chapelier proscrisse le organizzazioni professionali. Il delitto di coalizione (formalmente anche di serrata, cioè la sospensione dell'attività per decisione imprenditoriale a fini di lotta sindacale) fu presente nelle varie legislazioni e nei diversi codici.
Nella più arcaica concezione liberistica, infatti, il sindacalismo era valutato negativamente, come un assurdo tentativo di intralciare il libero giuoco naturale della concorrenza nei rapporti tra offerta e domanda di lavoro. Il salario era considerato un prezzo di mercato come tutti gli altri.Con tempi diversi nei vari paesi, il reato venne poi soppresso e la legge penale non considerò più tale lo sciopero: il sindacato si era imposto con la sua grande capacità di lotta. Maturò quindi una diversa concezione neoliberale (rappresentata in Italia da Einaudi) secondo cui la libertà sindacale dei lavoratori costituiva una naturale libertà di tutela degli interessi, alla pari delle altre libertà. Si passò, così, alla tolleranza legale. Non si trattava, tuttavia, di una libertà garantita in senso proprio, in quanto, sul piano del rapporto individuale di lavoro, secondo le tradizionali categorie privatistiche, era diffusa l'opinione che lo sciopero, come rifiuto del lavoro dovuto per contratto, si traducesse in inadempimento contrattuale suscettibile di sanzioni disciplinari o di licenziamento. Ma di fatto, in una situazione sindacalmente forte, queste reazioni padronali restarono solo teoriche.
Nella terza e ultima fase, formalmente compiuta in alcuni ordinamenti contemporanei (ad esempio in Italia con l'art. 40 della Costituzione, che riprese il preambolo della Costituzione francese del 1946), lo sciopero diventa diritto su tutti i piani, senza possibilità di sanzioni penali o civili.Spesso i patti di lavoro sono socialmente iniqui ed è giusto, si disse, che i lavoratori abbiano un'arma per ricondurli a equità. Solo eccezionalmente i fatti di azione diretta sono inibiti ed espongono a possibili reazioni: nel nostro ordinamento, per ragioni di sicurezza, lo sciopero è impedito nelle attività nucleari e, di recente, sono state introdotte sanzioni anche nella legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.
6. L'intervento pubblico
Negli ordinamenti contemporanei vi è un intreccio costante tra regolamentazione sindacale-contrattuale e disciplina di legge. Lungo tutto il corso dell'Ottocento vennero progressivamente approvate le diverse leggi sul lavoro, in modo però del tutto episodico e occasionale. A poco a poco gli Stati abbandonavano il dogma del non intervento in questioni economico-sociali (proclamato dall'originario liberismo assoluto) e in diverse occasioni si reputò inevitabile l'intervento statale per ragioni di ordine pubblico. Si sviluppò, così, un corpo di leggi variamente denominato come legislazione sociale, operaia ecc.In linea generale, il primo intervento fu ovunque quello a tutela delle cosiddette 'mezze forze', cioè bambini e donne. Durante la prima rivoluzione industriale questi lavoratori di ridotte capacità fisiche (anche bambini in tenera età) vennero utilizzati su larga scala e questo determinò forti preoccupazioni, soprattutto nelle diverse correnti del filantropismo sociale (molti esponenti socialisti infatti erano medici), per le ripercussioni che ciò poteva avere sulla loro salute.Successivamente, e in particolare in questo secolo, lo sviluppo della legislazione è stato ingente, e ha interessato praticamente tutti gli aspetti centrali dei rapporti di lavoro. In taluni ordinamenti, come quello italiano a partire dal 1948, la legislazione del lavoro è costituzionalmente dovuta. Per la nostra Costituzione il lavoro deve essere protetto in tutte le forme e applicazioni, lo Stato deve garantire il diritto al lavoro, una giusta retribuzione, la disciplina dell'orario, ecc.In epoca più recente è stata adottata una legislazione limitativa dei licenziamenti, per i quali si richiede un giustificato motivo che deve essere comprovato dal datore di lavoro. Nella combinazione di legge e di contrattazione sindacale, ben poco spazio resta quindi per la terza fonte regolatrice dei rapporti di lavoro, cioè per il contratto individuale.
7. La soluzione collettivistica
Tutto quanto è stato detto finora si è verificato nelle società borghesi-capitalistiche tradizionali, rimaste immutate nei loro pilastri malgrado il forte condizionamento che esse hanno subito nella direzione del benessere sociale. Per avere un quadro completo del problema, si deve aggiungere che questa evoluzione del sistema ha conosciuto delle alternative radicali, perseguite storicamente nell'ambito del filone socialcomunista, che tendevano a una piena emancipazione dei lavoratori attraverso un cambiamento del sistema stesso. Per i socialisti d'ispirazione marxista, che partivano dall'interpretazione della storia come lotta di classe, il cambiamento finale doveva verificarsi con l'integrale collettivizzazione dell'economia e con l'egemonia proletaria. Il Partito Socialista Italiano, ad esempio, si costituì a Genova nell'agosto del 1892, ponendosi l'obiettivo minimo della lotta dei 'mestieri' (cioè sindacale) nonché l'obiettivo della lotta politica per la distruzione integrale dell'ordine borghese. In quasi tutta l'Europa continentale, e in particolare nel centro e nel nord, di fatto si ebbe uno sviluppo in senso social-democratico-riformista, grazie alla diffusione di potenti movimenti sindacali legati a forti partiti presenti con rappresentanti sempre più numerosi nelle aule parlamentari e orientati verso una politica gradualistica dei piccoli passi. Un cambiamento radicale si ebbe nell'ex impero zarista con la Rivoluzione dell'ottobre 1917 e l'avvento al potere, in forme dittatoriali, del partito comunista bolscevico. L'economia venne pressoché interamente collettivizzata, con la motivazione che ora i lavoratori erano al governo. Nell'ambito dell'economia pianificata venne meno il sindacalismo con le sue funzioni tradizionali. I salari costituivano solo, ovviamente, un capitolo del piano economico quinquennale; inoltre, essendo il partito della classe operaia al governo, lo sciopero non aveva più ragion d'essere. I sindacati sopravvissero come 'cinghie di trasmissione' tra il partito e le masse; a essi vennero conferite funzioni importanti di gestione del sistema previdenziale. Dopo il secondo conflitto mondiale questo modello venne esteso di massima alle 'democrazie popolari' dell'Est e si affermò poi in tutti i paesi a egemonia comunista. Com'è noto questo sistema è crollato nel 1989. Ora in quei paesi si va, confusamente e con molte tensioni, verso la privatizzazione dell'economia e verso il mercato. Sono tornati i sindacati in senso tradizionale ed è tornato, di fatto, lo sciopero. È una evoluzione in corso, di cui non è facile prevedere gli sbocchi.
8. L'alternativa corporativistica
Nel tentativo di risolvere la questione sociale è stata anche praticata un'altra alternativa volta ad affermare la collaborazione di classe in luogo della lotta. Prima di descrivere brevemente le diverse soluzioni organiche, occorre ricordare che vi sono sempre stati, nell'ambito dei più diversi filoni ideologici, anche in quello di un liberalismo socialmente illuminato, numerosi tentativi orientati a eliminare, o quanto meno a ridurre, l'antagonismo di classe: ad esempio associando i lavoratori (e le loro organizzazioni rappresentative) alla gestione delle aziende (nella convinzione che se i rappresentanti del lavoro avessero partecipato ai consigli di amministrazione si sarebbero resi conto dei vincoli economici alle contrattazioni); oppure dando vita all'azionariato operaio, cioè facendo diventare i lavoratori compartecipi del capitale. Si potrebbe anche ricordare il contributo di Mazzini ("capitale e lavoro nelle stesse mani"), ma le soluzioni organiche tentate sono state quella cattolica e quella autoritario-fascista. La scuola cristiano-sociale (espressa nelle encicliche Rerum Novarum di Leone XIII e Quadragesimo Anno di Pio XI) partiva da una denuncia dei mali sociali indotti dal capitalismo liberista non meno violenta di quella dei socialisti, imputando ai liberali di aver dimenticato che l'uomo, oltre che cittadino, è anche produttore, concretamente inserito in un tessuto di corpi intermedi. Si riconosceva la piena legittimità della tutela degli interessi di categoria e, quindi, del sindacato; i conflitti del lavoro però non dovevano degenerare nelle forme rovinose della lotta di classe contro l'interesse generale superiore e doveva essere istituita una magistratura del lavoro per affrontarli pacificamente. I teorici di questo corporativismo (ad esempio Giuseppe Toniolo) rispolveravano quello medievale. Infine si auspicava, sul piano costituzionale, l'introduzione di un senato rappresentativo delle professioni e delle autonomie accanto alla camera politica. Questa scuola, tuttavia, non tradusse mai in realtà le sue idee (fatta eccezione, forse, per l'esperimento Dollfuss, in Austria, tra le due guerre). Diverse forme di attuazione ebbe invece, nello stesso periodo, il corporativismo d'ispirazione nazionalistico-autoritaria di destra; ma con non trascurabili differenze tra i diversi paesi. Antesignana fu l'esperienza fascista italiana. Come nel caso dei cristiano-sociali, queste esperienze intesero superare sul piano ideologico i due estremismi, ritenuti egualmente negativi, del liberalismo e del socialismo; anch'esse ricercarono, nella collaborazione tra le classi, il perseguimento dell'interesse superiore della nazione e dello Stato: una via intermedia che intendeva riaffermare l'assetto privatistico-proprietario ma con un incisivo condizionamento sociale. Si ebbe una prima fase esclusivamente sindacale e una seconda definita più propriamente corporativa.
Nell'aprile del 1926 venne varata la fondamentale legge Rocco e nel 1927 il Gran Consiglio del Fascismo approvò la Carta del lavoro, che esprimeva i principî generali dell'ordinamento, tradotti poi sul piano giuridico da una successiva legge del 1941. Secondo tali principî, l'inquadramento collettivo delle categorie veniva realizzato dall'alto, attraverso provvedimenti ministeriali, ma si ammetteva il riconoscimento giuridico di una organizzazione sindacale per ogni categoria. Più precisamente, pur venendo riaffermata la libertà sindacale sul piano teorico e quindi una possibile pluralità di organizzazioni, il governo poteva del tutto discrezionalmente riconoscere un solo sindacato; requisito sufficiente e necessario era la rappresentatività di almeno il 10% della categoria (quindi non la maggioranza) e il fatto che l'organizzazione fosse diretta da uomini di "sicura fede nazionale" (cioè fascista); nel contempo, i precedenti sindacati liberi venivano sciolti. Il sindacato riconosciuto acquisiva la personalità giuridica di diritto pubblico (con soggezione al controllo sugli atti da parte degli organi di governo) e quindi si vedeva riconosciuta la rappresentanza legale della categoria. In ragione di questa rappresentatività esclusiva, il contratto collettivo diveniva generalmente obbligatorio; mentre nel contratto individuale erano possibili pattuizioni difformi rispetto al contratto collettivo solo se più favorevoli al lavoratore (Codice civile, art. 2077). La pubblicistica del regime esaltò questa 'conquista', a seguito della quale si affermava che era stato raggiunto un risultato che le vecchie democrazie parlamentari avevano invano perseguito.
Per la risoluzione dei conflitti collettivi di lavoro era inibito, invece, il ricorso allo sciopero e alla serrata, che tornavano a essere reati; in caso di conflitto si doveva far ricorso alla magistratura del lavoro, che poteva emanare una sentenza sostitutiva del contratto collettivo mancato.La fase cosiddetta corporativa, iniziata formalmente nel 1930 e mai giunta a conclusione (come fu ufficialmente riconosciuto), mirava alla realizzazione di un obiettivo più ambizioso: la programmazione dell'economia non secondo il modello dirigistico sovietico, ma sulla base dell'autogoverno dei produttori, anche se subordinato all'interesse superiore. Più precisamente, per ogni settore dell'economia i vari sindacati sarebbero stati collegati in un'entità di diritto pubblico, la corporazione, che poteva regolamentare le varie attività emanando ordinanze corporative. Le corporazioni vennero costituite nel 1934, ma furono scarsamente incisive; successivamente venne soppressa la vecchia Camera dei deputati e in suo luogo, nel 1939, venne costituita la 'Camera dei fasci e delle corporazioni', che riuniva i due massimi organi direttivi del partito e delle corporazioni; chi occupava certe cariche era automaticamente consultore nazionale, per il principio della rappresentanza 'istituzionale' (in base al quale colui che occupa certe posizioni è automaticamente rappresentativo).Il modello italiano venne largamente ripreso dal Portogallo, sotto la dittatura di Salazar. Seguì l'esperienza spagnola del franchismo, ma con notevoli differenze rispetto all'originale; ad esempio la contrapposizione di classe, formalmente mantenuta nel modello italiano, venne eliminata in Spagna con il sindacato misto, che raggruppava insieme datori di lavoro e lavoratori.
Ideologicamente ispirata a questi principî fu anche l'esperienza nazionalsocialista, peraltro assai diversa sul piano istituzionale. In Germania tutti i vecchi sindacati vennero soppressi e non vennero sostituiti da organizzazioni legate al regime. Il Fronte Tedesco del Lavoro era una colossale organizzazione non sindacale, che raggruppava datori e lavoratori con compiti propagandistici e dopolavoristici. Tutto venne impostato rigidamente secondo il Führerprinzip. Al vertice del sistema c'era il Führer con i suoi ministri; non erano ammesse entità antagonistiche, in quanto non era possibile incrinare il principio dell'unità totalitaria. Nelle imprese il datore di lavoro, assistito soltanto da un 'consiglio di fiducia' reclutato fra il personale, era egualmente il capo, subordinato al governo ma con pienezza di poteri sui lavoratori.Tentativi di soluzione corporativa furono attuati, sempre tra le due guerre, in altri paesi europei a regime autoritario e anche altrove: si pensi, ad esempio, al Brasile di Vargas. Nel secondo dopoguerra, inoltre, si affermò in Argentina il regime di Peron, con sue specifiche particolarità.
9. L'evoluzione inglese
L'Inghilterra ha conosciuto per prima lo sviluppo del sindacalismo (con le Trade Unions: unioni di mestiere), in quanto in questo paese, già nel Settecento, la rivoluzione industriale cominciò a svilupparsi in proporzioni imponenti (al punto che l'agricoltura diventò marginale nell'ambito del sistema economico complessivo).Già nel 1824-1826 vennero approvate leggi che attenuarono un poco il regime di repressione legale del sindacalismo. Da allora lo sviluppo sindacale fu inarrestabile; inoltre, intorno agli anni sessanta del secolo scorso si attuò per la gran parte il passaggio dal sindacato di mestiere a quello d'industria (anche se la prima formula è sopravvissuta). Con le leggi del 1871 (Trade Union act) e del 1875 (Conspirancy and protection of property act) sul piano penalistico si determinò il passaggio alla tolleranza legale del sindacato; questa trasformazione avvenne, singolarmente, a opera di una maggioranza conservatrice nell'ambito di una contrapposizione elettorale con i liberali. Merita sottolineare con quale tecnica si sia attuato questo passaggio nel particolare contesto del diritto britannico. In un paese che non aveva e non ha costituzione scritta e dove impera la common law, la riforma si realizzò in termini di immunità dalle possibili interferenze statuali-legali; nel senso che, rispetto ai fatti di azione diretta in ambito sociale, la legge negava la possibilità di azione in giudizio; i sindacalisti, cioè, non potevano più essere incriminati per i loro specifici comportamenti.
Si ebbe così lo sviluppo del diritto del lavoro, caratterizzato da un basso tasso di regolamentazione legislativa, più accentuato solo rispetto a taluni aspetti (ad esempio la tutela delle 'mezze forze') e arricchito attraverso la contrattazione collettiva, che pure non era nemmeno essa formalmente riconosciuta nell'ordinamento. Il contratto collettivo non prevedeva sanzioni legali, ma valeva di fatto, come 'contratto tra gentiluomini', il cui rispetto era legato alla forte presenza delle organizzazioni sindacali. Strumento specifico dell'egemonia sindacale furono le cosiddette clausole di sovranità sindacale (largamente diffuse anche nel diritto statunitense): clausole di varia intensità cogente, con l'obbligo per il datore di lavoro di assumere solo lavoratori iscritti al sindacato o con l'obbligo per i lavoratori dell'impresa di iscriversi al sindacato entro un certo termine, pena il licenziamento. Da queste clausole derivarono controversie che si sono trascinate fino a epoca recente.
Immediatamente dopo si aprì un nuovo capitolo sul piano dei rapporti tra sindacalismo e legge. Se non era più possibile, di massima, perseguire penalmente per i fatti d'azione diretta, era tuttavia possibile, secondo i principî della common law, agire civilmente contro il sindacato promotore dello sciopero, proponendo azione risarcitoria per i danni conseguenti all'ingiustificata 'rottura' degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Si sviluppò pertanto una massiccia offensiva giudiziaria (ad esempio l'affare Taff Vale), che ottenne dai giudici numerose sentenze di condanna di facile esecuzione sul non irrilevante patrimonio delle Unioni. Si decise allora di agire sul piano politico-parlamentare, cercando di far approvare una legge che riconoscesse l'immunità sindacale anche sul piano civile. In occasione delle elezioni del 1900 vennero eletti alcuni deputati legati ai sindacati e poco dopo venne costituito il Partito Laburista: un partito con caratteristiche peculiari formato non solo attraverso adesioni individuali, secondo il modello continentale (partito 'territoriale'), ma soprattutto grazie all'affiliazione dei sindacati, nonché di altre organizzazioni del lavoro. In quanto tale, questo partito raggruppava formalmente milioni di aderenti (che erano individualmente liberi di votare per uno degli altri due partiti, il conservatore e il liberale). Si ebbe così, senza alcun ideologismo, il partito del lavoro, caratterizzato da un legame organico col sindacalismo che solo recentemente è venuto meno. La battaglia venne vinta e con una legge del 1906 (Trade disputes act) vennero 'tagliate le unghie' alla magistratura.
Successivamente sorse una questione legale in ordine alla liceità o meno del finanziamento sindacale del partito politico. Un operaio, certo Osborne, fece causa per impedire al sindacato di versare parte della sua contribuzione al partito. Venne quindi approvata una legge, nel 1913, che legalizzò tale forma di finanziamento, prevedendo tuttavia la facoltà individuale di sottrarvisi. A questo punto il sistema britannico di 'democrazia industriale' era consolidato, arrivando spesso a costituire un modello per gli stranieri (ad esempio nella teorizzazione di Luigi Einaudi).Pochi cenni sugli sviluppi successivi. A seguito del grande sciopero del 1926 nel settore del carbone, l'anno successivo venne emanata una legge 'antisindacale', che prevedeva talune restrizioni per il diritto di sciopero e altre limitazioni. Il Partito Laburista, vittorioso nel 1945, per 'onor di firma' fece abrogare la legge del 1927, anche se per diversi anni, nel difficile periodo del dopoguerra, venne istituito l'arbitrato obbligatorio per i conflitti di lavoro con proibizione dello sciopero. Si tornò poi alla normalità, ma reiteratamente, sia coi governi conservatori che con quelli laburisti, le relazioni industriali furono rimesse in discussione, in particolare sul punto decisivo della politica dei redditi. Infine con il governo conservatore degli anni ottanta, nel quadro di declino della potenza britannica, il sistema è profondamente cambiato, con decisivi interventi legislativi che hanno scalzato l'antica egemonia dell'unionismo, riportando il sistema verso il modello continentale.
L'evoluzione nordamericana
Nella grande democrazia nordamericana il sindacalismo e il diritto del lavoro si sono sviluppati tardivamente, non già per un ritardo della rivoluzione industriale, ma a causa di altri specifici fattori; in particolare perché, fino alla fine dell'Ottocento, vi era la 'frontiera aperta' dall'Atlantico verso il Pacifico. Offrendo la possibilità di spostarsi per acquisire nuove terre, essa costituiva la grande valvola di sfogo di tutte le potenziali tensioni sociali, in una situazione caratterizzata da un naturale individualismo.Un ruolo importante ebbe anche la struttura federale, nel giuoco delle competenze tra i singoli Stati e la Confederazione; quest'ultima era costretta a cercare di far passare i primi interventi di legislazione sociale tra le maglie strette della competenza federale. I primi interventi a favore delle 'mezze forze' furono pertanto presentati come atti tesi a disciplinare il commercio 'interstatale', nel senso che la Confederazione poteva inibire la circolazione dei prodotti provenienti da fabbriche ove era diffuso uno sfruttamento indiscriminato di queste forze.
Solo sul finire dell'Ottocento si ebbe un certo sviluppo del sindacalismo. A parte l'azione pionieristica e presindacale dell'associazione detta dei 'Cavalieri del lavoro', costituitasi nel 1869, solo nel 1881 si costituì la Federazione Americana del Lavoro come centrale dei sindacati di mestiere. Nel 1938 si ebbe una scissione che portò alla costituzione del Congresso delle Organizzazioni Industriali (CIO), basato sulla diversa formula organizzativa del sindacalismo d'industria; successivamente le due centrali si sono collegate tra loro. La caratteristica specifica del sindacalismo statunitense è la neutralità ideologica: mentre in Europa il sindacalismo è sempre stato variamente collegato a partiti politici, in America il movimento ha sempre accettato l'ideologia corrente della libera impresa e del mercato. Ma questo non significa totale disimpegno politico. Posto che dei due partiti tradizionali, il repubblicano e il democratico, il secondo ha una maggiore attenzione per il mondo del lavoro, il sindacalismo solitamente lo appoggia secondo la parola d'ordine 'aiutare gli amici e punire i nemici', cioè far eleggere possibilmente parlamentari favorevoli al mondo del lavoro e boicottarne gli avversari. Anche negli Stati Uniti si ebbe un lungo periodo di repressione legale dell'attività sindacale, seguito poi da un graduale passaggio alla tolleranza, seppure nella decisa opposizione del mondo imprenditoriale, che spesso cercò di dar vita a forme rappresentative del personale poste sotto il suo controllo (company unions o sindacalismo 'giallo').
Dopo alcuni interventi ispirati alla tolleranza, soprattutto per inibire o contenere la pratica delle ingiunzioni giudiziarie antisindacali (come la legge Norris-La Guardia del 1932, a seguito della grande crisi del 1929), la svolta decisiva si ebbe col New Deal di Roosevelt e col riconoscimento della libertà d'azione sindacale. Ma un primo intervento in questo senso si scontrò con l'opposizione della Corte Suprema, per cui il Presidente reagì minacciando una diversa composizione della Corte medesima. Si arrivò così alla legge Wagner del 1935, secondo la quale i lavoratori erano chiamati a esprimere in libere votazioni la loro volontà in materia, nell'ambito di units discrezionalmente determinate in vario modo (al livello di singola azienda, a diverso raggio territoriale, di categoria) dall'Amministrazione. In base a tale legge, i lavoratori possono rifiutare il sindacato preferendo la libertà del contratto individuale, oppure possono conferire la rappresentanza a un sindacato che ne ha l'esclusiva per un periodo predeterminato e che deve essere accettato dalla controparte datoriale. Nel 1947 si ebbe poi la legge Taft-Hartley, a carattere nettamente restrittivo; ultimamente si è avuta una svolta in senso nettamente liberistico durante la presidenza Reagan, mentre è ancora in via di realizzazione la virata impressa dall'attuale amministrazione Clinton.In quest'immenso paese il sindacalismo è stato ed è egemone solo in aree ristrette, mentre nel complesso il grado di sindacalizzazione è assai più basso della media europea.
Il Giappone
Un breve cenno merita l'esperienza giapponese, così lontana da quella occidentale. Formalmente il Giappone riconosce la libertà sindacale con le sue tipiche manifestazioni; di fatto, vi sono però alcune peculiarità che fondamentalmente non hanno base in testi formali di legge, bensì nella concezione sociale diffusa in un paese in cui il sottofondo feudale-patriarcale è tuttora presente. Vi è una netta distinzione tra la manodopera assunta in forma stabile e il precariato. Di norma, per la copertura dell'organico permanentemente necessario, i lavoratori assunti, salva l'ipotesi della giusta causa, restano in servizio per tutta la vita, fino al pensionamento, in un rapporto di fedeltà all'impresa; vi è poi la grande massa della manodopera precaria e fluttuante, utilizzata a seconda dell'andamento della congiuntura. In sostanza siamo quindi in presenza di un contesto in cui domina l'ideologia comunitaria e solidaristica. Secondo lo stesso ordine d'idee, le imprese sogliono assumere, una volta all'anno, una certa aliquota di lavoratori, anche se non suscettibili di utile impiego nell'immediato. Sotto questo aspetto l'impresa opera come istituzione sociale. Anche altrove, del resto, al di là del dato formale, si risente l'influsso di convinzioni radicate nel comune sentire. In Germania, ad esempio, domina tuttora la convinzione che i pubblici dipendenti, in quanto al servizio della nazione, debbano di massima astenersi dallo sciopero.
L'evoluzione nel continente europeo
In tutti i paesi dell'Europa occidentale e settentrionale si è avuto lo stesso processo di avanzata del sindacalismo e di incremento della legislazione sociale. Specialmente nella prima fase, il sindacalismo fu spesso diviso in centrali di diversa ispirazione ideologica: socialdemocratica, socialcristiana e talora liberale, come nel caso della Germania imperiale. Un incremento particolarmente rilevante della legislazione sociale si ebbe nella Germania di Weimar tra le due guerre; un incremento che aveva come punto di riferimento la Costituzione del 1919 con la sua larga ispirazione sociale, anche se restava inattuato il disegno di combinare armoniosamente il parlamentarismo d'ispirazione liberale con la strutturazione consiliare in materia economico-sociale.Marcate sono state, e in parte sono tuttora, le differenze tra i paesi latini e gli altri. In Francia, in Italia e anche in Spagna il sindacalismo è più nettamente diviso secondo l'ispirazione ideologica; nel primo paese fu a lungo egemone nella CGT il sindacalismo rivoluzionario teorizzato da Sorel. In questo paese il sindacato non ha mai avuto un forte livello di rappresentatività e ciò ha determinato talora conflitti tra base e apparato. Il sindacalismo dei paesi latini è generalmente più turbolento, come risulta in particolare dalle modalità dello sciopero: di norma si ricorre infatti allo sciopero articolato, a singhiozzo (alternando astensione dal lavoro e ripresa, almeno formale, dello stesso), a scacchiera (a turno tra i vari reparti) o altrimenti in varia combinazione, con l'obiettivo di disorganizzare al massimo la produzione, col minimo danno per i lavoratori in termini di riduzione retributiva. Tutto questo ha determinato aspri dibattiti dottrinari, e soprattutto giurisprudenziali, in merito alla distinzione tra forme lecite e non di azione diretta.
Nei paesi nordici la situazione è del tutto diversa. Il sindacalismo è forte e compatto ed è in genere collegato ai partiti socialdemocratici, che in molti casi guidano anche il governo, e ha al suo attivo imponenti realizzazioni di tutela sociale. Secondo quanto emerge in larga parte della pubblicistica, in questi casi saremmo in presenza di un sistema 'neocorporativo' o 'neocorporato', basato sul confronto e l'accordo tra il governo e le parti sociali fortemente istituzionalizzate sul piano associativo, dove la pace negli ambienti di lavoro è normale e la lotta eccezionale.
Previdenza e sicurezza sociale
Parallelamente al processo descritto si è andata sviluppando ovunque la previdenza sociale, istituto che fa parte in senso lato del diritto del lavoro. Oltre al posto di lavoro e a una giusta retribuzione, occorre garantire una tutela per il lavoratore ammalato, vittima di un infortunio del lavoro o collocato a riposo per l'età avanzata. Il sistema al quale si è fatto ricorso è quello della previdenza sociale basata sull'assicurazione obbligatoria. A questo fine vengono creati istituti ad hoc; datori di lavoro e lavoratori debbono obbligatoriamente versare all'ente preposto al settore contributi proporzionali alle retribuzioni; se si verifica uno degli eventi considerati (infortunio, malattia, pensionamento, ecc.), l'ente verrà chiamato a erogare prestazioni sanitarie e prestazioni economiche periodiche (pensioni o rendite).
Il sistema si sviluppò organicamente negli ultimi decenni dell'Ottocento nei paesi di lingua tedesca. Bismarck combinò politicamente le leggi antisocialiste e la Kulturkampf, vanamente sperimentate contro socialdemocratici e cattolici, con una forte politica previdenziale che, in un disegno organico, prese l'avvio con apposite istituzioni per la tutela in caso di malattia (istituzioni che vennero conservate, dopo la prima guerra mondiale, nelle provincie redente conquistate dall'Italia). In questo modo, nei paesi di lingua tedesca, i governi si garantirono la fedeltà delle masse lavoratrici alle istituzioni, come si poté verificare nel primo e nel secondo conflitto mondiale.
Questa politica ebbe ulteriori impulsi nel secondo dopoguerra, in particolare, a partire dal 1945, nell'Inghilterra a governo laburista, dove ebbe corso il programma di protezione di Beveridge, detto 'dalla culla alla bara'. In alcuni casi si passò dal sistema di previdenza a quello di sicurezza sociale: mentre nella previdenza la tutela era riservata, specialmente alle origini, ai lavoratori in senso stretto, la sicurezza intende tutelare il cittadino (e anche lo straniero) in quanto tale, a prescindere dalla sua collocazione nel mondo del lavoro. Un esempio di sicurezza sociale si è avuto, almeno formalmente, in Italia, con l'istituzione nel 1978 del Servizio Sanitario Nazionale garantito a tutti (e con questo non siamo più nell'ambito del diritto del lavoro, ma in quello del diritto amministrativo). Il prodotto di queste evoluzioni è il Welfare State, o Stato del benessere, recentemente entrato in crisi per la constatata impossibilità di poter garantire tutto a tutti. In questo contesto è stato talora adottato il 'salario di cittadinanza', in base al quale il soggetto ha diritto a una tutela economica, anche se non collocato nel mondo del lavoro.
L'evoluzione italiana
In Italia lo sviluppo del sindacalismo operaio in senso proprio si ebbe solo a partire dall'ultimo decennio dell'Ottocento, in quanto soltanto allora si verificò un sia pur limitato sviluppo industriale. Prima di tale data vi erano stati movimenti popolari non direttamente legati alla classe operaia, di diversa ispirazione ideologica: dapprima il filantropismo moderato, poi i mazziniani e quindi l'anarchismo internazionalista. In Italia, anzi, venne prima creato il partito della classe operaia e poi il sindacato: infatti il Partito Socialista si costituì a Genova nell'agosto del 1892, mentre la Confederazione Generale del Lavoro, sempre d'ispirazione socialista, si costituì nel 1906. Accanto al sindacalismo socialista si formò poi quello d'ispirazione cattolica e quello estremista dei sindacalisti rivoluzionari.
Il primo periodo fu caratterizzato, anche in Italia, dalla repressione legale. Il Codice penale sardo del 1859, primo dell'Italia unita (fatta eccezione per la Toscana, che conservò il più illuminato codice del 1853), puniva scioperi e (in teoria) serrate. Il Codice Zanardelli del 1889 non contemplava più esplicitamente i reati di azione diretta. Dopo i tumultuosi eventi dell'ultimo decennio, caratterizzati da turbative dell'ordine pubblico (Fasci siciliani, fatti della Lunigiana del 1894 e di Milano del 1898) e dalla prospettiva politica del sonniniano 'ritorno allo Statuto' non parlamentare del 1848, con l'avvento del neoliberalismo, rappresentato da Giolitti e teorizzato da Einaudi, ci si avviò alla tolleranza, al libero sviluppo dei sindacati e alla prima contrattazione collettiva. Si ebbero così le prime leggi sociali per le 'mezze forze' e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1898 e 1904). Si posero anche le fondamenta del diritto del lavoro in senso stretto, attraverso l'esperienza giurisprudenziale dei probiviri. Nelle diverse categorie, in base a una legge del 1893, si potevano costituire collegi eletti da datori di lavoro e lavoratori con presidente imparziale, con il compito di risolvere i conflitti del lavoro. Poiché questi giudici non avevano a disposizione leggi specifiche, dovevano giudicare secondo equità. Attraverso il ripetersi dei lodi (nel primo periodo studiati organicamente da Enrico Redenti), si vennero precisando delle regole in realtà nuove, che costituirono i primi elementi di un nuovo diritto. Solo nell'ultimo scorcio dell'età liberale si ebbe la prima legge organica sul rapporto di lavoro; organica, ma parziale, perché riferita solo agli impiegati (1919 e 1924).
Allo Stato liberale subentrò il corporativismo fascista, di cui si è già detto (v. cap. 8). Oltre alla disciplina giuridica del sindacalismo secondo i principî fascisti, durante il ventennio vennero anche emanate molte e importanti leggi in materia di lavoro: ad esempio sull'orario di lavoro, sul riposo settimanale, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, ecc., alcune delle quali sopravvivono tuttora. Nel 1942, col nuovo Codice civile, si ebbe la prima organica regolamentazione del rapporto individuale di lavoro, che non fu però di tipo corporativo ma, nella sostanza, liberale, in quanto consacrava la piena libertà di licenziamento (mentre il franchismo spagnolo aveva coerentemente introdotto la regola del giustificato motivo). Venne altresì completato l'edificio della previdenza sociale, allorché si aggiunse all'assicurazione contro gli infortuni quella per invalidità, vecchiaia e superstiti e quella per le malattie (1943). Caduto il fascismo, si tornò al libero sindacalismo, in un primo momento organizzato unitariamente per l'accordo delle tre grandi correnti: comunista, democristiana e socialista. A partire dal 1949, il movimento sindacale si divise nuovamente in tre centrali, CGIL, CISL, UIL, e in altre organizzazioni autonome in conseguenza della guerra fredda e della dura contrapposizione in atto col Partito Comunista. Riprese anche la contrattazione collettiva ma, non essendosi attuata la previsione costituzionale (art. 39) circa il riconoscimento del sindacato e l'efficacia generalizzata dei contratti stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi, si concluse che il contratto cosiddetto 'di diritto comune' valeva solo per le imprese sindacalmente affiliate. L'impatto sociale negativo di questa conclusione venne attenuato attraverso la consolidata giurisprudenza sulla giusta retribuzione, ai fini della determinazione del salario, facendo i magistrati riferimento alle tariffe sindacali. L'esercizio dello sciopero, garantito dalla Costituzione come diritto, non conobbe alcuna restrizione.
Nel primo quindicennio postbellico non vi furono significative evoluzioni del diritto del lavoro: erano i tempi difficili della ricostruzione, caratterizzati dal contenimento dei salari praticato spontaneamente dalle parti sociali (vi fu un accordo interconfederale in questo senso, definito specificamente 'di tregua salariale'). Le decisioni in materia salariale vennero avocate alle confederazioni e solo nel 1954 venne ripristinata la competenza dei sindacati di categoria.
La situazione si mise in movimento a metà degli anni cinquanta con il cosiddetto 'miracolo economico', durante il quale divenne prevalente l'economia industriale e si verificarono grandi spostamenti di manodopera dal sud al nord. Nel decennio successivo, nella stagione politica del centro-sinistra che vide l'accesso dei socialisti al governo, cominciarono a raccogliersi i frutti di alcune grandi inchieste parlamentari degli anni cinquanta sulla disoccupazione, sulla miseria e, in generale, sulle condizioni dei lavoratori. Del 1962 è la legge che limita la possibilità di assunzioni a termine; del 1963 è quella sul divieto di licenziamento della donna a causa di matrimonio. Nel giugno del 1965 la Corte Costituzionale statuisce la non decorrenza della prescrizione dei diritti in costanza di rapporto (allorquando - si preciserà poi - non vi siano adeguate garanzie contro il licenziamento arbitrario). Finalmente, nel luglio 1966, viene emanata la legge che introduce la regola del giustificato motivo per i licenziamenti individuali; ma tale tutela opera solo nei confronti dei datori di lavoro che occupano più di 35 dipendenti (le piccole e piccolissime unità sono privilegiate) ed è una tutela debole: in pratica il datore se la cava pagando una penale oscillante tra 5 e 12 mensilità di retribuzione.
Dal 1962, oltre alla tradizionale contrattazione collettiva a livello nazionale di categoria, comincia la pratica della contrattazione articolata a livello di azienda o di gruppo. A partire da tale data la conclusione del conflitto a livello nazionale non garantisce affatto la pace in azienda dove, anzi, il conflitto spesso si riaccende aprendo un capitolo dei più tormentati. Illustri giuristi affermano che il contratto collettivo obbliga solo gli imprenditori, mentre lascia liberi i lavoratori di riprendere il conflitto a qualsiasi livello per ulteriori rivendicazioni. È nello stesso periodo che viene enunciata la teoria del salario 'variabile indipendente', in base alla quale si deve corrispondere ai lavoratori la retribuzione sufficiente, quali che siano le condizioni delle imprese e dell'economia in generale.
Sopravviene quindi la contestazione e l'autunno 'caldo' del 1969, con lotte sindacali di notevole durezza che vanno spesso oltre il limite della legalità; le violenze contro i crumiri, specie tra gli impiegati, sono all'ordine del giorno. In questo clima viene varata la legge sullo Statuto dei diritti dei lavoratori, emanata nel maggio 1970. Questa legge fondamentale, in sé di ottimi principî, ma stravolta nelle applicazioni prevalenti, da una parte garantisce il rispetto della personalità morale del lavoratore nell'ambito dei rapporti di lavoro, dall'altra prevede la costituzione in azienda di un vero e proprio 'contropotere sindacale', con la formazione di rappresentanze sindacali nell'ambito dei sindacati affiliati alle confederazioni maggiormente rappresentative e con una serie di diritti conseguenti (ad esempio di assemblea, di permessi e aspettative), e col prelevamento dei contributi sindacali sulle retribuzioni, cosicché il datore diventa un comodo esattore per conto delle organizzazioni. Ne segue una sorta di abusivismo a livello di massa, mentre l'assenteismo giustificato con compiacenti certificazioni mediche tocca punte elevate. La bilancia dei rapporti si è ormai del tutto spostata.Il ciclo si conclude nel 1973 con la legge sul processo del lavoro, demandato al pretore giudice monocratico, con la normale efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e con la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro. Sul piano della contrattazione collettiva il ciclo del 1973 è segnato dall'inquadramento unico retributivo delle diverse categorie (impiegati, intermedi, operai); quello del 1976 per l'introduzione dei diritti d'informazione, cioè l'obbligo per la parte imprenditoriale di comunicare periodicamente alla parte sindacale numerose informazioni. Questa richiesta, formulata inizialmente in chiave di ulteriore e accentuata conflittualità, poi, invece, nella crisi presto sopravvenuta, è sembrata piuttosto favorire possibili sviluppi concertativi e partecipativi nella gestione delle aziende.
La crisi e le sue implicazioni
La situazione comincia a cambiare dapprima con la crisi petrolifera del 1973 e quindi con le successive ondate di una recessione che dopo venti anni non ha ancora esaurito i suoi effetti. Mentre continua l'onda lunga ispirata, anche per forza d'inerzia, dalla precedente impostazione del movimento, l'intero assetto dei rapporti di lavoro viene rimesso in discussione o da destra o in forma autocritica. Si lamenta autorevolmente che l'impresa sia irretita e impacciata da 'lacci e laccioli' derivanti dalla rigidità del fattore lavoro. In tutti i paesi si caldeggia la flessibilità nella gestione della forza lavoro, mentre si depreca ogni vincolismo eccessivo. Ovunque si invoca una deregolamentazione delle condizioni di lavoro (il che porterebbe in pratica alla fine del diritto del lavoro) o quanto meno una larga delegificazione della materia, mentre si auspica che la legge lasci degli spazi agli aggiustamenti possibili con la contrattazione sindacale.
Negli stessi anni comincia a crescere la disoccupazione, alla quale, almeno in Italia, si pone riparo con l'utilizzazione sempre più intensa della 'cassa integrazione'; una cassa gestita dall'INPS, che eroga una sostanziosa indennità nel caso di sospensione del lavoro o di riduzione dell'orario (di fatto molti lavoratori sono rimasti in cassa integrazione per anni e si sono verificati perfino casi di imprese 'fantasma', esistenti cioè solo sulla carta, create esclusivamente ai fini della formale imputazione di rapporti di lavoro inesistenti, e quindi come presupposto della tutela).
La legislazione e la contrattazione si sono mosse e si muovono in vario modo per tamponare la crisi: tutte le occasioni di occupazione sono comunque coltivate; le possibilità di contratti a termine sono cresciute, e si è infine consentito che la contrattazione collettiva preveda ulteriori casi oltre quelli stabiliti dalla legge. Inoltre, superando l'ostilità sindacale che ha sempre preferito il lavoro a tempo pieno, si ammette formalmente il contratto a tempo parziale; si introducono i contratti di solidarietà, con i quali i lavoratori accettano riduzioni di orario, con proporzionale riduzione del salario al fine di evitare i licenziamenti collettivi, contratti sostenuti da forti incentivi garantiti dallo Stato. Nel contempo si proclama la volontà di una svolta partecipativa che, coinvolgendo le organizzazioni dei lavoratori nella gestione delle aziende, favorisca un costruttivo dialogo sociale, in un sistema complessivo di compromesso a tre: tra parti sociali contrapposte e parte pubblica.Infine, con la legge 146 del 1990, si disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dannoso per la collettività e quindi anche per i lavoratori. In questo settore la legge prescrive attualmente tre regole: preavviso minimo di 10 giorni; comunicazione della durata dello sciopero; assicurazione, in ogni caso, delle prestazioni indispensabili per garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell'utenza. Per garantire l'equo contemperamento nel rispetto dei principî della legge, si è costituita una Commissione di garanzia.
Il costo del lavoro
Negli ultimi anni si è lamentato da più parti che il costo del lavoro è eccessivo, anche perché comprende una contribuzione previdenziale mediamente pari a circa il 50% dei trattamenti retributivi. I tentativi di risposta a tale problema costituiscono un capitolo particolarmente aspro e controverso in questa lunga fase di assestamento del diritto del lavoro, che dura ormai da vent'anni. Si è seguita, in generale, una politica di contenimento del costo del lavoro, che ha ottenuto qualche risultato. Nel 1976, ad esempio, vennero praticamente confiscati in buoni del tesoro, per due anni, gli aumenti retributivi per i livelli più elevati. Un accordo interconfederale incise poi sull'ammontare dell'indennità di anzianità; ne derivò una controversia nella quale ebbe modo di interloquire anche la Corte Costituzionale. L'intera materia venne disciplinata, nel 1982, da una nuova legge che sostituì alla vecchia indennità un nuovo istituto, il 'trattamento di fine rapporto', assai meno oneroso per le imprese.Per molti anni si è anche trascinata la vertenza relativa al meccanismo di rivalutazione automatica dei salari, detto della 'scala mobile', istituito per neutralizzare le conseguenze dell'inflazione. Si seguiva l'andamento dei prezzi per la famiglia tipo e ciò comportava periodicamente l'aumento in scatti dell'indennità di contingenza. Questo meccanismo, che alimentava ulteriormente l'inflazione, è stato definitivamente abolito nel 1992-1993. Ora si prevede solo che, in caso di ritardo nei rinnovi contrattuali, scatti un'indennità (destinata a sparire con la rinnovata tariffa salariale) detta 'carsica'.
L'ultimo risultato è l'accordo trilaterale (parti sociali e governo) del 23 luglio 1993 per la risistemazione del sistema contrattuale. Le parti si sono impegnate a perseguire la politica dei redditi e a far sì che gli aumenti salariali siano mantenuti nei limiti dell'inflazione programmata. Il contratto collettivo nazionale di categoria ha ora cadenza quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica. La contrattazione articolata è ammessa, ma nelle sole materie cui rinvia il contratto nazionale, evitando così duplicazioni rispetto al livello più generale. Si prevedono anche innovazioni per i contratti di solidarietà a tempo parziale, di formazione e lavoro, con l'introduzione di 'salari d'ingresso'. È ammesso anche il lavoro 'in affitto' da parte di entità che dovrebbero essere soggette a un rigoroso controllo. Infine si procede verso un sistema di rinnovo delle rappresentanze sindacali aziendali su base elettiva, un sistema che dovrebbe essere volto ad accertare l'effettiva consistenza rappresentativa dei vari sindacati, abbandonando quello precedente, fondato sulla rappresentatività 'presunta' delle organizzazioni affiliate a CGIL, CISL, UIL. Queste le principali innovazioni in un settore che, in gran parte, attende ancora ulteriori trasformazioni. (V. anche Corporativismo/Corporatismo; Sicurezza sociale; Sindacato).
Bibliografia
Arcà, F., Legislazione sociale, Milano 1930.
Bettelheim, C., La planification soviétique, Paris 1946 (tr. it.: La pianificazione sovietica, Milano 1949).
BIT (Bureau International du Travail), La liberté syndicale, Genève 1927-1928.
BIT (Bureau International du Travail), Le mouvement syndical dans la Russie des Soviets, Genève 1927.
Bollecker, R., La Charte du Travail du III Reich, Paris 1937.
Brioschi, G.A., Lo sciopero nel diritto, Milano 1948.
Butler, M.B., Les rélations industrielles aux États-Unis, Genève 1927.
Cabrini, A., La legislazione sociale (1859-1913), Roma 1913.
Carnelutti, F., Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro, Padova 1927.
Cesarini Sforza, W. (a cura di), L'esperienza sociale francese 1936-1939, Firenze 1940.
Cesarini Sforza, W., Il corporativismo come esperienza giuridica, Milano 1942.
CESOS (Centro di Studi Sociali e Sindacali), Le relazioni sindacali in Italia 1990-1991, Roma 1992.
Danilova, E. N., Diritto sovietico del lavoro, Padova 1931.
Dolléans, E., Histoire du mouvement ouvrier, Paris 1936 (tr. it.: Storia del movimento operaio, Roma 1946).
Dore, R., Taking Japan seriously: a Confucian perspective on leading economic issues, Stanford, Cal., 1987 (tr. it.: Bisogna prendere il Giappone sul serio: saggio sulla varietà dei capitalismi, Bologna 1990).
Franck, R.L., L'expérience Roosevelt et le milieu social americain, Paris 1937.
Garilli, A., Mazzamuto, S., Lo Statuto dei lavoratori (1970-1990), Napoli 1992.
Giugni, G., Giuridificazione e deregolazione nel diritto del lavoro italiano, in "Giornale del diritto del lavoro e di relazioni industriali", 1986, VIII, pp. 317-341.
Jouhaux, L., Le syndicalisme et la CGT, Paris 1920.
Kahn Freund, O., Caratteristiche fondamentali del diritto del lavoro in Gran Bretagna, in "Diritto del lavoro", 1951, I, p. 83.
Laschi, R., I delitti contro la libertà del lavoro, Torino 1903.
Levasseur, P.E., Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France de 1789 à 1870, Paris 1903.
Louis, P., Histoire du mouvement syndical en France, Paris 1910.
Louis, P., Le syndicalisme français d'Amiens à Saint-Étienne (1906-1922), Paris 1924.
Messina, G., Scritti di diritto del lavoro, Milano 1948.
Pera, G., Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, Milano 1960.
Pierro, M., L'esperimento Roosevelt e il movimento sociale negli Stati Uniti d'America, Milano 1937.
Ramm, T., Per una storia della Costituzione del lavoro tedesca, a cura di L. Gaeta e G. Verdero, Milano 1989.
Redenti, E., Massimario della giurisprudenza dei probiviri, Torino 1992.
Rigola, R., Storia del movimento operaio italiano, Roma 1947.
Riva Sanseverino, L., Storia del movimento sindacale cristiano dal 1850 al 1939, Roma 1950.
Simitis, S., Il diritto del lavoro e la riscoperta dell'individuo, in "Giornale del diritto del lavoro e di relazioni industriali", 1990, XII, pp. 87-113.
Spirito, U., Capitalismo e corporativismo, Firenze 1933.
Treu, T., Cogestione e partecipazione, in "Giornale del diritto del lavoro e di relazioni industriali", 1989, XI, pp. 597-629.
Veneziani, B., Stato e autonomia collettiva. Diritto sindacale italiano e comparato, Bari 1992.
Waline, P., Les syndicats aux États-Unis, Paris 1951.
Webb, S., Webb, B., The history of Trade unionism, London 1894 (tr. it.: Storia delle unioni operaie in Inghilterra, in Biblioteca dell'economista, V serie, vol. VI, Torino 1906).
Webb, S., Webb, B., Industrial democracy, London 1897 (tr. it.: La democrazia industriale, Torino 1912).
Webb, S., Webb, B., The history of Trade unionism, ed. ampliata, London 1920 (tr. it. ampliata: Le leghe operaie dal 1890 al 1920, in Lavoro, a cura di C. Arena, in Nuova collana di economisti italiani e stranieri, vol. XI, Torino 1936, pp. 689-878).
Webb, S., Webb, B., Soviet communism. A new civilisation?, 2 voll., London 1935 (tr. it.: Il comunismo sovietico: una nuova civiltà, Torino 1950).