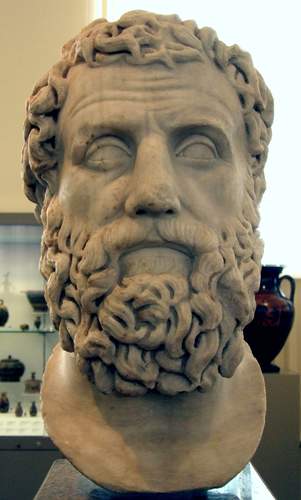Archìloco
Poeta greco, il più antico dei poeti greci di cui conosciamo la personalità (di Callino, forse di poco più anziano, sappiamo troppo poco), fiorito intorno alla metà del 7° sec. a. C. (in uno dei suoi frammenti è ricordata da lui stesso l'eclissi di sole del 6 apr. 648 o 647) e considerato il poeta giambico per eccellenza. Ad A. molto debbono i poeti eolici e a lui risale molto della metrica oraziana. Grandissimo fu l'influsso di A. sui poeti posteriori, greci e latini. A noi sono giunti meno di 300 versi; nessun carme intero.
Vita e opere
Nato nell'isola di Paro e figlio (o pronipote) di Telesicle (o Tellis) e di una schiava tracia, Enipo, emigrò spinto dalla povertà a Taso dove partecipò come mercenario alle guerre contro i Traci, i Sai e contro le colonie delle città rivali: e in combattimento contro i Nassi trovò la morte. Dei ricordi della vita di guerra abbondano i frammenti poetici: da quando egli si dichiara al servizio di Ares e delle Muse fino alle descrizioni di avvenimenti bellici, tra cui ben nota quella sull'abbandono del proprio scudo. Durante la vita A. errò a lungo da Carpato a Creta, all'Eubea, a Lesbo, forse al Ponto, forse anche in Italia. L'avventurosa esistenza di A. è vivamente rispecchiata nella sua opera: primo fra i poeti greci egli fa oggetto di canto sé stesso, le proprie gioie e sofferenze. L'amore, parte essenziale della lirica archilochea, si esprime talvolta violentemente, con linguaggio e immagini realistiche; con delicatezza però A. sa ritrarre soavi figure di giovinette. Dalla sua passione per Neobule e dal rifiuto opposto dal padre di lei, Licambe, a concedergliela in sposa contro la precedente promessa fattagli, scaturisce un sentimento alternato di amore e di odio, che culmina nella più acerba invettiva. Questa è appunto la più forte caratteristica della poesia di A., il quale si getta contro i propri nemici toccando il culmine della violenza, mettendoli in ridicolo o vituperandoli, sfidando i valorosi, insultando i vili, invocando su essi i peggiori guai. Ma una parte non trascurabile della poesia archilochea ebbe anche carattere obiettivo e addirittura narrativo, connesso con innovazioni musicali di complesso accompagnamento strumentale. Essa comprenderebbe peani, ditirambi, inni, epinici e componimenti di soggetto mitico rispetto ai quali, anzi, il parallelo tra A. e Omero era un luogo comune della critica letteraria antica; e si sa che i rapsodi dell'età aurea recitavano A. come Omero ed Esiodo. Accanto al mito, A. trattò anche la favola di origine popolare (per es., quella della volpe e dell'aquila, della scimmia e della volpe) e ne fece uno strumento per la sua invettiva.
La personalità di A. quale emerge dal complesso della sua poesia ci mostra una morale tendente al fatalismo; da ciò l'invito a godere la vita, affogando il dolore in feste e banchetti, ma quando il poeta riflette e si piega su sé stesso spunta l'invito al proprio cuore di sollevarsi sopra le avversità, di saper contenere l'eccessiva gioia e il troppo profondo dolore. La lingua di A. fu il dialetto ionico delle Cicladi con influssi omerici e neologismi; lo stile ha brevità ed efficacia espressiva con geniale ricchezza di tropi, preludente alla commedia. Nella metrica A. fu geniale creatore. Oltre alla grande varietà del distico elegiaco, è suo merito l'assunzione nell'uso letterario del giambo, con tecnica vigorosa e perfetta che si valeva delle forme popolaresche anteriori elaborate con ricchezza e varietà. Vari schemi dattilici, giambici, trocaici, portano il suo nome; a lui il merito della creazione della prima strofe, con l'accoppiamento di un verso semplice o composto con uno generalmente più breve (epodo).
Negli ultimi decenni sono stati recuperati alcuni documenti epigrafico-archeologici di notevole interesse per la biografia e la cronologia del poeta, tra i quali la scoperta, a Taso, dell'iscrizione funeraria (fine 7° secolo a. C.) di Glauco, amico di A. e condottiero dei Pari, e, più importante, il ritrovamento a Paro (1949) di un'iscrizione dell'Archilochèion (recinto sacro costruito in onore del poeta da un certo Mnesiepe verso la seconda metà del 3° secolo a. C.), dalla quale risultano dati leggendari intorno alla figura di A., oltre a citazioni di alcuni suoi versi. Apporti considerevoli alla conoscenza della poesia di A. si sono avuti a partire dal 1954 con la pubblicazione di trimetri giambici, tetrametri trocaici ed epodi in testi papiracei che vanno dal 1° al 3° secolo d. C.; tra questi senza dubbio il più interessante è il Papiro Coloniense 7511 (2° sec. d. C.), pubblicato nel 1974, contenente un epodo di 35 versi, attribuibile con grande verosimiglianza ad A., su un. avventura erotica del poeta probabilmente con la sorella minore di Neobule, sorprendente per il realismo della descrizione.