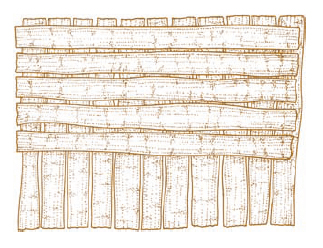papiro
Pianta palustre (Cyperus papyrus; fig. 1) della famiglia delle Ciperacee, con fusto alto da 3 a 5 m, a sezione triangolare, che termina con un’ampia infiorescenza a ciuffo. Cresceva spontaneamente nell’antico Egitto, lungo le rive del Nilo e nelle paludi del suo delta, dove però è in seguito quasi scomparso. Rimane nell’Africa tropicale e in Sicilia orientale, dove secondo alcuni è originario, secondo altri fu importato dagli Arabi nel 9° secolo. Si coltiva anche in vasche a scopo ornamentale.
Nell’antico Egitto dal p. si ricavavano cibo, combustibile, cordami, farmaci, vesti, calzature e piccole imbarcazioni, oltre al materiale scrittorio omonimo, di cui il paese era l’unico produttore e anche esportatore.
Il p. come materiale scrittorio
Come materiale scrittorio, il p. si otteneva tagliando il midollo del fusto della pianta in parti sottili, che erano distese le une accanto alle altre su due strati sovrapposti ortogonalmente (fig. 2). Essi erano pressati in modo che il succo della pianta facesse aderire gli elementi, poi fatti essiccare e levigati. Un foglio di carta così preparato (gr. kòllema) era incollato a molti altri fino a formare un rotolo di vari metri (lat. volumen; gr. bìblos, chàrtes, tómos), le cui dimensioni e qualità potevano variare notevolmente. La facciata interna del rotolo, con le fibre parallele al lato lungo dello stesso, è detta tecnicamente recto, la facciata esterna verso. Di solito si scriveva sul recto, mentre il verso, maggiormente esposto a logorio, rimaneva libero. Tuttavia, spesso anche il verso è stato utilizzato per una scrittura successiva.
Dal 2° sec. d.C. circa, a quanto risulta dai reperti rinvenuti, con i fogli di p. si confezionarono anche «quaderni» cuciti su un lato (i codici), una forma libraria nuova per l’antichità classica che divenne fondamentale nell’epoca moderna. Dal 3° sec. la produzione del p. subì delle crisi ricorrenti, favorendo così l’uso della pergamena e, successivamente, dall’8° sec., della carta di stracci. Tuttavia, fino all’11° sec. si è fabbricata la carta dal p., che era utilizzato in Occidente, ormai, quasi esclusivamente, presso la cancelleria papale.
P. letterari e documentari
L’Egitto rimane la fonte principale dei ritrovamenti di testi scritti su p. grazie al suo clima arido e secco, ma un gran numero di p. sono venuti alla luce anche in Siria (in particolare a Dura-Europo), in Palestina, nell’antica Nessana, nel deserto circostante il Mar Morto (le grotte di Qumrān), nella Nubia. I p. si distinguono in letterari e documentari. I primi conservano opere destinate allo studio e alla lettura: possono essere opere note di autori già conosciuti (come il diffusissimo Omero) o di scritti sconosciuti, o di autori del tutto nuovi. Grazie ai p. si leggono ora ampi brani delle commedie di Menandro, dei drammi di Eschilo, Sofocle, Euripide, dei versi di Callimaco e dei poeti eolici, nuovi testi magici e scientifici, opere cristiane (soprattutto apocrife). Assai problematici sono i casi, non rari, di p. che conservano testi ignoti di autori sconosciuti (o non identificati). I p. documentari contengono invece documenti pubblici (ordinanze, verbali, petizioni alle autorità) e privati (contratti di vario genere, lettere, ricevute e documenti fiscali).
La papirologia
Per la scienza che si occupa dello studio e della conservazione dei testi scritti su papiro ➔ papirologia.