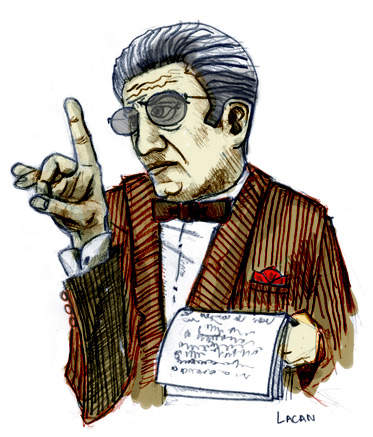Lacan, Jacques
Psicanalista francese (Parigi 1901 - ivi 1981). Conseguita la laurea in medicina, si specializzò in psichiatria con G.-H. G. de Clérambault. Divenuto membro della Société psychanalytique de Paris (SPP), si dedicò al lavoro psichiatrico nell'istituzione ospedaliera. Frequentò gli ambienti letterarî del surrealismo, collaborò con la rivista Minotaure e seguì, presso l'École pratique des hautes études, i corsi tenuti da A. Kojève su Hegel. Nel 1936, al XIV Congresso internazionale di psicanalisi, lesse una prima bozza de Le stade du miroir, che sarebbe stato presentato in forma definitiva al Congresso di Zurigo nel 1949. Dopo essere stato direttore dell'Institut de psychanalyse (1952), venne eletto il 20 gennaio 1953 presidente della SPP ma, ritenuto responsabile di aver sostenuto, e anzi fomentato, le dure critiche rivolte da un gruppo "allievi" al tentativo di ridurre la psicanalisi "nell'ambito delle scienze mediche e della neurobiologia", nonché all'ordinamento rigidamente gerarchico e alle modalità burocratiche dell'analisi didattica, fu costretto, il 16 giugno 1953, a dimettersi. Si distaccò quindi dalla SPP fondando la Société française de psychanalyse (SFP), che rivendicava una profonda diversità "di ordine morale ma non teorico" nei confronti della SPP e identificava il proprio obiettivo nella costituzione di un Istituto e di una Società psicanalitica basati sul rispetto e sulla collaborazione reciproca. Successivamente L., nella relazione Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, approfondì la polemica con gli analisti dell'Istituto di Parigi e, attribuendo il successo della psicanalisi, in particolare negli Stati Uniti, a una mistificazione e a un disconoscimento ideologico dell'opera di Freud - che portò a una sempre maggiore sottolineatura dell'aspetto terapeutico della psicanalisi e a un progressivo disinteresse per "le funzioni della parola e del campo del linguaggio" - propose un "ritorno a Freud". Questo tipo di critiche e di posizioni, sostenute da L. in modo sempre più esplicito, portarono a un irrigidimento delle posizioni dell'Associazione psicanalitica internazionale che nel 1963 chiese, come condizione per il riconoscimento della SFP, l'allontanamento di F. Dolto e di L., considerato "inaccettabile come didatta". L. fu così costretto, assieme a S. Leclaire, F. Dolto e F. Perrie, a dimettersi dal direttivo della SFP, al cui interno si costituirono le condizioni per una nuova scissione. Nel 1964 L., che continuò a tenere alla clinica Saint-Anne, e poi all'École pratique des hautes études, i "seminari del mercoledì", iniziati fin dal 1953, fondò l'École française de psichanalyse, che diverrà in seguito l'École freudienne de Paris (EFP). Nel 1965 pubblicò un volume di scritti (Écrits) e nel 1968 uscì il primo numero della rivista Scilicet, con scritti di L. e dei suoi allievi. A partire dal 1972, L. iniziò la pubblicazione dei Seminaires. Il 5 gennaio 1980 propose lo scioglimento dell'EFP e il 21 febbraio dello stesso anno fondò la nuova associazione La cause freudienne. Figura di primo piano della cultura e del movimento psicanalitico francese, sostenitore di un "ritorno a Freud" contro le deviazioni di certe correnti della psicanalisi, anche ortodossa (K. Abraham, E. Jones, S. Ferenczi), e dei neofreudiani americani, identificò nel sovvertimento della concezione tradizionale della soggettività, che fece risalire a Cartesio, la vera rivoluzione del pensiero freudiano. Da questo presupposto derivano tre tesi paradossali: 1) l'inconscio, il centro della vita pulsionale condizionato dal linguaggio, coincide realmente con l'intero soggetto; 2) L'Io - che, a partire dal 1936, L. considerò fondamentalmente all'interno della problematica del "farsi del soggetto", sottolineando in modo particolare la differenziazione tra Je e Moi (oggetto necessario e alienato) - svolge una funzione narcisistica e quindi difensiva, è soltanto il soggetto immaginario, l'"assoggettato" privo di una vera autonomia; 3) la cura non cerca la Guarigione ma la Verità. Nella polemica contro la "prassificazione americana della psicanalisi", L. collegò la teorizzazione metapsicologica di Freud a uno studio delle dimensioni simboliche che costituì, per il pensatore francese, il nucleo essenziale della scoperta freudiana. Secondo L. sul piano simbolico, dove si attua il legame tra la coazione a ripetere, la memoria e l'"accesso al linguaggio", si svolgerebbe una continua dialettica tra bisogno e desiderio che, ripetendo allucinatoriamente l'esperienza passata, ritrova l'oggetto perduto sul piano fantasmatico e cerca una realizzazione. La dinamica del desiderio è guidata dalla "logica della mancanza", che si manifesta sia in modo negativo sul "registro" reale (come compromesso nel sintomo) sia in modo positivo sul "registro" immaginario (per es., nel sogno). L. individuò inoltre, come soggiacente al "registro" dell'immaginario, il "registro" del "simbolico", dominato dal linguaggio, in cui si svolge la dialettica fondamentale della "domanda", cioè della richiesta rivolta ad altri. Mentre il bisogno, per soddisfarsi, necessita di "un oggetto specifico della natura", la domanda esige il riconoscimento dell'altro e il desiderio, dominato dalla logica della mancanza, nasce dallo scarto tra bisogno e domanda. Secondo L. la scoperta del registro simbolico dimostra che la dinamica pulsionale dell'inconscio segue leggi di tipo strutturale, simili a quelle poste in evidenza da F. de Saussure per la linguistica e da C. Lévi Strauss per l'antropologia. Il primato simbolico permette così "l'adeguamento al vero spirito del freudismo" e consente di impostare, con rigore matematico, lo studio della "logica del desiderio diveniente linguaggio": in tal modo la "logica della mancanza" o della "incompletezza" si trasforma nella "logica delle catene simboliche" che si incrociano nella sovradeterminazione freudiana e fanno sì che tra il bisogno biologico e la domanda si trovi la connessione tra il biologico e il linguistico cercata da Freud.