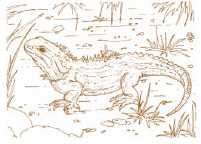fossile
In geologia, ogni resto o traccia di organismo animale o vegetale conservato negli strati della crosta terrestre, vissuto in epoca anteriore a quella attuale. Sono f. anche le tracce e impronte lasciate in sedimenti non ancora consolidati, nonché i fori dovuti all’azione di animali perforanti.
I f. hanno un ruolo litogenetico quando i resti degli organismi sono un costituente prevalente della roccia che li contiene (roccia organogena).
Studio dei fossili
Lo studio dei f. costituisce la paleontologia; esso ha portato non solo alla conoscenza, spesso approfondita, degli organismi scomparsi, ma anche all’identificazione dei loro legami di parentela evolutiva, così da permettere la ricostruzione della filogenesi dei singoli gruppi; inoltre, lo studio degli organismi f. e delle loro associazioni, insieme con quello dei caratteri litologici delle formazioni che li contengono, permette di risalire agli ambienti biologici del passato e alla loro evoluzione, quindi di operare delle ricostruzioni paleogeografiche. La diversa distribuzione delle specie f., infine, fornisce al geologo stratigrafo, attraverso la costruzione di scale cronologiche, il mezzo fondamentale per l’identificazione dell’età relativa dei terreni sedimentari.
I più antichi f. conosciuti risalgono a oltre 3 miliardi di anni fa: sono batteri di forma allungata del genere Eobacterium. I f. dell’era archeozoica sono rari e consistono di pochi resti organici, di dubbia interpretazione. Nell’era paleozoica, i f. divengono numerosi e sono rappresentati per la maggior parte da organismi marini appartenenti a quasi tutti i gruppi di invertebrati e a molte piante; i primi vertebrati compaiono nel Cambriano, e nel Siluriano si rinvengono le prime forme terrestri.
Si chiamano fossili guida quelli che hanno una limitata distribuzione verticale e un’ampia diffusione areale: sono quindi utili per le correlazioni temporali; fossili deformati quelli che, in seguito ad azioni meccaniche subite dai sedimenti che li contengono, sono stati soggetti a fratturazione, schiacciamento ecc.; fossili rimaneggiati si dicono quelli più antichi del sedimento che li contiene.
Fossilizzazione
Il processo per cui resti o tracce di organismi si conservano entro i sedimenti della crosta terrestre è detto fossilizzazione (fig. 1). Perché ciò avvenga è necessario che l’organismo alla sua morte sia isolato dagli agenti esterni distruttivi (biologici, atmosferici, meteorologici, climatici, fisici, chimici, sedimentologici) il più velocemente possibile, in modo che i processi chimico-fisico-biologici che intervengono portino il resto organico ad acquistare sufficiente stabilità fisico-chimica rispetto al mezzo inglobante.
Le probabilità che un organismo divenga f. sono in genere basse e dipendono dalla costituzione dell’organismo stesso, dalle caratteristiche dell’ambiente in cui esso viveva e da quelle del bacino di sedimentazione in cui si è depositato ed è inglobato. Per il primo punto, sono condizioni favorevoli la presenza di parti già parzialmente mineralizzate nel vivente (gusci, ossa ecc.) o in ogni modo costituite da tessuti duri (legno, tessuto chitinoso, corneo ecc.); non mancano però esempi di conservazione di tessuti molli. Per il secondo punto, hanno più probabilità di conservazione gli organismi che vivono negli stessi ambienti in cui saranno inglobati e ciò tanto più facilmente quanto più sottili saranno i materiali sedimentati, più veloce il ritmo di sedimentazione e tranquillo il mezzo in cui si ha la sedimentazione. Un f. raramente consiste della stessa sostanza che costituiva le parti corrispondenti dell’organismo vivente, ma più spesso intervengono scambi chimici; tre composti predominano nella natura dei f.: la silice, il carbonato di calcio (particolarmente la calcite) e il fosfato di calcio; nell’ordine seguono carbone, pirite e numerose altre sostanze.
Principali processi di fossilizzazione
2.1.1 Mineralizzazione Consiste nella sostituzione delle sostanze originali dell’organismo da parte di altre, ad opera dell’acqua circolante nel sedimento; quando questo processo avviene rapidamente si altera la microstruttura originaria lasciando inalterata la morfologia esterna, mentre quando avviene molto lentamente rimane inalterata per pseudomorfosi.
2.1.2 Incrostazione Si tratta di un tipo di fossilizzazione comune presso sorgenti, cascate e cavità carsiche: l’acqua circolante, ricca in bicarbonato di calcio, deposita sugli organismi (foglie, gusci ecc.) minutissimi cristalli di calcite, che costituiscono delle croste che riproducono la morfologia esterna. Il prodotto più tipico di questo fenomeno è il travertino, che si è formato in epoche passate per incrostazione su grande scala; è facile trovare in esso impronte di foglie e altri resti vegetali.
2.1.3 Mummificazione È caratterizzata dall’essiccamento (perdita dei liquidi) e avviene in ambienti secchi, caldi e ventilati come, per es., i deserti. Questo processo è favorito da microrganismi che, dopo l’essiccamento, determinano un indurimento dei tessuti molli.
2.1.4 Inglobamento Avviene per mezzo di un elemento inglobante che racchiude l’organismo prima che abbia inizio la decomposizione; in questo modo si conservano anche i tessuti più delicati (es.: gli insetti conservati in ambra, i mammuth nel terreno gelato).
Sono considerati tipi di fossilizzazione i modelli naturali interni ed esterni, le impronte del corpo, le piste ecc.; la formazione di modelli interni o esterni riguarda soprattutto quegli organismi provvisti di parti dure delimitanti cavità interne (Bivalvi, Gasteropodi, Brachiopodi ecc.); il calco riprodurrà tanto più fedelmente le parti dure dell’organismo quanto più fine sarà il sedimento che si depositerà all’interno o all’esterno dell’organismo.
La carbonizzazione è un processo legato alla decomposizione della materia organica, che porta prima all’eliminazione dei composti volatili e liquidi, costituiti da idrogeno, ossigeno e azoto, fino a lasciare un residuo composto principalmente da carbonio. Questo processo avviene sia in ambiente subaereo, dopo seppellimento, sia in ambiente subacqueo; comunque sempre in un ambiente asfittico, e porta alla formazione dei carboni fossili. Esso consiste in una lenta e graduale disossidazione della cellulosa dei vegetali, con conseguente arricchimento in carbonio, a opera di microrganismi in ambienti di acqua dolce e salmastra; si ha la formazione di una massa unica colloidale fondamentale, ‘gel’ di idrocarburi vari e carbone amorfo, che ingloba le strutture istologiche resistenti che vi si conservano in modo perfetto.
Fossili viventi
Organismi viventi che appartengono a gruppi sistematici rappresentati soprattutto da specie f., per es. il Limulus (Artropode dei Merostomi) o il genere di rettili Sphenodon (fig. 2), unico rappresentante vivente di un gruppo del Mesozoico (Rincocefali, che ebbero grande sviluppo durante l’era terziaria), tra gli animali, e l’albero Ginkgo biloba (Ginkgoali) tra i vegetali; oppure specie, come molti Brachiopodi, che si sono mantenute inalterate fino ai nostri giorni da ere geologiche remote. Esemplari di gruppi ritenuti estinti sono stati rinvenuti viventi; per es. Latimeria chalumnae, pesce dei Celacantidi, famiglia ritenuta estinta fino al 1938, quando un esemplare di questa specie fu pescato al largo delle coste dell’Africa meridionale.