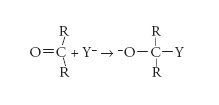criminalità organizzata
criminalità organizzata Forma di delinquenza associata che presuppone un’organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati, per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali. In Italia, il termine (mutuato dall’ingl. organized crime) indica principalmente i sodalizi criminali più strutturati, quali la mafia, la camorra, la ’ndrangheta e la Sacra corona unita. Il fenomeno ha assunto un’incidenza tale da configurare una realtà autonoma rispetto alle altre tipologie di delinquenza. Il dato principale è che le varie forme di c. si manifestano come autentici contropoteri criminali, sia in via esterna e concorrenziale rispetto al sistema legale, sia all’interno di questo, attraverso i partiti, le amministrazioni locali, alcuni settori dell’apparato istituzionale e determinate articolazioni del sistema bancario (paradigmatico è stato, in questo senso, il caso della loggia P2).
L’attività criminale è legata sempre più a una serie di traffici su scala internazionale e intercontinentale, nei quali la singola organizzazione territoriale appare spesso come il segmento di un’attività che, a monte e a valle, si avvale di una complessa catena di relazioni e di complicità, e che dunque può essere compresa, e combattuta, solo a partire dalla definizione di un quadro d’insieme. Si evidenziano, infatti, in misura sempre maggiore, collaborazioni consolidate tra le organizzazioni endogene e quelle di matrice straniera (cosiddetta intermafiosità), in particolare dell’Europeo orientale, dell’area balcanica, del continente asiatico, del Nordafrica e del Sudamerica, particolarmente attive nei settori dell’immigrazione clandestina, della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione e del traffico di stupefacenti. Quest’ultimo esemplifica bene la complessità delle moderne attività criminali, in quanto il raffinamento e lo spaccio degli stupefacenti (generalmente gestiti localmente da organizzazioni malavitose) sono gli anelli intermedi di un processo che si svolge per lo più in luoghi diversi, e che comprende, oltre alla produzione delle droghe, il riciclaggio dei proventi, largamente impiegati in attività economiche lecite e comunque dislocate al di fuori del tradizionale raggio d’azione delle cosche.
In Europa, il quadro dei poteri criminali si è modificato, nell’ultimo decennio del 20° sec., anche a seguito della disgregazione dell’Unione Sovietica e del blocco socialista. La fragilità politica degli Stati nati da quel processo (compresa l’Albania e i paesi dell’ex Iugoslavia) ha consentito lo sviluppo di organizzazioni criminali di tipo mafioso, che hanno esteso i loro traffici in gran parte dell’Europa (inclusa l’Italia) e hanno dato talora prova di poter incidere anche sugli equilibri politici dei rispettivi paesi. Per altri versi, hanno acquistato importanza in Europa, anche al seguito delle ondate migratorie, le triadi cinesi (sequestri a scopi estorsivi e immigrazione clandestina), la mafia nigeriana (droga e prostituzione) e i cartelli colombiani (produzione e traffico di cocaina).
Per quanto concerne la disciplina normativa, l’inadeguatezza del codice penale del 1930, che prevedeva e disciplinava soltanto il reato di associazione per delinquere, ha indotto il legislatore a emanare nuove fattispecie, in particolare l’associazione segreta e l’associazione di tipo mafioso (1982). Sotto il profilo processuale, per la natura transnazionale del fenomeno criminale, è emersa per la magistratura la necessità di lavorare collettivamente, soprattutto nella fase delle indagini preliminari. Per far fronte a tale esigenze, il d. legisl. del giugno 1992, convertito nella l. 356/1992, ha istituito le procure distrettuali antimafia e la direzione nazionale antimafia, attribuendo a questi nuovi uffici del pubblico ministero la competenza esclusiva a svolgere le indagini in tema di c. di stampo mafioso nei singoli distretti di corte d’appello, nonché il potere di coordinare su base nazionale le indagini in corso nelle diverse sedi distrettuali. Sono stati adottati, inoltre, significativi provvedimenti per colpire il fenomeno, sempre più diffuso, dell’usura, spesso caratterizzato da gravi atti di estorsione nei confronti delle vittime (l. 108/1996). Infine, la l. 45/2001 ha disciplinato in maniera analitica la protezione e il trattamento dei collaboratori di giustizia.
Nell’ambito del Consiglio d’Europa, nel 1993 è stata stipulata una Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato; dal 1994 ha iniziato a operare l’Europol drugs unit, nucleo specializzato dell’agenzia anticrimine dell’Unione Europea Europol. Nel giugno 1998 è stata istituita la Rete giudiziaria europea per la cooperazione in materia penale tra gli Stati membri. Nel dicembre 2006 è stata ratificata, a Palermo, la prima Convenzione Onu sul c. organizzato transnazionale, importante strumento di coordinamento tra i diversi sistemi penali nazionali.
Approfondimento
Criminalità organizzata di Salvatore Lupo
Generalmente si usa distinguere tra i vari gruppi di criminalità organizzata italiana in base all'origine regionale: si parla quindi di mafia e di cosa nostra in Sicilia, di 'ndrangheta calabrese, di camorra campana, di sacra corona unita pugliese. Questa raffigurazione simmetrica, però, rischia di essere fuorviante. La mafia siciliana ha, rispetto alle altre organizzazioni, una ben più forte continuità storica e si caratterizza per un elevato tasso di centralizzazione, anche se ci sono bande che in varie parti dell'isola si muovono in quasi totale autonomia. La camorra è composta da gruppi forti, pericolosi, sanguinari, ma del tutto autonomi gli uni dagli altri, poco capaci di organizzarsi, nel senso di coordinarsi tra loro, impegnati in affari redditizi ma anche in interminabili conflitti. Inoltre, nelle loro molteplici attività i vari gruppi regionali si scompongono, si mischiano tra loro e con una gran quantità di interlocutori situati magari ai quattro angoli del mondo, entrando in certi mercati e uscendone secondo convenienza, stipulando mutevoli accordi d'affari e sciogliendoli continuamente.
Controllo del territorio e connivenze sociali
Parlando di criminalità organizzata non dobbiamo dunque necessariamente pensare a organizzazioni piramidali o permanentemente interconnesse, ma a pratiche delittuose che non sono quelle tipicamente 'predatorie', rapine o aggressioni, bensì tali da consentire grandi attività economiche e connessioni con mercati che interessano la gente comune. In tal modo le associazioni criminali si assicurano un giro d'affari continuativo e una certa tolleranza sociale. Tipiche loro attività sono, dunque, il contrabbando in genere, il narcotraffico, la prostituzione, l'emigrazione clandestina, il commercio di armi. In molti casi (ma non in tutti) l'organizzazione si caratterizza per il controllo di un determinato territorio, per es. un quartiere: in questo caso la sua attività più tipica è il racket, ossia l'estorsione continuativa e sistematica su attività economiche lecite e magari anche illecite. La parola racket nacque negli Stati Uniti del primo dopoguerra per definire una relazione perversa tra criminali da un lato e dall'altro i soggetti (quali uomini d'affari, politici, autorità di polizia) senza il cui sostegno è ben difficile che la criminalità organizzata possa svilupparsi e prosperare. La tolleranza sociale implica molto spesso una tolleranza istituzionale. Quello statunitense nell'età del proibizionismo è un caso classico e molto citato. Una legge del 1920 proibì il consumo e il commercio delle bevande alcoliche creando grande spazio per il contrabbando, che molti cittadini onesti, politici, amministratori e persino poliziotti non consideravano in sé riprovevole.
Il gangster per eccellenza dell'era del proibizionismo, Al Capone, disse una volta: "Tutto quello che faccio è dare risposta alla domanda del pubblico", rivendicando la funzione sociale (imprenditoriale) da lui svolta. Dopo l'abrogazione del proibizionismo (1933), i gangster cercarono di conservare il rango acquisito riciclandosi nel settore del racket del lavoro, ossia infiltrandosi nei sindacati, e controllando il gioco d'azzardo, cioè un settore, anch'esso considerato da molti legittimo, capace di alimentare un grande giro di capitali.
Criminalità e immigrazione
Negli Stati Uniti fin dal 19° sec., e ora anche in Europa, è diffusa la tesi che riconduce lo sviluppo della criminalità organizzata all'immigrazione. Troppo spesso si pensa che la predisposizione al crimine sia una specie di bagaglio culturale che gli immigrati si portano da casa, perché in una società multietnica la percezione della criminalità grande o piccola passa attraverso un gioco complesso di simboli che usualmente servono ai nativi per compiacersi di una propria pretesa superiorità morale sull'altro. La teoria dell'equivalenza tra una certa razza, o una certa cultura, e un comportamento delinquenziale è inaccettabile. È evidente che l'accento va messo sulla domanda oltre che sull'offerta di criminalità, cioè sulle condizioni che nella società di arrivo agevolano lo sviluppo di questa fenomenologia: i quartieri-ghetto che le società opulente riservano agli immigrati sono il naturale 'brodo di coltura' della criminalità e, in alcuni casi, i membri di certi gruppi etnici possono specializzarsi nel rifornire la società che li ospita di 'beni' e 'servizi' illeciti di cui essa sente il bisogno.
La criminalità etnica rappresenta un ponte tra società opulente e società periferiche o arretrate: per i gruppi che si collocano a cavallo tra queste due dimensioni viene usato oggi il termine mafie (cinese, giapponese, russa, albanese, turca, colombiana, cecena). Molto spesso questi gruppi fanno base in zone periferiche, del tutto sottratte per particolari congiunture storico-politiche a qualsiasi controllo legale. I narcotrafficanti svolgono per es. funzioni di autorità statale in Afghanistan o in Thailandia, dove si trovano fruttifere piantagioni di prodotti-base per la lavorazione della droga. Si consideri il caso dei cd. cartelli della droga in Colombia o in Messico, che controllano intere regioni di questi paesi usando come manovalanza i disperati delle grandi periferie urbane, alleandosi con esponenti del potere politico e all'occorrenza anche con gruppi politico-guerriglieri, per poi inviare la cocaina negli Stati Uniti, attraverso una lunga catena di relazioni d'affari comprendente connazionali ma anche gregari e imprenditori del crimine di diversa nazionalità, fino a raggiungere il più ricco mercato del mondo, dove la merce sarà pagata cifre enormemente superiori al suo costo di produzione.
Per approfondire Aspetti problematici della confisca di Francesca Panzuto