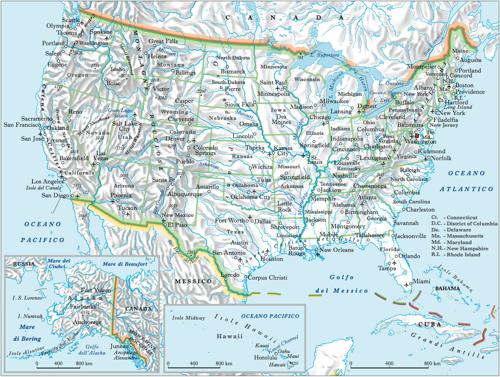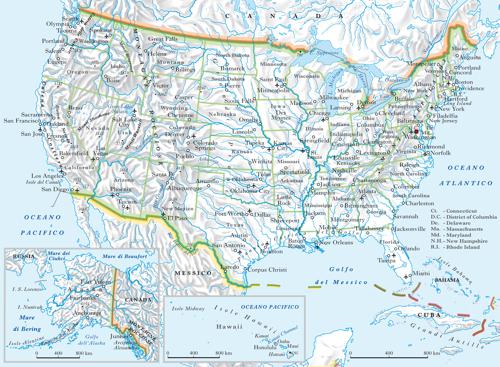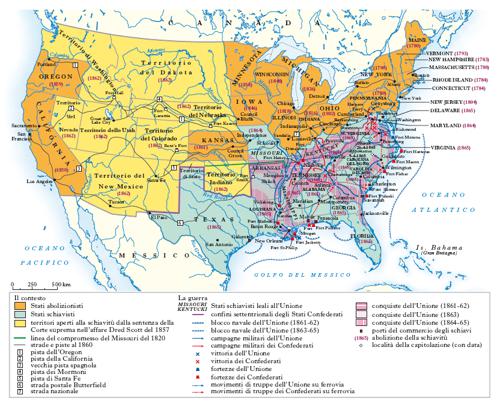Stati Uniti d’America
Stati Uniti d’America Stato federale dell’America Settentrionale, il cui territorio è suddiviso tra 50 Stati membri e il Distretto di Colombia, nel quale sorge la capitale Washington. La continuità territoriale degli S. fu alterata nel gennaio 1959, quando venne accordata dignità di Stato membro all’Alaska, separata dagli Stati tra loro confinanti (conterminous United States) per l’interposizione di un vasto tratto di territorio canadese; l’ingresso, pochi mesi dopo, delle Hawaii (nel Pacifico settentrionale, a circa 4000 km dalla costa californiana) come cinquantesimo Stato aggiunse un altro rilevante elemento di discontinuità. Agli USA appartengono anche: come territori non incorporati, le Isole Vergini Americane (Mar Caribico), l’isola di Guam e le isole Samoa Americane (Oceano Pacifico), lo Stato libero associato di Puerto Rico (Mar Caribico); come Commonwealth, le Isole Marianne Settentrionali (Oceano Pacifico); come dipendenza, le Isole Midway e altre piccole isole (Oceano Pacifico); come base militare in affitto, la Baia di Guantánamo (Cuba).
I conterminous United States confinano a N con il Canada lungo il parallelo di 49°, dal Pacifico fino alla regione dei Grandi Laghi Laurenziani, quindi seguono la linea centrale di questi e, fin quasi all’Atlantico, il fiume San Lorenzo. Il confine meridionale con il Messico segue un andamento SE-NO, alla latitudine di circa 30°; a E è segnato per circa 1200 km dal basso corso del Río Grande, nella parte occidentale segue le linee rette concordate nella seconda metà del 19° secolo. Il settore continentale si affaccia sull’Oceano Atlantico a E, sul Pacifico a O e sul Golfo del Messico a S; con l’Alaska giunge a O sul Mare di Bering e a N sul Mare di Beaufort, tratto del Mar Glaciale Artico.
Caratteristiche fisiche
Geomorfologia. Il territorio continentale può essere distinto in quattro principali zone morfologiche, allungate nel senso dei meridiani; dal Pacifico all’Atlantico si incontra dapprima una regione di alti rilievi; a E di questi, si aprono grandi estensioni pianeggianti drenate dal sistema del Mississippi-Missouri; più a E un’altra zona montuosa, più antica, e infine una cimosa costiera lungo l’Atlantico.
La costa atlantica è generalmente bassa, poco estesa, articolata solo da estuari di fiumi (Hudson, su cui sorge New York; Potomac, con la capitale Washington; più a S Savannah, con la città omonima) e dalla penisola di Capo Cod. A S, tra Atlantico e Golfo del Messico si protende per oltre 500 km la bassa penisola della Florida, interessata da vaste zone paludose (everglades).
Alle spalle della pianura costiera un falsopiano ampio un centinaio di kilometri (piedmont belt) sale dapprima gradualmente, fino a 600 m circa, e quindi bruscamente fino alla prima delle dorsali che formano i Monti Appalachi, allungati per circa 2500 km in direzione SO-NE. L’erosione ha addolcito tutte le forme e la dorsale più elevata è quella della Blue Ridge, dove il Monte Mitchell supera appena i 2000 m. Oltre lo spartiacque, l’erosione ha colmato gran parte delle valli, formando il Cumberland Plateau. I grandi fiumi che scendono verso O (Ohio, Kentucky, Tennessee) confluiscono nel Mississippi, salvo pochi che si dirigono al Golfo del Messico, come l’Alabama. Verso N una serie di colline moreniche abbraccia la regione dei Grandi Laghi, di escavazione glaciale, attraversati dal confine tra USA e Canada nel senso della lunghezza. Poco a O dei Grandi Laghi nasce il Mississippi, che in pratica manca di un vero alto corso: le sue sorgenti sono a circa 450 m di quota, in pochi kilometri scende a 300 m e per giungere alla foce percorre ancora quasi 4000 km. I suoi affluenti di sinistra sono i fiumi appalachiani; più rilevanti sono quelli di destra, che nascono dalle Montagne Rocciose e percorrono le Grandi Pianure (Great Plains) e le praterie (prairies). Il maggiore è il Missouri che, dalle sorgenti del più alto ramo (il Red Rock) alla confluenza nel Mississippi, è lungo più del doppio rispetto ai circa 2000 km percorsi fin lì dal Mississippi stesso, considerato tuttavia il corso principale, data la portata nettamente superiore e il regime più regolare. Dopo la confluenza del Missouri, il corso del Mississippi è ampio circa 1 km, dopo la confluenza dell’Ohio supera i 2 km e, dopo la confluenza di Arkansas e Red River, giunge a superare i 3 km. Il Mississippi riceve un rilevante carico solido dai suoi affluenti, con il quale costruisce alla foce un delta in continuo avanzamento. L’accumulo di detriti ha inoltre sollevato tutto il basso corso, rendendo pensile il fiume, il che determina frequenti amplissime inondazioni. A O della foce del Mississippi sfocia il Río Grande che, con l’affluente Pecos, raccoglie le acque del settore meridionale delle Montagne Rocciose.
La regione delle Grandi Pianure è un falsopiano debolmente inclinato, che sale dalla destra del Mississippi fin verso i 600 m, alla regione dei rilievi occidentali. Questi, come i rilievi dell’Alaska cui sono strutturalmente collegati, sono costituiti da formazioni antiche, però coinvolte dai sollevamenti meso-cenozoici. Si tratta di un articolato sistema di dorsali e rilievi, dove molte cime superano i 4200 m, in Wyoming come in Colorado, Utah e New Mexico. Nella parte settentrionale si è verificata attività vulcanica, che ha prodotto espandimenti lavici, e tuttora alimenta notevoli fenomeni di vulcanismo secondario, tanto che vi si istituì (1872) il primo parco nazionale nel mondo, lo Yellowstone. Nella parte più meridionale si superano i 4300 m nella Sawatch Range e nei Monti Sangre de Cristo. A O i rilievi declinano verso una vastissima regione ad altezza media di 1000-1500 m, che i Monti Wasatch dividono in Gran Bacino a NO e Altopiano del Colorado a SE. Tutta la zona è arida e in parte endoreica; massimo bacino interno è quello del Gran Lago Salato, alle falde nord-occidentali dei Wasatch. Il maggior fiume del Gran Bacino è lo Snake, che si apre la strada con profondi canyon fino a confluire nel fiume Columbia, proveniente dal Canada. L’Altopiano del Colorado ha una struttura tabulare, per la maggior parte costituita da arenarie paleozoiche, nelle quali il fiume Colorado ha scavato l’impressionante Grand Canyon, che in alcuni tratti si approfondisce per 1800 m, fino a mettere allo scoperto rocce di età precambriana. A O la regione degli altopiani è limitata dalla Catena delle Cascate e dalla Sierra Nevada, e lungo il litorale dalla Catena Costiera. Le cime più elevate (Whitney, Rainier, Shasta, oltre i 4000 m) sono apparati vulcanici. A N, nella Catena delle Cascate, si apre la strada verso il Pacifico il fiume Columbia, mentre più a S il San Joaquin e il Sacramento si uniscono a breve distanza dalla costa, sfociando nella Baia di San Francisco. L’aridità degli altopiani si accentua verso O, dove si trovano estese zone desertiche, che scendono anche sotto il livello del mare nella nota Valle della Morte, in California, dove si giunge a −84 m, e nel bacino endoreico del Salton Sea, a −75 m. Tutti i rilievi prossimi al Pacifico sono recenti e presentano forte sismicità. Anche il vulcanismo è attivo.
Clima. A parte l’Alaska, il territorio statunitense ricade nella fascia delle latitudini temperate e si affaccia su due oceani e su un mare mediterraneo caldo; ma è caratterizzato da climi più continentali che oceanici. Le catene montuose sulla costa pacifica limitano l’influenza dell’oceano e dei venti occidentali a una ristretta fascia costiera. Un maggior apporto di umidità proviene dall’Atlantico, in quanto l’ostacolo dei Monti Appalachi viene superato dai venti orientali. La fascia costiera è qui tutta soggetta a precipitazioni dell’ordine dei 1000 mm annui, mentre lungo il Mississippi si scende a 600 mm. Procedendo verso O, oltre le Montagne Rocciose, si passa a valori semiaridi e si hanno aree addirittura desertiche ancora a poche decine di kilometri dal Pacifico, mentre sul versante esposto all’oceano le piovosità aumentano, da S (Los Angeles: 400 mm annui) a N (Seattle: 900 mm).
La distribuzione delle temperature è influenzata, più che dalle latitudini, dalle correnti marine costiere, dalla distribuzione dei rilievi e dalla circolazione atmosferica locale. A Seattle si va da 5 °C in gennaio a 18 °C in luglio, mentre a Los Angeles i valori corrispondenti sono di 13 e 22 °C. Sulla costa atlantica, una sorta di limite climatico è rappresentato dal Capo Hatteras: a N scorre la fredda Corrente del Labrador, a S la calda Corrente del Golfo. La costa a nord di New York ha medie di gennaio inferiori a 0 °C, mentre in luglio si possono superare i 25 °C; a Savannah si può rimanere a 10 °C in gennaio, ma è difficile che si superino i 28 °C in luglio. In tutto il bacino del Mississippi, d’inverno, le alte pressioni subpolari spingono masse d’aria gelida fino alle latitudini tropicali. L’influenza tropicale si manifesta con i tifoni che battono la regione costiera del Golfo, soprattutto verso la fine dell’estate, come il disastroso Katrina (agosto 2005). Gli apporti di aria caldo-umida contribuiscono poi a mantenere elevate le medie estive: in luglio, a S, si registrano da 28 a 30 °C a Baton Rouge o a Dallas, mentre si rimane attorno ai 25 °C a Chicago o a Cincinnati o Indianapolis; al confine con il Canada si possono ancora superare i 20 °C. Ben altra la situazione invernale, quando a New Orleans e in tutta la costa del Golfo le medie di gennaio non scendono sotto i 10 °C, mentre l’isoterma di 0 °C si colloca attorno ai 30° N (la latitudine del Cairo). A Chicago si scende a −4 °C, al confine canadese le medie di gennaio giungono spesso a −15 °C, con una escursione annua sempre superiore ai 30 °C. Sulle Montagne Rocciose i climi assumono ovviamente carattere montano. Nei grandi altopiani i caratteri continentali vengono esaltati: a Salt Lake City, a 1300 m di altezza, si va da −3 °C in inverno a 25 °C in estate; a Reno, alla stessa quota, la media di gennaio rimane sotto 0 °C ma in estate non si giunge in genere a 20 °C. Condizioni del tutto particolari ha la grande penisola della Florida, a SE: a Miami, presso il tropico del Cancro, a gennaio la media è vicina ai 20 °C, a luglio si avvicina a 30 °C, e le piogge superano normalmente i 1500 mm.
Flora e fauna. Per la vegetazione e la fauna negli USA ➔ America.
Popolazione
Popolamento. Il popolamento originario avvenne dall’Asia, probabilmente oltre 40.000 anni fa. Gli Indiani d’America (o Amerindi) avevano una densità bassissima e tecnologicamente si trovavano a livello neolitico quando cominciò l’immigrazione degli Europei. Nettissima fu la prevalenza di Inglesi, con una presenza olandese che portò alla fondazione di Nuova Amsterdam (poi presa dagli Inglesi e chiamata New York). Poco più a S si addentrarono i quaccheri, che fondarono la Pennsylvania. Immediatamente più a S i cattolici fondarono il Maryland. In tutti gli insediamenti le convinzioni religiose finirono per dominare la vita pubblica, determinando anche l’atteggiamento verso gli Amerindi, considerati privi della grazia divina, e verso la tratta degli schiavi dall’Africa; la sola preoccupazione fu imporre loro una conversione al cristianesimo. Dopo la proclamazione dell’indipendenza (quando la popolazione bianca si attestava sui 2 milioni), il primo censimento ufficiale (1790) registrò quasi 4 milioni di abitanti, tra i quali circa 750.000 schiavi di origine africana. Si può ipotizzare che all’epoca vivessero sul territorio statunitense odierno oltre 6 milioni di persone.
Multietnicità. Nei due secoli seguenti l’indipendenza, la popolazione è aumentata di circa 50 volte, un incremento mai verificatosi in nessuna parte del pianeta. Causa ne furono le ulteriori immigrazioni dall’Europa, con prevalente apporto di giovani adulti, un tasso di natalità molto sostenuto e un incremento elevato fin dopo la Seconda guerra mondiale. Alla metà dell’Ottocento l’annessione di parte del territorio messicano portò abitanti cattolici e ispanofoni, mentre la carestia che aveva devastato l’Irlanda determinò un fortissimo afflusso dall’isola. Più decisivo fu però l’arrivo costante di centinaia di migliaia di persone ogni anno. Tra il 1840 e il 1880, in effetti, gli Irlandesi costituirono meno di un quinto degli oltre 10 milioni di immigrati, tra cui quelli provenienti dalla Germania superarono quelli della Gran Bretagna e numerosi furono gli scandinavi. Al censimento del 1860 vennero censiti 31,4 milioni di abitanti, dei quali 4,4 afroamericani: in 70 anni la popolazione bianca era aumentata, per natalità e immigrazione, di circa 9 volte, mentre quella nera, per natalità e tratta, di 6 volte.
Dopo la guerra di secessione si avviò il popolamento a O del Mississippi. L’immigrazione venne favorita, e in una dozzina di anni giunsero oltre 4 milioni di persone. Gli Irlandesi erano cattolici e tra i Tedeschi numerosi erano sia i cattolici sia gli ebrei, ma la popolazione di origine europea si presentava nel complesso omogenea. Dal 1880 alla Prima guerra mondiale, invece, entrarono nel paese circa 22 milioni di persone, solo 5 dei quali dell’Europa centro-settentrionale: prevalevano ormai Italiani, Serbi, Croati e, in minor misura, Spagnoli e Greci dal Mediterraneo; altri Slavi (Russi, Polacchi, Ucraini) e Ungheresi dall’Europa orientale. Nella popolazione statunitense si crearono separazioni nette, in aggiunta a quelle già esistenti. I nuovi arrivati, Latini e Slavi, cattolici ed ebrei, vennero emarginati dalla società benestante, di composizione ‘bianca, anglosassone, protestante’, il che li spinse a conservare legami comunitari e territoriali, e un sentimento di identità etnica che solo a distanza di un paio di generazioni è stato accolto come uno specifico contributo culturale. Con il popolamento della California e della costa pacifica, diventò rilevante anche l’immigrazione attraverso il Pacifico, dalla Cina e dalle Filippine; più tardi molti di questi asiatici migrarono verso le città dell’Atlantico, sostituiti da giapponesi.
Nel 1921 l’afflusso annuo per etnia venne fissato al 3% dei relativi residenti nel 1910; tre anni dopo si scese al 2% dei presenti nel 1890, quando, cioè, Latini e Slavi erano pochissimi, e nel 1928 si fissò il limite annuo complessivo a 150.000 unità per tutte le provenienze. I freni vennero leggermente allentati in seguito, ma dopo il 1955 si tornò a fissare il limite complessivo di 170.000 unità annue. In realtà non è stato possibile mantenere questa limitazione: essendo libera l’immigrazione dal Canada, molti programmano una migrazione verso gli USA in due tappe, pur se a distanza di alcuni anni l’una dall’altra. Molti eventi hanno poi determinato afflussi improvvisi che il governo non ha voluto impedire: i boat peoples in fuga dal Sud-Est asiatico, i balseros che abbandonano Cuba, gli Ebrei provenienti dall’Est europeo. Si è aggiunta la massiccia immigrazione clandestina ispanofona: dal Messico in California, Arizona e Texas, da Puerto Rico in Florida e a New York, da Cuba alla Florida; lo spagnolo si è rapidamente imposto come seconda lingua parlata nel paese. L’afflusso dall’Europa si è invece praticamente arrestato. Al censimento del 2000 gli oriundi europei erano 196 milioni su un totale di 281 (il totale stimato era di circa 6 milioni inferiore, il che mostrò l’ampiezza dell’immigrazione non registrata).
La popolazione, nel complesso degli USA, aumenta del 10‰ annuo, ma per gli oriundi europei il valore è circa la metà, mentre per gli Afroamericani (ca. 35 milioni) e gli Asiatici (11 milioni) il dato effettivo supera il 16‰, e ancor più elevato è per gli ispanici (31 milioni) cui va attribuito circa il 40% dell’incremento, fra nascite e ingressi.
Italiani e Slavi si vanno sempre più fondendo nella società statunitense, mentre ne rimangono esclusi Amerindi, Afroamericani, Asiatici e i gruppi ispanofoni dell’ultima immigrazione. Gli Amerindi, spinti sempre più a O, sono oltre 1.500.000: per metà circa nelle riserve, e per il resto nelle periferie urbane degli Stati del Sud-Ovest e in California. Circa il 23% degli Afroamericani e degli ispanici vive al di sotto della soglia di povertà, mentre per gli asiatici la percentuale scende intorno all’11%; ma per i gruppi di origine europea non raggiunge l’8%. Di conseguenza, vari indicatori della qualità della vita (speranza di vita alla nascita, tasso di mortalità, grado di istruzione ecc.) si attestano, a livello medio degli USA, su valori leggermente peggiori rispetto alla maggior parte dei paesi sviluppati.
Distribuzione e movimenti della popolazione. La densità della popolazione presenta differenze accentuate e variazioni nel tempo. Il suo ‘baricentro’ si sposta continuamente verso O e recentemente anche verso S: l’aumento della popolazione nella regione atlantica è cioè sempre inferiore rispetto a quello registrato sul Pacifico e verso il Golfo del Messico. Nell’insieme, però, le densità della regione atlantica rimangono superiori; i valori diminuiscono verso il Mississippi e, ancor più rapidamente, verso le Montagne Rocciose, fino ai minimi degli altopiani interni; oltre, le densità salgono nuovamente verso la costa pacifica, senza raggiungere, tuttavia, nemmeno un terzo dei valori della regione costiera atlantica centrale. Gli Stati in cui si superano i 100 ab. per km2 sono tutti sulla costa atlantica, Florida compresa, più l’Ohio. Lo Stato più popoloso è comunque la California (36,5 milioni), seguita a distanza dal Texas (23,9), dallo Stato di New York (19,3) e dalla Florida (18,3), che negli ultimi decenni ha registrato un incremento eccezionale, per l’immigrazione di adulti (pensionati) da altri Stati. All’estremo opposto si trova l’Alaska, che è lo Stato più vasto (1.530.700 km2), ma il meno popoloso (circa 680.000 ab.); più significativo, però, è il caso di Montana e Wyoming, a latitudini corrispondenti a quella della Francia centrale, dove su una superficie più che doppia rispetto a quella italiana abitano in totale circa 1.500.000 persone, meno di 3 ab./km2.
Urbanizzazione. La popolazione statunitense è tra le più urbanizzate del mondo, considerando che per circa quattro quinti vive in città con almeno 100.000 abitanti. La crescita urbana è stata continua, anche se nei decenni più recenti ha manifestato la tendenza a privilegiare le aree più periferiche rispetto ai centri cittadini consolidati. Di conseguenza, è arduo stabilire l’esatto ammontare della popolazione di un centro urbano, cui vanno sommate varie corone periferiche anche se a grande distanza e oltre i limiti amministrativi o statali. New York, con la sua area metropolitana che si estende anche negli Stati confinanti, supera i 18,8 milioni; non lontano, l’area metropolitana di Filadelfia ha superato i 5,8. Più a S, l’area metropolitana di Washington (5,3 milioni) deborda dal distretto federale e costituisce il settore più meridionale della cosiddetta Megalopoli che si estende verso NO fino a Boston (4,5 milioni), includendo anche l’area metropolitana di Filadelfia, per un totale di circa 45 milioni di abitanti. A S, il centro urbano maggiore è divenuto nel giro di pochi decenni Atlanta, capitale della Georgia, con oltre 5 milioni di abitanti. Nella Florida, spiccano grandi aggregati costieri, tra i quali Miami-Fort Lauderdale (5,5 milioni di ab.) e Tampa-Saint Petersburg-Clearwater (2,7).
New York, la città più popolosa al momento della dichiarazione di indipendenza, con meno di 80.000 ab. al primo censimento del paese (1790), superava i 100.000 nel 1820, saliva a quasi 700.000 nel 1850, a fine secolo si avvicinava a 3,5 milioni, e nel 1930 aveva registrato un ulteriore raddoppio nel centro, mentre nell’area metropolitana si superavano i 10 milioni: già allora le aree urbane edificate superavano largamente i limiti amministrativi stabiliti pochi decenni prima, quando gli insediamenti erano di dimensioni molto più limitate. Nel caso particolare, New York debordava addirittura dallo Stato, invadendo il confinante New Jersey. Altri casi di grandi città dalla crescita rapidissima sono quelli di Chicago (da 30.000 ab. nel 1850 a 1.700.000 nel 1900) e di Los Angeles (da 100.000 ab. nel 1900 a oltre 2.300.000, per l’area metropolitana, nel 1930).
Le città più antiche sono quelle del settore atlantico e dei Grandi Laghi, che hanno cominciato a strutturarsi nel 19° sec. e che hanno tutte composizione multirazziale, includendo di norma oriundi europei, africani e asiatici. Dalla fine del 19° sec., attorno alla downtown (il nucleo centrale della città) si sono sviluppati insediamenti industriali e residenze operaie; con lo sviluppo dei trasporti, le classi agiate si sono trasferite su fasce residenziali esterne, in villini unifamiliari. Nelle parti centrali si sono edificati grattacieli sempre più numerosi, e di altezza sempre crescente, dove si trovano banche, sedi direzionali di industrie, grandi magazzini, strutture amministrative pubbliche, ovvero le poche attività in grado di pagare affitti elevati. Attorno ai grattacieli sopravvivono edifici di due categorie: alcuni la cui scarsa altezza è ormai simbolo di prestigio, in quanto indica che il proprietario non ha necessità di sfruttare al massimo il suolo; altri completamente fatiscenti, popolati da emarginati di ogni genere, che pagano affitti bassi, mentre i proprietari aspettano di poter abbattere e costruire un nuovo grattacielo.
Densità. Il Sud atlantico, con una popolazione totale di quasi 58 milioni, è la più popolosa delle grandi regioni, con un tasso di crescita nettamente più elevato della media; immediatamente dopo segue la costa pacifica meridionale, con 48,7 milioni. È insomma evidente la predilezione della popolazione statunitense per le fasce costiere.
Nelle regioni centrali, tra Montagne Rocciose e Appalachi, le densità tracollano. Tra le città qui spiccano Chicago (9,5 milioni di ab.) e Detroit (4,5), mentre Minneapolis-Saint Paul raggiunge i 3,5 milioni, e Cincinnati, Cleveland e Kansas City ne hanno circa 2 milioni; più a S, Houston registra 5,5 milioni di cittadini, l’agglomerato di Dallas-Forth Worth circa 6 milioni, quello di Saint-Louis 2,8. I confini settentrionali e meridionali dei diversi Stati dell’ampia regione centrale (Mid;west) poggiano spesso su paralleli: si tratta di limiti amministrativi decisi a Washington prima del popolamento del ‘West’da parte degli Europei; i ‘territori’, posti sotto diretta gestione federale, potevano far domanda per essere qualificati come Stati solo quando la popolazione tassabile avesse superato la soglia oltre la quale un’amministrazione locale si poteva considerare autosufficiente.
Nella regione ancora più a O, quella delle Montagne Rocciose, troviamo le minime densità degli USA (Alaska esclusa), con una media di 10 ab./km2. Qui poggiano sul reticolo geografico anche i confini occidentali e orientali tra Stati, tanto che Colorado e Wyoming hanno forme quadrangolari. L’insediamento sparso è occasionale e a N anche i centri urbani hanno dimensioni limitate; a S le città maggiori concentrano gran parte della popolazione dei relativi Stati: Phoenix (4 milioni di ab.) ospita quasi due terzi della popolazione dell’Arizona; qui e nel Nevada, peraltro, l’incremento recente è stato molto forte.
Sulla costa pacifica, infine, la densità media torna a crescere, fino agli 89 ab./km2 della California. A N, l’agglomerato Seattle-Tacoma giunge a 3,3 milioni di abitanti; ma nel cuore della California San Francisco supera i 7 milioni e la formazione urbana gravitante su Los Angeles, con oltre 17,8 milioni, è tra le più imponenti del mondo. Nelle due concentrazioni vivono oltre i due terzi degli abitanti dello Stato più popoloso. Anche la California ha conosciuto una forte immigrazione da tutti gli altri Stati, e quindi un incremento molto superiore alla media nazionale.
Mobilità. Negli USA la mobilità delle persone è molto più accentuata che in Europa: è abituale che i giovani compiano gli studi superiori senza vivere in famiglia, trasferendosi nella sede universitaria, spesso in un altro Stato; e, in seguito, trovare lavoro cambiando ancora residenza è nell’ordine delle cose. Un tempo si andava a O perché la regione era spopolata; oggi perché le prospettive di lavoro sono migliori sul Pacifico che sull’Atlantico. Migrano, quindi, persone in età lavorativa, tanto che la popolazione del NE risulta mediamente più anziana di quella degli Stati occidentali. La destinazione dei migranti è, in genere, un’area urbana. Negli USA, data la mancanza di un preesistente popolamento, l’insediamento è stato accentrato fin dall’inizio: non è stato il prodotto dell’immigrazione dalle campagne, spopolate, ma dell’afflusso di persone dall’esterno del continente. Il suo accrescimento, pertanto, si è presentato immediatamente in forma esasperata.
Religione. Non esiste una religione ufficiale; secondo i dati calcolati dalle singole confessioni, vi sarebbe circa il 25% di protestanti, il 22% di cattolici, il 34% di altri cristiani (forte è la tendenza alla costituzione di sette religiose), il 10% di non credenti, circa il 2% di ortodossi e altrettanti ebrei, meno del 2% di musulmani ecc.
Condizioni economiche
Quadro generale. Gli USA sono la prima potenza economica mondiale. Rispetto agli altri paesi di dimensioni geografiche più vaste, presentano alcuni vantaggi incontestabili: l’ampiezza dell’area coltivabile è superiore a quelle canadese, cinese e russa; le risorse minerarie sono ingentissime. Inoltre sono spesso statunitensi le grandi compagnie che estraggono minerali nel resto del mondo. Anche nel settore manifatturiero, gli USA hanno dato luogo ai primi episodi di decentramento, spostando gli stabilimenti produttivi dalle città del NE verso cinte periferiche, poi verso i centri urbani dell’Ovest, quindi in paesi del Terzo Mondo (o in Messico, specie dopo l’entrata in vigore del NAFTA).
Caratteristica del sistema statunitense è la forte capitalizzazione, conseguenza dell’accesso diretto dei piccoli risparmiatori al mercato finanziario (attraverso strumenti come i fondi di investimento), che garantisce alle imprese una liquidità tale da permettere investimenti di grande rilevanza. Il formarsi di una concorrenza internazionale ha peraltro spesso portato le industrie a chiedere al governo federale interventi di sostegno e protezione.
Le condizioni di disparità sociale sono marcate: in passato ne soffrivano soprattutto le minoranze, ma oggi il problema è più diffusamente distribuito. Tuttavia, solo il 12% della popolazione è classificato al di sotto della ‘linea di povertà’ (2008), mentre il reddito pro capite è di 46.400 dollari (stima 2009), dopo un paio di decenni di aumenti quasi costanti: è il valore più elevato tra i grandi paesi industrializzati, malgrado la recessione avviata nel 2000, la crisi di fiducia susseguente agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, il calo della produzione industriale, la ripresa della disoccupazione, le oscillazioni borsistiche e infine il crack finanziario esploso nel 2008. Motivi di preoccupazione sono la scarsità di investimenti infrastrutturali, i bassi consumi delle famiglie, l’aumento della spesa sociale causato dall’invecchiamento della popolazione, l’enorme deficit commerciale e del bilancio pubblico.
L’euro potrebbe erodere il ruolo del dollaro come divisa internazionale, con ricadute pesanti sul debito pubblico, di fatto largamente sovvenzionato dalle partite invisibili generate dall’enorme volume di dollari circolanti nel mondo.
Attività agricole. Il primato mondiale statunitense nel settore agricolo è schiacciante, grazie a un enorme uso di mezzi meccanici, fertilizzanti e anticrittogamici e grazie a investimenti statali nella ricerca, per cui i coltivatori sono informati riguardo alle colture più adatte ai loro terreni. La dimensione dei circa 2 milioni di aziende agricole aumenta fortemente verso O, ma è notevole anche nella regione atlantica. Vari provvedimenti hanno teso a favorire la conduzione diretta, anche se in molti casi l’agricoltura viene praticata part-time; nelle zone ortofrutticole a forte richiesta stagionale di manodopera, in particolare in California e nel SO, è fortissima l’immigrazione clandestina di braccianti dal Messico. Lo 0,6% della popolazione attiva coltiva quasi il 20% di superficie del paese, cui vanno aggiunti circa il 26% di prati e pascoli nonché il 33% di zone forestali.
La maggiore superficie coltivata è destinata al mais, con quasi 30 milioni di ha (nelle regioni centro-settentrionali); la produzione giunge a 270 milioni di t annui ed è destinata in gran parte a foraggio. Il frumento è coltivato in quasi tutto il bacino del Mississippi, su oltre 20 milioni di ha, con una produzione di 57 milioni di t. Forti sono anche le produzioni degli altri cereali, soprattutto il riso (quasi 9 milioni di t nel 2006). Alcune produzioni, come patate (quasi 20 milioni di t), barbabietole da zucchero, girasole e colza, sono presenti un po’ ovunque; notevoli sono le colture subtropicali negli Stati del SE, in California e, da minor tempo, in Arizona, New Mexico, Texas, Florida: agrumi, arachidi, tabacco, cotone, oltre alla soia (88 milioni di t), e all’ananas nelle Hawaii. Nelle aree irrigue della California si ottengono primati mondiali nella produzione agrumaria (e ortofrutticola in genere); per la produzione vinicola gli USA seguono da vicino i paesi mediterranei.
Le foreste utilizzate sono in prevalenza quelle della regione montuosa occidentale: se ne ricavano quasi mezzo miliardo di m3 di legname (2006) nonché rilevanti quantità di cellulosa e carta.
Il settore zootecnico conta su un patrimonio bovino di quasi 100 milioni di capi, allevati in stalle negli Stati orientali e allo stato brado nelle Grandi Pianure e nella regione montuosa; oltre 60 milioni sono i suini, nell’area dei Grandi Laghi; molto più modesto, ma tuttora non trascurabile (nonostante la sensibile diminuzione) è il numero degli ovini (6 milioni) e cospicuo quello dei volatili. A tutto ciò si sommano oltre 5,7 milioni di t di prodotti della pesca.
L’agricoltura è collegata con un complesso di produzioni industriali a monte, per la fornitura di macchinari, fertilizzanti ecc., e a valle, per la lavorazione e il commercio dei prodotti, costituendo un vero sistema agroindustriale. Alla metà del 20° sec. si distinguevano alcune fasce (belts) agricole specializzate, in funzione della Megalopoli del NE: nelle vicinanze si sviluppava la dairy belt, con le attività lattiero-casearie; più all’esterno la corn belt, con il mais, oggi largamente affiancato dalla soia; ancora all’esterno si trovava la wheat belt, destinata al frumento; più oltre, nelle Grandi Pianure e nelle zone montane, si stendeva la zona dell’allevamento bovino brado. Negli Stati del Sud si trovava la cotton belt, la sola determinata dal clima (un tempo con il cotone, oggi con tabacco, canna da zucchero, arachide). Da quando il mercato è divenuto veramente mondiale gli USA si preoccupano del livello dei prezzi internazionali al punto che, per mantenerli elevati, si programma la diminuzione di alcune produzioni, come un tempo si procedette alla distruzione delle eccedenze. Malgrado tutto, però, la produzione agricola risulta insufficiente alle esigenze interne del mercato.
Risorse minerarie ed energetiche. Gli USA figurano tra i massimi produttori mondiali di minerali, benché le necessità dell’apparato industriale ne facciano anche il maggiore importatore di materie prime (fig. 2). Nel settore energetico, la grande disponibilità di carbone (Appalachi occidentali, Montagne Rocciose) fu una delle condizioni che consentirono il decollo industriale degli USA, anche se precoce fu la sostituzione del carbone con il petrolio, negli anni della Seconda guerra mondiale. Il carbone è tornato competitivo con l’aumento dei prezzi del petrolio e se ne produce oltre un miliardo di t all’anno (2006). Anche il petrolio statunitense (Texas, Alaska, Louisiana, California) ha conosciuto una ripresa dell’estrazione dopo l’aumento dei prezzi, mentre aveva registrato una seria flessione, dovuta sia agli alti costi di estrazione e di lavorazione, sia alla volontà di preservare le riserve nazionali. Oggi gli USA sono il terzo produttore mondiale, con oltre 250 milioni di t, ma sono anche il primo importatore e coprono circa due terzi dei consumi interni con petrolio importato. Molto attive sono le ricerche nei fondali oceanici, e le sperimentazioni su varie formazioni rocciose bituminose. Una rete di oleodotti di quasi 300.000 km, senza paragoni nel mondo, distribuisce il greggio alle raffinerie, che totalizzano una capacità di raffinazione pari a circa il 20% del totale mondiale. Il gas naturale degli USA (secondo produttore, con oltre 500 miliardi di m3) si estrae soprattutto in Texas, Louisiana e Oklahoma; la rete dei gasdotti misura più di 300.000 km. La produzione di elettricità (4.000 miliardi di kWh nel 2005, un quarto della produzione mondiale) è garantita da centrali termiche convenzionali per circa il 71%, termonucleari per circa il 20% (con una produzione che assegna agli USA il primato mondiale), idroelettriche per il 7%; in aggiunta, si importa una grande quantità di elettricità dal Canada. Gli USA sono comunque tra i paesi più impegnati nella sperimentazione di modalità alternative di produzione di energia.
I maggiori giacimenti di ferro sono quelli del Lago Superiore e, con molti altri, danno una produzione di circa 52 milioni di t di metallo (2007). La produzione di rame (Utah e altri Stati delle Montagne Rocciose), con circa 1,2 milioni di t annue, è al terzo posto al mondo; così quella di piombo (430.000 t) in prevalenza estratto, spesso insieme con lo zinco (740.000 t, quarto produttore), in Missouri, Idaho, Montana. Fra le prime al mondo sono anche le quantità estratte di oro (240 t) e di argento (1200 t), dall’Alaska e dalle Montagne Rocciose, nonché di zolfo, fosfati, bentonite, molibdeno, barite e altri minerali.
Attività industriali. Il settore industriale incide ormai per meno del 20% del PIL e per meno del 23% dell’occupazione (fig. 2). Nonostante la contrazione di quasi tutti i settori a basso contenuto tecnologico e a basso valore aggiunto (per i cui prodotti si ricorre alle importazioni), le produzioni statunitensi continuano ad avere una rilevanza planetaria un po’ in tutti i comparti. La composizione delle esportazioni, tuttavia, vede una metà circa rappresentata da beni intermedi (meccanica, elettrotecnica, elettronica) e solo circa il 15% da beni di consumo (meccanica, chimica fine), che invece pesano per circa un terzo delle importazioni. La produzione siderurgica, che un tempo era ingentissima, caratterizzava intere regioni e determinava il corso economico mondiale, si è molto ridotta e si è orientata sempre più verso gli acciai, mantenendo in questo il terzo posto al mondo, sia pure con un ampio distacco da Cina e Giappone. Il comparto metallurgico rimane importante anche per metalli dei quali non vi sia disponibilità interna, come l’alluminio.
La massima concentrazione di impianti industriali nel paese è sempre nella manufacturing belt (fascia manifatturiera), tra la costa atlantica settentrionale e l’alto Mississippi, e tra i Grandi Laghi e il bacino dell’Ohio a S: fin dalle origini è questa la parte più industrializzata del paese, sia per la presenza di giacimenti di carbone e di ferro, sia per la disponibilità di energia idrica e poi idroelettrica, sia per la possibilità di fruire di trasporti via acqua – la via navigabile Grandi Laghi-San Lorenzo è la più importante al mondo ed è collegata ad altre verso Sud. È in quest’area che sorge Detroit, già cuore mondiale della produzione di autoveicoli, e dove tuttora si realizza gran parte della produzione di automobili, di veicoli commerciali, di pneumatici. Per i prodotti meccanici, compresi i veicoli, il paese è di gran lunga il primo produttore mondiale. Soprattutto in quest’area è concentrata anche l’industria chimica, che realizza da un quinto a un quarto delle esportazioni statunitensi, e che è alla testa della classifica mondiale del comparto benché ormai investita dalla concorrenza cinese. Non mancano certo nell’area le industrie leggere, a eccezione del tessile (cotone), tradizionalmente forte nel S degli USA. Malgrado la recente delocalizzazione in direzione del Messico e di altri paesi latinoamericani e malgrado la concorrenza di Giappone e Cina, il comparto tessile statunitense figura ancora al primo posto al mondo, come anche quello alimentare.
Negli Stati sul Golfo del Messico si è concentrata ovviamente l’attività di raffinazione del petrolio (gli USA raffinano quasi la metà delle benzine prodotte al mondo) e in seguito si è sviluppata la produzione delle fibre sintetiche, data la disponibilità di materia prima.
Attività industriali sono diffuse in tutto il paese, ma l’ampia area del bacino del Mississippi e quella delle Montagne Rocciose è indubbiamente poco industrializzata. Grande sviluppo hanno invece registrato le coste del Pacifico: dapprima in conseguenza della Seconda guerra mondiale e della guerra di Corea, ma poi e soprattutto per la crescente concentrazione di attività di studio e ricerca, e quindi di tecnologie avanzate, di nuovi materiali (leghe speciali, polimeri, ceramiche avanzate, materiali compositi, fibre ottiche, tecniche di miniaturizzazione) e via dicendo. Particolare notorietà ha assunto la Silicon Valley (➔), in California, considerata la culla dell’informatica. Sul suo esempio si sono sviluppate decine di ‘parchi tecnologici’: per es., la Technology Square o la Route 128 a Boston, con il sostegno del Massachusetts institute of technology, o il Technological Triangle presso Raleigh, capitale della Carolina del Nord. I risultati della ricerca scientifica ‘pura’ hanno applicazione in tempi sempre più brevi e gli USA investono nella ricerca più di ogni altro paese del mondo, tramite sia l’amministrazione sia le imprese, favorite dalla legislazione fiscale.
Il ricorso alla tecnologia e a una continua innovazione tecnologica è una costante negli USA: da quando, nel 19° sec., la meccanizzazione dovette supplire alla carenza di manodopera, a quando le innovazioni belliche mirarono non solo a garantire la superiorità sul campo, ma soprattutto a ridurre al minimo le perdite umane statunitensi. Il complesso militare-industriale continua a essere alla testa dell’innovazione nel campo dei nuovi materiali, delle comunicazioni a distanza, dell’elettronica ecc., anche se le ricadute civili sono sempre più rapide e numerose. Molte imprese industriali statunitensi hanno consolidato così una posizione di imprescindibile preminenza mondiale: per es., nel campo informatico IBM, Apple, Univac e Honeywell; General Electric domina il settore dell’elettromeccanica, Westinghouse le ricerche relative al nucleare, ITT, Bell e ATT le telecomunicazioni, altre imprese giganteggiano nella chimica, nella farmaceutica, nel settore delle bevande e via dicendo.
Non va tuttavia dimenticato che oltre la metà del PIL statunitense è oggi garantito da piccole e medie imprese; che sopravvivono, sempre più ai margini del sistema, attività non più competitive; e che problemi assai gravi di riconversione investono comparti tradizionalmente importanti, come quello automobilistico.
Servizi e comunicazioni. Quasi l’80% della popolazione attiva è impiegato nel settore dei servizi, che produce una pari quota di PIL e che è quasi totalmente basato, in ogni settore, sull’organizzazione privata. Fu l’iniziativa privata a strutturare la rete delle comunicazioni ferroviarie, per es., che nel giro di un ventennio provocò la nascita di un’industria siderurgica senza precedenti, la colonizzazione delle Grandi Pianure, la definitiva sconfitta degli ultimi Amerindi, lo sfruttamento minerario delle Montagne Rocciose, la formazione di un mercato unitario di dimensione continentale. La rete ferroviaria complessiva, tutta privata, è la più lunga al mondo, con circa 229.000 km (2005), elettrificati solo per qualche centinaio di km. Nel 1916 la rete misurava addirittura 420.000 km, con 5 linee trans;continentali, prima di subire la concorrenza dei 6.544.000 km di strade, asfaltate per due terzi circa. Le autostrade a pagamento sviluppano oltre 90.000 km. Le autovetture circolanti sono 137 milioni, i veicoli commerciali 105 milioni. Dagli anni 1970, il trasporto di persone si è sempre più orientato verso il mezzo aereo, processo accelerato negli anni 1980 (deregulation), quando i prezzi sono diminuiti. Nel 2005 sono stati trasportati 725 milioni di passeggeri, grazie a oltre 7000 aeroporti: il sistema aeroportuale di New York ha un movimento complessivo enorme ma, per singolo aeroporto, il maggior traffico è quello di Atlanta (90 milioni di passeggeri), seguito da Chicago-O’Hare, quindi da Los Angeles, Dallas-Forth Worth, Denver. Il sistema portuale più trafficato è ormai quello che fa capo a New Orleans (208 milioni di t nel 2007), seguito da Houston (200 milioni, pur essendo un porto fluviale) e quindi da New York (143). Per i container, invece, il primo porto è Los Angeles, seguita da Long Beach e da New York.
Sviluppatissimo è il settore delle comunicazioni a distanza: telefonia, radiotelevisione, e più recentemente Internet, con oltre 700 connessioni ogni 1000 abitanti. È sempre capillare la diffusione della stampa di informazione e molto efficiente il servizio postale, che tra l’altro garantisce l’inoltro della grande mole di vendite per corrispondenza. Il commercio al dettaglio è quasi monopolizzato dalle grandi reti di distribuzione, essendo stati pressoché eliminati gli esercizi commerciali tradizionali; la diffusione dell’impiego di cibi surgelati e il ricorso alla ristorazione veloce (fast food) hanno determinato lo sviluppo di enormi catene di ristorazione.
Nel commercio internazionale gli USA figurano (2007) come terzo esportatore mondiale, dopo Germania e Giappone, e come primo importatore, prima di Germania e Cina; principali corrispondenti sono, senza confronto, Canada e Messico – con i quali vige il NAFTA, accordo di libero scambio – e solo dopo vengono Cina e Giappone, e poi Germania e Gran Bretagna.
Storia
L’età coloniale
La Dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776, sottoscritta dalle 13 colonie inglesi in Nordamerica (New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, Delaware, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Georgia), mise fine a un capitolo di storia coloniale durato complessivamente oltre un secolo e mezzo (fig. 3).
Il dominio coloniale. L’impero inglese in America era infatti sorto per ragioni strategiche con la fondazione della Virginia nel 1607 e si era esteso fino a coprire (1763) un immenso territorio che comprendeva il Canada, varie colonie continentali e isole caribiche. Queste ultime, grandi produttrici di zucchero, erano le più ricche; ma le colonie continentali erano realtà forti e in rapidissimo sviluppo.
A nord, nell’area del New England, si trovavano le colonie sorte dall’emigrazione puritana, iniziata nel 1620, cui aveva fatto seguito (1630) una grande spedizione che aveva dato vita al Massachusetts e a Connecticut, Rhode Island e New Hampshire. Commercio atlantico, pesca e cantieristica avevano nel tempo fatto la fortuna delle città costiere come Boston, principale centro delle colonie anche da un punto di vista culturale. Le cosiddette colonie del centro erano etnicamente e religiosamente miste. Nella colonia di New York, presa agli Olandesi nel 1664, convivevano Olandesi, Inglesi, Scozzesi, Francesi, Tedeschi e ogni sorta di chiesa e setta protestante. La Pennsylvania si era sviluppata attraverso l’immigrazione di Tedeschi renani fuggiti nel corso delle guerre di Luigi XIV. La ricchezza delle colonie del centro si fondava sull’agricoltura cerealicola nei grandi bacini dei fiumi Hudson e Susquehanna. Nelle colonie del Sud la presenza del tabacco aveva fatto sorgere il sistema di piantagione fondato sulla schiavitù dei Neri.
Pur tanto diverse fra loro, le colonie lo erano ancor di più rispetto all’Inghilterra, e vi nacquero società molto meno gerarchiche e più individualiste di qualunque società europea dell’epoca. L’impero inglese, inoltre, non era governato dal centro in modo burocratico come quello spagnolo e francese. Ragioni costituzionali e il prevalere nella classe dirigente britannica di un’idea commerciale piuttosto che territoriale di impero avevano fatto sì che le colonie nascessero come concessioni territoriali a fini economici fatte dal re a privati. Il potere conferito dalle Carte regie ai concessionari di governare chi vi immigrasse, garantendo loro i diritti di sudditi inglesi, trasformò le colonie in entità politiche autonome sul piano interno e dotate di organismi rappresentativi esemplati sul Parlamento inglese. L’impero era governato unitariamente solo in campo economico in quanto il Parlamento, con i cosiddetti Atti di navigazione, fece dell’impero un sistema commerciale compatto, posto al servizio della madrepatria. Il trattato di Parigi del 1763, che mise fine alla guerra dei Sette anni, liberò gli Americani dalla presenza francese; nonostante la vittoria, il governo britannico era preoccupato per l’enorme debito pubblico accumulato durante la guerra e perché l’immenso impero creava problemi che richiedevano costosi interventi centrali. Nello stesso 1763, la torrentizia avanzata dei pionieri sulla frontiera e l’incapacità dei governi coloniali di regolarla provocò una terribile rivolta indiana nel Nord-Ovest e il re Giorgio III intervenne con un proclama che bloccava la penetrazione nelle terre indiane.
La guerra d’indipendenza. Nel 1765 il Parlamento, per finanziare l’amministrazione imperiale e mantenere truppe lungo la frontiera, approvò lo Stamp act, che estendeva alle colonie la tassa di bollo in uso in Gran Bretagna. All’immediata reazione a questa legge la risposta inglese fu che il Parlamento rappresentava la nazione e quindi, virtualmente, tutti i sudditi ovunque si trovassero. Le due posizioni rimasero distanti; gli Inglesi si convinsero di non poter più lasciare ai coloni i loro poteri di autogoverno e questi ultimi crearono una rete di gruppi politici, i Sons of liberty, per resistere alla ‘tirannia’. Quando nel 1774 il governo inglese decise di sospendere il governo del Massachusetts e di chiudere il porto di Boston come punizione contro le attività dei Sons of liberty, gli Americani risposero sostituendo quasi ovunque i governi coloniali con altri provvisori e convocarono un Congresso continentale di tutte le colonie per decidere unitariamente le azioni da intraprendere contro Londra.
Nel 1775 iniziarono scontri militari attorno a Boston, assediata dalle forze americane sotto il comando del virginiano G. Washington. Trascinato dall’enorme successo popolare di Common sense, un pamphlet di un radicale inglese appena giunto in America, T. Paine, che chiedeva l’indipendenza, il 4 luglio 1776 il Congresso approvò la Dichiarazione di indipendenza stilata da un altro virginiano, T. Jefferson; in essa si proclamavano i diritti naturali alla vita, libertà e felicità, il principio della sovranità popolare e il diritto dei popoli alla rivoluzione e all’indipendenza. La guerra che seguì fu lunga e drammatica. Gli Inglesi conquistarono New York (1776) e Filadelfia; Washington riuscì però a mantenere operativo il suo piccolo esercito e le tante offensive inglesi si dimostrarono presto inutili. Sconfitti a Saratoga Springs (1777), gli Inglesi subirono una decisiva disfatta a Yorktown (1782) a opera di Washington. Nel 1783 l’Inghilterra finì con l’accettare l’indipendenza americana (Trattato di Versailles).
Dall’indipendenza alla guerra civile
Gli USA, riconosciuti sovrani su un territorio in buona parte non colonizzato, che andava dall’Atlantico al Mississippi, avevano istituzioni politiche deboli. Il Congresso continentale era stato solo un organo di coordinamento politico e militare degli Stati e gli Articoli di confederazione, ratificati nel 1781, non avevano creato un governo centrale; tale situazione rispondeva ai sentimenti repubblicani del popolo, che temeva un governo lontano e incontrollabile. Di diverso avviso era una élite di uomini nuovi, formatisi nella rivoluzione, nazionalisti e attenti al ruolo degli USA in un mondo di grandi potenze. I tentativi di Francia e Gran Bretagna di impadronirsi del commercio americano con una politica neocoloniale, che tendeva a dividere i singoli Stati, li convinse della necessità di cambiare le istituzioni. Essi riuscirono a far sì che il Congresso continentale convocasse una Convenzione per modificare gli Articoli e la trasformarono in un’assemblea costituente.
Nell’estate del 1787 a Filadelfia, Washington, A. Hamilton, J. Madison e B. Franklin guidarono la Convenzione verso la stesura di una nuova Costituzione, da sottoporre a ratifica popolare negli Stati. Dai molti compromessi uscì una struttura statuale innovativa, fondata sulla divisione dei poteri, sul presidenzialismo bilanciato dal federalismo, su un potere legislativo in cui al Senato si affiancava una Camera dei rappresentanti eletta in base alla popolazione, e su un riconoscimento indiretto della schiavitù, mitigato dal fatto che la tratta era ammessa solo fino al 1808. Fra il 1787 e il 1788 la Costituzione fu ratificata dagli Stati e Washington fu eletto presidente degli Stati Uniti d’America. Nel definire il futuro del paese si verificarono divisioni profonde, simboleggiate dallo scontro fra Hamilton, ministro del Tesoro e uomo forte del governo Washington, che rafforzò i poteri del governo federale, e Jefferson, segretario di Stato, che riteneva la Costituzione troppo centralista e oligarchica e nel 1791 aveva fatto approvare dal Congresso i primi 10 emendamenti, per dare garanzia costituzionale ai diritti dei cittadini.
Eletto presidente (1801), nel 1803 Jefferson inaugurò la politica di espansione territoriale degli USA acquistando da Napoleone la Louisiana. Subito dopo un fiume di pionieri si rovesciò verso Ovest, oltre gli Appalachi, e a metà secolo il territorio fra questi e il Mississippi era tutto suddiviso in Stati. Nel frattempo la frattura tra il Nord e il Sud dell’Unione si approfondì. La società di piantagione sudista si rafforzò passando alla produzione cotoniera in coincidenza con la rivoluzione industriale inglese. Ciò determinò l’aumento della popolazione schiava che raggiunse 1.500.000 unità nel 1820 per arrivare a oltre 4.000.000 nel 1860. In parallelo nel Sud si sviluppò anche un’ideologia che non considerava più la schiavitù un male necessario, ma la difendeva apertamente come forma di lavoro adatta alla popolazione di colore e sosteneva la piantagione come sistema alternativo all’industrializzazione. Tale sistema, che finì per identificare il Sud, malgrado la presenza di contadini non possessori di schiavi, veniva contrapposto dagli ideologi sudisti alla ‘schiavitù industriale’ del Nord, che cominciava a estendere i suoi effetti al Bacino del Mississippi, trasformato con l’arrivo dei contadini del New England in centro granario della nazione, mentre nel Nord si avviava il passaggio alla produzione industriale.
Verso il 1840 le ferrovie fornirono un ulteriore impulso all’economia, unificando il mercato nordista e facendo dell’industria siderurgica uno dei motori dello sviluppo, tanto che nel 1860 il Nord aveva terminato la sua rivoluzione industriale. L’impetuosa crescita economica portò a un rinnovamento sociale con la rottura delle vecchie oligarchie sociali e una democratizzazione a vantaggio dell’individualismo degli uomini nuovi che volevano avere libertà e opportunità di fare fortuna. Queste istanze si concretizzarono nel suffragio universale, trovarono spazio politico con la nascita del Democratic party (1828) e si impersonarono nella figura del presidente A. Jackson, eroe della seconda guerra contro gli Inglesi (1812-14) e uomo della frontiera, che con lo spoils system favorì la democratizzazione della burocrazia, combatté i privilegi delle oligarchie economiche legate alla Banca degli USA e garantì ai coloni territori da coltivare fino al Mississippi. A questo si aggiungano gli effetti della ‘dottrina Monroe’, elaborata dal segretario di Stato J.Q. Adams e illustrata dal presidente J. Monroe, che enunciava l’esclusione delle potenze europee dalla colonizzazione del continente americano e poneva gli USA come potenza predominante sul continente (dottrina del ‘destino manifesto’); se ne ebbe il primo effetto con la guerra del Texas che portò prima all’indipendenza di tale Stato dal Messico (1836) e poi all’annessione all’Unione (1845), cui seguì quella dell’intero Sud-Ovest e della California nel 1850.
L’Unione raggiungeva così l’Oceano Pacifico, ma restava da conoscere e colonizzare l’enorme parte centrale del continente. Su tale espansione pesava la questione schiavista (la California fu annessa come territorio senza schiavitù, ma per gli altri territori si lasciò la decisione alle assemblee locali). Nel Nord si era formato un movimento abolizionista (W.L. Garrison e F. Douglass), mentre il Sud era agitato dalle minacce di rivolte. Ma fu al momento di organizzare i territorio del Kansas che esplosero le contraddizioni tra abolizionisti e schiavisti, con la nascita del Republican party, contrario alla schiavitù perché riteneva che democrazia e progresso fossero legati al valore morale del lavoro e all’iniziativa individuale degli uomini liberi. Alle elezioni del 1860, quando si erano avute già concrete azioni antischiaviste (come quella di J. Brown a Harper’s Ferry nel 1859), la divisione del partito democratico favorì la vittoria del repubblicano A. Lincoln, avversario dell’introduzione della schiavitù nei nuovi territori in vista di una lenta ma progressiva abolizione in tutta l’Unione.
L’uscita della Carolina del Sud dall’Unione e l’attacco a Forte Sumter portarono alla Secessione della Confederazione sudista (con la presidenza di J. Davis) e alla guerra civile (fig. 4) nella quale fu necessaria al Nord una strategia di lento logoramento (blocco navale, guerra di posizione), basata sulla netta superiorità dell’industria bellica, contro un avversario che contava sulle grandi capacità strategiche di una guerra difensiva e sui rapporti economici con la Gran Bretagna, da cui però non fu appoggiato. Nel 1863 con i proclami antischiavisti di Lincoln e le vittorie militari nordiste a Gettysburg e a Vicks;burg il destino del Sud era segnato: la resa del generale R.E. Lee al suo avversario U.S. Grant avvenne il 9 aprile 1865.
Dalla Ricostruzione alla Prima guerra mondiale
Dopo l’assassinio di Lincoln da parte di un irriducibile sudista, il Nord impose con l’occupazione militare l’abolizione della schiavitù, concedendo cittadinanza e diritti civili e politici alla popolazione nera (13°, 14° e 15° emendamento), ma senza assegnarle le terre. Il partito repubblicano si espanse nel Sud soprattutto grazie agli ex schiavi, provocando le reazioni dei bianchi con organizzazioni anche violente come il Ku Klux Klan. Nel 1867 iniziò la ricostruzione fondata sulla leadership economica del Nord alleata con il partito repubblicano. L’avanzamento della frontiera fu favorito dallo sviluppo della rete ferroviaria, con conseguente slancio dell’industria siderurgica. Soprattutto venne favorita un’integrazione economica del paese con la formazione di un mercato nazionale, che marginalizzava le classi sociali legate alla politica e all’economia locale (professionisti, operai specializzati del Nord-Est) per favorire uomini nuovi che crearono dal nulla enormi imperi industriali, attingendo la manodopera in un sottoproletariato formato da immigrati dall’Europa. Da questa società verticalizzata vennero esclusi i nativi americani che, tranne alcuni episodi (massacro della colonna del generale Custer a Little Big Horn, 1876) vennero confinati in riserve, e anche gli ex schiavi del Sud, che l’élite bianca privò progressivamente dei diritti politici (Jim Crow Laws, 1887). Il sistema di mercato integrato colpì i piccoli contadini delle grandi pianure, la cui ribellione attraverso il People’s party (1891) non ebbe successo. L’ondata immigratoria successiva al 1880, formata da Italiani e da Polacchi e altri Europei dell’Est, molti dei quali di religione ebraica, costituì un serbatoio di manodopera non specializzata a poco prezzo e una massa di manovra per la corruzione politica. Inoltre il sindacato American Federation of Labour (AFL) organizzava gli operai specializzati e rifiutò ogni richiamo classista, cosicché il movimento socialista americano (Socialist party of America, costituito nel 1901 da E.V. Debs) non prese mai le redini del movimento operaio. Con la presidenza di W. McKinley (1896) il capitalismo monopolistico toccò il suo apice con magnati (tycoons) quali A. Carnegie nell’acciaio, N. Rockefeller nel petrolio, B.H. Hill nelle ferrovie e P. Morgan nella finanza.
Al capitalismo monopolistico e alla corruzione derivante dalla commistione tra politica e business rispose un movimento progressista fautore di riforme in favore della partecipazione popolare e dell’efficienza modernizzatrice espressa dalla middle class. La spinta progressista si incarnò in T. Roosevelt, presidente dal 1901 al 1909, favorevole ai trust, ma anche alla loro regolamentazione in favore dei diritti dei consumatori (Pure food and drugs, 1905), nonché apertamente espansionista con la politica del big stick (➔) in politica estera (guerra di Cuba con occupazione di Puerto Rico e Filippine; annessione delle Hawaii; costituzione dello Stato indipendente di Panamá nel quale costruire l’omonimo canale). Nelle presidenziali del 1912 Roosevelt fondò il Progressive party contro il repubblicano W.H. Taft e il democratico W. Wilson, espressione del progressismo etico e individualista che si muoveva contro i trust, che prevalse. Nonostante una serie di leggi di riforma, come quella che nel 1913 mise ordine nella politica monetaria istituendo il Federal reserve system, le due presidenze di Wilson furono segnate soprattutto dalla politica estera, sia in occasione della rivoluzione messicana, sia, superata la proclamata neutralità, nella Prima guerra mondiale, con l’intervento del 1917 che risultò decisivo sia militarmente sia economicamente. Alla conferenza di pace di Versailles, Wilson cercò di usare la sua posizione di forza per far accettare una pace basata sui suoi 14 punti, che culminavano nella proposta di creazione della Società delle Nazioni. Nell’estate 1919 poté quindi tornare in patria certo di aver fatto degli USA non solo la prima potenza mondiale, ma anche il garante di un pacifico ordine internazionale.
Dalla ‘paura rossa’ alla Seconda guerra mondiale
Tuttavia la ‘paura rossa’, sviluppatasi nel 1919-20 a seguito della Rivoluzione russa, produsse un ritorno conservatore che travolse Wilson, colpendo con durezza anche il sindacato AFL nel suo sforzo di sensibilizzare gli operai siderurgici e non risparmiando la persecuzione di comunisti e anarchici (il sindacato Industrial Workers of the Words, la condanna di N. Sacco e B. Vanzetti nel 1921). Gli anni 1920 furono connotati da elementi conservatori dai tratti moralisti quali il proibizionismo (1919) e il nativismo (leggi anti-immigrati e rinascita del Ku Klux Klan). Parallelamente però si assistette a un boom economico, guidato dalle industrie di beni di consumo, dalla pubblicità e dall’industria del divertimento. La donna (cui era stato riconosciuto il diritto di voto nel 1920) fu spinta all’interno del mondo del lavoro, ci furono mutamenti nella famiglia e nella morale e il divertimento (musica, cinema, sport, moda) entrò nella vita quotidiana. Aumentarono PIL, reddito medio pro capite e produzione industriale sulla base di autoregolamentazioni e accordi di mercato tra imprese consorziate (trade association); il ruolo di mediatore tra i vari interessi era svolto dal governo, secondo il pensiero di H.C. Hoover. La modernizzazione economica e sociale avvenne quindi sotto l’egida di valori conservatori incarnati dal presidente C. Coolidge, che aveva duramente represso gli scioperi. Il suo successore fu proprio Hoover, che però si trovò a fronteggiare la non prevista crisi del 1929 in cui si unirono gli effetti speculativi del boom della Borsa che durava dal 1926, il declino delle industrie tessili e del carbone, la sovrapproduzione agricola.
Legato alla sua idea di governo arbitro al di sopra delle parti, Hoover non intraprese una politica di aiuti governativi e durante la ‘grande depressione’ il suo potere si logorò fino alla sconfitta nelle presidenziali del 1932 di fronte al democratico F.D. Roosevelt. All’inizio del suo mandato con il paese al tracollo, Roosevelt, convocato il Congresso in sessione straordinaria ed evitato il tracollo del sistema bancario, lanciò il suo programma di New deal che investiva il governo federale del compito di intervenire nello stimolo dell’attività economica e nell’incentivo ai singoli. Su questa base agirono agenzie quali la Public works administration e i Civilian conservation corps, quest’ultima rivolta ai giovani. Nel complesso il New deal rimase inizialmente fedele al principio di cooperazione fra i gruppi economici e sociali, pur se guidati dallo Stato, e con la National Recovery Ad;ministration (NRA) cercò di rivitalizzare prezzi e produzione industriali con i ‘Codici di concorrenza leale’ di settore, che dividevano il mercato fra le aziende in base ad accordi fra imprese, sindacati e governo. Ma nel 1935 fu necessaria un’ulteriore iniziativa in senso progressista e keynesiano con la Works project administration, che prevedeva un vasto piano di opere pubbliche e un’apertura ai sindacati, ai contratti collettivi, alla previdenza sociale e alla progressività del sistema fiscale e al controllo sulle grandi holding. Raggiunto l’acme della popolarità nelle elezioni del 1936 con il sostegno della classe media, la politica del New deal conobbe una crisi a partire dall’anno successivo, nel quale la Corte Suprema invalidò alcuni provvedimenti che non erano condivisi neppure dei conservatori del Partito democratico, impressionati dagli scioperi che i sindacati industriali, federati nel Congress of Industrial Organization (CIO), erano riusciti a organizzare nell’industria dell’acciaio e in quella automobilistica. Roosevelt ribadì il carattere super partes del governo e concluse la politica del New deal nel 1938 con il Fair labor standard Act, che vietava il lavoro minorile e fissava minimi retributivi nell’industria.
La Seconda guerra mondiale e la guerra fredda
Il periodo tra le due guerre. La cooperazione tra le grandi potenze e l’espansionismo commerciale fu l’iniziale politica statunitense nel periodo tra le due guerre. Grazie al rifiuto di condonare i debiti di guerra agli alleati della Prima guerra mondiale, gli USA posero l’Europa sotto la loro egemonia economica. Inoltre esercitarono pesanti interferenze in America Latina e in Estremo Oriente. Con Roosevelt prese forma la politica del ‘buon vicinato’ nella quale gli interessi statunitensi, pur chiaramente sostenuti, dovevano aver luogo nel contesto dello sviluppo mondiale. Ciò portò anche al riconoscimento nel 1933 dell’Unione Sovietica, malgrado l’opinione pubblica americana, spaventata dagli eventi internazionali degli anni 1930, fosse spinta verso l’isolazionismo, cui fecero riscontro i Neutrality Acts tra il 1935 e il 1937. Roosevelt tuttavia iniziò a sostenere una politica di opposizione alle potenze antidemocratiche, Germania, Italia e Giappone, per le quali propose nel 1937 una ‘quarantena’.
Vinte le elezioni nel 1940, Roosevelt seguì la via della ‘non belligeranza’, che tuttavia consentiva aiuti statunitensi contro il nazismo (Lend-lease Act, 1941). Intanto gli USA sostenevano la Cina contro l’invasione giapponese passando poi nell’autunno nel 1941 a chiedere a Tokyo il ritiro delle truppe.
La guerra. L’attacco giapponese a Pearl Harbour del 7 dicembre 1941 provocò l’ingresso degli USA nel conflitto mondiale sui due scenari europeo e asiatico. In Europa le truppe alleate iniziarono l’offensiva dal Nord Africa (novembre 1942) all’Italia (luglio 1943), fino al decisivo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944 guidato da D.D. Eisenhower e conclusosi con la resa tedesca del maggio 1945. Nel Pacifico le operazioni furono più lente, partendo dalla battaglia delle isole Midway cui seguì la lenta avanzata guidata dall’ammiraglio C.W. Nimitz e dal generale D. MacArthur. Dal 1942 Roosevelt impostò l’ordine postbellico sulla base di una contrapposizione tra democrazia e totalitarismo, secondo un internazionalismo neowilsoniano (accordi di Bretton Woods del 1944 che dettero vita alla Banca Mondiale e al Fondo monetario internazionale; Nazioni Unite costituite a San Francisco il 26 giugno 1945). Alla base di questo doveva esserci l’accordo con l’altro vincitore della guerra, l’Unione Sovietica, che accettò il programma di Roosevelt, ottenendo in cambio il principio delle ‘sfere d’influenza’ che le consentivano la creazione di un forte nucleo di Stati ‘amici’ (conferenza di Jalta, febbraio 1945).
L’alleanza tra le due superpotenze fu compromessa dalle diffidenze reciproche e anche dalla morte di Roosevelt nell’aprile 1945. Si sviluppò così senza pianificazione, ma inevitabilmente, la guerra fredda, che nasceva dalla contrapposizione di ideologie e interessi che nessuno dei due Stati voleva risolvere con le armi. L’utilizzo dell’arma atomica deciso dal presidente H.S. Truman a Hiroshima e Nagasaki (primi di agosto 1945) non solo eliminò l’incubo della resistenza giapponese, ma instaurò la politica dell’‘equilibrio del terrore’ atomico.
La guerra fredda. Il 12 marzo 1947 Truman enunciò al Congresso la ‘teoria del contenimento’ che sanzionava la guerra fredda: gli USA avrebbero difeso i paesi minacciati dall’espansionismo sovietico. Intanto in Europa, dopo la crisi di Berlino (blocco sovietico delle strade e ferrovie delle zone di occupazione occidentale), la guerra fredda si stabilizzò. Per contenere ulteriori espansioni del comunismo, gli USA promossero una politica di alleanza con e tra i paesi alleati (costituzione della NATO, 1949) e di sviluppo economico di questi nella ricostruzione postbellica con il Piano Marshall. Mentre in America Latina il panamericanismo teneva i governi in linea con le posizioni di Washington, in Asia la Rivoluzione cinese rovesciò il governo di Jiang Jieshi, sostenuto dagli statunitensi, nel 1949 portando al potere i comunisti di Mao Zedong. Nel giugno 1950 l’invasione nordcoreana della Corea del Sud provocò l’intervento degli USA, sotto le bandiere delle Nazioni Unite. L’invasione fu fermata, ma non riuscì la controinvasione della Corea del Nord che avrebbe scatenato una guerra mondiale.
In campo interno la guerra fredda bloccò ogni istanza riformatrice e Truman, per respingere il pericolo di una vittoria elettorale repubblicana, nel 1948 propose una difesa del welfare State abbinata a un rigido conservatorismo sui valori della religione e della famiglia. Il secondo mandato di Truman fu caratterizzato dall’anticomunismo, in particolare dall’iniziativa del senatore J.R. McCarthy contro un gruppo di cineasti di Hollywood che furono costretti a subire un processo spettacolo. La svolta conservatrice non cancellò comunque le riforme del New deal in quanto la middle class che ne beneficiava costituiva ormai più della metà della popolazione e il cuore del sistema politico. Inoltre l’economia era florida sia per le forniture ai paesi distrutti dalla guerra, sia per lo sviluppo dei consumi interni soprattutto di prodotti nuovi (materie plastiche, fibre sintetiche, elettrodomestici). L’ideale dell’American way of life, fondato su democrazia, cooperazione tra gruppi sociali e fede concreta nell’individuo, permeava e definiva la società statunitense.
L’elezione nel 1952 di Eisenhower caratterizzò questa epoca sulla base di un modern republicanism, conservatorismo moderato e benevolo volto alla pace sociale, alla politica di welfare e allo sviluppo. In politica internazionale, insieme al segretario di Stato J.F. Dulles, Eisenhower teorizzò la guerra fredda come scontro di civiltà tra due blocchi contrapposti, evitando tuttavia lo scontro, ma favorendo una coesistenza con i successori di Stalin (morto nel 1953), anche se gli incontri con N.S. Chruščëv fallirono al momento conclusivo quando, nella primavera 1960, un U2, aereo spia americano, venne abbattuto nei cieli russi.
Dalla New Left al neoconservatorismo
Kennedy. Alla fine degli anni 1950 le sicurezze dell’epoca di Eisenhower entrarono in crisi, anche perché la concorrenza sovietica diventava tecnologica (lancio dello Sputnik nel 1957) e politica in campo internazionale, per il ruolo di referente di Mosca per i paesi postcoloniali. Internamente covava da tempo la crisi relativa alla segregazione razziale. La clamorosa sentenza della Corte Suprema guidata dal giudice E. Warren nel caso Brown versus il Board of Education che nel 1954 dichiarò incostituzionale la segregazione nelle scuole (vigente nel Sud e di fatto altrove), rafforzò il movimento per i diritti civili. Nel 1955 M.L. King jr assunse la guida del movimento non violento ispirato dalle chiese e dalle teorie di Gandhi e trovò il sostegno di un numero crescente di bianchi, ottenendo risultati positivi dopo sanguinose lotte negli anni 1960 e 1961.
Le elezioni del 1960 rappresentarono una svolta. Il candidato repubblicano R.M. Nixon, vicepresidente in carica, venne battuto per pochi voti dal democratico J.F. Kennedy, senatore cattolico del Massachusetts che presentò uno stile politico nuovo e un programma per ‘rimettere in moto’ la nazione detto della Nuova Frontiera contro la povertà e per i diritti dell’uomo, nel quale egli collaborò con il fratello R.F. Kennedy. Venne rafforzato il welfare State e, a seguito della grande marcia su Washington guidata da King nel 1963, fu proposto un progetto di legge sui diritti civili. In politica estera Kennedy cercò di attirare le simpatie dei paesi del Terzo mondo con aiuti concreti in concorrenza con l’URSS. Tuttavia si scontrò con la crisi di Cuba dove la rivoluzione socialista e populista di F. Castro fu seguita dall’avvicinamento di questi all’URSS. Il fallimento dell’invasione di anticastristi armati dalla CIA nell’aprile 1961 offuscò l’immagine di Kennedy, che tuttavia nell’ottobre 1962, scoperta l’installazione di missili sovietici a medio raggio a Cuba, riuscì a imporre il loro ritiro con la promessa di non attaccare Castro. Per alcuni giorni il mondo fu sull’orlo di una guerra nucleare e il successo dette a Kennedy la statura di leader mondiale e interlocutore con l’URSS, con cui nel luglio 1963 firmò un accordo per la sospensione degli esperimenti nucleari. La presidenza di Kennedy si concluse il 22 novembre 1963 con l’attentato mai definitivamente chiarito di Dallas, che tramandò nell’immaginario collettivo l’età kennedyana come quella di una promessa di un’età migliore.
Johnson e Nixon. Il successore L.B. Johnson, liberal del Texas, continuò la lotta alla povertà e tra il 1964 e il 1966 fece approvare la legge sui diritti civili preparata da Kennedy e norme che cambiarono lo Stato federale assicurando, per es., copertura sanitaria ad anziani e indigenti (programmi Medicare e Medicaid). Tuttavia si riaccesero le tensioni sociali. Da un lato la destra ultraconservatrice trovò in B.M. Goldwater un suo rappresentante. Dall’altro lato le rivolte dei ghetti degli afroamericani, organizzati nelle associazioni di musulmani neri, e i nuovi leader (Malcom X, S. Carmichael) che avevano abbandonato le posizioni pacifiste di King (assassinato nell’aprile 1968) mostrarono il fallimento della politica di integrazione. A ciò si aggiunse la rivolta studentesca, che presentava istanze di democrazia partecipativa e, più in generale, esprimeva una diffusa controcultura pacifista che si opponeva alla guerra in Vietnam, e un movimento femminista che giunse a maturità.
Nella politica estera si giocò il destino di Johnson e dell’interventismo americano. Nel 1965 gli USA si mossero per evitare una seconda Cuba nella Repubblica dominicana, ma fu sul Vietnam che la politica estera e la guerra ebbero ricadute sulla politica e sulla società nel paese. Con Johnson il sostegno americano ai Sudvietnamiti divenne diretto con bombardamenti massicci e invio di soldati, cui i Nordvietnamiti risposero con l’offensiva del Tet. Nel marzo 1968, di fronte all’impopolarità della guerra, Johnson propose colloqui di pace e annunciò di non volersi ricandidare.
L’assassinio di R.F. Kennedy, probabile candidato alla presidenza, accrebbe il senso di smarrimento, cosicché le elezioni del 1968 furono vinte dal repubblicano conservatore R. Nixon, il cui appello alla ‘maggioranza silenziosa’ riscosse successo, anche perché egli si presentò come moderato. In campo internazionale Nixon intese adottare un approccio meno ideologico e più realistico, firmando il primo trattato sulla limitazione delle armi nucleari (SALT) e avvicinandosi alla Cina con la storica visita di Stato del 1972. Per costringere i Nordvietnamiti a un accordo e così disimpegnarsi militarmente, egli estese il conflitto alla Cambogia, intensificando i bombardamenti. In Medio Oriente la sua politica fallì, perché gli Stati arabi produttori di petrolio potevano giocare in modo autonomo dalle superpotenze grazie al controllo dell’OPEC e alle possibilità di embargo.
Nelle elezioni del 1972 Nixon ebbe un grande successo anche tra i democratici del Sud, ma nel 1973 emersero dei tentativi di spionaggio a danno del Partito democratico che coinvolsero direttamente il presidente e portarono nel 1974 al suo empeachment, cui seguirono le dimissioni.
Carter e Reagan. Il subentrato vicepresidente G.R. Ford non fu all’altezza del compito, così i democratici poterono riconquistare la Casa Bianca con J. Carter, che non riuscì a dar sostanza a una nuova politica estera basata sui rapporti Nord-Sud, scontrandosi con una fase economica di stagflazione in peggioramento, nonché subendo l’umiliazione dell’occupazione dell’ambasciata americana a Teheran, a seguito della rivoluzione islamica, e del fallimento del tentativo di liberare gli ostaggi. Con un paese frustrato e un presidente indebolito, guidati da nuovi leader e nuove idee, mossero alla conquista della Casa Bianca i repubblicani che avevano impresso una svolta conservatrice alla loro politica indirizzando il loro programma allo smantellamento del welfare State per battere l’ideologia progressista liberal dei democratici. Grazie alla crisi economica del Nord-Est democratico e all’accresciuto peso politico del Sud-Ovest individualista, nel 1980 fu eletto R.W. Reagan, governatore della California ed ex attore cinematografico. Reagan poté perseguire una politica economica di tagli a imposte e spese pubbliche riducendo l’intervento statale in economia; non realizzò invece la rivoluzione sociale in senso conservatore che aveva promesso. L’esito dei due mandati della reaganomics fu brillante nel medio periodo, ma lasciò deficit di bilancio e creò un deficit commerciale. In politica estera Reagan riprese lo schema bipolare dello scontro con l’‘impero del male’ comunista, ricominciando le interferenze nell’America Centrale e intervenendo direttamente a Grenada nel 1983.
Nel 1985, con l’avvento al potere in URSS di M.S. Gorbačëv, la strategia di Reagan si dimostrò vincente: la guerra fredda ebbe termine con la firma di un trattato per lo smantellamento dei missili a medio raggio (1987). Nonostante l’insuccesso dell’intervento nella guerra del Libano e le ombre suscitate dalle accuse di aver fornito armi all’Iran in cambio della liberazione degli ostaggi statunitensi (caso Irangate), Reagan concluse i due mandati da trionfatore, ma lasciò una diminuita concorrenzialità dell’economia e uno scontro fra la cosiddetta Nuova destra cristiana e movimenti (afroamericani, ispanici, nativi, donne e omosessuali) che volevano riconosciuto il ‘diritto alla differenza’.
Bush senior. Il successore repubblicano G.H.W. Bush intese garantire gli equilibri regionali dove maggiori erano gli interessi nordamericani (intervento militare a Panamá, 1989; guerra del Golfo contro l’Iraq, 1991; avvio di un processo di pace in Medio Oriente, 1991), ma non seppe rialzare le sorti dell’economia e gestire le tensioni sociali, sfociate nella rivolta razziale di Los Angeles (1992).
Da Clinton a Biden
Clinton. Nel 1992 Bush fu sconfitto dal governatore democratico dell’Arkansas, B. Clinton, che aveva riportato il suo partito a un programma centrista. Clinton non ripudiò la politica estera di Bush, ma diede la precedenza alla riconquista della competitività del paese in un’economia globale. Nel 1994 fronteggiò la Nuova destra del repubblicano N. Gingrich che, pur facendo fallire la riforma sanitaria e vincendo le elezioni legislative con il ‘Contratto con l’America’, non mise in difficoltà Clinton nella corsa alla Casa Bianca nel 1996, che sfruttò la crescita economica del paese. Nel suo secondo mandato presidenziale Clinton abbandonò ogni visione welfaristica dello Stato per una politica di incentivi fiscali e sociali individuali per lo sviluppo delle ‘risorse umane’. Sul piano internazionale promosse l’allargamento della NATO ad alcuni paesi dell’Europa orientale e si impegnò ad ampliare la sfera di influenza americana in Africa centrale. La crisi finanziaria delle ‘tigri asiatiche’ nella seconda metà del 1997 costrinse gli USA a costosi interventi di sostegno, che nel 1998 si dovettero allargare alla Russia. Inoltre Clinton procedette unilateralmente nei focolai di crisi come in Iraq con i bombardamenti di installazioni militari del dicembre 1998, compiuti con l’aiuto della sola Gran Bretagna. All’interno, Clinton fu in difficoltà per scandali e inchieste, come l’affare Whitewater su finanziamenti illeciti, e soprattutto per aver mentito sotto giuramento sui suoi rapporti con una ‘stagista’ della Casa Bianca. Quest’ultimo caso aprì la strada alla procedura costituzionale di impeachment contro Clinton, ma il Senato non si pronunciò per la condanna, anche per la pressione dell’opinione pubblica. I progressi dell’economia tra 1998 e 1999 premiarono l’azione politica di Clinton, una ‘terza via’ fra progressismo e conservatorismo, tesa ad assecondare flessibilità e inventiva, e a fornire strumenti in favore dei singoli in una società permeata dalla rivoluzione informatica e dalla globalizzazione. Anche in politica estera le iniziative unilaterali nel contesto della NATO su singole aree regionali (intervento in Kosovo del marzo 1999 contro la pulizia etnica della Iugoslavia) erano basate sulla premessa che la globalizzazione dovesse portare a un convergere spontaneo delle politiche nazionali e quindi a un’accettazione internazionale degli interventi contro chi operasse in nome di interessi culturali o politici a essa estranei. Ma sia la politica economica, sia la politica estera non furono senza incertezze, e i risultati altalenanti dell’ultima fase di Clinton (successo diplomatico con la Cina, mediazioni in Irlanda del Nord e in Medio Oriente, controbilanciati dal fallimento del vertice di Seattle con lo sviluppo del movimento antiglobalizzazione) resero incerta la battaglia elettorale del 2000 tra il vicepresidente A. Gore e il candidato repubblicano G.W. Bush, figlio dell’ex presidente e governatore del Texas, che auspicava la diminuzione delle tasse e la limitazione del welfare, insieme a un richiamo morale di forte impronta religiosa basato sulla famiglia.
G.W. Bush
Bush prevalse dopo una votazione contestata che richiese l’intervento della Corte Suprema per l’attribuzione (a favore di Bush) dei voti elettorali della Florida. Le sue prime mosse (diminuzione delle tasse, disimpegno dagli accordi ambientali di Kyoto) andarono nel senso di una difesa degli interessi americani, ma gli attentati terroristici portati a termine dall’organizzazione al-Qā‛ida l’11 settembre 2001 (quattro aerei di linea dirottati e lanciati contro obiettivi come le Twin Towers e il Pentagono con migliaia di morti civili) resero prioritaria la lotta al terrorismo. Nell’ottobre una coalizione militare guidata dagli USA iniziò una guerra (denominata Enduring freedom) contro il regime dei Talebani in Afghanistan, che provocò la caduta del regime talebano, ma non raggiunse l’obiettivo prioritario della cattura del capo di al- Qā‛ida, Osama Bin Laden. Sul piano interno furono adottate misure straordinarie di sicurezza che provocarono restrizioni delle libertà civili e il controverso trattamento dei prigionieri talebani e di al-Qā’ida detenuti nella base di Guantánamo a Cuba. I viaggi del presidente in Giappone, Corea del Sud e Cina (febbraio 2002) e l’avvicinamento alla Russia (maggio 2002) cercavano di consolidare una difficile rete di accordi e alleanze internazionali, a cui si aggiunsero provvedimenti di rafforzamento militare. Sul piano interno, l’amministrazione fu coinvolta nello scandalo della società multinazionale energetica Enron (che aveva finanziato la campagna presidenziale), il cui fallimento, nel dicembre 2001, seguito da quello di altre importanti società, provocò una fortissima pressione sociale. I primi mesi del 2003 furono segnati dai preparativi dell’invasione dell’Iraq; la politica estera americana si trovò al centro di violente polemiche. Tra marzo e aprile le truppe angloamericane ebbero facilmente ragione della resistenza irachena; nei mesi successivi, tuttavia, si vide chiaramente che sarebbe stato necessario occupare a lungo militarmente l’Iraq. Negli USA la corsa alle elezioni presidenziali fu molto condizionata dal dibattito sulla politica estera e sulla gestione del dopoguerra iracheno, così come dalla disastrosa gestione dei soccorsi per l’uragano Katrina, nell’estate del 2005 abbattutosi sugli Stati che si affacciavano sul Golfo del Messico, con conseguenze particolarmente gravi per la città di New Orleans. Tuttavia Bush fu rieletto a larga maggioranza. Nel corso del 2006 vennero rinnovate le leggi speciali contro il terrorismo. Nel novembre le elezioni di metà mandato videro i democratici prevalere in entrambi i rami del Parlamento; la sconfitta repubblicana determinò le dimissioni del segretario della Difesa D. Rumsfeld.
Da B. Obama a D. Trump
A pochi mesi dalla scadenza del mandato presidenziale di G.W. Bush ebbe inizio un periodo fortemente critico per l’economia interna, dovuto dapprima alla crisi dei mutui subprime e al fallimento di molti gruppi bancari nazionali, poi al crollo di Wall Street e delle borse internazionali, accompagnato dal protrarsi della guerra in Iraq. In questa difficile situazione nazionale e internazionale, nel novembre 2008, il popolo americano elesse a grande maggioranza alla presidenza l’esponente del Partito democratico B. Obama, un afroamericano che, con un’incisiva campagna mediatica, riuscì a infondere speranza per il futuro, impersonando, con la sua vicenda privata, la realizzazione del sogno americano. Sulla realizzazione del suo programma, incentrato sul sostegno dell’occupazione, sull’alleggerimento fiscale per famiglie e imprese, sull’introduzione di forme di welfare, fra cui l’assistenza mutualistica, sugli investimenti pubblici nelle infrastrutture, sugli investimenti nella produzione di energie rinnovabili hanno pesato il protrarsi della crisi economica, con una preoccupante crescita della disoccupazione, e il riaccendersi delle ostilità sul fronte dell’Afghanistan e dell’Iraq, che nel 2010 ha richiesto l’invio di altri 30.000 uomini. Altra causa di preoccupazione nel 2010 è stato il disastro ambientale provocato dall’affondamento di una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. Negli anni successivi nonostante i successi sia in politica interna con il salvataggio dell’industria automobilistica e l’approvazione della riforma sanitaria nel 2010 e quelli in politica estera con l’uccisione di O. Bin Laden e la fine della guerra in Iraq nel 2011, l’aggravarsi della crisi economica e l’aumento della disoccupazione hanno inciso negativamente sulla popolarità del presidente che nel 2012 si è ricandidato per un secondo mandato contro il candidato repubblicano W. M. Romney. Dopo una dura battaglia elettorale, malgrado la persistente crisi economica mondiale, Obama è stato riconfermato alla Casa Bianca per altri quattro anni, vincendo le elezioni di novembre 2012 contro il candidato repubblicano. Nel novembre del 2014 le elezioni di metà mandato hanno visto i repubblicani prevalere in entrambi i rami del Parlamento; la sconfitta democratica è stata interpretata come una bocciatura della politica di Obama, nonostante la ripresa dell'economia, poco interventista a livello internazionale e a livello interno per l’incerto lancio della riforma sanitaria e il mancato rinnovo delle leggi sull’immigrazione.
Nel biennio successivo, di contro, si è meglio profilata una politica estera nuova, multilaterale e dialogante, che ha saputo ottenere risultati più con la diplomazia e il pragmatismo che con la forza bellica: in questo senso vanno citati, nel 2015, lo storico disgelo tra USA e Cuba, le cui relazioni diplomatiche erano sospese dal 1961, e l’accordo sul nucleare con l’Iran e, nel 2016, l’accordo sul clima di Parigi, preceduto dall’intesa bilaterale del 2014 con la Cina. Sono rimaste irrisolte su scala mondiale questioni di cruciale importanza, quali la crisi libica, il nuovo interventismo della Russia, il conflitto siriano e l’ascesa dell’IS, contro cui dal 2014 gli USA hanno avviato campagne militari bombardando le roccaforti controllate dal Califfato e, parallelamente, incrementando la fornitura di armi e l’assistenza alle forze moderate in campo. Alla conclusione di otto anni di governo, la presidenza di Obama – grazie soprattutto al risanamento dell’economia, tornata in salute in ragione delle politiche anticicliche obamiane dopo il difficile periodo post-crisi finanziaria – sembra dunque in senso globale aver raccolto ampi consensi, ottenendo l’approvazione del 45% degli statunitensi, sebbene siano rimasti aperti nodi cruciali quali la recrudescenza di tensioni razziali mai sopite, spesso associate a profonde diseguaglianze economiche, il perdurante blocco della riforma sull’immigrazione e soprattutto la crisi interna generata dai ripetuti scontri istituzionali con l’opposizione. Ciò ha prodotto negli elettori un calo di fiducia nel governo e portato ad affacciarsi sulla scena politica forze anti-establishment populiste concretizzatesi nella figura del candidato repubblicano, il magnate D. Trump, che alle elezioni presidenziali svoltesi l’8 novembre 2016 è stato eletto quarantacinquesimo presidente degli USA ottenendo il 47,8% dei consensi contro il 47,4% aggiudicatosi dalla candidata democratica H. Clinton; anche il controllo della Camera e del Senato sono rimasti al Partito repubblicano. Insediatosi il 20 gennaio 2017 in un clima di tensione sociale sfociato in numerose proteste di piazza, il neopresidente ha ribadito nel discorso inaugurale alcuni temi forti del programma politico di chiara matrice nazionalista presentato in campagna elettorale, quali tra gli altri una vigorosa virata protezionista in campo economico, rigide politiche anti-immigratorie e la revisione della riforma sanitaria voluta da Obama.
Da D. Trump a J. Biden
L’inizio della presidenza di Donald Trump – caratterizzato peraltro da una serie di proteste di piazza negli USA e nel mondo che non trova confronto nella storia americana – ha visto riconfermate le priorità enunciate durante la campagna elettorale, prime fra tutte la revisione delle politiche immigratorie e sanitarie, ma l’intraprendenza del neoeletto presidente ha trovato ostacoli quali il veto della magistratura a due ordini esecutivi (i cosiddetti Muslim ban o Travel ban) volti a impedire o limitare l’ingresso negli Stati Uniti di rifugiati e di cittadini provenienti da alcuni Paesi a maggioranza islamica, e il mancato appoggio dello stesso Partito repubblicano, che lo ha costretto a ritirare la riforma sanitaria che avrebbe dovuto sostituire l’Obamacare. Sul fronte della politica estera, in contrasto con le scelte USA degli ultimi anni, Trump si è dimostrato riluttante a esercitare quel ruolo di egemonia sul mondo che è stato la cifra politica degli Stati Uniti nelle presidenze precedenti a Obama, ostentando un atteggiamento di indifferenza se non di ostilità nei confronti della stessa Unione europea e manifestando la volontà di destrutturare accordi multilaterali quali il NAFTA e il TPP, per poi assumere inaspettate posizioni interventiste nel conflitto mediorientale, sferrando per la prima volta un attacco diretto e unilaterale contro le forze armate della Siria nell’aprile 2017 a seguito del massacro perpetrato attraverso l'uso di armi chimiche nel villaggio di Khan Shaikun, e inviando nell’Alto Pacifico un gruppo d’assalto navale come risposta alla volontà della Corea del Nord di potenziare il suo programma atomico, ciò che ha suscitato forti contrasti con la Russia rischiando di destabilizzare gli equilibri geopolitici su scala mondiale. Ancora sul piano internazionale, mentre nei mesi successivi il conflitto con la Corea del Nord si è andato progressivamente acuendo, vastissimo impatto ha avuto a dicembre la decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele e avviare le procedure per il trasferimento dell’ambasciata da Tel Aviv, dando seguito al Jerusalem Embassy Act approvato dal Congresso nel 1995 ma mai applicato dai presidenti che lo hanno preceduto. Nel giugno 2018, la fase di progressivo disgelo nelle relazioni con la Corea del Nord aperta mesi prima da Kim Jong-un ha reso possibile lo storico incontro avvenuto tra i due capi di stato sull'isola di Sentosa (Singapore), nel corso del quale essi hanno firmato un documento per la denuclearizzazione della Penisola coreana.
Sul fronte della politica interna, le elezioni di metà mandato del novembre 2018 - ritenute il banco di prova dell’operato di Trump e svoltesi in un clima di accese tensioni e di violenze politiche, quali la strage nella sinagoga di Pittsburgh ad opera di suprematisti bianchi – hanno registrato la perdita del controllo repubblicano della Camera, la cui maggioranza è stata riconquistata dopo otto anni dai democratici, mentre il Gop ha mantenuto quello del Senato, ciò delineando un quadro di netta polarizzazione in cui sono stati decisivi per la rimonta democratica la massiccia partecipazione al voto, sollecitata dalle tematiche cruciali dell’assistenza sanitaria e dell’immigrazione, e la mobilitazione di forme eterogenee di dissidenza organizzate in primo luogo da donne, afroamericani e giovani elettori. Nei mesi successivi l'inasprimento dei conflitti razziali, le violente proteste di piazza organizzate dal movimento Black lives matter che hanno trovato risonanza e sostegno internazionali e l'aggravarsi della crisi economica hanno parzialmente eroso i consensi accordati al presidente, che nel mese di agosto ha accettato la nomination repubblicana per un secondo mandato in vista delle presidenziali del novembre 2020. Le consultazioni, svoltesi in un clima di rigida polarizzazione politica e culturale acuita dalla pandemia di Coronavirus cui il presidente uscente ha fornito risposte inefficienti se non irresponsabili, perdendo popolarità ma riuscendo comunque a mantenere una soglia di resistenza costituita da elettori di classe medio-alta e alimentata dalle teorie cospirazioniste e dai miti salvifici di QAnon, hanno registrato la sconfitta di Trump, cui dal gennaio 2021 è subentrato il candidato democratico J. Biden.
J. Biden
La gravissima invasione di Capitol Hill durante la ratifica dell'elezione di Biden, organizzata a pochi giorni dal suo insediamento da un'eterogenea massa composta da cospirazionisti di QAnon, rappresentanti dell'ultradestra, veterani dell'esercito e suprematisti, fomentati dalla prolungata campagna di delegittimizzazione delle istituzioni federali intrapresa da Trump a seguito della sconfitta elettorale, ha creato intorno all'Inauguration Day un clima esasperatamente teso, in cui la frattura insanabile tra le due amministrazioni è stata iconicamente rappresentata dall'assenza del presidente uscente alla cerimonia di insediamento e, sul piano politico, dall'urgente volontà di Biden di disfarsi dell'operato trumpiano attraverso l'immediata emanazione di decreti esecutivi mirati a ribaltarne alcune discutibili scelte. Segnatamente, tra i focus dell’amministrazione Biden figurano il rientro degli Stati Uniti negli accordi di Parigi per la lotta al mutamenti climatici e nell'Organizzazione mondiale della sanità, l'abolizione del Muslim ban, il prolungamento del blocco degli sfratti per le fasce economicamente deboli, agevolazioni per la riunificazione dei minori migranti separati dalle famiglie e l'interruzione delle esecuzioni federali. Rispettando solo in parte gli impegni presi in campagna elettorale, e malfermamente collocato in una scena geopolitica mondiale stravolta da eventi epocali - in un biennio che ha assistito alle crisi profondissime nel settore sanitario prodotte dalla pandemia da Covid-19, al discusso ritiro delle truppe di pace dall'Afghanistan tornato sotto il controllo talebano, fino allo scoppio del conflitto russo-ucraino -, nonostante la progressiva perdita di consensi ampliata da una grave crisi economica e da forti tensioni sociali e interetniche, alle elezioni di metà mandato svoltesi nel novembre 2022 Biden è riuscito a conservare la maggioranza in Senato, perdendo di misura il controllo della Camera ma ottenendo un risultato comunque superiore ai sondaggi preelettorali.
Lingua
Rispetto all’inglese parlato in Inghilterra (British), quello usato negli USA (Amer;ican English) presenta numerose differenze lessicali, sintattiche e di pronuncia. Tali variazioni sono dovute in massima parte alle massicce ondate migratorie dall’Europa continentale prima e da quella meridionale poi, che si sovrapposero all’originaria colonizzazione di origine britannica, e al contatto con il variegato patrimonio linguistico amerindiano.
Tra le differenze di tipo fonetico più evidenti, l’Amer;ican English presenta, rispetto al modello britannico, una generale tendenza alla nasalizzazione, la lenizione del t intervocalico, la variazione di pronuncia di alcune vocali e dittonghi, la frequente ritrazione dell’accento sulla prima sillaba. Sul piano ortografico, frequenti le semplificazioni (honor per honour) e le modificazioni in vista della pronuncia (center e theater per centre e theatre; oppure s per c: defense per defence); su quello lessicale, numerose e marcate le differenze e le sostituzioni di un termine con un altro (railroad per railway, mail per post).
Nella seconda metà del Novecento, il fenomeno del plurilinguismo si è enormemente accentuato, tanto da richiedere l’emanazione, nel 1968, del Bilingual Educational Act con norme atte a favorire studenti di diverse etnie la cui conoscenza dell’inglese fosse inadeguata o insufficiente. Si valuta intorno al 18% della popolazione statunitense il numero di coloro, soprattutto ispanici, per cui l’inglese non rappresenta la madrelingua, con punte di concentrazione maggioritarie rispetto all’inglese madrelingua in alcune zone della Florida e della California o di metropoli come New York. Fenomeno a sé stante e molto studiato è quello delle ‘variazioni sociali’ della lingua inglese, la più importante delle quali è il black English, forma di vernacolo dovuta a un processo di creolizzazione dell’inglese con l’immissione di forti elementi di provenienza africana, successivamente sviluppatisi internamente alle piantagioni, che rappresenta la lingua più diffusa della popolazione afroamericana, soprattutto negli Stati del Sud e nelle grandi concentrazioni urbane.
Letteratura
Periodizzazione
Fu nel gruppo di Stati settentrionali denominati New England (Maine, Massachusetts, Rhode Island e Connecticut) che la cultura, prima d’importazione, poi autonoma, cominciò a diffondersi. La diffusione avvenne per gradi, in un periodo lungo e per linee regionali, cosa che spiega l’importanza, anche letteraria, che per vario tempo ebbe la cosiddetta Frontiera tra le regioni orientali più progredite e i territori dell’Ovest. Tenendo presente che date e divisioni non sono da intendere rigidamente, si può fissare un primo periodo che va dal 1620 al 1730, ed è il periodo coloniale; un secondo periodo che dal 1730 si estende fino a circa il 1820 e forma l’epoca della ragione; infine il graduale trapasso al periodo romantico, dominato dal pensiero trascendentalista, di origine idealista, che occupa gli anni tra il 1820 e la guerra civile (1861-65). All’affievolirsi di questa spinta si contrappose l’emergere di una componente realista e naturalista che sigla il periodo di fine secolo, estendendo i suoi influssi a tutta la prima metà del Novecento, periodo peraltro caratterizzato dall’affermarsi di un forte sperimentalismo di marca modernista. Accanto al disordinato proliferare di forme sostanzialmente riconducibili a questi modelli, nella seconda metà del Novecento si assiste al progressivo sovrapporsi di neoavanguardie legate alle diverse fasi del dibattito sul postmoderno, nonché alla definitiva consacrazione del multiculturalismo, contrassegnato dall’emergere di modelli linguistici di estrazione etnica e di soggetti sociali fin lì ritenuti minoritari e subalterni.
Periodo coloniale
La denominazione di questo periodo va intesa sia nel senso politico di dipendenza dalla corona inglese, sia nel senso culturale di una letteratura autoctona, in larga parte a sfondo religioso, i cui inizi rimangono pressoché interamente sotto l’influsso del modello inglese.
I padri fondatori. Un centinaio di uomini si stabilirono nel 1607 all’imboccatura della baia di Chesapeake costituendo, sotto la guida del capitano John Smith, un piccolo centro che in omaggio a Giacomo I, succeduto a Elisabetta, chiamarono Jamestown. Smith è solitamente citato nelle storie della letteratura americana per le relazioni che scrisse sulle vicende del piccolo stanziamento e sulle esplorazioni che compì sulle coste atlantiche verso nord.
Spirito ancora europeo ebbe il centinaio di uomini che nel 1620 approdarono con la nave Mayflower a Cape Cod. Questi coloni, che gli Americani hanno poi chiamato Pilgrim Fathers, appartenevano alla setta dei ‘separatisti’. Fuggiti dalle Isole Britanniche per sottrarsi alle persecuzioni, si erano rifugiati in Olanda; infine (6 settembre 1620), salpati da Plymouth, sbarcarono in quello che è oggi il porto di Provincetown a Cape Cod per stabilirsi, sul lato opposto della baia, in un punto cui diedero lo stesso nome della cittadina inglese di provenienza. A quel primo gruppo di emigrati ne seguì un altro di circa 800, calvinisti come i primi e mossi dalle medesime ragioni. Occorre notare che il rigido calvinismo di questi emigrati e il manifestarsi di ciò che oggi si chiamerebbe complesso di persecuzione contribuirono a dar vita a una forma di fanatismo che, unito alla teoria della predestinazione, manteneva le coscienze in uno stato di allarme, favorendo la pratica dell’introspezione. A sua volta, il costante vedere dietro ogni fatto una manifestazione della volontà divina alimentò fortemente la tendenza al simbolismo. W. Bradford, uno degli emigrati giunto con la Mayflower, fu il creatore del piccolo Stato iniziale, diede le istituzioni fondamentali alla colonia di Plymouth di cui fu governatore e scrisse una History of Plymouth plantation (postumo, 1856) che, seppure non immune da spirito di parte, rimane un documento di valore storico e letterario. Quel che Bradford fu per la colonia di Plymouth, J. Winthrop fu per l’altra colonia della Baia di Massachusetts, dove giunse nel 1630 mandatovi dall’Inghilterra come governatore. Del suo operato tenne anche lui un diario che, senza pretese letterarie, registra nudi fatti.
Avverso all’intolleranza dei puritani, R. Williams, bandito dal Massachusetts nel 1635, diede vita alla colonia di Providence, aperta alla pratica di ogni culto, sostenendo, in The bloody tenent of persecution for cause of conscience discussed between truth and peace (1644), il diritto dell’uomo alla libertà di coscienza e, più tardi, la necessità di una separazione tra Stato e Chiesa.
Poeti e poetesse. Giunta in Massachusetts nel 1630, A. Bradstreet è la prima, tra i poeti delle colonie, a veder pubblicato un suo libro, The tenth muse (1650), raccolta di brani per lo più convenzionali e di derivazione inglese. Per contro, M. Wigglesworth si formò intellettualmente in America e non si notano influssi europei nella sua unica opera poetica, The day of Doom (1662), lavoro da artigiano del verso e della rima, che gli procurò un successo enorme. Ma la miglior poesia scritta in America nel Seicento è dovuta a E. Taylor, tra i maggiori rappresentanti del barocco americano o barocco coloniale, il quale scrive nella tradizione dei metafisici inglesi, dei concettisti anglo-cattolici, e si riconnette al maggiore di essi, J. Donne; le sue liriche sono animate da un sincero e ardente sentimento religioso e dal senso della poesia come arte.
Diari. Alla seconda generazione dei coloni appartiene la cosiddetta dinastia dei Mather, Richard, suo figlio Increase e il nipote Cotton, ecclesiastici e letterati, campioni di una teocrazia che il mutare dei tempi andava rendendo meno attuale e meno facile da amministrare. L’ultimo dei tre, uomo assai colto, va ricordato per la sua storia ecclesiastica del New England, Magnalia Christi Americana (1702), opera di grande respiro storico e di retorica ecclesiale che si propone di tramandare la sacralità dello spirito e dell’esperienza coloniali. Nell’enorme attività di C. Mather rientrò anche la stesura di un diario, in cui prevale una introspezione dominata dal timore del demonio.
Assai diverso è invece il diario di S. Sewall, uno dei giudici, nel cosiddetto periodo della caccia alle streghe, dei famigerati processi di Salem finiti con la condanna a morte di molti innocenti: ammirevole per la sincerità e il pudore che attraversano la sua scrittura, The diary of S. Sewall (1674-1729) rimane una delle riflessioni più intense e drammatiche sulle contraddizioni pubbliche e private dello spirito puritano.
Vivacità e senso del pittoresco caratterizzano il diario di S.K. Knight, figlia di un commerciante, che nel 1704 fece un viaggio d’affari a New York e registrò le sue sagaci osservazioni su costumi, usanze e tipi, non senza qualche momento di umorismo. In una letteratura dominata da preoccupazioni politiche, religiose, edificanti, l’umorismo è la cosa più rara, ma se ne incontra anche in W. Byrd. Nato in Virginia, compì gli studi in Inghilterra, dove ebbe amici illustri tra cui i commediografi W. Wycherley e W. Congreve, e tornò in patria come un perfetto gentiluomo inglese della Restaurazione. Fu uno dei commissari incaricati di stabilire la linea di confine tra la Virginia e la Carolina del Nord, e ne scrisse la relazione in quella che è la sua opera più importante, intitolata The history of the dividing line (1841), in cui racconta le vicende non di rado umoristiche della spedizione e i costumi degli Amerindi. Tenne anche lui un diario molto particolareggiato e molto franco sulla sua vita di ogni giorno, usando una specie di stenografia di sua invenzione che fu decifrata solo nel 1941.
Diari, relazioni di viaggio e opere a sfondo religioso ed edificante che dominano il primo secolo di vita di una letteratura ancora fortemente ancorata ai modelli inglesi, consentono tuttavia di cogliere l’emergere di una nota autoctona che vede nella realtà geografica americana e nell’esperienza politica delle colonie i primi, importanti segnali di una, seppur limitata, autonomia. È su questa linea, rafforzata da una marcata tendenza introspettiva e dai primi accenni a una propensione narrativa non scevra di embrionali spunti fantastici, che si sarebbe in seguito formata una prosa riconoscibilmente americana.
Il ‘grande risveglio’. Ma l’epoca dei sermoni non era ancora finita, per opera dell’ultimo difensore del calvinismo, J. Edwards, che lottò per un ritorno allo zelo religioso dei primi immigrati. Nella sua parrocchia istituì un regime rigorosissimo, inculcando il terrore della giustizia divina con sermoni che spinsero molti al suicidio, e riuscì a suscitare un movimento che chiamò Revival. Nato nel 1773, il movimento si esaurì nel 1775, per rinascere nel decennio successivo, sempre per impulso di Edwards, con il nome di Great awakening. Considerato il primo filosofo che sia nato e abbia scritto in America, nelle sue molte pubblicazioni (tra cui il celebre trattato sulla libertà Freedom of the will, 1754), Edwards cercò, sebbene contrario all’arminianismo, di conciliare calvinismo e deismo.
La serie dei diaristi si chiude su una nota di serenità: quella di J. Woolman, il cui Journal (postumo, 1774), caratterizzato da un genuino senso di solidarietà nei confronti degli Amerindi, dei poveri e dei diseredati in genere, rimane come uno dei documenti di maggior tolleranza della tradizione diaristica che, nell’epoca precedente la guerra civile, aveva già avuto modo di radicarsi presso il pubblico americano.
L’epoca della ragione
Letteratura politica. «Riteniamo queste verità evidenti di per sé. Tutti gli uomini sono creati uguali»: così, con una logica in cui non è difficile riconoscere l’eco di filosofi come J. Locke e il Rousseau del ‘contratto sociale’, inizia la Dichiarazione d’indipendenza, formulata nel 1776 da T. Jefferson. Nelle sue espressioni più significative, il Settecento americano trova nel pensiero illuminista la base di un’elaborazione che, a causa delle particolari condizioni storiche e politiche, assume in America connotati di grande concretezza e praticità. Ne sono un esempio le Notes on the State of Virginia (1787), in cui lo stesso Jefferson, partendo dall’osservazione critica di dati della realtà quotidiana, giunge di fatto a formulare una sua visione scientifica della politica. Ma già nelle Letters from an American farmer (1782) di H. Saint-John de Crèvecoeur si sente in pieno lo spirito dell’epoca: in esse non vi è soltanto il sentimentalismo romantico della natura, ma anche un nucleo di pensiero di economia politica e di pratica agronomica.
Tuttavia, la personalità che nel bene e nel male si può considerare più rappresentativa dello spirito americano di questo periodo è B. Franklin, il quale, giovanissimo, riuscì a imporsi dalle colonne del The New England Courant, di proprietà del fratello, come eclettico polemista d’ispirazione liberale in forte contrasto con la vecchia aristocrazia intellettuale della nativa Boston. Aperta una sua stamperia a Filadelfia, ottenne grande successo con i diversi volumi della sua opera più nota, Poor Richard’s al;manack (1733-38), sorta di enciclopedica summa del buon senso e breviario, non di rado semplicistico e gretto, del nascente mercantilismo. Ma è la sua Autobiography, ripubblicata a più riprese tra il 1771 e il 1779, a costituire la testimonianza letteraria di maggior pregio, dotata di una semplice eleganza che è frutto, come lui stesso racconta, di un perfezionamento accanito condotto sui migliori modelli della prosa inglese del tempo.
Un posto nella storia letteraria hanno anche le Letters from a farmer in Pennsylvania to the inhabitants of the British colonies pubblicate nel 1767 da J. Dickinson, pur se di colonie per poco ancora si sarebbe parlato: nell’aprile 1775 scoppiò la rivoluzione che l’ormai settantenne Franklin aveva contribuito a preparare con l’azione diplomatica, e fu la guerra d’indipendenza contro l’Inghilterra. Eloquente animatore della lotta fu T. Paine, i cui opuscoli (tra i quali Common sense, 1776) esercitarono un’azione determinante sull’opinione pubblica. L’orientamento razionalistico, rafforzato dal fatto che per la nuova nazione nata dall’indipendenza era necessario affrontare problemi costituzionali e politici, sancisce, in questo periodo, il dominio di una prosa più attenta alle cose da dire (l’ampio dibattito sull’alternativa tra l’indipendenza dei singoli Stati e il federalismo) che non ai modi in cui dirle. Oltre a T. Jefferson, terzo presidente della Confederazione, le personalità di maggior spicco furono J. Madison, quarto presidente, A. Hamilton; J. Adams, anch’egli presidente, J. Jay. Nei due anni (1787-88) in cui l’ex colonia di New York fu incerta se ratificare la costituzione federale, Hamilton pubblicò sui giornali della sua città una serie di 85 saggi (cui collaborarono anche Jay e Madison) in favore della ratifica, poi raccolti in volume con il titolo The federalist (1945). Tutti questi uomini politici mantennero voluminose corrispondenze in cui spesso si colgono i loro momenti più felici come scrittori.
Letteratura afroamericana. All’infuori di questa letteratura d’interesse politico, uno dei fenomeni letterari più interessanti della seconda metà del Settecento è costituito dal faticoso emergere di una scrittura afroamericana ancora in gran parte imitativa e convenzionale, che tuttavia acquisisce un importante valore storico, dal momento che segnala l’appropriarsi da parte degli schiavi di uno strumento, quello della scrittura, a loro esplicitamente interdetto da leggi e divieti. Tra i più importanti interpreti di questo nuovo sviluppo, J. Hammon, primo poeta nero a essere pubblicato in America, di cui si ricordano alcuni brani a sfondo religioso, sermoni del periodo rivoluzionario e il pamphlet Address to the Negroes. In the State of New York (1787), e P. Wheatley, rapita dall’Africa ancora bambina e trapiantata come schiava a Boston, i cui Poems d’ispirazione neoclassica furono originariamente pubblicati in volume a Londra nel 1773. Ma la personalità di maggior spicco in questo ambito è senza dubbio quella di Oulaudah Equiano, conosciuto anche sotto il nome occidentale di Gustavus Vassa, il quale, imbarcato come schiavo su diverse navi, riuscì poco più che ventenne a ricomprare la propria libertà. Fervente abolizionista della prima ora, Equiano è autore di una delle prime autobiografie di ex schiavi, The interesting narrative of the life of O. E., or G. V., the African (1789), in cui rivela un indubbio talento narrativo.
Poesia post-rivoluzionaria. Sul versante poetico, il periodo post-rivoluzionario è dominato dal declino del lungo poema filosofico, di cui A. Pope era stato il modello: una situazione di sostanziale ristagno cui si sottraggono in pochi. Tra questi, due esponenti dei cosiddetti Hartford wits: J. Trumbull, autore, tra l’altro, di The progress of dullness (1772-73), poema satirico sulla vita universitaria, e del saggio in versi An essay on the use and advantages of the fine arts (1772); e J. Barlow, la cui fama è legata soprattutto a The hasty pudding (1793), lunga ricostruzione in versi di antichi quadri rurali. La presenza più importante è tuttavia quella di P. Freneau, da molti considerato il primo poeta di rilievo della tradizione americana, il quale grazie alla satira politica e alla farsa inizia a liberare il proprio linguaggio dagli schemi convenzionali settecenteschi, per approdare, con la poesia The power of fancy (1770), a una prima affermazione di quello spirito preromantico che permea i componimenti più maturi, da The wild honey suckle (1786) a The Indian burying ground (1788), in cui si affaccia il tema a lui caro dell’indiano come figlio della natura, a The house of night (1779), che anticipa atmosfere poi sviluppate appieno da S.T. Coleridge e, in America, da certa poesia di E.A. Poe.
Gli inizi del Romanticismo
La poesia dei luoghi selvaggi. Il primo Romanticismo risente ancora molto del razionalismo e dell’illuminismo del 18° sec. e trova i suoi modelli nella letteratura inglese di quel secolo. Tra scienza e vivo senso della natura si colloca il botanico W. Bartram che viaggiò in territori a quel tempo ancora poco conosciuti. Alle minute descrizioni botaniche egli alterna descrizioni di paesaggi e scene naturali d’indubbio valore letterario che influirono, fino a essere imitate, sui poeti laghisti inglesi e offrirono lo scenario all’Atala di R. de Chateaubriand. Nella letteratura americana, l’opera di Bartram introdusse un tema nuovo: la poesia dei luoghi selvaggi.
Gli esordi della narrativa. Anche la narrativa prese qualche volta come scena i territori di frontiera, cioè le regioni che cominciavano appena a essere colonizzate, ma ripiegò su imitazioni europee o ebbe intento satirico verso la nuova democrazia. Denso di humour è il romanzo Modern chivalry, pubblicato tra il 1792 e il 1812 da H.H. Brackenridge, in cui i personaggi, che vivono nelle regioni di frontiera, si dedicano prosaicamente al commercio di cavalli e al contrabbando del whisky.
Parziale imitatore del romanzo gotico inglese è C.B. Brown, personalità che tuttavia, proprio negli anni di passaggio tra i due secoli, contribuisce a segnare un netto spartiacque tra l’epoca della subalternità culturale e quella di un’autonomia sempre più marcata nei confronti dell’ex madrepatria. Non a caso si suole ormai individuare l’origine del romanzo americano proprio nei romanzi (Wieland, 1798; Ormond, 1799; Edgar Huntly, 1799; Arthur Mervyn, 1799-1800) mediante i quali quest’autore di origine quacchera, nativo di Filadelfia, opera quella ‘naturalizzazione’ del gotico che vede la realtà americana sostituirsi all’abituale scenario del vecchio mondo, e in particolare italiano, su cui si fondava il genere. Ma quella di Brown non è soltanto un’innovazione che agisce sullo sfondo geografico culturale, giacché tratto caratteristico e originale della sua opera è soprattutto l’insistenza sugli aspetti più inquietanti della psicologia dei personaggi, sulle zone più oscure dell’interiorità personale: un aspetto che diverrà poi centrale della grande tradizione narrativa americana dell’Ottocento (E.A. Poe, N. Hawthorne, H. Melville). Grazie alla speculazione sulle possibili motivazioni di azioni umane apparentemente inspiegabili, Brown per la prima volta afferma, romanticamente, il dominio di quella spinta antirealistica e di quella tendenza all’ispessimento simbolico della scrittura, che costituiscono tratti essenziali del romance americano.
E proprio a questo genere, che alla referenzialità storico-geografica affianca e sovrappone una predilezione per la fuga fantastica e per la ricerca di una verità che mai s’identifica con la realtà quale essa appare, dà un fondamentale apporto l’opera di uno scrittore consapevole e cosmopolita quale W. Irving. All’esordio satirico sul periodico Salmagundi, con saggi scritti in collaborazione con il fratello William e con J.K. Paulding, segue A history of New York (1809), sua prima opera importante, improntata a un tono burlesco sotto cui già si cela il conflitto tra la presunta autenticità del materiale storico e l’apparente inattendibilità della rielaborazione narrativa, vero nodo problematico delle sue opere più mature. Tra queste, la più nota è The sketch;book of Geoffry Crayon, gentleman (1819-20), pubblicato originariamente in Inghilterra grazie anche all’interessamento di sir W. Scott, raccolta di racconti, schizzi di viaggio, rifacimenti di antiche leggende e di saghe europee, originalmente trapiantate sullo sfondo immaginario, eppure riconoscibile, dell’America del periodo della rivoluzione. Al racconto di costume, rivisitato con notevole successo anche in Bracebridge hall (1822) e in Tales of a trav;eller (1824), Irving alterna opere a sfondo storico, come The conquest of Granada (1829), e The Aalambra (1832), entrambe scritte durante il suo impegno come diplomatico in Spagna e in Inghilterra, A tour of the prairies (1835) e Astoria (1836), che consolidano, anche all’estero, la sua immagine di primo scrittore americano di successo.
J.F. Cooper. La natura e la storia americane fanno invece da sfondo pressoché costante alla narrativa di J.F. Cooper, autore estremamente prolifico, capace di dare un apporto determinante a forme diverse, quali il romanzo di guerra (The spy, 1821), il racconto marino (The pilot, 1823) e quello costruito attorno al motivo della Frontiera, cui peraltro la grande popolarità delle sue avventure rimarrà più a lungo legata. L’avanzata dei colonizzatori nei territori sconosciuti dell’Ovest, l’incontro con i gruppi dei nativi, i conflitti d’interesse tra gruppi diversi di avventurieri costituiscono la materia privilegiata dei cosiddetti Leatherstocking tales, saga di cui fanno parte cinque romanzi (The pioneers, 1823; The last of the Mohicans, 1826; The prairie, 1827; The pathfinder, 1840; The deerslayer, 1841), tutti costruiti attorno alla figura di Natty Bumppo, mitico cacciatore bianco dotato di una grande statura morale. Tornato in patria nel 1833 dopo un lungo soggiorno in Europa, Cooper inasprì il tono nei confronti di una nazione che ai suoi occhi sembrava aver tradito l’ideale originario di democrazia agraria, in favore di una industrializzazione che comportava un netto imbarbarimento sociale e politico. Questa vena polemica, che affiora in opere come The Monikins (1835), Home as found (1838) e The crater (1847), costituisce forse l’aspetto meno conosciuto di un autore spesso visto come campione di un esotismo non scevro di risvolti paternalistici e che invece, come nella trilogia The Littlepage manuscripts (1844-46), sa misurarsi anche con aspetti controversi della società a lui contemporanea.
E.A. Poe. Ma la personalità di maggior spicco della prima metà dell’Ottocento rimane sicuramente quella di E.A. Poe, figura poliedrica di narratore e poeta, critico e giornalista, che tra l’adottiva Virginia e New York anima la scena culturale americana negli anni 1830 e 1840. Particolarmente importante è l’originalità con cui, dopo l’esordio in poesia (Tamerlane and other poems, 1827; Al Aaraaf, 1829), incide sulle strutture del romanzo (The narrative of A. Gordon Pym, 1838) e soprattutto sul genere del racconto (Tales of the grotesque and arabes;que, 1840, e Tales by E.A. Poe, 1845), portandolo a livelli di perfezione tecnica e formale fin lì sconosciuti. Inventore del genere poliziesco (il suo Monsieur A. Dupin rimarrà come il prototipo del moderno detective), nella sua opera Poe propone una fusione di motivi romantici, direttamente mutuati da Coleridge, e di spinte squisitamente razionali. Si consolida, nella sua scrittura, quella tendenza allo sconfinamento fantastico già notata nelle opere di altri americani, mentre rigore critico, empito polemico ed energia speculativa trovano modo di manifestarsi in saggi di grande portata, quali The philosophy of com;position (1846), The rationale of verse ed Eureka (entrambi 1848).
Il Rinascimento americano
Mutuata dal titolo di un saggio del critico letterario F.O. Matthiessen (1941), l’espressione designa il periodo aureo della letteratura americana del 19° sec., quello in cui, negli anni di metà secolo, R.W. Emerson, H.D. Thoreau, N. Hawthorne, H. Melville e W. Whitman pubblicarono le loro opere maggiori.
Il trascendentalismo. Presupposto di questa fioritura artistica fu l’affermarsi nella Nuova Inghilterra di una corrente di pensiero, direttamente ispirata all’idealismo tedesco, denominata trascendentalismo, la quale ebbe il suo massimo sviluppo tra il 1836, anno di pubblicazione del saggio di Emerson, Nature, e il momento in cui, verso la metà degli anni 1850, cominciò a profilarsi lo spettro della guerra civile. Nato come evoluzione della Chiesa Unitaria con cui, a partire dal 1815, W.E. Channing aveva tentato una prima riforma liberale della rigidità calvinista dominante, il trascendentalismo trovò in R.W. Emerson il massimo esponente e il più autorevole teorico. Rivendicando, sulla base dell’insegnamento kantiano, l’assoluta centralità del processo conoscitivo, appunto trascendente, Emerson si fece interprete di un concetto di libertà religiosa che riconosceva all’individuo la capacità di partecipare, in virtù della spontaneità dell’esperienza mistica, alla conoscenza dell’anima collettiva trascendente (oversoul). Tra i fondatori della rivista The Dial, con indole molto pragmatica, nei suoi più famosi discorsi Emerson piega il suo credo trascendentalista alle esigenze d’indipendenza della cultura americana del tempo (The American scholar, 1837), a quelle di libertà di testimonianza (The divinity school address, 1838) e di affermazione delle capacità individuali (Self-reliance, negli Essays del 1841), dando così vita a un corpus (formato, oltre che dagli imponenti Journals e da Representative men, 1851, da altri volumi di saggi, poesie, lettere) che, seppur non sistematico, divenne il terreno di coltura per la definitiva emancipazione intellettuale e artistica statunitense.
Il fondamentale ottimismo con cui Emerson guarda all’individuo e al suo rapporto armonico con la natura diviene parte integrante della visione che il suo amico H.D. Thoreau articola nei suoi più importanti scritti, da A week on the Concord and Merrimack rivers (1849) a quel capolavoro della prosa americana, a cavallo tra racconto, saggio e diario, che è Walden (1854), testo in cui Thoreau ripercorre i due anni d’isolamento nei boschi vicino Concord che si autoimpose tra il 1845 e il 1847. Tale spinta individualistica trova sbocco propriamente politico nel saggio Civil disobedience, apparso come Resistance to civil government nel 1849, in cui il trascendentalista Thoreau, anticipando certe forme di spontaneismo anarchico del 20° sec., difende le ragioni del singolo contro il potere di uno Stato che la sua profonda coscienza politica trova modo di criticare pesantemente nell’ambito del dibattito abolizionista; e ancora, nei saggi di Slavery in Massachusetts (1854) e nel famoso A plea for John Brown (1860).
Il romanzo. Sempre sul conflitto tra individuo e società, sui significati del legame tra uomo e natura indaga, in quello stesso lembo del Massachusetts, N. Hawthorne, autore che pone le basi di quella tradizione americana che troverà nell’opera di H. James ulteriore sviluppo. Diviso tra un forte senso dei colpevoli eccessi dell’eredità puritana e l’imperativo di dare dignità a una pratica artistica ancora largamente mal tollerata (motivi ricorrenti dei suoi racconti, raccolti nelle due edizioni dei Twice-told tales, 1837, 1852; e in Mosses from an old manse, 1846), è nel grande affresco storico di The scarlet letter (1850), ancor più che in The house of the seven gables (1851) e negli altri romanzi, che egli riesce a trasporre il suo travaglio morale in testimonianza letteraria di prima grandezza, allegoria di un tormento interiore vissuto nell’isolamento.
Ed è proprio al genio di Hawthorne che H. Melville dedicherà l’altro capolavoro indiscusso della narrativa americana dell’Ottocento, quel Moby Dick che, apparso nel 1851, sarebbe stato riconosciuto come tale solo molto più tardi. Dopo il felice esordio con romanzi d’atmosfera esotica (Typee, 1846; Omoo, 1847) e il parziale insuccesso dell’allegorico Mardi (1849), con Redburn (1849) e White Jacket (1850) Melville torna a indagare i precari equilibri della vita di bordo, già direttamente sperimentati in gioventù come marinaio, che faranno da sfondo al grande dramma faustiano di Ahab e dell’equipaggio del Pequod. Avvalendosi di una straordinaria varietà di calchi linguistici, dal modello biblico a Shakespeare, dalle cadenze orali al lessico scientifico, Moby Dick si costruisce come tragedia moderna, a tratti perfino realistica, e tuttavia densa di risvolti allegorici, scarti fantastici, riverberi simbolici tali da rendere il testo unico nel suo genere. Il fallimento commerciale del libro, di fatto, fece di Melville un romanziere sopravvissuto a sé stesso, pur se in anni successivi riuscì a pubblicare alcuni splendidi racconti, riuniti in Piazza tales (1856) e nel postumo Billy Budd and other prose pieces (1924).
La poesia. Se è dunque la prosa, e in particolare il romanzo, a dar vita al Rinascimento, è la poesia, il canto del ‘figlio di Manhattan’ W. Whitman a completarlo. Anticipando l’odierno concetto di opera aperta, tra la prima pubblicazione di Leaves of grass (1855) e la cosiddetta deathbed edition del 1891-92, Whitman rilavorò costantemente il suo capolavoro portandolo, tra aggiunte e revisioni, dalle 12 poesie originarie che accompagnavano la densa prefazione, alle centinaia di brani di questa grande epica dell’America moderna. Efficacemente concentrato nella metafora di un titolo, che all’idea trascendentalista di armonia della natura rimanda in modo esplicito, è il giudizio critico su tale opera di ‘poesia democratica’: foglie d’erba, o anche poesie diverse di una stessa opera, uguali ma distinte, unite in un insieme di singole individualità riconoscibili.
Poesia e tradizione
Se il Rinascimento americano segna il momento in cui la cultura statunitense riesce, soprattutto attraverso i suoi scrittori, a completare quel processo di emancipazione che sul piano politico si era concluso nell’ultimo scorcio del 18° sec., persiste, soprattutto in poesia, una tendenza a muoversi nel solco della tradizione europea e dei grandi modelli del Romanticismo inglese. Così alla geniale irregolarità del verso di Whitman fa riscontro la perfezione formale della poesia di W.C. Bryant, la cui ‘meditazione sulla morte’, il poemetto Thanatopsis (1817; 1821), risente dell’influsso di W. Wordsworth, oltreché di una formazione classica di tipo nettamente tradizionale.
Ma è soprattutto nella Boston degli anni 1840 e 1850, dominata dalla personalità di H.W. Longfellow, professore di francese e spagnolo a Harvard, traduttore di Dante e poeta formatosi prevalentemente sui modelli europei, che la poesia americana di quegli anni esprime, attraverso la cosiddetta scuola dei ‘bramini’, la sua vena più schiettamente tradizionale. Autore di componimenti molto popolari (in parte raccolti in Ballads and other poems, 1841), nel poema Evangeline (1847) e più ancora in The song of Hiawatha (1855), egli riesce a rendere motivi storici e folcloristici autoctoni attraverso modelli linguistici e formali d’ispirazione classica, nel tentativo di pervenire a una sintesi epica che tuttavia si rivelerà per lo più prevedibile e convenzionale.
Alla lezione di Longfellow s’ispirano anche J.G. Whittier, autore di Legends of New England in prose and verse (1831) e in seguito di poesie impegnate nella causa abolizionista, e soprattutto J.R. Lowell, successore di Longfellow a Harvard, oltreché direttore dell’Atlantic Monthly prima e della North American Review poi, autore di The Biglow papers (1848; 1862), interessante esperimento nel dialetto della Nuova Inghilterra, e di numerosi volumi di versi, tra cui il famoso A fable for critics (1848), che contiene una raffinata satira dei trascendentalisti. Al gruppo di Boston appartiene anche l’eclettico O.W. Holmes che, dividendo i suoi interessi tra la medicina e la letteratura, si ricava un ruolo di primo piano, soprattutto come saggista, grazie alla serie di vivaci conversazioni a tema: The autocrat at the breakfast table (1858), The professor at the breakfast table (1860) e The poet at the breakfast table (1860).
Tra gli intellettua;li vicini al gruppo di Boston vanno ricordati inoltre alcuni storici con forti interessi letterari, quali W.H. Prescott, primo biografo del romanziere C.B. Brown e autore di una monumentale History of the conquest of Mexico (1843); J.L. Motley, che scrisse un romanzo, Merry-Mount: a romance of the Massachusetts colony (1849), oltre a volumi di storia tra cui The rise of the Dutch Republic (1856); infine, F. Parkman, autore del famoso The Oregon trail (1849), documento fondamentale sull’avanzata della Frontiera, in cui rivisita le sue impressioni di viaggio col piglio del narratore.
Ma il discorso sulla centralità del Massachusetts nello sviluppo della cultura americana dell’Ottocento non può non concludersi sul nome di E. Dickinson, la cui vastissima produzione poetica, pubblicata per intero soltanto nel 1955 sotto il titolo The poems of Emily Dickinson, ha ormai acquisito stabilmente il posto d’eccellenza che le compete. Lontana dall’espansività del verso di Whitman, la scrittura di Dickinson, molto più intima e delicata, non è in realtà meno potente, né meno innovativa. E se nell’uno il legame con il trascendentalismo è trasparente, nell’altra esso va colto proprio nella qualità inversa: in quell’apparente mancanza di sicurezza di sé, nel dubbio e nell’interrogativo, che tuttavia sempre preludono al manifestarsi del tratto individuale.
Tra realismo e naturalismo
La Frontiera. Eccezion fatta per la poesia di Whitman e per alcuni componimenti di Melville, sulla letteratura americana coeva il trauma della Guerra civile non ebbe, direttamente, grande risonanza, neppure in chi, come S. Lanier, ‘primo’ poeta sudista e combattente tra le file confederate, avrebbe poi dedicato i suoi interessi principalmente alla musica. Di tutt’altra portata, sul piano letterario, fu invece l’esperienza dell’espansione verso l’Ovest, cui nella seconda metà dell’Ottocento si ispirarono storici, romanzieri e umoristi di rilievo, come il giornalista e scrittore di origine newyorkese F.B. Harte, autore, tra l’altro, di The luck of Roaring camp and other sketches (1870), una raccolta di racconti del West che gli assicurò grande successo.
Sempre come umorista della Frontiera fece il suo esordio M. Twain, quando, nel 1865, apparve il suo irresistibile racconto The celebrated jumping frog of Calaveras County. Tra i maggiori narratori del secondo Ottocento, Twain ottenne immensa popolarità con romanzi quali The adventures of Tom Sawyer (1867) e The prince and the pauper (1882), oltre a ‘resoconti di viaggio’ come The innocents abroad (1869) e Roughing it (1872), in cui trasgressione linguistica e innovazione formale si fondono in una comicità schietta e prorompente. Grande oratore, apprezzato su entrambe le sponde dell’Atlantico, in anni successivi la sua fantasia si ammanta progressivamente di pessimismo, da cui non è immune uno dei suoi maggiori romanzi, The adventures of Huckleberry Finn (1885), e che permea altre sue grandi opere, quali A Connecticut yankee in King Arthur’s court (1889) e The tragedy of pudd’nhead Wilson (1894). Acuita da varie tragedie personali, questa vena si rafforza, sfociando in frequenti accessi moralistici, negli ultimi scritti, tra cui The man that currupted Hadleyburg (1900), il filosofico What is man? (1906) e l’incompiuto The mysterious stranger (postumo, 1916).
Regionalismo. Aspetto rilevante del movimento realista è anche il diffondersi di un regionalismo legato alla specificità culturale e linguistica di aree rurali, in genere prive di centri urbani sviluppati, in cui più forte permane l’influsso delle tradizioni. A una visione edulcorata e romantica del Sud sono legati i racconti di Uncle Remus: his songs and his sayings (1881), prima raccolta di una fortunatissima serie di J.C. Harris, in cui il linguaggio virtuosisticamente ricostruito degli schiavi neri, con il quale si esprimono anche le figure di animali che popolano la saga, diventa il mezzo espressivo di una rivisitazione posticcia della grande tradizione orale della piantagione. Quello stesso ambiente fisico fa da sfondo a Uncle Tom’s cabin (1852), romanzo di scarso valore letterario ma di grande impatto politico con cui, alla vigilia della guerra civile, H. Stowe dà nuovo impulso alla causa abolizionista. E sempre al Sud, e in particolare alla Louisiana s’ispirano anche un colorista locale come G.W. Cable, autore di romanzi e racconti (Old creole days, 1879) molto apprezzati da M. Twain, e una scrittrice come K. Chopin, il cui breve romanzo The awakening (1899), storia del simbolico risveglio di un’identità femminile storicamente annullata dalle convenzioni, ha ormai ottenuto quel riconoscimento che un lungo periodo di censura le aveva negato.
A un ambiente completamente diverso, quale il Maine, s’ispira invece il raffinato linguaggio di S.H. Jewett, la quale a bozzetti e racconti alterna, come nel suo maggiore romanzo The country of the pointed firs (1896), punte di un’intensità drammatica sconosciuta a molti praticanti del colore locale.
Genteel tradition. Personalità centrale del realismo americano, W.D. Howells si afferma come giornalista per divenire poi narratore e critico tra i più influenti del periodo di fine secolo. Sostenitore di Lincoln, che lo nominerà console a Venezia (1861-65), è tra gli iniziatori, negli anni 1870, della cosiddetta genteel tradition, di quel romanzo ‘cortese’ in cui la rimozione degli aspetti deteriori della realtà si giustifica sulla base dell’intento didattico che informa l’opera. Radicalmente avverso al Romanticismo, Howells approda successivamente a una narrativa di più schietto impegno sociale che, come testimoniano i suoi maggiori romanzi, da A mod;ern instance (1882), a The rise of Silas Lapham (1885), a A hazard of new fortunes (1890), fa dello scontro tra moralità e interesse che caratterizza l’America dell’età dorata il suo motivo centrale.
Se questa piega della narrativa di Howells anticipa direttamente quelli che saranno gli sviluppi del romanzo naturalista, è soprattutto nel solco della tradizione cortese che s’innesta, in quegli stessi anni, l’opera d’innovazione delle strutture narrative compiuta da un caposcuola del realismo qual è H. James. Fortemente attratto dalla visione di Hawthorne (cui dedicherà, nel 1879, un importante saggio critico) e attento cultore dell’opera di H. de Balzac, G. Flaubert e I. Turgenev, fin dai racconti d’esordio James elegge l’indagine psicologica del personaggio quale nucleo privilegiato di una ricerca condotta prevalentemente sullo sfondo di una società borghese minata dal disfacimento. Stabilitosi definitivamente a Londra nel 1876, raggiunge la maturità artistica con The portrait of a lady (1881), romanzo in cui il rapporto tra Vecchio e Nuovo mondo, già esperito in The Amer;ican (1877), Daisy Miller (1879) e Wash;ington Square (1880), si giova di tecniche pienamente compiute. Scavo interiore, complessa architettura dell’intreccio, affinamento della funzione del narratore, uso insistito del simbolo: questi i nodi tecnici su cui il romanzo di James continuerà in anni successivi a costruirsi come forma d’arte, lungo un percorso che, attraverso The Bostonians (1886), The Aspern papers (1888), What Maisie knew (1897), The turn of the screw (1898), porterà alla scrittura complessa e rarefatta dei tre capolavori della fase maggiore: The wings of the dove (1902), The ambassadors (1903), The golden bowl (1904). Affrontato con insistenza come tema di romanzi e racconti, spesso dominati da inconsueti elementi fantastici (The private life, The lesson of the master, The fig;ure in the carpet), il suo lavoro di artista troverà sbocco sistematico e illuminante nelle dense prefazioni apposte all’edizione definitiva della sua opera, Novels and tales by Henry James (1907-09).
Vicina agli interessi di James, e in parte al suo stile, è la narrativa di E. Wharton, anch’essa trapiantata in Europa dalla nativa New York, città che tuttavia ricompare, sfondo stravolto nei tratti fisici e morali dall’invasione dei nuovi ricchi, nei romanzi maggiori, The house of mirth (1905), The custom of the country (1913) e The age of innocence (1920). Altri rilevanti esempi di scrittura femminile, sospesi tra regionalismo e tradizione cortese, sono infine quello della virginiana E. Glasgow, il cui romanzo Barren Ground (1925) ruota attorno a un memorabile ritratto d’eroina, e quello di W.S. Cather, che in O pioneers! (1913) e in My Antonia (1918) utilizza l’originario Nebraska come scenario su cui si muovono protagoniste femminili simili, nel carattere, ad alcuni modelli jamesiani.
Naturalismo. Caratterizzato da una più spiccata attenzione alle dinamiche e ai conflitti sociali, il naturalismo annovera tra i suoi primi esponenti H. Garland, che nella raccolta di racconti Main-travelled roads (1891) fa delle squallide condizioni di vita dei braccianti agricoli dell’Ovest il motivo centrale di un inedito, aspro verismo. Diverso, almeno in parte, è invece il caso di S. Crane, che dal darwinismo sociale del romanzo breve Maggie: a girl of the streets (1893), ambientato nella Bowery di New York, passerà a un romanzo sulla guerra civile, The red badge of courage (1895), in cui l’esperienza traumatica del conflitto, filtrata attraverso l’ingenuità del giovane protagonista, è resa senza cedimenti retorici, in tutta la sua crudezza. Modello paradigmatico di un naturalismo derivato dall’opera di É. Zola è McTeague (1899), romanzo con cui F. Norris indaga, non senza un gusto per il sensazionale che limita la portata della sua scrittura, in processi di degenerazione psicofisica analoghi a quelli già descritti da R.L. Stevenson nel suo Dr. Jekill e Mr. Hyde.
Se con i romanzi di A. Cahan, capostipite degli scrittori ebraico-americani, il ghetto di New York torna stabilmente in primo piano, nelle avventure del più noto ed eclettico J. London, sono spesso gli spazi aperti e primordiali a far da sfondo (come nel poderoso A call of the wild, 1903) a una lotta per la sopravvivenza che accomuna tutti, secondo un’ottica deterministica che porterà poi all’utopia negativa di The iron heel (1908) e al tragico ritratto d’artista di Martin Eden (1909).
Ma è con T. Dreiser che il naturalismo americano trova la sua voce più compiuta e consistente, grazie al vigore con cui, in Sister Carrie (1900) e in An American tragedy (1925), egli interpreta gli effetti devastanti, in termini di alterazione delle coscienze, che fenomeni quali inurbamento e consumismo hanno creato negli anni a cavallo tra i due secoli.
Per l’impatto diretto che le teorie evoluzionistiche di Darwin hanno avuto sulla sua scrittura, va segnalato tra i naturalisti anche H.B. Adams, amico e coetaneo di H. James, il quale nell’autobiografico The education of Henry Adams, prende lo spunto per proporre, non senza una vena di latente pessimismo, una visione dinamica della storia che fa risaltare il grande disagio in cui l’intellettuale d’inizio secolo si dibatte.
Il modernismo
La poesia. La necessità di rinnovare il linguaggio attraverso la creazione di modelli comunicativi capaci di misurarsi con una realtà in profonda e rapida evoluzione è l’esigenza che accomuna tutti coloro che nel movimento modernista si riconoscono, a cominciare da G. Stein, espatriata a Parigi nel 1903, che con E. Pound ne rappresenta, specie agli inizi, la figura più carismatica. Meglio conosciuta per alcuni suoi testi in prosa (tra cui Three lives, 1909, e The autobiography of Alice B. Toklas, 1933), Stein pone al centro del suo programma un’opera di costante sperimentazione cui non viene meno neppure quando più aspre si levano le critiche contro di lei. È quello stesso obiettivo a guidare Pound lungo un percorso che dall’imagismo lo porterà al vorticismo e quindi al complesso sincretismo dei Cantos (1919-70), nonché a scoprire, come corrispondente europeo della rivista Poetry (fondata nel 1912 a Chicago da H. Monroe), tutta una serie di poeti ancora semisconosciuti, tra cui A. Lowell, H. Doolittle e lo stesso T.S. Eliot. Considerato la figura di maggior peso della poesia americana del Novecento (premio Nobel per la letteratura nel 1948), nei suoi componimenti maggiori, The waste land (1922), The four quartets (1943), Eliot persegue l’intento di ridare ordine e senso ai frantumi dell’esperienza attraverso un linguaggio poetico che, come anche per Pound, deve muoversi verso l’oggettività, abbattendo ogni residua resistenza romantica.
Se Pound ed Eliot agiscono prevalentemente in Europa, dove entrambi sono espatriati, W.C. Williams e W. Stevens sono le personalità di maggior spicco tra quanti operano a più diretto contatto con la realtà statunitense, nell’ambito di un fermento che, grazie soprattutto ai Chicago poems (1916) di C. Sandburg, a The Congo and other poems (1914) di V. Lindsay e alla celebre Spoon River anthology (1915) di E.L. Masters, vede il Midwest e la città di Chicago affiancarsi a New York come nuovi poli di vivace elaborazione del moderno. Guardando alla poesia come a un ‘piccolo congegno fatto di parole’, Williams fa della concretezza il presupposto di un linguaggio che mira a proporre una sintesi visiva dell’immagine. Più vicino alla tecnica di contaminazione tra linguaggi diversi (già teorizzata da Pound), Stevens pone invece la figura della metafora al centro di quel processo di trasposizione creativa della realtà che egli individua come l’obiettivo di fondo della propria poesia. Tra gli altri poeti direttamente legati all’innovazione modernista, un ruolo importante si ricavano l’ironico E.E. Cummings, il cui funambolismo, sintesi di ritmi musicali e di oralità, trova sbocchi felici in & e in is 5, entrambi del 1925; L. Hughes, primo poeta afroamericano d’impronta moderna, che già in The weary blues (1926) si dimostra capace di fondere in calco linguistico originalissimo la specificità dell’esperienza culturale dei neri; H. Crane, tragica figura di poeta geniale, irrequieto e sradicato, che nel poemetto The bridge (1930), in cui sembra seguire, ma al tempo stesso superare l’influsso del modello eliotiano, raggiunge momenti di rara intensità visionaria. Infine, voci comunque legate alla temperie modernista sono quelle di E.A. Robinson, che per scelte tematiche è vicino alla realtà contemporanea, di R. Frost, la cui opera è caratterizzata dalla ricerca, prettamente novecentesca, di un linguaggio accessibile e quotidiano, e soprattutto di M. Moore, ironica cultrice di una poesia eclettica, sempre sospesa tra sconfinamenti fantastici e puntualità scientifica.
La narrativa. Spesso considerato un romanziere minore, S. Anderson, che nei racconti di Winesburg, Ohio (1919) si confronta con la realtà interiore, spesso tormentata, dei suoi personaggi, è in effetti una presenza cruciale per l’intera generazione di giovani scrittori che in poco più d’un decennio avrebbe completato l’opera di rinnovamento del romanzo americano, già avviata da M. Twain e da James. Tra i maggiori esponenti di questo nuovo corso sono: F.S. Fitzgerald, che, sovvertendo la linearità del racconto mediante un’opera di frammentazione di grande efficacia, con The great Gatsby (1925) propone soluzioni tecniche che molti in seguito adotteranno; E. Hemingway, il quale, in The sun also rises (1926) e A fare;well to arms (1929), così come nei racconti di In our time (1925), affina quell’opera di condensazione del linguaggio che diverrà cifra pressoché costante del suo stile; J.R. Dos Passos, la cui trilogia U.S.A. (1930-36) si basa su un suggestivo collage di materiali e stili eterogenei; il provocatorio e scandaloso H. Miller di Tropic of cancer (1934); e infine N. West, che con The day of the locust (1939) sottopone il mito di Hollywood a uno smembramento che la struttura frammentata del romanzo ripropone e completa.
Discorso a parte merita W. Faulkner, il più grande tra i narratori americani del Novecento, che trasformando fantasticamente i connotati dell’originaria contea del Mississippi, nei suoi romanzi costruisce una saga tanto complessa e tormentata quanto inusitate, penetranti, a volte surreali, sono le innovazioni tecniche e le soluzioni linguistiche attraverso cui essa viene proposta. Altri importanti scrittori che al panorama culturale e geografico del Sud rivolgono in quegli stessi anni la loro attenzione sono E. Caldwell, realista molto popolare tra gli anni 1930 e 1940, J. Cain, autore di The postman always rings twice (1934), E. Welty, nota soprattutto per la sua narrativa breve, e C. McCullers, legata ai temi dell’incomunicabilità e del disagio esistenziale.
Tra coloro che si affidano a soluzioni tecniche meno innovative, pur tuttavia centrando la loro narrativa su problemi, spesso scottanti, di grande attualità, vanno ricordati: S. Lewis, premio Nobel per la letteratura nel 1930, che in Main street (1920) e in Babbitt (1922) offre una convincente critica della provincia americana; U. Sinclair e J.T. Farrell entrambi impegnati a denunciare con i loro romanzi le situazioni di degrado ambientale e di decadimento morale proprie dei centri urbani; J. Steinbeck, esponente di punta della proletarian novel degli anni 1930, e autore dei celebri affreschi realisti di Of mice and men (1937) e di The grapes of wrath (1939). Sempre sullo scabro sfondo della Depressione vanno infine collocati T. Wolfe, le cui opere, da Look homeward, angel (1929) a You can’t go home again (postumo, 1940), trattano motivi autobiografici in chiave realista, e R. Wright, primo narratore afroamericano di vaglia internazionale, che con Uncle Tom’s children (1938) e soprattutto con il crudo, coinvolgente linguaggio di Native son (1940), piega il naturalismo all’indagine dei guasti della discriminazione razziale.
Il teatro. Motivi di diversa natura, non ultimo la storica presenza di una forte matrice puritana, hanno impedito per secoli che negli USA si radicasse una tradizione teatrale paragonabile a quella delle altre culture occidentali, al punto che, quasi a colmare la lacuna, è lo stesso romanzo, specie nell’Ottocento, a incaricarsi di offrire ampi spazi allo sviluppo drammatico dell’azione. A parte episodi isolati trascurabili, legati per lo più a realtà culturali circoscritte, è appunto nei primi anni del secolo che, con la figura di D. Belasco, autore tra l’altro di Madame Butterfly (1900) e di The girl of the golden West (1905), entrambe poi trasformate in libretti per opere di G. Puccini, e con C. Ficht si assiste alla nascita di una tradizione teatrale. Ma è soprattutto a E. O’Neill e alla compagnia dei Provincetown players, con la quale egli collaborò a lungo, che si deve l’inizio riconoscibile di un teatro statunitense d’autore, con una serie di atti unici di successo, messi in scena tra il 1916 e il 1920. Dopo un’importante fase espressionista (The emperor Jones, 1920, e The hairy ape, 1922), O’Neill toccherà la vetta con Strange interlude (1928) e Mourning becomes Electra (1931), opere in cui sempre si avverte una forte carica sperimentale, legata anche ai contemporanei sviluppi del teatro europeo e al vincolo intenso con i modelli della tragedia greca, che egli reinterpreta. Altri importanti esponenti di un teatro d’avanguardia che risente soprattutto dell’influsso espressionista e di una forte motivazione ideologica sono E. Rice, autore dell’irresistibile The adding machine (1923) e dell’innovativo Street scene (1929), e C. Odets, che con Awake and sing! e Waiting for Lefty (entrambi del 1935) affronta, sul modello del teatro di B. Brecht, temi di forte impatto sociale.
La critica. Fenomeno importante della cultura statunitense tra le due guerre è anche il consolidarsi di una forte tradizione critica, cui il movimento modernista nel suo complesso offre dovizia di materiali. Eliot, con The sacred wood (1920), Dante (1929) e On po;etry and poets (1957), e Pound, con i numerosissimi saggi, antologie e traduzioni, confermano la tendenza dell’autore ad agire anche in sede critica. Ma è con l’opera di I. Babbitt e V.W. Brooks e, soprattutto in Inghilterra, con la scuola di Cambridge di I.A. Richards, F.R. Leavis e W. Emp;son, che la critica militante riesce a darsi una sua precisa fisionomia. Già animatore del gruppo dei Southern agrarians, di cui fanno parte tra gli altri i poeti e scrittori del Sud A. Tate e R.P. Warren, verso la fine degli anni 1930 J.C. Ransom dà vita al movimento del new criticism, che richiamandosi alla centralità del testo letterario e delle sue dinamiche interne, pone come premessa quell’idea di close reading, o lettura ravvicinata, che dominerà fino agli anni 1950 la critica statunitense e quella internazionale. A questi presupposti s’ispirano, seppure in forme diverse, i maggiori critici del periodo, dai già citati Warren e Tate a Y. Winters e C. Brooks, a L. Trilling e L.P. Blackmur.
Centrale, per lo sviluppo di una critica che agli aspetti specifici del testo unisce l’esigenza di analizzare il contesto in cui esso si sviluppa e ricade, è invece l’apporto del già citato F.O. Matthiessen, grande esegeta del Rinascimento americano, e di H. James, ai cui presupposti si rifarà più avanti la critica d’ispirazione marxista e l’opera di E. Wilson, primo ad applicare quei principi, calandoli nella rete delle ascendenze europee, ai moderni.
Il dopoguerra
Nell’arco di tempo che va dalla fine della Seconda guerra mondiale ai primi anni 1960, periodo in cui la guerra fredda raggiunge i livelli di maggior tensione, si assiste a un profondo rinnovamento della letteratura americana, da parte di un più ampio sommovimento che interessa il costume e, più in genere, l’intera cultura statunitense. Dangling man, l’opera con cui S. Bellow esordisce nel 1944, anticipa e compendia quello stato di insicurezza e di mancanza di equilibrio che diverrà motivo ricorrente del suo corpus (tra cui The adventures of Augie March, 1953; Herzog, 1960; Humboldt’s gift, 1975) e di gran parte della narrativa di questa stagione. Se il 1951 è l’anno in cui J.D. Salinger pubblica The catcher in the rye (conosciuto in Italia con il titolo Il giovane Holden), romanzo in cui il linguaggio giovanile del periodo diviene protagonista di un testo letterario tra i più fortunati del Novecento, il 1952 è dominato dall’uscita di Invisible man, inquietante spaccato dei rapporti interrazziali interni, con cui lo scrittore afroamericano R. Ellison s’inserisce tra i protagonisti della narrativa contemporanea, aprendo un percorso che J. Baldwin, l’altro grande prosatore nero del periodo, contribuirà a consolidare con i romanzi Giovanni’s room (1956) e Another country (1962), e con i saggi di Notes of a native son (1955) e Nobody knows my name (1961). Sempre alla seconda metà degli anni 1950, inoltre, data l’esordio di B. Malamud, che con The assistant (1957), i racconti di The magic barrell (1958) e più tardi con The fixer (1966), costruisce attorno alla figura dell’ebreo inurbato un universo di composta desolazione in cui ironia e black humour giocano un ruolo non secondario; dello stesso periodo è il grande successo di Lolita (1955), che farà della rarefatta scrittura del narratore e saggista russo V. Nabokov, transfuga prima in Europa e dal 1940 negli USA, uno dei punti di riferimento obbligati del romanzo contemporaneo. Infine, intellettuale forse più d’altri rappresentativo della fluidità di questi anni, è il poliedrico N. Mailer, che alla grande risonanza di The naked and the dead (1948), suo primo romanzo sul crudo sfondo del recente conflitto, farà seguire una serie di prove (Barbary shore, 1951, Advertisement for myself, 1959, An American dream, 1965, The armies of the night, 1968) che, seppur diseguali per qualità e pregnanza, sono legate dal gusto per la provocazione e dalla tendenza a travalicare i confini tra generi. Lo stesso avviene in Myra Breckinridge (1968), lucida satira di G. Vidal e nel riuscito esperimento In cold blood (1966), con cui T. Capote rivisita la cronaca usando modelli narrativi diversi.
Anche per quanto attiene alla poesia, gli anni del dopoguerra sono caratterizzati dal grande fermento con cui gruppi e scuole diverse si affacciano contemporaneamente sulla scena. Tra questi, la Black mountain school, cui daranno vita, nei primi anni 1950, C. Olson, con il suo ‘verso proiettivo’, aperto e privo di costrizioni metriche precostituite, R. Creeley, D. Levertov e R. Duncan; e il cosiddetto gruppo dei poeti ‘confessionali’, che nella riflessione sull’esperienza personale, spesso dolorosa, individuano un possibile legame con l’esterno: R. Lowell e T. Roethke, J. Berryman e W.D. Snodgrass, S. Plath e A. Sexton. A queste espressioni di un periodo culturalmente molto vivace, va affiancato l’anticonformismo della beat generation, cui danno vita poeti come L. Ferlinghetti, A. Ginsberg, G. Corso, il primo L.R. Jones, e narratori come W. Burroughs, J. Kerouac, e il gruppo della New York school, in cui, sul finire degli anni 1950, confluiscono poeti della visionarietà urbana, come F. O’Hara, J. Ashbery e K. Koch.
Sulla scena teatrale, alla figura storica di O’Neill, si succedono quelle di T. Williams e di A. Miller, che nel decennio successivo alla fine della guerra daranno vita a un periodo particolarmente felice per il dramma statunitense, il primo con The glass managerie (1944), A street-car named desire (1947) e Cat on a hot tin roof (1955), il secondo con pièces di grande impatto sul dibattito contemporaneo, tra cui Death of a salesman (1949), e The crucible (1953).
La fine del 20° sec. e gli inizi del 21°
Narrativa postmoderna. Nella letteratura statunitense contemporanea la narrativa s’impone come il genere letterario dominante ed è interessante notare come una letteratura postmoderna per definizione come quella statunitense non soltanto sia dominata da romanzi imponenti per dimensioni e ambizioni, ma prediliga, tra tutte le varianti, quella del romanzo storico. Vero è che nei romanzi dei padri fondatori del postmoderno la storia è assunta come un gigantesco repertorio di eventi e personaggi che possono essere collegati tra loro secondo modalità imprevedibili, ignorando gerarchie di rilevanza e nessi logico-temporali. E.L. Doctorow ha puntato l’attenzione su aspetti sociali o nodi storici irrisolti, materia che peraltro caratterizza anche le opere di M. McCarthy e di C. Ozick; K. Vonnegut si esprime attraverso gli schemi di una pseudofantascienza; J.H. Updike si fa cantore degli aspetti più logori della provincia americana; T. Pynchon conduce un’opera di radicale destoricizzazione in Mason & Dixon (1997) e in Against the day (2006).
La dipendenza dai mass media è esplorata a fondo e condotta alle sue estreme conseguenze nell’opera di D. DeLillo, da Americana (1971) a Libra (1988), sull’assassinio di J.F. Kennedy, fino a Underworld (1997) e a Falling man (2007), ispirato al tragico attacco contro le Twin Towers di New York dell’11 settembre 2001. Autori interessanti, molto diversi tra loro, sono J. Heller (celebre per la sua satira antimilitarista Catch-22, 1961), R. Sukenick, R. Federman, H. Brodkey, G. Sorrentino, W. Abish. Si impongono all’attenzione testi come American pastoral (1997), The dying animal (2001) e Everyman (2006) di P. Roth.
Oltre alla fantascienza, altri generi competono per acquistare dignità letteraria: tra questi, in primo luogo l’horror e il poliziesco. Così, è la struttura del gotico a sorreggere l’intricato gioco di specchi nell’opera di W. Gaddis; è la sua versione sudista e postfaulkneriana a innervare l’orrore etico di W. Percy, J. Dickey, J. Purdy, W. Styron e C. McCarthy; per non parlare del grottesco fine a sé stesso di tutta la produzione di C. Bukowski e della titanica metafora del cuore oscuro dell’America disegnata in decine di romanzi dal re dell’horror, S. King. L’indecifrabilità del reale nel mondo contemporaneo giustifica la proliferazione di investigatori alla ricerca di verità irraggiungibili, come quelli che popolano i romanzi di P. Auster o di R. Coover (Gerald’s party, 1986). A questi vanno aggiungendosi i più canonici ma sempre meno prevedibili investigatori di E. Leonard, T. Harris e J. Ellroy (The Black Dahlia, 1987; L.A. noir, 1998; The cold six thousand, 2001). Non tanto all’horror più canonico quanto alla sua versione americana appartiene gran parte dell’opera di J.C. Oates, che peraltro si è cimentata con altri generi.
Nell’ambito della narrativa, andrà poi menzionato una sorta di ritorno alla realtà e al quotidiano, teorizzato e realizzato dal T. Wolfe di The bonfire of the vanities (1987). Si è giunti al conio di una nuova etichetta, minimalismo, per descrivere quella specie di reazione al virtuosismo stilistico che accomuna la ricerca attenta e sofferta di T. Olsen, G. Paley, e soprattutto di R. Carver e dei suoi successori R. Banks, R. Ford, J. McInerney, D. Leavitt e B. Easton Ellis. Tra gli scrittori nati fra il 1959 e il 1970 si segnalano ancora J. Franzen, D. Foster Wallace (morto suicida nel 2008), M. Chabon, D. Eggers, N. Englander.
La poesia postmoderna. Nel panorama poetico, alle voci degli ex beat si sono alternati le più quiete meditazioni esistenziali di K. Shapiro, R. Wilbur e R. Creeley, il surrealismo ironico e quasi domestico di M. Strand, la religiosità raccolta di R. Duncan e G. Snyder. Anche i poeti più affascinati dalla potenza del mito, come A. Hecht, J. Merrill e W.S. Merwin, sembrano optare per una forma controllata e compatta. Di segno opposto il virulento surrealismo di R. Bly, mai disgiunto da un impegno diretto sulle più scottanti questioni d’attualità, e l’eversiva iconoclastia di J. Ashbery, esponente, insieme a C. Bernstein, di quella language poetry che traduce le teorie decostruzioniste nel linguaggio poetico. La rappresentante per eccellenza del femminismo poetico, A. Rich, opera un importante salto di prospettiva, passando dalle esplicite rivendicazioni dei diritti delle donne alla riflessione sulla scomposizione e ricomposizione dei caratteri che si usa definire come maschili e femminili (An atlas of the difficult world, 1991).
Il multiculturalismo. Nell’ambito del multiculturalismo, l’etnia che si impone per numero e influenza culturale è senz’altro quella afroamericana. E se nella prima metà del secolo gli autori sono quasi esclusivamente di sesso maschile (come L. Hughes, R. Ellison, J. Baldwin, R. Wright e L.R. Jones/A. Baraka), le generazioni successive hanno visto le donne, fino ad allora rappresentate da singole e controverse figure come Z.N. Hurston, impadronirsi della leadership, una leadership posta in discussione, forse, soltanto dalla narrativa di I. Reed e dai solidi drammi storici di A. Wilson. Nella produzione delle scrittrici afroamericane le tematiche dell’emarginazione razziale si fondono con quelle della guerra dei sessi. Seguendo l’esempio di G. Brooks, che unisce l’eleganza della dizione alla lucidità dell’impegno sociopolitico, elaborano nuovi modi del linguaggio poetesse afroamericane come A. Lorde (The marvellous arithmetics of distance, postumo, 1993); N. Giovanni (Sacred cows, and other edibles, 1988); Ai (Florence Ai Ogawa: Sin, 1986), la cui opera è influenzata notevolmente dalla sua ascendenza etnica mista (giapponese, afroamericana, amerindia, irlandese).
Autrice di riferimento, in poesia (Possessing the secrets of joy, 1992) come nella narrativa (The colour purple, 1982), è A. Walker, mentre la cultura orale afroamericana trova eco maggiore nella narrativa di T. Morrison, premio Nobel per la letteratura nel 1993 (Beloved, 1987; Paradise, 1998; A mercy, 2008).
Teatro. Il teatro contemporaneo, superate le divisioni fra teatro commerciale e teatro d’avanguardia che avevano contrapposto la scena di Broadway alla scena off e poi entrambe all’off-off-Broadway, si caratterizza per il carattere estremamente eterogeneo. Autori di punta sono S. Shepard e D. Mamet, ai quali si possono aggiungere J. Guare (Six degrees of separation, 1990), D. Rabe, e ancora L. Wilson, A. Innaurato, H. Fierstein, che hanno reso con grande forza espressiva il dramma della condizione omosessuale. Il teatro ancora tradizionalmente di parola di A. Miller ed E. Albee (autore di un classico del teatro contemporaneo come Who’s afraid of Virginia Woolf?, 1962) trova il suo contraltare nelle sperimentazioni collettive, centrate soprattutto sul lavoro scenico, dei gruppi diretti da R. Foreman, da R. Wilson, da P. Schumann. I successi e i fallimenti del femminismo sono rivissuti in tutta la loro ambigua complessità nei testi di autrici quali W. Wasserstein, T. Howe, M. Norman, B. Henley, E. Mann, E. Ensler (la più celebre grazie a lavori come The vagina monologues, 1996, e The good body, 2005).
Arte e architettura
Dal periodo coloniale al 19° secolo
L’architettura del periodo coloniale. Nelle colonie spagnole la cultura della madrepatria fu rapidamente assorbita e si sviluppò usufruendo anche di apporti indigeni. Sotto il dominio degli Spagnoli sorsero insediamenti (presidios, pueblos e missiones) caratterizzati dalle attività che vi si svolgevano (militare, commerciale, religiosa): di questi centri il più antico ancora esistente è Saint Augustine, fondato nel 1565 sulla costa atlantica della Florida. Fino a tutto il 18° sec. si realizzarono chiese in pietra con reminiscenze rinascimentali e poi barocche (cattedrale di Saint Augustine, chiesa di San Xavier del Bac a Tucson). Nelle colonie inglesi le arti si svilupparono molto più lentamente. Nonostante la presenza di coloni francesi, olandesi e svedesi, l’influsso predominante dall’inizio del 16° sec. fu quello di derivazione inglese (soprattutto nel New England e nella Virginia: insediamenti a economia agricola, pianificati secondo logiche di tipo collettivo; case d’abitazione sorte intorno a spazi comuni). Tra i materiali edilizi fu usato il legno; le soluzioni tecniche si affinarono creando una duratura tradizione costruttiva: tra i sistemi più diffusi, il balloon frame (➔). Negli Stati anglosassoni del Sud, l’economia basata sul latifondo portò alla tipologia della villa padronale isolata; fino a tutto il 17° sec. quasi non esistevano centri urbani, a eccezione di Williamsburg. Dal 18° sec. nelle province del Nord e dell’Est, dal grande sviluppo commerciale, le città si ingrandirono e si consolidò l’esigenza di realizzare architetture rappresentative del potere economico: i modelli furono quelli della tradizione inglese sistematizzata in numerosi trattati (Vitruvius Britannicus, C. Campbell 1717; Palladius Londonensis, W. Salomon 1734 ecc.).
L’architettura dopo l’indipendenza. Dalla conclusione della guerra d’indipendenza (1783), all’esigenza di una nuova architettura a carattere nazionale rispose, ancora, un eclettismo di stampo europeo che durò fino a tutto il 19° sec.: al Nord, nell’edilizia privata residenziale prevalse l’influsso dell’inglese R. Adam; a New York, Filadelfia e in tutte le grandi città emersero caratteri del classicismo francese e della idealizzata antichità romana. La figura di T. Jefferson fu determinante con le sue realizzazioni: Campidoglio di Richmond in Virginia; colonnati e Rotonda dell’Università di Charlottesville. Tali opere sulla scia della tradizione palladiana giunsero a ingigantirne stilemi e tipologie a seconda delle varie funzioni: Campidoglio degli Stati Uniti e Casa Bianca di Wash;ington, sorta di modello per gli edifici pubblici che sorsero nelle altre città. Sulle orme della contemporanea architettura europea, tra la riproposizione delle varie forme del passato si registrò un gusto vittoriano in case di abitazione e costruzioni ecclesiastiche (J. Renwick, cattedrale di St. Patrick a New York, 1858) o lo stile Tudor per le università.
Alla persistenza di forme classiche, gotiche o rinascimentali, si associarono (dalla metà del secolo) alcune caratteristiche tipicamente americane: attenzione per la funzionalità delle piante e per i servizi; uso di nuovi materiali (ferro, ghisa); realizzazione di nuove tipologie edilizie (edifici per uffici o alberghi, sviluppati in altezza). Con grandi personalità come H.H. Richardson e ancor più con L.H. Sullivan e con gli architetti e ingegneri attivi a Chicago, l’architettura negli USA si afferma in modo autonomo e originale. L’esposizione mondiale di Chicago (1893) fissò una tappa significativa della complessa realtà architettonica del periodo in virtù dell’impianto generale progettato da D.H. Burnham e R.M. Hunt, della realizzazione dei vari padiglioni, del movimento noto come City Beautiful, teso a riproporre i valori estetici delle grandi metropoli europee (apogeo nel Piano di Chicago, redatto da Burnham nel 1909).
La pittura e la scultura. In pittura, e ancor più nella scultura, la rigida morale puritana delle prime colonie limitò la produzione prevalentemente alla ritrattistica, derivata dall’arte olandese e inglese, conosciuta soprattutto per mezzo di stampe, di livello tecnico modesto ma con qualche caratteristica di freschezza e vivacità. Nel 18° sec. la produzione artistica divenne più raffinata riflettendo, oltre alla determinante influenza inglese, l’attenzione a modelli italiani: emergono J. Smiberg; P. Vanderlyn; R. Feke; lo svedese G. Hesselius; l’inglese J. Blackburn. Particolare rilievo hanno nella seconda metà del secolo B. West e J.S. Copley, formatisi in Europa. Ritrattisti notevoli, per primi affrontarono anche composizioni di soggetto storico ispirate alla storia americana. Al volgere del secolo cominciò a prendere forma un’arte più specificamente americana, nel ritratto e nei quadri storici come nel paesaggio e nella pittura di genere (W. Allston, J. Vanderlyn, G. Stuart). C.W. Peale nel 1805 organizzò quella che poi divenne la Pennsylvania academy of the fine arts; fu capostipite di una famiglia di pittori tra i quali il più notevole fu Raphaelle.
La pittura di paesaggio ebbe particolare impulso con la Hudson River School; importante per la formazione della scuola fu l’arrivo a New York nel 1825 di T. Cole, animatore del gruppo, e significative furono le esperienze precedenti nel paesaggio di Peale, Allston, R. Earl, S.F.B. Morse. In questo ambito operarono A.B. Durand, J.F. Fensett, A. Bierstadt, G.C. Bingham, G. Catlin, S. Eastman. Un posto particolare occupa J.J. Audubon con i suoi raffinati disegni di fauna americana. Continuava inoltre una pittura non accademica, praticata da artisti autodidatti: paesaggi, nature morte, ritratti, segnati da una fresca e intensa vena naïf (J.H. Davis, E. Hicks).
Nell’ambito della scultura, di indirizzo neoclassico e accademico, si distinsero H.K. Brown, C. Mills, T. Ball, E.D. Palmer; J.Q.A. Ward, allievo di Brown; W. Rimmer, antesignano del naturalismo del 20° secolo. Alla fine del 19° sec. artisti come W. Homer, G. Inness, F. Duveneck, T. Robinson, J.H. Twachtman, M. Cassatt ecc., sensibili alle ricerche dell’impressionismo, si dedicarono, con esiti diversi, allo studio della luce e della resa atmosferica. Gli inizi dell’arte statunitense furono segnati da una frattura tra pubblico e artisti: molti artisti, attivi fino all’inizio del 20° sec., rinunciarono all’arte (Morse) o si isolarono (Homer, dal vigoroso impressionismo impregnato di realismo; T. Eakins, dal crudo realismo; il visionario A.P. Ryder, alla base della corrente surrealista americana) mentre altri, come J.A. Whistler, Cassatt, J.S. Sargent, emigrarono in Europa.
Il 20° sec. e l’inizio del 21°
I movimenti di avanguardia. La corrente surrealista rappresenta una costante nella pittura americana (da A.B. Davies sino a P. Blume, O.L. Guglielmi, C. Burchfield, A. Dove). A New York una svolta importante fu segnata dalla mostra del gruppo degli Otto pittori statunitensi (R. Henri, J. Sloan, W.J. Glackens, E. Lawson, M. Prendergast, G.B. Luks, E. Shinn, Davies) nel 1908, dalle esposizioni d’arte d’avanguardia europea organizzate da A. Stieglitz e dall’Armory Show. Il gruppo degli Otto, che si sciolse quasi subito, ebbe il merito di introdurre nella tradizione pittorica americana l’influenza delle nuove correnti europee, e affermò un liberalismo sociale progressista pur in uno stile reazionario; i modernisti americani, pur convenzionali nei soggetti, erano avversi alla tradizione stilistica realista.
J. Stella e M. Weber furono i principali esponenti del movimento futurista negli USA, intorno al 1913 M. Russel e S. MacDonald-Wright avviarono ricerche sul sincromismo, mentre la presenza di M. Duchamp, a New York dal 1915, e di F. Picabia catalizzò le esperienze del dadaismo americano, di cui Man-Ray fu l’esponente più significativo.
Il realismo. Nel terzo e quarto decennio del secolo sulla scena artistica americana prevalse il realismo (precisionisti; regionalisti; American scene painters). La semplificazione delle forme e un repertorio d’immagini legato alla civiltà industriale caratterizzarono le opere di C. Demuth, P. Dickinson, C. Sheeler, G. O’Keeffe; J. Marin si esprimeva in un espressionismo semiastratto. La crisi economica degli anni intorno al 1930 coincise con l’affermarsi di un realismo che, rifacendosi alle tradizioni americane, riprese in esame, oltre agli scenari urbani e industriali, quelli delle campagne e dei piccoli centri (T.H. Benton, J.S. Curry, G. Wood). W. Gropper, B. Shahn, P. Evergood, J. Levine e altri, con distorsioni espressioniste, rappresentarono una cruda critica sociale. E. Hopper infuse un’atmosfera immota ai suoi interni e vedute urbane; Burchfield propose in forme spettrali i suburbi.
Fino al 1930 circa la scultura rimase legata a modi accademici; emergono però per l’attenzione all’espressività della materia, per la monumentalità semplificata delle forme, le opere di W. Zorach e di G. Lachaise, R. Laurent, E. Nadelmann, J. Flannagan, J. Storr. Va ricordato l’unico esperimento di patronato statale, il Public work of art project (1933) che nel 1935 sfociò nel WPA (➔).
Tendenze dell’architettura. Lo sviluppo industriale e le importanti innovazioni tecnologiche che alla fine dell’Ottocento avevano portato alla grande esperienza della Scuola di Chicago (➔ Jenney, William le Baron) segnarono in modo fondamentale la successiva evoluzione dell’architettura statunitense, che tuttavia rimaneva permeata di un eclettismo formale. In risposta all’aumento di valore delle aree urbane cominciava a imporsi la tipologia architettonica del grattacielo: è del periodo la riaffermazione dell’impianto a scacchiera come soluzione urbanistica, scelta già attuata a New York e a New Orleans. A questo tema del centro urbano ad altissima densità si è affiancato quello dell’edilizia residenziale, spesso risolto, in continuità con la tradizione, nella villa unifamiliare isolata nel lotto, negazione di ogni concetto di aggregato urbano; divario particolarmente accentuato nelle città dell’Ovest (Los Angeles). Il fenomeno del suburbio ricalca questo divario, configurandosi come sommatoria di casette unifamiliari accostate, nei casi più poveri senza neppure l’alibi del verde intorno a esse.
Agli studi di progettazione delle città, a grande compartecipazione e organizzati come una piccola industria produttiva, si affiancò l’impegno più autonomo di ricerca di studi come quello di F.L. Wright, che calò nel dibattito americano un ricco e originale bagaglio di proposizioni alternative alle soluzioni correnti. Nel 1932 la mostra International Style (➔) contribuì a diffondere i principi del cosiddetto movimento moderno europeo che, già introdotti da W. Lescaze, ebbero particolare riscontro con l’esodo negli USA dopo il 1933 di alcuni grandi architetti tedeschi (W. Gropius, L. Mies van der Rohe, M. Breuer, E. Mendelson ecc.).
Arte astratta, pop art, espressionismo e antiespressionismo. Dopo la chiusura del Bauhaus da parte dei nazisti, alcuni dei suoi insegnanti più famosi (J. Albers, L. Moholy-Nagy ecc.) emigrarono negli USA e altri artisti (M. Beckmann, P. Mondrian, F. Léger, M. Ernst ecc.) vi si rifugiarono allo scoppio della Seconda guerra mondiale. Questo fattore sfociò nella straordinaria vitalità dell’arte astratta negli USA fino alla fine degli anni 1950 (A. Gorky, J. Pollock, W. de Kooning, M. Rothko, M. Tobey, R. Motherwell, W. Baziotes ecc.). In conseguenza e in reazione all’espressionismo astratto (➔ action painting; S. Francis, W. de Kooning, R.B. Motherwell), viene affermandosi la pop art (➔ pop), sulla scorta della quale, e delle avanguardie precedenti, il limite tra le arti è gradualmente annullato: insieme all’assemblage e ai combine paintings è introdotto il concetto di environment, che coinvolge l’ambiente nell’opera stessa. In questo ambito si inseriscono le opere di G. Segal o E. Kienholtz e, in seguito, le esperienze minimaliste di R. Serra o D. Judd. I maggiori rappresentanti della pop art sono R. Rauschenberg, C. Oldenburg, J. Johns. Con A. Kaprow, Oldenburg, R. Whitman e altri, J. Dine fu uno dei pionieri di manifestazioni effimere (happening). La pop art ebbe il suo drammatico debutto nel 1962 con una mostra di opere di R. Lichtenstein, J. Rosenquist, A. Warhol, T. Wesselmann e R. Indiana.
La ricerca di soggetti e luoghi comuni caratteristica della pop art ha dato luogo poi a una sorta di nuovo realismo (iperrealismo o fotorealismo) che ha ricercato la riproduzione illusionistica della realtà (M. Morley, A. Leslie, C. Close, J.C. Clarke).
Anche nell’ambito dell’arte non figurativa vi fu una reazione all’espressionismo astratto. Già negli anni 1950 ricerche di artisti come Rothko, Still, Newman avevano caratteristiche (immagini unitarie, forme simmetriche, larghe campiture di colore piatto) decisamente contrastanti con l’action painting. Agli inizi degli anni 1960 tale ricerca è continuata da artisti più giovani (E. Kelly, F. Stella, M. Louis, K. Noland, A. Held). La pittura non figurativa ‘antiespressionista’ ha trovato ulteriori definizioni: color field paintings (H. Frankenthaler, K. Noland e J. Olitski); hard-edge painting (Kelly, L. P. Smith, Held, Stella); shaped canvas (C. Hinman, P. Feeley e anche Stella); pittura monocromatica (R. Ryman e R. Mangold, che si riallacciano alle ricerche di A. Reinhardt).
Basata sulla dinamica della percezione e sull’illusione ottica è l’optical art, per la quale fondamentale è stata la ricerca di J. Albers. Systemic painting e minimal art, combinando l’illusionismo, di cui l’optical art faceva un gioco paradossale, con elementi strutturali essenziali (A. Martin, J. Baer, W. Insley, D. Bannard, R. Bladen, R. Morris, D. Judd, C. Andre, S. LeWitt, D. Flavin, R. Smithson ecc.), rientrano nell’ambito più ampio dell’arte concettuale.
Nel campo scultoreo oltre ad A. Calder, uno dei grandi maestri dell’arte moderna, a L. Nevelson, L. Bourgeois e alla complessa personalità di D. Smith, si rilevano esperienze genericamente inseribili nell’espressionismo astratto (T. Roszac, I. Lassaw ecc.), nella pop art (Segal, Kienholtz, J. Chamberlain) o nell’iperrealismo (D. Hanson, J. De Andrea).
La graduale trasformazione dell’intervento dell’artista è portata avanti dall’arte concettuale, operando nell’ambiente (➔ land art) o trasformando il prodotto artistico da oggetto fisico in immagine mentale, per mezzo di fotografie, videoregistrazioni, documenti, definizioni, formule (J. Kosuth, D. Huebler). Sulla stessa linea le esperienze della computer art o arte programmata (P. Citron, J. Whitney, A.M. Noll), dell’electric art, che lavora con la luce artificiale (Chryssa, S. Antonakos, B. Nauman).
Alla fine degli anni 1970 si è delineato, come in Europa, un ritorno all’espressione figurativa, legato in parte alla tradizione espressionista, in parte all’arte della strada (murales e graffiti). Tra gli artisti più attivi: D. Salle, R. Longo, K. Haring, J. Borofsky, J. Schnabel, J.M. Basquiat.
Linee di tendenza contemporanee. Negli ultimi due decenni del 20° sec. alcuni dei protagonisti dell’espressionismo astratto, della pop art e della funk art (➔) hanno continuato a imporsi con rinnovata inventiva, mentre tra la fine del 20° e l’inizio del 21° sec. tornano ad affermarsi ricerche di matrice concettuale, e assumono un ruolo di primo piano la fotografia, il film e il video, le tecnologie avanzate e la net art. Emerge il tentativo di ridefinire il ruolo dell’arte nei confronti di una realtà dominata dalla comunicazione di massa e dall’informazione elettronica, o in rapporto a temi di impegno politico e sociale. Recuperano i valori legati all’arte applicata e ai lavori tradizionalmente femminili (ceramica, tessitura, ricamo ecc.) esponenti del pattern and decoration movement (J. Kozloff, M. Schapiro); affrontano i temi della condizione della donna, con approccio concettuale, le scultrici L. Benglis, M. Kelly, A. Mendieta, A. Saar. Nuove ricerche espressive sperimentano J. Holzer (installazioni luminose e sonore, uso della rete telematica), B. Kruger, C. Sherman, C. Opie. Nell’ambito della videoarte, accanto ad artisti affermati quali N.J. Paik e B. Viola, emergono tra gli altri M. Kelley, T. Oursler, J. Crandall, D. Thater. Numerosi gli artisti che sperimentano l’uso di Internet (M. America, L. Baldwin, B. Benjamin, K. Goldberg, A. Weintraub ecc.). Nella pittura e nella scultura si affermano artisti come J. Shapiro, P. Halley, L. Pittman, J. Koons, A. Aycock; nell’installazione A. Hamilton; J. Turrell lavora con la luce su opere ambientali; J. Baldessari, D. Graham, E. Ruscha, J. Borofsky perseguono l’integrazione tra scultura, installazione, performance, fotografia.
In campo architettonico, dal secondo dopoguerra, nonostante la realizzazione di prodotti di alto livello formale, la grande spinta creativa impressa dagli architetti europei sembra essersi come raggelata. Parallelamente, si registrano interventi nel tessuto urbano a una scala così complessa da presupporre grandi studi animati da una progettazione coordinata, con staff di tecnici e operatori chiamati a risolvere i problemi organizzativi sollevati dalle grandi imprese costruttive: a questi grandi studi, SOM, TAC ecc., si deve buona parte dell’attuale volto delle cities americane. Il superamento dei modelli razionalisti o delle rigide stereometrie derivate dalla lezione di Mies van der Rohe, in favore di soluzioni più complesse e plasticamente elaborate, è inizialmente rintracciabile in alcune opere di R.B. Fuller e di K. Wachsmann, in cui il concetto di standard e di serialità si svincola da un mero principio di produttivismo economico. Il rigorismo morfologico dell’International Style è messo in crisi quando P. Johnson (1958) elabora la prima versione del progetto per il Lincoln Center. Analogamente, la maniera di Mies van Der Rohe trova una più complessa esperienza spaziale e cromatica nell’edificio della General Motors (1956, Warren, Michigan) di E. Saarinen. Ma la più netta alternativa si ha con l’opera di L. Kahn; accanto a lui, nell’assoluta priorità concessa all’elemento strutturale, va ricordato P. Rudolph. Nella linea di ricerca orientata verso una rinascita architettonica vanno citati: I.M. Pei, E. Mitchell e R. Giurgola, V. Lundy, J. Johansen, K. Roche, B. Goldberg, C. Pelli, C.F. Murphy. Una linea di critici;smo intellettuale nella quale le contraddizioni della realtà vengono assunte come un dato di fatto, ironico o tragico, è rappresentata da R. Venturi, C. Moore, D. Lyndon, J. Esherick, M. Graves, J. Hejduk, P. Eisenman, R. Meier, C. Gwathmey. Accanto a interventi imponenti nelle dimensioni come supergrattacieli e centri civici e commerciali (Twin Towers del World trade center di New York, 1972, di M. Yamasaki, distrutte nell’attentato del 2001; John Hancock, 1970, e Sears Tower, 1974, di SOM, a Chicago; John Hancock di Boston, 1976, di I.M. Pei; edificio della Wacker Drive a Chicago, 1983, di Kohn, Pedersen, Fox; World financial center a New York, 1981-87, di Pelli), vanno ricordate alcune interessanti soluzioni in ambito residenziale (Twin parks North-East, Bronx, 1969-72, di R. Meier, o Battery park city, 1979-93, piano generale di Cooper Eckstut Associated, a New York), come pure nella realizzazione o ampliamento di importanti musei e complessi universitari: a Washington, Hirshhorn Museum di SOM (1974); National air and space museum, di Hellmuth, Obata e Kassabaum (1976); nuova ala della National Gallery, di Pei (1978); High Museum di Atlanta (1983) e Getty Center di Los Angeles (1984-96) di Meier ecc. Alla fine del 20° sec., l’architettura presenta una coesistenza di stili eredi dei filoni neomodernisti e dei neoclassicismi postmoderni degli anni 1980; sono andate tuttavia maturando personalità di rilievo attive autonomamente, al di sopra delle classificazioni stilistiche, in grado di esportare la propria visione dell’architettura anche fuori dal continente americano e capaci di indicare nuove direzioni di ricerca, come R. Venturi, F.O. Gehry, Meier, P. Eisenman, S. Holl, E.O. Moss, T. Mayne, A. Predock e M. Rotondi. Le vere e proprie multinazionali della progettazione, i già citati SOM, Hellmuth Obata & Kassabaum (HOK), Kohn Pedersen Fox (KPF), Murphy & Jahn, Fox & Fowle, Ellerbe Beckett Associates, hanno esteso sempre più il loro campo d’azione, soprattutto in Estremo Oriente e nell’Europa centrale. Istituzioni accademiche come la Harvard University a Cambridge, la Columbia University a New York e la SCI-Arc a Los Angeles sono diventate i principali centri propulsori di un’ideologia architettonica d’avanguardia. Tra gli architetti più innovativi, affermatisi tra la fine del 20° e l’inizio del 21° sec., vanno inoltre segnalati: W. Bruder, attivo soprattutto in Arizona e nel Wyoming; Tod Williams & Billie Tsien, raffinati interpreti del ‘neomodernismo’; H. Smith-Miller & L. Hawkinson. Hani Rashid & Lise Anne Couture (Asymptote) e G. Lynn sono tra i progettisti, attivi nelle principali università statunitensi, dediti alla ricerca di nuove morfologie generate con l’ausilio dei computer.
Musica
Gli esordi
Le prime manifestazioni musicali negli USA furono strettamente connesse alle vicende dei colonizzatori della Nuova Inghilterra: per molto tempo il puritanesimo respinse ogni forma di esecuzione musicale e il primo concerto pubblico ebbe luogo solo nel 1731 a Boston, mentre a Charleston, nel 1755, vi fu un isolato tentativo di opera teatrale americana, Flora or hob in the well. Tra i compositori di questo periodo si segnalano F. Hopkinson (1737-1791) e W. Billings (1746-1800). Agli avvenimenti politici e militari del 18° e 19° sec. fu ancora legata la creazione di alcuni canti patriottici come l’attuale inno nazionale Star-spangled banner (1814).
L’Ottocento
Nel corso del 19° sec. si formarono varie istituzioni musicali e molti musicisti affluirono dall’Europa. La prima opera di autore statunitense a essere rappresentata (escludendo i pochi tentativi del 18° sec.) fu Leonora (1845) di W.H. Fry (1813-1864). Compositore interessante, aperto alle più diverse esperienze, fu L.M. Gottschalk (1829-1869), autore di molte pagine ispirate alla musica afroamericana e latino-americana. Dalla seconda metà del 19° sec. il paese cominciò a incoraggiare il recupero del patrimonio musicale nazionale, pur sviluppando naturalmente sempre più la conoscenza della musica europea. Molti compositori di questo periodo furono infatti legati per formazione alla tradizione musicale del Vecchio continente. Tra questi, in particolare: J.C. Dunn Parker (1838-1916) e J.K. Payne (1839-1906). Ricca di spunti originali fu la produzione, prevalentemente pianistica, di E. Mac Dowell (1860-1908). Verso la fine dell’Ottocento si impose il genere teatrale del musical, che grande fortuna avrebbe avuto nel secolo successivo.
Il Novecento
Tra i compositori giunti a notorietà nella prima metà del 20° sec. le personalità più interessanti furono C. Ives (che utilizzò in modo originale il patrimonio musicale della tradizione popolare statunitense), E. Varèse (tra i pionieri della musica elettronica), A. Copland e, soprattutto, G. Gersh;win, la cui produzione fu caratterizzata da un felice connubio tra il jazz, la musica popolare e una personalissima interpretazione del sinfonismo europeo. Sulla strada di una ricerca rivolta alla sperimentazione di nuovi mezzi d’espressione, si indirizzarono nel dopoguerra vari compositori tra i quali J. Cage, il più autorevole caposcuola delle avanguardie statunitensi. A partire dagli anni 1960 si affermò invece la corrente del minimalismo musicale, i cui esponenti di spicco furono T. Riley (n. 1935), S. Reich e P. Glass. Un posto particolare va a L. Bernstein, autore di balletti e commedie musicali di altissima qualità. Sono da ricordare anche altri compositori dell’avanguardia come L. Foss (n. 1922), M. Feldman (1926-1987).
Di importanza capitale per l’evoluzione della musica statunitense sono state le orchestre sinfoniche (tra le più note la Filarmonica di Los Angeles e quella di New York, la Sinfonica di Chicago, Boston e Filadelfia) e le scuole musicali come la Juillard e la Eastman, il Curtis Institute, nonché le università del Michigan, dell’Indiana e del Massachusetts.
Accanto alla produzione ‘colta’, la musica statunitense del Novecento ha trovato anche un’autentica espressione artistica nazionale nei vari generi della musica afroamericana (su tutti il jazz) e nei vari modi in cui le tradizioni folcloriche, urbanizzandosi, hanno dato origine alla pop music.